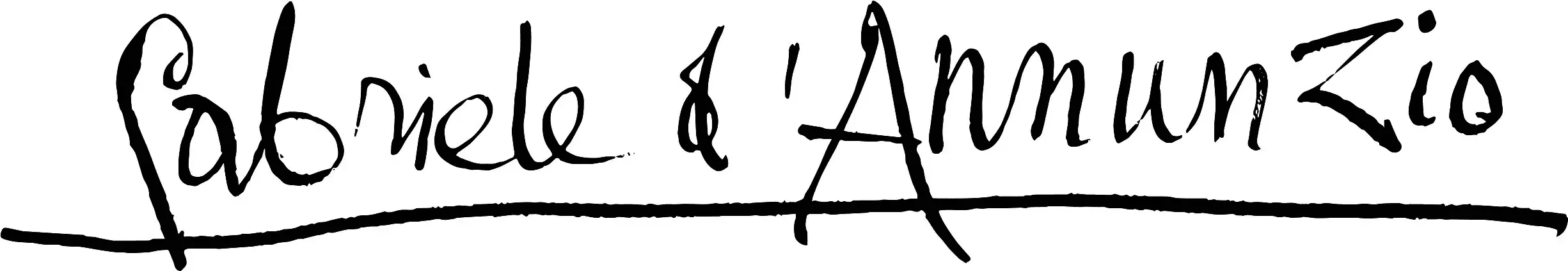di Paola Goretti, Enciclopedia dannunziana
Alma natura
In d’Annunzio la Rosa è un poema vivente, una preghiera di grazia sacra e profana, un concentrato universale di commozione e sensualità. Più che un fiore, una dottrina di legamenti, un punto astrale, un’illimitata innamorante carezza, un’ascesi di ebbrietà. Bellezza allo stato puro, divinità di spirito da trasformare in gioia ossea. La Rosa è Parola, la Parola è Rosa. Furore della vita abbrancante, ossessione del fiore-sesso, canto di desiderio, entità languidissima, castità pudicissima che sfuma virginale, ispirazione trasverberante dai petali corpuscoli di luce. Sacro fior di Venere, imperatrice della voluttà, archeologia di ogni atmosfera. Ma anche gaudio spiritualizzato, simile a quello della “perfetta letizia” francescana, dal Poeta tanto amata, per mescolanze musicali e coloriti d’ascensione. Laus Vitae.
E Laus Vitae è il peana verso il Fiore Tutto, essenza vegetale del soffio superiore. Tra le centinaia di pagine inneggianti la semplicità di questo concetto (elementare quanto mistico; rinnegato dalle strutture del razionalismo di ogni tempo ma nel Vate costantemente convocato), eccolo sgusciare dalle venature mestissime delle Vergini delle rocce (1895), quasi per contrappasso e felicità pànica celebrativa del Creato, nel rivolgersi a chi – in modo quasi blasfemo – si stava apprestando a scegliere la via della monacazione, della rinuncia al mondo:
Ecco un prodigio di cui bisogna lodare il Cielo. Considerate le innumerevoli scritture che contiene il tessuto argentino di questa corolla, e il rapporto occulto che corre tra il numero dei petali e quello degli stami, e la tenuità dei filamenti che sostengono i lobi delle antere, e queste tuniche diafane e queste reticole e queste valve e queste membrane coperte d’una pelurie quasi impercettibile, ov’è chiusa l’agitazione misteriosa della fovilla, e tutta la divina arte che si rivela nella struttura di questo corpuscolo vivente, pur nella sua fralezza dotato d’infinite potenze per amare e per fecondare. Considerate la rete mobile delle ombre che fa sul terreno il fremito delle foglie e quella che fa su la parete il raggio riverberato dell’acqua tremolante, l’una azzurra, l’altra d’oro per cullare la vostra malinconia; e le piccole dita bionde che si alzano in cima ai raggi dei pini; e le stille di rugiada che pendono in cima alle reste dell’avena; e le esilissime nervature nelle ali delle api; e gli occhi verdi splendenti delle libellule fuggevoli; e le iridi che variano la gola gonfia dei palombi; e le strane imagini che sorgono dalle macchie dei licheni, dagli screpoli dei tronchi, dalla disposizione delle selci…
La rosa suggella e amplifica quello che già è del fiore, nel prodigio segreto della vita vegetale, espansa oltre ogni limite. Sembra di percepire l’eco di Fechner (1801-1887), che mezzo secolo prima (1848) aveva scritto sull’anima delle piante (Nanna, o l’anima delle piante, Milano, Adelphi, 2008). Nell’orizzonte di questo trattatello – uscito per mano di un botanico, filosofo e fondatore della psicofisica – si sconfessavano come per incanto le drammaturgie evoluzionistiche di matrice illuminista, smantellando le gerarchie antropocentriche a cui le piante sembravano non accedere neppure, per non essere dotate di pensiero. Con Fechner esse diventavano metafora di uno sconfinamento che pur “immobile” e radicato al suolo, era in grado di aprire da sopra e da sotto, verso le vastità dell’infinito. Non solo. Inquadrate e comprese intimamente come esseri di luce destinati a cantare la freschezza dell’Anima Mundi (poiché nulla – né pietra, né onda né pianta né creatura infinitesima – è esclusa dal turbinare di questo moto: divino e non illusorio, soggiacente a tutte le cose), le piante offrivano una lezione chiarissima che riparava lo scandalo di un’esclusione. Recuperando i prolegomeni panteistici di Goethe e la perenne plasticità del processo trasformativo teorizzato nella Metamorfosi delle piante (1790), unitamente agli incanti poetici di Lucrezio e di Virgilio, il dialogo col Vivente si riaffacciava negli arcaismi di un sentire primitivo devoto alla sua sacralità, restituita al posto che le spettava di diritto. La vita delle piante agiva come esercizio di ampliamento per l’immaginazione umana: arpeggio metamorfico, concatenazione armonica, frequenza melodica, visione miracolosa della grande respirante creazione. Parole di Fechner che sembrano del Vate: «gli alberi e i fiori sono in certa guisa le corde d’una grande arpa psichica, suonata dal vento; ogni corda percepisce in sé il suo suono, e Dio ode il suono complessivo di tutte le corde. Fiori, corde viventi di un’immensa arpa psichica. Avviene dei fiori come della musica», dice. E ancora: «L’intero fiore è un vaso di incenso sacro». In chiosa di un lungo periodare, i fiori si manifestano come luce che si fa colore, e una pianta come luce che si rende corpo: «Il corpo è, per così dire, un violino che sente esso medesimo il suono interno delle sue corde», sentenzia Fechner con delicata premura. Dietro, c’era ancora lui, sempre lui, sebbene addolcito e cristianizzato: il dionisiaco. Le fondamenta di uno scuotimento mai sopito, una danza di libertà destinata a produrre il sempre nuovo. D’Annunzio, nella sua vita inimitabile, lo avrebbe reso spazio interiore di dissidenza, verbo di tumulto orgiastico, ortodossia antiborghese. Lo avrebbe reso Evoé. Un grande violino-corpo-fiore, una grande erotica arpa cosmica siglata dalla luce.
L’invocazione a Bacco Dionisio così come espressa in Primo Vere (1880), non si sarebbe spostata di un grammo in tutta la sua produzione. Egli è già il nume tutelare di ogni gaudio. Eccolo, dal Libro Secondo, Nel Museo Archeologico della Marciana in Venezia:
Evoe, Libero!… Tu sei lo Spirito
lieto degli uomini; sei ’l fausto Genio
in mezzo a fulgidi lampi di gioia
traversante pe’ secoli.
Eccolo ancora, verso il declino dell’ultima stagione (1936), immutato, sebbene il Poeta sia ammantato di solitudine rammaricante; memore di aver tutto vissuto e guerreggiato, sanguignamente. L’ode a Pan liberatore – Signore delle Opere Tutte – si fa sentire inconsumabile, anche nel mezzo delle ceneri, nel vituperio inaccettabile della decrepitezza. Ariel si avventa sul suo manto azzurro, avventurandosi senza sosta in ciò che un tempo fu il lauto pasto della vita. Nell’ora dello sfacelo, Pan è un frammento di cielo stellato tatuato in petto. Un sentimento di eternità che si rinnova sotto il clangore delle armi, incitando a rimestare la vita dentro le bombe, nelle meditazioni della mestizia (Libro ascetico, 1922), nei movimenti di tanta massa d’anima.
Echi di Euripide (Baccanti), nella possanza del sommo dio divinatore dal potere mantico, nelle saturazioni di scuotimento orgiastico, negli atti predittivi, nei ricongiungimenti d’archeologia sovrana, nel furore irrorato di splendidezza. Tra serti ombelicali di ogni tempo e sacri numi dell’eterno, onde di rose intrecciate al sacro sistro. Echi di Ovidio, il caposaldo del ritorno metamorfosante. Echi dello sfatto marcire delle rose passe (Nella belletta), nel trascolorare invertebrato che si infossa per dolcigna afa di morte. Proprio Ovidio, nella perpetua germinazione di tutto nel tutto, fa da sottotraccia agli innamoramenti per il sommo dio. Sebbene Pan non sia figura di spicco delle Metamorfosi (troppo terragno lui, troppo aeree loro), rozzo e maleodorante semicaper che non risiede nell’olimpo ma altrove e ovunque, Egli è il principio dell’ubiquità errante, morendo e rinascendo per infinite forme. Demone oracolare, tedoforo corporale, principio vivificante della natura, ospite sgradito della letteratura esemplare convocato ogni qual volta si fosse reso necessario un terremoto emotivo, divoratore di ogni mansuetudine.
Venerato in Arcadia come signore della selva e compagno della grande madre, tutore del disordine e della sovversione, comandante dell’erotismo divinizzato e degli stati di sospensione, il dio Pan è un giardino che apre all’incanto del mondo. Con lingua sempre nuova – panica, appunto – gioiosa di ebbrezza totale, colma di tocchi di forza carezzevole, ci introduce al Sacro con flauto irresistibile.
Ma d’Annunzio non studia Pan. D’Annunzio è Pan. Lo indossa. Molesto col suo furore disseppellito cavato fuori dalle memorie ossificate, col suo caricamento rifondatore che sostanzia il diluvio dell’impervia veggenza, telepatico di energia invasata pronto ad irrompere in ogni dove, in ogni dove liberando. Ondeggiando spavaldamente.
Il passato è presente, i cambi d’abito sono riassunti nel divenire: tutto è antichissimo, contemporaneo, eterno. La materia fosforica si alterna e si ricompone, mentre si mostra nei movimenti segreti del rivolgimento perpetuo, con l’autorevolezza di una pulsazione. Evoè, tracio Nume! Evoè… Il sostrato bacchico a cui sembra partecipare è tutto in questo sgomento inconsumabile. Nel Fiore-Rosa, la saldatura con l’ebbrezza remota si fa più stretta, assoluta, totalizzante. E’ il sentimento dell’Alma Natura, in perfetta citazione carducciana (Odi Barbare, Sogno d’estate, 1877), dal Vate ripresa in Oblivia (Primo Vere, Libro Primo, 1880), che già sigla ogni arcano:
L’immensa solitudine secura
m’avvolge in sua magia;
ne ‘l sentimento de l’alma Natura
la mia anima s’oblìa,
Alma Natura Fecit. Nella sterminata cosmogonia del Vate vasta come il titanismo degli dèi greci e satura di ogni allaccio, tutto si fonde. Per questo, non è possibile comporre un censimento della rosa che abbia criteri di sistematicità, per estrapolarne ogni menzione; meglio evocare un andamento complessivo, una costellazione di orizzonte, qualche categoria atmosferica all’interno della quale le rose siglano in modo indelebile i cangianti riverberi osmotici del Poeta.
Le partiture hanno coloriti differenti, pur confluendo in alcune aree dominate dalle incantazioni. E d’Annunzio non poteva che percorrerle tutte, nella ricapitolazione della tradizione a lui precedente, negli anticipi di quella futura. Carnis Rosa, Rosa Aulentissima, Rosa Elisia, Aura Rosa, Fluens Rosa, Rosa Melancholica, Rosa Duendica, Rosa Mystica, Rosa in Laude, Rosa Francescana, Rosa Durlindana, Rosa d’araldica, Rosa di fiaba, Hypnerotomachia Rosae, Theatrum Rosarum.
Nell’alchimia magnifica dalla possanza spudorata, nell’empatia tra tutti gli esseri che pone in dialogo umano e divino, la Rosa è fecondazione, abbondanza, gioia, felicità piena – elementare, elementale – nastro srotolato che più si dona e più arde. Come la crescita di una fiammata, un roveto perpetuo ebbro di fuoco inestinguibile. Superlativa dell’altrove e del tumultuario di tutti i sensi, biblioteca invisibile dalla melodia antica quanto il mondo, astro vellutato che atterrisce di commozione; nel vagabondare delle oscillazioni percettive con cui d’Annunzio celebra il fiore dei fiori, trasalimenti di parole e rose sono presenti fin dai componimenti dell’adolescenza (La Rosa, sempre in Primo Vere) e con loro gli urei fregi, i colonnati d’erme, i temperamenti aristocratici, l’azzardo cromatico sfolgorante d’ellenica luce e ambrosia gentile. Il sole del morto paganesimo rivive nella grazia smeraldina che tutto spolvera, trillando. Talvolta in immagini un po’ fruste, talvolta fresche e gorgoglianti. Il Vate consacrò alla rosa talmente tante pagine che essa sembrò metamorfosarsi in divinità, in amante libellula del divino gaudio:
Ecco, il tuo stelo trema a ’l bacio languido
d’un’amante libellula,
e le viole invidïando guardano
i tuoi divini gaudii:
Eccola ancora in Canto Novo (1882), tra freschissime piogge, vaste nozze dei plenilunii, inni della luce che si dilegua (IX, 68):
Van li effluvî de le rose da i verzieri,
da le corde van le note de l’amore,
lungi van per l’alta notte
piena d’incantesimi.
Soprannaturale, vertiginosa, esalante di aspettazione. Nel Piacere (1889), il primo romanzo del ciclo della rosa, le rose signoreggiano in una quarantina di brani, aggrovigliate in spirali estetiche, emotive, spirituali; naturali e soprannaturali, coagulate dal formidabile impasto performativo della scrittura del Poeta che, nella selva intricatissima del suo “auratico universo superiore” si diletta a nascondere trame cristalline. Folte, minuscole, larghe, vellutate, sfogliate, spogliate, spetalate, in spalliere, a fasci, a canestrate, a pioggia, in vasi semplici, in vasi umbri da farmacia, bianche gialle vermiglie brune nivee lunari, cosparse sui tappeti, accatastate come cumuli di neve, abbondanti fino al soffocamento.
Rose rose rose piovevano da per tutto, lente, spesse, molli, a somiglianza d’una nevata in un’aurora, dice nel testo, quasi a tradurre visivamente e ossessivamente Le Rose di Eliogabalo di Alma-Tadema (1888, Messico, collezione Pérez Simon), celeberrima tela inscenante i fasti dissoluti della tarda romanità raccontati nella Historia Augusta (Hist. Aug. Eliogabalus, 21.5).
Perfetto coagulo della visione della rosa cara al Vate è poi l’omaggio tributato da Adolfo De Carolis, in costante liaison artistica col Poeta (a partire dal 1901, quando il pittore è chiamato ad eseguire i disegni per scenografie costumi e locandina della Francesca da Rimini), specie per le soluzioni grafiche dei frontespizi editoriali e per quelle celebrative dell’avventura del Carnaro. Di De Carolis è proprio l’orcio biansato decorato con fitto roseto e cartiglio Così partia le rose e le parole (1900 circa, Firenze, Museo Stibbert), recante doppia citazione: esplicito un verso del Piacere, ripreso dal Petrarca (Canzoniere, CCXLV), quasi sintesi alchemica dell’impresa:
Cosí partia le rose et le parole,
onde ’l cor lasso anchor s’allegra et teme:
o felice eloquentia, o lieto giorno!
È in esso che trova collocazione il vero assioma della Rosa, la cifra di una superba evocazione: una partitura assoluta, saldante in modo inscindibile la mistica del fiore a quella delle parole: per il Vate entità profumate, dee danzanti, carni vivissime di desiderio inconsumabile.
In Rilke, la Rosa è un Dio; angelo che canta, conturbante fremito, pura bellezza e pura danza. Suavitas. Fiore molteplice e unitario, entità dispensatrice di ogni consolazione, grazia illuminata che ha risolto la sua ricerca pacificandola per via interiore, godimento di bene intimo. Non esiste capolavoro sensitivo più nobile, come di spiritualità che esala petalo a petalo, nello spazio interiore del compimento, per via di un’antinarcisismo appagato che in sé tutto addensa e tutto esaudisce.
In d’Annunzio, una Dea. Dove il primo la esalta come Presenza dell’Altissimo – girotondo cherubinico, ricciolo pastorale, bocciolo pentecostale – il secondo la assume come entità del supremo vivere; divinissimo, ma mai trasceso. O meglio, trasceso con e come la carne. Insieme a lei.
Rammemorazione sensoriale, visione spiraliforme, scenario dell’adulazione, teatro della magnificenza, fasto e capriccio linguistico. Sublime al punto da far diventare un fiore reciso una visione dell’anima. Nel giardino del Vittoriale, essa precede persino d’Annunzio. Fin dal concepimento, il roseto era già contemplato, a chiare lettere indicato nei documenti. Quando la proprietà era di Luigi Wimmer (Sindaco di Gardone tra il 1881 e il 1883), particolare cura fu infatti riservata a palme, pini, cipressi, siepi di bosso e di mortella digradanti a lago, limoni e orti; oltre, naturalmente, alle spalliere di rose. Lì il Vate avrebbe trovato il serbatoio contemplativo a cui attingere rugiada provvidenziale, necessaria come l’aria al suo inesausto tutto. Mai piantagione fu più indicata. Perché la rosa della terra e quella delle parole avrebbero partecipato della stessa medesima sostanza. Essendo intimamente la stessa medesima sostanza.
Villa Cargnacco, Somnii explanatio. Ecco allora; la Rosa sta a d’Annunzio come l’aria all’ispirazione, l’acqua alla pioggia, la terra alle radici, il fuoco a se stesso, ignifugo e salamandrato. È presenza indispensabile – come l’odore, come il profumo – talmente ovvia da diventar tutt’uno col quel “mitridatico corpo” che si ergeva a guisa di telamone nella scienza e nell’arte della vita: sempre “capolavorando”, all’interno di un sogno carambolante imbibito di riflessi antichizzanti e slarghi senza confini. La Rosa è Fiore-Parola, Parola-Feticcio (quelle che il Vate iniettava in ogni dove, posseduto dalla vertigine della lista di infiniti allacci sensoriali), Parola-Gioiello di opulenta perlacea ammantatura, ricoprente i riflessi del nuovo e dell’antico, del sempre e del qui. Parola-Totem da venerare eternamente.
La Rosa è l’Ebbrezza e l’Ebbrezza è la Rosa. Alma Venere Dea. Ciò che in Natura sboccia nel fiore, tra gli umani divampa in voluttà (Rêverie, Primo Vere). L’abbraccio di un amplesso senza fine.
Il bacio ultimo chiedono
le rose a le libellule divine:
io chiedo a te, mia Giulia,
l’ebrezze d’un amplesso senza fine.
Carnis Rosa
Ovviamente, la Regina è Lei. Sopra ogni cosa, è la rosa di carne, sonata perfetta, canto inconsumabile, tra connessioni ancestrali che radicano il femminile alla potenza trasfigurante del bell’animale, dal Vate alluso fin dalla precocissima Cronachetta delle pellicce (1884). Violenza barbarica del profondo, realtà tumultuosa, cruenta e liberatoria: la forza delle passioni di antica stirpe greca è fatalmente sorretta dalla sostanza mitica dell’odore. Odore di rosa piena.
Così, fin dall’epistolario del Poeta alla moglie, Maria Hardouin di Gallese, specie nelle lettere maturate nei primi dieci anni della loro unione (1883-1893). Prima di lasciar posto a missive sfilacciate e telegrafiche, è tutto un profluvio d’inebrianti felicità d’alcova. L’esaltazione della femmina, divinizzata e santificata fino a un’adorazione totemica, approda alla trasfigurazione, colorando di profumo la Rosa, superbamente. Nella Lettera da Pescara di martedì 10 luglio 1883, l’inambramento regna sovrano:
Come ora mi scotta la fronte! Sento nelle narici il tuo odore, quell’odore di Colonia che, mescolandosi al profumo naturale della tua pelle, prendeva un senso strano, non conosciuto, che a volte ricordava il fiore dell’arancio, a volte un effluvio di succhi di frutta tropicali, a volte la freschezza di un fiore d’acqua, e volte, non so, la fragranza misteriosa che io credevo dovessero avere le dee della Grecia.
Il fiore umano del sesso già si erge. Poco più avanti (nella stessa lettera) si fa largo un’animalità monumentale, prossima alla Rosa meditativa di Salvador Dalì (1958, collezione privata), specchio della Casida de la rosa di Garcìa Lorca. Un tabernacolo di proclami, tra magnetismo e venerazione:
Prima di conoscerti, io avevo sognata una pura bellezza pagana come la tua e l’avevo inseguita nel verso, io adoratore della forma, adoratore avido e inappagato. L’avevo sognata nascente come un gran fiore umano; ed avevo sognato che tutto il caldo profumo di quel fiore io soltanto potessi aspirarlo e morirne.
Nelle lettere a Barbara Leoni (più di un migliaio; da molti considerato l’epistolario più bello di sempre), la rosa di lei è inesausta ossessione. Rosa assoluta e definitiva (rosa originale, come Egli la chiama), sigillo indelebile che appare a tutte le ore del giorno e della notte, stendardo issato ovunque, lì a ricordare e a promettere. In un tempo in cui la passione bruciante degli inizi aveva subito molte battute d’arresto, in un andirivieni già intorbidato da intrusioni d’ogni sorta, all’ombra dell’imminente fine più volte annunciata, così scrive il Poeta da Napoli, il 16 gennaio 1892:
Da molto tempo un pensiero fisso mi divora il cervello: e tu lo sai forse: il pensiero della tua rosa: un pensiero ardente, una visione lucidissima, uno spasimo di brama quasi folle.
Pochi giorni dopo (25 gennaio), consumato da una sorta di febbre occipitale dovuta a uno stato nevrotico implacabile, prostrato dalle sovreccitazioni della fantasia erotica, Ariel rincara la dose:
In fatti, da qualche mese, io ho il pensiero fisso di te; ho nel cervello l’imagine fissa della rosa, della divina e incomparabile rosa, di cui ho un ricordo quasi vivente nel talismano che non mi abbandona mai…
La carne divinissima di vita è vita divinissima di carne. Ubriaco del corpo dell’amata, del suo colore, del sapore della sua carne umida e calda, dell’odore del suo odore:
Tu parevi allora, nell’ombra, un fiore, un gran fiore umano, più inebriante d’un vino prezioso e più dolce del miele puro. Ti ricordi?…
I baci della sua più intensa voracità sono sempre dove tu sai. Sempre lì, nel sacro cuore della femmina-mondo. Su quella rosa delle rose (rosa originale, appunto), senza la quale non può vivere. Perché ella è gioia, gioia della rosa-mondo, della rosa monda (da Napoli, 28 novembre 1891):
“Ella, ella sola è gioja”. Ti ricordi? Questo mio grido lirico è antico, è dei primi tempi. E come la mia anima fu profetica! Dopo cinque anni ripeto con una convinzione più profonda, mentre tutto quanto il mio essere trema, ripeto: “Ella, ella sola è gioja!”
E ora sarà così per sempre. Per una curiosità intellettuale, talvolta io faccio uno sforzo per imaginare me in un altro amore, me posseduto da un’altra donna. E non riesco ad imaginarmi.
Ho veduto qui passare qualche donna bella; e non mi sono turbato. Ho pensato anzi con un disgusto istintivo all’atto di voluttà. Tu sola, tu sola sei la rosa monda, rosa munda. Io non ho desiderii che per te. Il mio sangue ti chiama.
Tra le tante ancora, eccone un ulteriore passaggio (da Pescara, 17 marzo 1888):
Mi sono levato. Oggi la giornata è tiepida. Ho passeggiato nel giardino ed ho colto le violette, le grandi viole odorose. Te ne mando cinque: una per la tua bocca sovrammirabile; una per la mammella sinistra che è molto amica mia; una per l’ascella destra che si lascia baciare qualche volta senza smorfie; una par ce bon petit endroit che è sotto l’orecchio, fonte di scandali inauditi; e una per la rosa delle rose, per il freschissimo fiore del mio piacere, per la rosa originale. A te nulla.
Addio. Domani è il mio giorno onomastico. Mandami tutto il miele che hai sotto la lingua; tutto!
Struggentissimo questo stralcio di roseti abbarbicati tra le spire del loro amore, che paiono tutto incensarlo, profumarlo, celebrarlo (da Francavilla al Mare, 13 maggio 1891):
Grazie della tua lettera lunga d’amore. L’ho avuta dianzi, a pena tornato da Pescara. Sono già le otto. E’ una sera divina. Tengo il balcone spalancato e vedo il cielo profondo, la piccola luna, le stelle palpitanti; vedo il chiarore incerto dell’Adriatico. Dai roseti folti, che fioriscono lungo il muro, sale un profumo pieno e fresco; dagli aranci sale come un veleno volatile. Questa è un’essenza che darebbe al nostro desiderio una infaticabilità meravigliosa. Da quest’ora all’alba io vorrei rimaner congiunto a te in un solo abbracciamento. Il mio desiderio non ha confini.
Poco più oltre, ritorna all’erotico:
Addio. Ti bacio la bocca, ti suggo tutto il miele della tua lingua; e poi ti bacio e ti suggo la rosa, l’incomparabile fiore… Oh, parlami di lei!
Dal trono del dio Pan, la creazione plastica dell’inesausto desiderio ha sempre forma di rosa:
Nell’apice della voluttà, l’abolizione delle persone, la scomparsa del singolare. I due sessi ingigantiti e ampliati. Le dita cercano nelle pieghe superficiali della rosa la profondità della radice umana. Le dita intorno alla verga eretta stringono il perno del mondo. Le apparenze fluiscono e fluttuano di sopra alle idee sempiterne. Nella nostra congiunzione tutte le congiunzioni: da quella di Leda con l’aurora, da quella di Endimione con Diana – a quella di Sakuntala, di Marica… Assaporo sul suo corpo le frutta di tutte le regioni, la fame di tutte le latitudini.
Di rosa in rosa, di carne in carne. Insenature e promontori della libidine. Nell’inesausta cordigliera di parole che allaccia il Vate al mistero femminino, la Rosa è regina di ogni dispiegamento. Colonna della liberazione, che dopo la furia dell’amplesso si spiritualizza in santità. Duplice medesima cosa, duplice medesima rosa:
“Io l’Impuro? Io sono puro e innocente, candido e semplice. Altrimenti, come potrei accogliere in me l’odore della rosa o del gelsomino come un sentimento della mia sostanza segreta? Altrimenti come potrei distinguere il sapore delle acque diverse, tra sette fontane, fra dieci ruscelli, fra tre fiumi?”
Lo aveva detto, sempre a Barbara Leoni (10 agosto 1888): Io sono puro come una creatura paradisiaca. Lo avrebbe ripetuto incessantemente. Nell’Arcilibro del Vate, Sentire, Intuire, Sapere, Godere, Celebrare, Pregare, sono una cosa sola: i rinascimenti interiori e anteriori si cuciono in un diadema letterario, divengono divini abbracciamenti, divine orazioni sul corpo dell’amata, divine superiori voluttà. Nel tumultuario dei sensi, la tortura della rosa è un brivido ardente languente, mai sopito di lassitudine, spaesamento, vertigine, migrante in soavità. L’aspettazione, la tortura delle ore vuote, il memoriale della rosa da ripassare in rassegna mentalmente, ripercorrendo ogni millimetro del corpo insaziabilmente posseduto, lo struggimento per essere “senza la rosa”, la misteriosa armonia promanante da ogni sommovimento della rosa amata, si trasformano in aria rilucente. Il fiore-sesso cessa di essere solo una zona erogena e si trasforma in entità, occupando tutto lo spazio dei pensieri, tutto lo spirito dell’anima. Nella distanza, forma un’imago assai diversa, mentre la rosa dell’assente diviene mandorla di luce che guida il pellegrino verso le vastità soprannaturali: fino alla parte migliore della sua anima.
«Ricordarsi della metamorfosi di talune carezze (ecco di nuovo Goethe e la Metamorfosi delle piante…), dopo ore ed ore di ebrezza. La carne non è più carne ma è l’orlo di un potere interiore», dice nelle Faville (1907). Che espressione perfetta per significare l’insignificabile! Il flusso del sangue si gonfia e rinnova il suo nutrimento, la grandiosa festa carnale si muta in vita dello spirito, irradiata di santa beatitudine. E nella follia orgiastica, Ariel si spiritualizza. Sempre.
Nel morimento orgasmico, negli indovinamenti del suo cuore – che sanno, odono sentono: l’indicibile, l’inconsumabile, l’eterno –, le carezze anche solo immaginate sono rose, rosa lo sfondamento della cognizione spazio temporale, rosa la voluttà che abbranca il corpo dell’amata, rosa i gemiti del desiderio, rosa l’illimitata voracità, rosa il frammento di un corpo reliquia da suggere continuamente, nel dimenarsi del contorcimento interiore, imbestiato. Duplicando, triplicando, moltiplicando i moti dei sensi, per ribadire il desiderio imperioso di una richiesta, una supplica, un comando. Come quando avrebbe voluto solo la rosa, la rosa, la rosa…
In Ariel, la carne è santa, la carne è la rosa. Guai a tradirla, rinnegarla, nasconderla (Donna Francesca, in La Chimera, 1888; compare in anticipo anche in Isaotta Guttadauro ed altre poesie, 1886; Donna Francesca, VII):
La carne è santa. È l’immortale rosa
che palpita di suo sangue vermiglia.
È la madre de l’uomo ed è la figlia.
Ed è quella che sta sopra ogni cosa.
Ella racchiude, come un’urna aromi,
tutte le voluttà, tutti i dolori.
Ha l’ardente opulenza ella de’ pomi,
ha la soavità casta de’ fiori.
La carne è santa, la carne è la rosa, la rosa è l’Officum, l’altare supremo, una religione, una divina apparizione, nell’assoluto del mescimento dove la divisione tra i corpi non più esiste. Per solfeggio tattile, ostia di marezzatura. E non distinguo l’anima dalla carne, anzi dichiaro la carne, la pongo sopra tutto: questo è l’amore, soltanto questo. Così avrebbe sentenziato nel Libro Segreto.
Lo splendore della sensualità è un bene inalienabile, figlio dello splendore del creato, avida bestia sbuffante gonfia di sostanza divinatoria. Lo ripete in ogni dove, tanto che ne Il secondo amante di Lucrezia Buti (1907) gli dedica una specifica, ribadendo la commistione ugualitaria e compenetrante tra far opera di carne e opera di spirito:
La mia divinazione mi fa certo che, oggi e domani e fino al trànsito, l’opera di carne è in me opera di spirito, e che l’una e l’altra opera concordano nell’attingere una sola unica bellezza. La più fertile creatrice di bellezza nel mondo è la sensualità rischiarata dalla divinazione. La sensualità mi accomuna alle cose che guardo, mi fa simile alle cose che tocco ed esamino mi dà la veggenza di Francesco cieco che vedeva le musiche. Non vedo io le mie musiche? Ma ho ancóra da penetrare questo mistero, ho ancóra da esplorarlo impudicamente, cioè innocentemente.
L’estasi eucaristica è sposa della voluttà. In tutti gli odori della rosa è l’ora della vita superba. L’ora perfetta di un atto interiore, divino. Voluttà, eterno canto. Rosa, Anima Mundi del desiderio.
Rosa, Vita Universa
Rammemorando il tempo eroico dell’adolescenza spesa sull’orlo del rischio e del segreto, è lo stesso d’Annunzio a dichiarare l’amore per i forzati imparolamenti di quando, impudicamente, aveva scelto proprio il termine “rosa” per declinarlo non come sostantivo ma come verbo, nella burlonaggine di imberbe liceale (Il secondo amante di Lucrezia Buti), già avvezza nel mettere a fuoco i termini più astrusi per impallinare i compagni e sfoggiare la sua virtuosa supremazia.
Mi ritorna nella memoria l’irrisione feroce dei miei condiscepoli nel ginnasio pratese quando per la prima volta chiamato mi levai dal mio banco a declinare il nome della rosa pronunziandolo come fosse il participio passato del verbo ródere. Mi ritorna nella memoria quella mia costante e orgogliosa disciplina vocale per cui giunsi in breve a correggere i suoni del dialetto nativo e a vincere di «moderazione con bellezza» perfino un mio emulo affettatuzzo di Siena. «O rosa che di Napoli venisti, e ti bagnasti nella Fonte Gaia!
Disciplina vocale di un orecchio accordatore, aura tosca, apparizione melodiosa di uno stregamento che non ha rivali, uso a percepire la bestia dei secoli imbestiati, a sfuggire qualsiasi atto prosaico pianeggiante, a inseguire le matrici del genio originario, l’odore della prosa calda, le formelle invetriate della r arrotata. La rosa, da gioco linguistico in un attimo si sarebbe mutata in Laude, offertorio. Canto riparatorio issato sulla disgregazione delle epoche. Preghiera dolcissima.
Abolisce il senso del tempo, Ariel; riassume le ere e le coagula in un sommovimento uniformante, sempre sull’orlo del rischio e del segreto, in un cofanetto smaltato a sbalzo dall’incessante divenire, nella fluidità dell’oro interiore costantemente profetizzato. La litania della temporalità ordinaria è sconfessata, la vita è adagiata su un’antica foglia di rosa, ed è lì da sempre. Tutti i venti hanno forma di Rosa, tutto i Tempi sono una Rosa, tutte le Rose sono Una (Clepsydra mentitur, sempre in Il secondo amante di Lucrezia Buti):
Io, ne’ miei belli attimi, riduco a una folgorante unità lirica gli spiriti e le imagini che a me vengono dai quattro punti della sfera e da tutti i punti dell’orizzonte trovando in me accoglimento e comprendimento simultanei. Anche i vènti dello spirito hanno una Rosa con assai più di trentadue rombi; anche le età del mondo hanno una Rosa con assai più divarii che a distinguerli non bastino tutti i metalli nobili e vili dei pianeti e delle stelle fisse. E con l’una e l’altra Rosa io mi son piloto perdutissimo a scoprire i miei mondi: al sommo? all’imo?
D’Annunzio insegue L’immensa plenitudine vivente (da Alcyone, Il fanciullo), l’eternarsi dell’eterno in ogni ora, in ogni cosa, in ogni gesto. E la divinità dell’Uno, non quella del Tre, che Egli sente e rincorre in ogni dove, come Siddharta (Già egli sapeva, nelle profondità del proprio essere, riconoscere l’Atman, indistruttibile, uno con la totalità del mondo). Nei secoli dei secoli, Ariel aspira al dio unico, lo dichiara in ogni dove (Libro Segreto, 1935):
Aspiro al dio unico, cerco il dio soprano. E sento come ‘quel che è in me divino’ tenda a ricongiungersi col dio inaccessibile, si sforzi di possederlo.
Le forme delle sue ali si posano di volta in volta sul poverello d’Assisi o sulle braccia dell’India, sul volto del Divino Infante e su quello del Veggente Indiano o Tibetano, in un sincretismo religioso senza limiti né confini. Esplicito è nelle Laudi (1903), dove venera il Tutto. Il Tutto nel Tutto che al Tutto ritorna e si rinnova, visto che il dio luminoso/vi diffondea col respiro/ un’armonia sempre uguale (XV). Ecco il Laus Vitae nel Libro primo, Maia, I:
Laudata sii, Diversità
delle creature, sirena
del mondo! …
Infiorescenza creaturale immarcescibile. Nell’evidente francescanesimo di fondo, la rosa è l’allerta di questo Tutto, di questo axis mundi la manifestazione, tanto nella celebrazione dell’eternità che nell’esaltazione dell’effimero. Onniveggente e divinatoria come la Parola, essa è passione alchemica soverchiante, purità intimissima, fasto solare. OM. Nel fluttuamento degli accavallamenti temporali, la rosa tutto assorbe e tutto rende, come se in essa ci fosse l’assimilazione di una percezione temibile: quella dell’incontenibile smisuramento, che atterrisce per vastità e seduce per mistero. Tutto è occulto, tutto è mondo, tutto è niente. L’illimitata seduzione per le arti della rosa sono identiche a quelle della parola. Della Parola che si fa Rosa. Della Rosa che si fa Mondo.
Così, somiglia alla rosa l’Unità creaturale dei Veda – spesso invocati dal Poeta – dove il marasma delle cose sdrucciole confluisce nell’infinito sussurramento della Vita. Dove tutto si compie, si disintegra e si ricompie. Dove tutto è perfetto. Rosa, teatro di dio.
Sebbene i contatti col mondo asiatico (con l’India in particolare) in d’Annunzio siano sporadici, tra le sue pagine non mancano i riferimenti al soffio del divino superiore e alle verità risplendenti proclamate nelle formule sanscrite. Sporadici ma intensissimi. Fin dal Piacere, il Vate si cimenta infatti in una connessione tra l’Anima Individuale e l’Anima Cosmica, sottolineando una sorta di appagamento verso la pura Conoscenza e la Pura Contemplazione. Precisamente in quei momenti, Sperelli si sente completamente penetrato dalle verità proclamate nelle Oupanishad:
“Hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est”. Il gran soffio d’idealità che esalano i libri sacri indiani, studiati e amati un tempo, pareva lo sollevasse. E tornava a risplendergli la formula sanscrita, chiamata Mahavakya cioè la Gran Parola: TAT TWAM ASI; che significa: Questa cosa vivente, sei tu.
Ondulazioni, increspature, allusioni intuitive a certi insegnamenti della Gran Parola. Come per la tradizione indiana, anche per d’Annunzio le parole sono Esseri Viventi. La loro forza propulsiva discende dal pensiero pneumatico ed è tutt’uno con l’Arte del Respiro. E la Parola, la Divinità in grado di restituire l’Unità creaturale di tutte le cose. Non Ekfrasis, non Logos. Ma Pneuma.
Parole, Esseri Viventi. Cattedrali di fragranze sgorganti dalle radici arcaiche dell’immaginazione mitica. È questo – a parer mio – il vero snodo di congiunzione, che conduce direttamente alle radici vediche dell’India e alla coppa della Parola profumata. La Parola, è manifestazione della Dea; ispira, soffia, coagula, copula, agglutina, seduce, ipnotizza, agendo sulla facoltà del parlare mediante la grazia di una donna desiderosa di unirsi luminosamente al suo diletto, attivando atti d’amore senza fine. Una Dea che presiede agli atti della voluttà, travasando nella Parola l’energia del femminile più remoto, assorbita nella stereofonia della carne profonda. Ciò che Egli venera, il propagarsi dell’Anima Mundi. Non il pensiero. Ma il respiro, l’esalazione, la danza.
Anima Mundi, certo. E quella di Ariel è una sorta di bufera di rose perpetua. Non ha la visione adamantina di Yeats, né la sua argomentazione dottrinale che passa in rassegna le differenti confessioni religiose, nel sostrato esegetico e teologico. D’annunzio per farle sue – sensitivamente, orgiasticamente – evita di compiere disamine lenticolari, fatto salvo l’uso dei sogni, dei déja-vu, delle coincidenze turbinanti e della venerazione per il misticismo erotico. Per il Vate, occorreva non tanto trascendere o liberare un’anima mundi imprigionata chissà dove, ma farsi nuovamente Anima Mundi, aprire i sensi nella dottrina dei legamenti di tutte le congiunzioni, legarli insieme con un filo di miracolo. Ricongiungersi al Tutto, riedificare gioia, ebbrezza, voluttà. Divenire musica.
Salmodiando le reminescenze del pensiero indiano come fossero giaculatorie, d’Annunzio celebra l’universo, quasi che tutta la sostanza coagulata in esso – passato presente e futuro – e tutti i sobbalzi temporali si dessero collocazione in un battito di ciglia, nelle istanze del moto. L’architrave del Vate è infatti quello di un pensiero danzante – del Tutto nel Tutto – nelle particole di un andamento pulviscolare che si creano si rilasciano si riassorbono si modificano. Continuativamente.
L’agire del mondo si muove incessantemente; incessantemente il Poeta è lì a darne testimonianza, nel ritmo fluente della divinità. Senza teorie, in un atteggiamento di portentosa bellezza che venera il vorticare della creazione in cui immettere il proprio vorticante desiderio, la propria vorticante bramosia; intensificando l’andamento degli stati emozionali, nello sgretolamento di ogni pensiero logico e razionale. Intransigente nel dissobbedire a ogni cliché. Dice il Poeta nel Piacere:
Io sono ammesso dalla Natura nel più secreto delle due divine sedi, alla sorgente della vita universa. Quivi io sorprendo la causa del moto e odo il primo canto degli esseri in tutta la sua freschezza.
Alchimista volontario – come Ermete, archivista degli dèi – anch’Egli sembra dirci che tutto è avvolto da una rete di significati che appaiono e scompaiono, si rivelano e dileguano, nelle segrete emanazioni delle intelligenze luminose di cui Egli diviene non esegeta, ma interprete assoluto. Come Ermete, anch’Egli sembra dirci che il mondo è riempito dal pneuma, che esiste universalmente e per sempre. Come Ermete, Egli è occhio di orbo veggente. Kore Kosmou, pupilla del mondo.
Occhio pneumatico, occhio di rosa. Ariel è rapito dai volteggi diafani, dalle apparizioni della bellezza consolatrice, dall’acclamazione gloriosa dei fasti personali, per ritrovare nel fondo della creazione il connubio perfetto di Arte e Vita. Ma ciò che insegue è la fluttuazione di armonie in movimento, in scaturigine perenne. Nel loro vorticare si sostanzia un atto pneumatico a cui tutti i composti si sottopongono. Il ritornello è sempre quello. Sempre lo stesso, nell’ode alla sorgente dell’eterno, ai sensi di tutte le stirpi. Emblematica questa invocazione dalle Vergini delle Rocce:
O molteplice Bellezza del mondo… non a te soltanto sale la mia lode; non a te soltanto, ma anche ai miei maggiori, ma anche a quelli che seppero gioire di te nei secoli remoti e mi trasmisero il loro fervido e ricco sangue. Lodati sieno ora e sempre per le belle ferite che apersero, per i belli incendii che suscitarono, per le belle tazze che votarono, per le belle vesti che vestirono, per i bei palefreni che blandirono, per le belle femmine che godettero, per tutte le loro stragi, le loro ebrezze, le loro magnificenze e le loro lussurie sieno lodati; perché così mi formarono essi questi sensi in cui tu puoi vastamente e profondamente specchiarti, o bellezza del mondo, come in cinque vasti e profondi mari!
La componente dell’Animatio – sia essa Bacchica, Panica, Dionisiaca, Vedica – partecipa della medesima matrice e si riverbera nelle forme inimitabili dell’esistere. I coloriti dell’accensione e del decadimento, l’energia ascensionale degli inni e delle convocazioni temporali, la contemplazione imaginifica dello spirito di volta in volta evocato, prismaticamente definito con una particolare dimensione materiale e disposizione psichica, l’intuizione del Tutto come un essere vivente (alla maniera di Eraclito e Empedocle) mosso dalla mescolanza degli elementi – il fuoco in primis – il respiro cosmico unificante, il collante motorio generatore che plasma il sublime caos difforme in cui l’alternanza di ordine e disgregazione ne è matrice ineludibile, l’eternità sostanziata dall’effimero e l’effimero disciolto in essa, la potenza oracolare della poesia insufflante il divino, la poesia del Verbo e della Rosa. Rosa, aria di patria spiritale. Rosa Anima Mundi.
Giuntura di umano e divino la Parola, in accordo col ritmo dell’eterno, Potenza risvegliatrice, musica di resurrezione. Parola, Anima Carne, di volta in volta ispirata dall’amata, ispiratrice, Parola salvezza intera (Il fuoco), rito e ritmo:
Tra le materie atte ad accogliere il ritmo, la Parola è il fondamento di ogni opera d’arte che tenda alla perfezione.
Divina è la Parola, semplicemente. E in questo è il Tutto (Isotteo, Epodo, IV, 30):
O poeta, divina è la Parola
ne la pura Bellezza il ciel riposa
ogni nostra letizia; e il Verso è tutto.
Parola, cosa mistica e profonda saettante chiarori fosforici: cosa bella che svanisce si adegua si rigenera tra spazi d’infinito, arabescando. Liquore da versare in bocca, odore e unguento balsamico (La parola, in Poema paradisiaco). Ecco l’ennesima dichiarazione, in Novo encomio della mia arte (Il secondo amante…):
Così, nella vivente poesia, tutto è risonanza consonanza dissonanza… Il mio più alto e più raro privilegio è in questo potere di trarre nuove tempere di suono da tutte le cose ch’io tocco, da qualunque cosa ch’io tocchi; e ciascuna tempera nuova risveglia un nuovo mondo e si propaga nell’invisibile e si perpetua nell’eterno.
Infine, la sentenza capolavorante, da Il libro soprannaturale:
Voglio scrivere un libro ove tutte le parole sieno vive e musicali come le foglie che fremono variamente a ogni mutazione di soffio in una giornata varia del mio marzo. Voglio dare al mio libro il fremito delle foglie al soffio del mattino, al soffio di mezzodì, al soffio della sera, al soffio della notte. Ma chi scriverà un libro che somigli a un giorno e a una notte del solstizio? Chi scriverà un libro che somigli all’equinozio di settembre?
Le oracolerie della parola sono raggio solare, firmamento, natività, sintassi volubile, nella convocazione degli elementi tutti. È lì –precisamente lì – che l’amore per la Parola diviene amore per la Rosa, per trasmutazione alchemica. Che la Parola diviene Rosa.
La fluidità sentimentale della Parola che si fa Rosa – della Rosa che si fa Parola e Soffio – si carica del vapore aereo delle mutazioni atmosferiche. L’esangue martirio della bellezza si nutre di una voluttà senza misura, e la follia d’amore ha bei fogliami d’antico. Tumultuariamente, ecco Ariel che si impenna in prosa traslucida, tra ondeggiamenti simultanei. Compaiono le rose nei sommovimenti dell’animo, tirate a bulino e a cesello, negli interstizi dove il tempo si ritira. La Conoscenza di tutto l’universo (Libro Segreto) passa per la grazia di una rosa, nel patire che la costringe a fiorire e svanire. In lei – goccia di pioggia, rondine di maggio – e in tutte le cose fragili, vive la storia dell’eternità.
Qual dunque è il modo di conoscere? Scoprire il segreto dell’Universo mal nato ne’ granelli della sabbia, nelle granella della spiga o nelle stelle della costellazione Spica Virginis, in un acino d’uva, nell’ombra di ciglia chine; scoprire il segreto dell’angoscia nel cuore d’una rosa divorato da una cetònia non meno bella de’ petali cadenti; accogliere l’infinito nel cavo della mano che tiene l’acqua piovana o la rondinella caduta dalla gronda; vivere l’eternità in un’ora diurna, in un’ora notturna; uccidere l’oscuro iddio sotto i ginocchi della preghiera.
Rosa Movimento, Rosa Soffio di Vento (La Siesta, in San Pantaleone, 1866):
Il vento faceva incurvare i roseti che, passato il soffio, seguitavano a muoversi pesantemente. Li zampilli scintillavano e guizzavano, tra il verde, come stocchi.
È lo stesso modo di incurvare le parole, di renderle canna, fiato migratorio, flauto mesmerico (dal Libro soprannaturale):
C’è nell’arte di collocare le parole una novità perpetua che mi rinnova la vita universa e mi collega alla vita universa, a tutte le forme della vita innumerevole, anche a quelle in punto d’apparire.
Tutto l’universo obbedisce alla Luce e la Parola è Luce, Soffio, riverbero, pulviscolo che si dilata, proveniente dall’alito naturale e che all’alito naturale ritorna. Il Giardino – il Roseto, la Rosa singola; e la Parola di cui abbisogna per essere detta, sentita, respirata – sono esseri viventi tutti, incarnazioni plastiche del desiderio. Erma motoria e rilucente della divinità dell’ora e dell’eros, custodia epistolare della scrittura degli dèi, la Rosa è calligrafia di Dio, Dea essa stessa onniveggente.
Delicata la notte che viene col suo incanto luminatore, nel tumulto delle parole d’acqua, scoscianti semprevive mutevoli. Il divino battitore – il fioraio dalla vita elegantissima – risveglia la forza degli oracoli, il suono panlinguistico, volteggia sulla Parola Rosa, la convoca, la mastica, la erutta. Rosa, atto di devozione, sguardo cifrato di beatitudine, favola che non finisce mai. Nella melodia del perpetuo fluire (Notturno).
Stregamenti, ammaliamenti, incantagioni. Tutto il mondo ha forma di Rosa, ogni Rosa racchiude il mondo. Come Lui, l’orbo dei millenni dalle mille anime. Devoto all’Anima Mundi. Nel nome della Rosa senza fine.
Bibliografia essenziale
P. Goretti, Archivio della Rosa, in Antonia Ciampi. Archivio dei Sogni, catalogo della mostra (Roma, Casina delle Civette di Villa Torlonia, 5 dicembre 2013 – 8 giugno 2014), a cura di Claudio Strinati, Bari, Posa Edizioni, 2014, pp. 127-141.
P. Goretti, La beatitudine della rosa, in D’Annunzio e l’Arte del Profumo. Odorarius Mirabilis, catalogo della mostra (Gardone Riviera, Il Vittoriale degli Italiani–Museo d’Annunzio segreto, 14 aprile 2018 – 27 gennaio 2019), a cura di Paola Goretti, allestimenti e scenografie Pier Luigi Pizzi, Cinisello Balsamo (Mi), SilvanaEditoriale, 2018; pp. 11-29.
P. Goretti, “È l’immortale rosa”. D’Annunzio e il fiore dell’ebbrezza, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 2022.
Rose. Purezza e passione nell’arte dal Quattrocento a oggi, catalogo della mostra (Caraglio, Il Filatoio, 27 giugno – 25 ottobre 2009), a cura di Andreina d’Agliano, Cinisello Balsamo (Mi), SilvanaEditoriale, 2009.
Per l’opera omnia del Vate si vedano i volumi editati nei Meridiani Mondadori: Versi d’amore e di gloria, vol. I (1982); Versi d’amore e di gloria, vol. II (1984); Prose di romanzi, 2 voll. (1988-89); Tutte le novelle (1992); Prose di ricerca, 2 voll. (2005); Tragedie, sogni e misteri, 2 voll. (2013).
Gabriele d’Annunzio, Lettere a Barbara Leoni, Firenze, Sansoni, 1954.
Gabriele d’Annunzio, Di me a me stesso, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 1990.
Gabriele d’Annunzio, Infiniti auguri alla nomade. Carteggio con Luisa Casati Stampa, a cura di Raffaella Castagnola, Milano, Archinto, 2000.
Gabriele d’Annunzio, La miglior parte della mia anima. Lettere alla moglie (1883 – 1893), a cura di Cecilia Gibellini, Milano, Archinto, 2018.
Gabriele d’Annunzio, Tu m’inambri, a cura di Paola Goretti, Lucca, Edizioni Cinquesensi, 2023.
M. R. Giacon, Il suo nome è Gabriele: le vere lettere di Barbara Leoni 1887-1889, Pescara, Ianieri, 2013.
Paola Goretti, Odorarium Mirabilis: acque, profumi, voluttà in Gabriele D’Annunzio 150. “Vivo, scrivo”, Atti del convegno internazionale di studi, Pescara, Aurum, 12-13 marzo 2013, «Quaderni del Vittoriale», n. 4, a cura di Giordano Bruno Guerri, Cinisello Balsamo (Mi), SilvanaEditoriale, 2014, pp. 193-2005.
Giordano Bruno Guerri, D’Annunzio: l’amante guerriero, Milano, Mondadori, 2008.
Giordano Bruno Guerri, La mia vita carnale: amori e passioni di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 2013.
“Io per te. Tu per me”. Gabriele d’Annunzio e Giuseppina Giorgi Mancini. Carteggio 1906-1938, a cura di Francesca Martinelli, Cinisello Balsamo (Mi), SilvanaEditoriale, 2017.
“L’infinito della melodia”. Gabriele d’Annunzio e Adolfo de Carolis. Carteggio 1901-1927, a cura di Valentina Raimondo, Cinisello Balsamo (Milano), SilvanaEditoriale, 2018.
Lettere a Barbara Leoni (1887-1892), a cura di Vito Salierno, Lanciano, Carabba, 2008.
Lettere d’amore a Barbara Leoni, a cura di Federico Roncoroni, Milano, ES, 2008.
Valerio Magrelli, Il piacere del Piacere, «Quaderni del Vittoriale», nuova serie, n. 14, Cinisello Balsamo (Mi), SilvanaEditoriale, 2018, pp. 13-18.
Attilio Mazza, Cargnacco prima di d’Annunzio, Brescia, Ecoedizioni, 1985.
Tristano Gabriele Oppo, Barbarella: il grande romanzo d’amore di Barbara Leoni e Gabriele d’Annunzio, presentazione di Franco Di Tizio, Chieti, Tabula fati, 2004.
Tutte le sfumature della rosa. Eros e passione nelle lettere d’amore a Barbara Leoni, a cura di Tobia Iodice, Villariccia (Napoli), Edizioni Cento Autori, 2013.
Silvia Urbini, «Somnii explanatio». Novelle sull’arte italiana di Henry Thode, traduzioni di Paola Sofia Borghini, Roma, Viella, 2014.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)