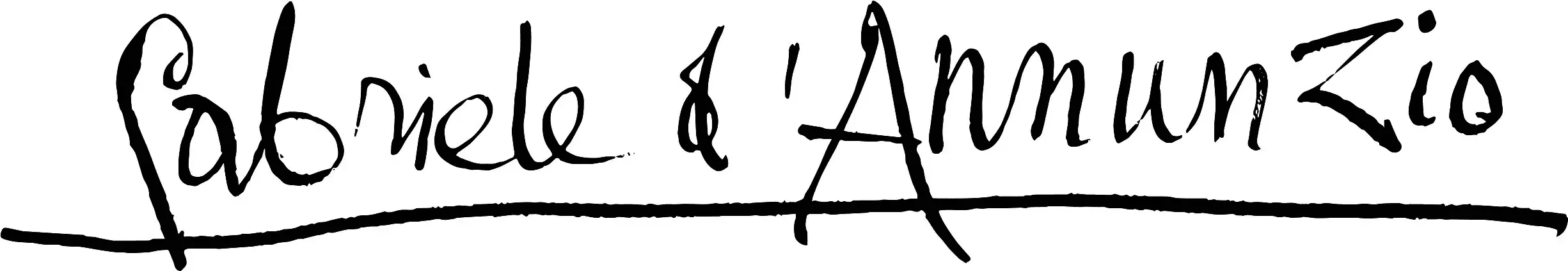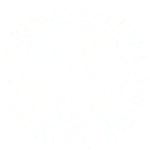Mano
di Nicola Di Nino, Enciclopedia dannunziana
Nelle pagine memorialistiche del Libro segreto, d’Annunzio scrive di sé:
Nato, educato, esercitato a osservare tutto, senza un solo attimo di tregua, io colgo sùbito – in qualunque uomo in qualunque donna ch’io veda per la prima volta – il gesto maniaco: direi il ticchio se parlassi di cavalli. I gesti maniaci involontarii incorreggibili rivelano in noi antiche attività antiche consuetudini antichi vizii della nostra specie, della nostra schiatta, della nostra ascendenza. Anch’io ho i miei gesti maniaci, taluni inavvertiti, altri a me noti come mi si rappresentano nel farli, non senza un moto di corruccio o d’avversione quasi io fossi abitato da un estraneo indomito.
Il paragrafo, pubblicato nel 1935, testimonia il perdurare dell’interesse dell’autore per la mano e il gesto nato negli anni Ottanta quando scopre le teorie fisiognomiche di Leonardo. Con il Vinci, d’Annunzio condivide l’idea che la forma, il colore e i movimenti della mano siano espressione dell’animo e, un attento studio, permetterebbe la comprensione del carattere di un individuo.
Prose di romanzi
Un primo esempio, e precisiamo che ci soffermeremo solo sulle opere principali senza dimenticare di dire che il tema è molto vasto, è nel Piacere quando Andrea Sperelli, per capire l’atteggiamento distaccato di Maria Ferres, decide di disegnare la sua mano. Il modello leonardesco non è ancora esplicito, però l’esercizio diventa un vero e proprio studio della personalità, come la donna avverte:
Mi pareva di non offrire alla sua indagine una mano nuda, sì bene una parte nuda dell’anima; e ch’egli me la penetrasse con lo sguardo sino al fondo, scoprendone tutti i più riposti segreti. Non mai io aveva avuto della mia mano un tal sentimento; non mai m’era parsa così viva, così espressiva, così intimamente legata al mio cuore, così dipendente dalla mia interna esistenza, così rivelatrice.
Come Sperelli, tutti i protagonisti maschili dei successivi romanzi guardano con attenzione le mani delle compagne. Nell’Innocente (1892), la «mano bianca e fedele, che portava l’amore, e l’indulgenza, la pace, il sogno, l’oblio, tutte le cose belle e tutte le cose buone», rivela a Tullio l’animo caritatevole della moglie Giuliana. Una bontà che impedisce alla donna di esprimere a parole il disagio nei confronti dell’adultero marito e lo comunica, al contrario, con il torcersi delle mani, una manifestazione di sconforto e dolore ripetuto con lo stesso significato da Massimilla nelle Vergini delle rocce, da Candia nella Figlia di Iorio e da Maria in Più che l’amore.
Tullio, invece, esprime l’incapacità di relazionarsi con il gesto di stringersi «la testa fra le palme» e cerca di avviare il dialogo con la moglie sempre con un contatto fisico (come aveva fatto Sperelli con Elena Muti) che dimostra la sua esigenza di avere un sostegno fisico e mentale. Significativo è il ruolo svolto dalla madre, le cui «care mani» che sorreggono Tullio ricordano quelle di Luisa d’Annunzio, una presenza costante nell’intera opera che il poeta evoca per i suoi gesti taumaturgici e caritatevoli e per la sua purezza espressa con la descrizione del cavo della sua mano, un’immagine presa dalla Bibbia dove il palmo rivolto al cielo indica la predisposizione dell’animo all’accoglimento del divino. Quest’immagine, su cui ritorneremo a lungo, è nell’Innocente quando Tullio bacia il cavo delle mani di Giuliana in cerca del perdono e della purificazione dalla sua infedeltà.
Sono sufficienti questi pochi esempi per dimostrare come d’Annunzio crei nel tempo un repertorio di gesti e d’immagini della mano cui attingere durante la sua scrittura.
Sempre nell’Innocente, lo scrittore assegna un importante ruolo al contadino Giovanni di Scòrdio. Tullio è affascinato dalle sue sue mani che portano i segni di un lavoro nobilitante e sacro nella sua ritualità:
Le sue mani ossute, asciutte, brune, che parevano fuse in un bronzo animato, non si fermavano mai, non conoscevano forse la stanchezza. Un giorno esclamai: – Ma quando si riposeranno le tue mani? L’uomo probo se le guardò, sorridendo; ne considerò il dorso e il cavo, rivolgendole prone e poi supine al sole. Quello sguardo, quel sorriso, quel sole, quel gesto conferivano a quelle grosse mani incallite una nobiltà sovrana. Incallite su gli strumenti dell’agricoltura, santificate dal bene che avevano sparso, dalla vasta opera che avevano fornita, ora quelle mani erano degne di portare la palma. Il vecchio le incrociò sul suo petto, secondo l’uso mortuario cristiano; e rispose, pur sempre sorridendo: – Fra poco, signore, se Dio vorrà. Quando me le metteranno così, nella cassa. Così sia.
La figura del contadino, un topos della letteratura europea del tempo e che d’Annunzio aveva ripreso pure da Nietzsche e dal socialismo di Morris, diventa ricorrente nell’opera in quanto con i marinai, secondo il poeta, saranno responsabili della rinascita dell’Italia. Il gesto sicuro del contadino torna nell’Ode a Garibaldi in Elettra, dove l’eroe è descritto mentre compie il movimento di spargere la semenza da cui, metaforicamente, germoglierà la nuova nazione, e poi nella Canzone d’oltremare e quella a Umberto Cagni in Merope sempre per elogiare gli eroi nazionali.
Lo studio di personaggi dalla psiche turbata continua nel Trionfo della morte (1894) dove l’omicida-suicida Giorgio Aurispa tiene lontano i caratteri maschili sani descrivendone negativamente la mano (ad es. quella del padre è «gonfia, quasi mostruosa, dai pori visibilissimi, singolarmente pallida a contrasto della faccia sanguigna»), un motivo comparso nel Piacere, quando Andrea descrive disgustato le mani del marito di Maria, e che ritorna nell’opera soprattutto nella variante dell’unghia simile ad un artiglio ferino come quello di Elena di Sparta in Maia.
Ippolita, la compagna di Giorgio minata dall’epilessia, cerca sempre il contatto con l’uomo compiendo movimenti ormai topici come quello di affondare la mano nei capelli dell’amato, un gesto sensuale e voluttoso. E quando nella mente contorta di Giorgio questa sensazione di piacere si trasforma in odio per Ippolita, considerata una Nemica perché capace di controllare i suoi sentimenti e di sottometterlo, la prima vendetta che medita è proprio per le mani della donna che simula di recidere durante la loro ultima cena. La macabra immagine della donna dalle mani mozze, già in Villa Chigi VI delle Elegie romane e ne Le mani del Poema paradisiaco, è centrale nel dramma La Gioconda, come diremo.
Con le Vergini delle rocce (1895), il modello leonardesco è esplicito non solo nel titolo, evocativo del quadro del Louvre, e nelle citazioni poste ad esergo di ogni libro, ma soprattutto nell’unione delle teorie fisiognomiche di Leonardo con quelle simboliste. Andrea Cantelmo è un vero e proprio chiromante come la vergine Anatolia rileva, «Ma perché voi guardate con tanta assiduità le nostre mani? Siete un chiromante, forse?». L’uomo, in effetti, cerca di superare il silenzio e il mistero che avvolge le giovani con lo studio delle loro mani. Un modo per andare oltre l’apparenza e la natura delle cose, come Leonardo aveva indicato e Pater, Séailles e Conti avevano ripreso a fine Ottocento nei loro studi sul Vinci e il Rinascimento. Una teoria che ben si collega alle idee simboliste che invitano le arti ad esplorare le zone d’ombra superando il reale.
Nel romanzo-poema, d’Annunzio non offre alcuna descrizione fisica delle donne e il lettore è costretto ad affidarsi allo sguardo di Cantelmo e alle sue reazioni per conoscere il loro carattere: «Io seppi comprendere le cose ineffabili che diceva il sangue eloquente nelle vene delle loro belle mani ignude». Studiando le mani, l’uomo prova a scegliere la vergine con la quale unirsi per dar vita al futuro re di Roma e realizzare il suo progetto superomistico.
Quelle intrecciate di Massimilla, una postura ripresa dal Trattato della pittura di Leonardo, comunicano la sua castità: «Silenziosamente, seduta sul sedile di pietra, con le dita delle mani insieme tessute, tenendovi dentro il ginocchio stanco»; quelle di Anatolia rivelano la sua completa devozione alla cura dei famigliari: «Le mie mani sanno avvolgere la benda intorno alle piaghe e strapparla di su le palpebre oppresse. Quando io le tendo, il più puro sangue del mio cuore affluisce all’estremità delle mie dita magneticamente»; mentre Violante comunica in una posa, ispirata dai ritratti preraffaelliti, tutta la sua bellezza: «Poggiato il gomito sul ginocchio, ella si reggeva il mento con la palma; e tutta la sua figura nell’attitudine semplice mi offriva quella successione di mute cadenze in cui è il segreto dell’arte suprema». Alle mani delle tre sorelle si contrappongono quelle «pallide nervose e inquiete» dei fratelli Antonello e Oddo e quelle del principe Luzio che, invece, «non avevano sofferto alcuna ingiuria dalla malattia e dalla vecchiezza, non mostravano alcuna deformazione senile. S’erano conservate belle e pure». Una giustapposizione che è alla base di un altro topos che d’Annunzio aveva creato nel Piacere. La completa guarigione fisica e mentale si manifesta per prima sulle mani, come notano Sperelli dopo essere stato ferito a duello, Paolo Tarsis nel Forse che sì forse che no e Lucio Settala nella Gioconda dopo un tentativo di suicidio.
Nelle ultime prose, l’interesse del protagonista per le mani continua ad essere centrale come si legge nel Fuoco (1898) nella presentazione che Foscarina fa a Donatella di Stelio: «È sensibilissimo alla bellezza delle mani. Le guarda sempre, quando incontra una donna».
A differenza dei nevrotici personaggi precedenti, Stelio ha i tratti del superuomo e il suo vitalismo è nella mano «così delicata e così nobile, che pur con un dono o con una carezza poteva farle tanto male», dice Foscarina. Con un semplice tocco Stelio è capace di mutare l’animo dell’amante, «Levò una mano, le sfiorò i capelli, la gota, il mento. Come se quella mano le schiantasse il cuore, ella ruppe in singhiozzi. Singhiozzò singhiozzò, là, sopra il petto di lui, senza morirvi», e quando la donna decide di lasciarlo per una differenza d’età che considera insuperabile, Stelio ricorre all’atto topico di affondare la mano nei capelli di Foscarina, un gesto che riaccende di passione l’amante: «insinuò le sue mani sensuali nelle ciocche folte. Ella chiuse gli occhi, presa dal gelo, dominata dal terribile potere; fu di lui come una cosa che si tiene nel pugno, come un anello in un dito, come un guanto, come una veste, come una parola che può esser detta o taciuta, un vino che può esser bevuto o versato a terra».
La mano di Stelio ha un potere così forte sulla donna che quando l’uomo si sofferma a carezzare i cani di Lady Myrtha, Foscarina trasferisce su di sé il contatto fisico: «Il giovine aveva preso tra le sue mani la testa di Ali-Nour, ma ella sentiva il tocco di quelle mani su le sue proprie tempie. Il giovine indagava le pupille di Ali-Nour, ma ella sentiva lo sguardo di lui nel fondo della sua propria anima. E le parve che la lode degli occhi andasse ai suoi propri occhi». Foscarina reagisce tremando, una reazione fisica che per d’Annunzio indica quasi sempre un mutamento d’animo. E, difatti, l’arrovellarsi del pensiero si risolve in gelosia con Foscarina che crede Stelio ami Donatella. L’uomo s’accorge del turbamento dell’amante sentendo le sue mani gelide e, nel tentativo di riaccedere la passione, la conduce in una fornace dove le «mani pieghevoli mobili prudenti […] forme espressive di destrezza e di esattezza» dei maestri vetrai creano e donano un calice a Foscarina che spezza quando la gelosia torna a dominarla.
Di fronte a questo mutevole stato d’animo Stelio, come Sperelli e Cantelmo, ricorre alla chiromanzia per tentare di decifrare il carattere della compagna:
Mirava attonito nel dorso di quella mano nuda le delicate vene violacee, palesi come se la pelle non le ricoprisse, e le unghie esigue che brillavano intorno allo stelo del calice. Pensava a una stilla di quel sangue circolante per quella sostanza limitata dai contorni comuni e pure immensurabile come l’Universo […]. Provò una smania ansiosa di arrestare la donna, di mettersi incontro a lei, di considerarla intentamente, di scoprirne tutti gli aspetti, di interrogarla senza fine.
Le mani tornano protagoniste alla fine del romanzo; quando Foscarina decide di recitare per Stelio, l’uomo è così emozionato che afferra e martoria le mani della donna: «Egli le prese le mani; e, senza accorgersene, le tormentava. Ella non sentiva il dolore. Entrambi erano intenti alle scintille che si generavano dalle loro forze commiste. Una medesima vibrazione elettrica correva per i loro nervi meravigliosi». S’intuisce come questa reazione di Stelio sia un ultimo tentativo di trattenere la donna a sé e di plasmarla in un’attrice perfetta, ma questo desiderio è arrestato dall’addio di Foscarina.
Dopo la lunga stagione delle Laudi, su cui diremo, d’Annunzio torna al romanzo nel 1910 con il Forse che sì forse che no nel quale l’indagine delle turbe psichiche si complica con lo studio delle relazioni incestuose tra fratelli, tema già toccato in un racconto del Libro delle vergini e nei drammi La città morta, La figlia di Iorio e Fedra.
Ancora una volta sono le mani e i gesti a rivelare le fobie e i turpi legami, e bastano gli ambigui gesti di un banale episodio ad insinuare nel lettore il dubbio che tra i fratelli corra qualcosa di più che il semplice legame di sangue. L’irruenza di un bacio di Paolo causa che Isabella sanguini da un labbro e all’offerta di Vana di un fazzoletto, l’uomo ha una reazione insolita alla vista della mano della sorella:
Paolo vide nel fascio di luce il risalto del bianco, intenso come smalto, su la stretta faccia olivastra; vide quella mano tesa. E nella faccia e nella mano era tanta forza d’espressione e d’illuminazione, ch’elle parevano sorpassare la realtà e intagliarsi nel cielo stesso del fato, come quando il crinale delle Dolomiti solo arde nei crepuscoli inciso contro tutta l’ombra e ciascuno dei suoi rilievi s’addentra nell’anima di chi mira e vi s’eterna.
Poco dopo, quando Isabella è punta da un ape, Aldo la soccorre succhiandole il dito: un gesto apparentemente goliardico del fratello ma che allude ad un’intimità tra i due, un particolare che sembra trovare conferma nel successivo elogio delle mani: dopo un parallelismo con quelle belle e profumate di Isabella d’Este, i fratelli sono in visita al castello estense di Ferrara, Aldo celebra le mani di «perfetto marmo» della sorella.
Quando i legami incestuosi si scoprono, all’inevitabile distruzione della famiglia Inghirami resiste il solo Paolo la cui rinascita è rappresentata dall’impresa di salvarsi atterrando, con l’aereo in avaria, su un lido sardo. Il recupero fisico e morale di Paolo è costruito da d’Annunzio attingendo al tema della mano.
La celebrazione di quelle di Iacopo Caracci, l’artista che sta preparando una statua celebrativa di Giulio Cambiaso (un amico di Paolo morto in un incidente di volo), si spiega con un episodio che parrebbe insignificante: lasciando la fonderia Paolo si scotta raccogliendo un residuo di metallo e, quando gli viene donato, si accorge che ha forma di una mano. Questo momento assume una forte carica simbolica in quanto sembra trasferire il potere creatore della mano dell’artefice-scultore a quella di Paolo che resta infatti salda e impavida durante l’avaria in volo. Ci pare, poi, di trovare un segno del cambiamento morale di Paolo nel gesto caritatevole verso una mendicante, «Una donna quasi cenciosa passò, e lo guardò con due occhi di febbre, pieni d’infinita miseria. Gli tese la mano cava, senza dimanda. Prese l’elemosina senza grazie; e scomparve nell’ombra trascinandosi come se avesse le reni spezzate». Mostrare la cavità del palmo è per d’Annunzio, come detto, un momento spirituale nel quale la persona è pronta ad accogliere l’altro. E Paolo Tarsis, riempiendo il vuoto, inizia un percorso di redenzione, «prova» la chiama d’Annunzio, come quella compiuta nel deserto dell’apostolo di Tarso al quale il nome del protagonista è chiaramente ispirato. Infine, come con Sperelli, la conferma dell’avvenuta guarigione è nell’aspetto delle mani sulle quali d’Annunzio si sofferma con insistenza negli ultimi paragrafi del romanzo: «le sue mani, che nel lavoro avevano conservata la loro nuova bianchezza e ch’egli aveva lasciate ignude, gli parevano anch’esse una forma della vita ideale».
Poesie
Al pari della prosa, anche nella poesia il tema è centrale. Le Elegie romane, ad esempio, cominciano a Villa Medici, dove si era consumato l’addio tra Andrea e Maria nel Piacere, e nei versi «Tutta nel cor segreto io sentiami languire e tremare / l’anima, al premer lieve de la diletta mano. // Ma, come fummo al sommo, la bocca ansante m’offerse / ella: feriva il sole quel pallor suo di neve», modellati su Shelley come ha segnalato Bertazzoli, compaiono tre immagini del romanzo d’esordio: il tremore del protagonista provocato dal tocco dell’amante e il candore niveo della pelle di questa che spesso d’Annunzio paragona al giglio per sottolinearne la purezza d’animo.
Nella raccolta, il poeta descrive la compagna Barbara Leoni con tratti stilnovistici, avviando una ripresa della figura di Beatrice che diventa più esplicita negli anni complice il modello preraffaellita: «ella in salir per l’erbe vestigia stellanti lasciasse, / gemmee spandesse ai mirti da le sue man rugiade». La donna è la regina della natura: al suo tocco la rugiada si trasforma in gemme preziose, un simbolismo magico che è anche di Isaotta nell’Isottèo capace di creare «schietti rubini» versando l’acqua da un giglio ricolmo (la Ballata delle donne sul fiume). Un prodigio che, sempre seguendo lo stilnovo, assegna un significato salvifico al gesto di Barbara: «Entro le man sue reca più luce che non l’Ora prima; / fatta ella tutta quanta è di sovrane cose». La donna, essendo d’origine divina «fatta di sovrane cose», è capace di irradiare dalle sue mani una luce più luminosa di quella dell’Ave Maria, la prima ora canonica. Quest’immagine è reiterata nei versi di Nel bosco e con essa, come nel Piacere, il poeta collega il gesto e il biancore ad un contesto di purezza mistico-sacrale di cui la donna è emblema e tramite.
Nell’Isottèo, la quarta ballata della corona Isaotta nel bosco, è dedicata alle mani della donna. Il «pugno», nel quale Isaotta stringe i freni mentre cavalca, una volta aperto mostra al poeta tutto il suo candore e la sua purezza. Il paragone delle mani di Isaotta con le «ostie in sacramento» da un lato riprende quello che nelle Elegie accostava il candore di Barbara ad una luce “sovrana” e dall’altro lo amplia: le mani «bianche e pure» della donna hanno un potere curativo (una funzione simile è in Athenais medica nella Chimera: «voi che le mani tenere ed aulenti / posaste ne le mie piaghe inasprite» e il paragone con le ostie nei versi di Le mani del Poema paradisiaco).
Questo esempio è utile per dimostrare la consueta rimeditazione di d’Annunzio di tanti modelli: Bertazzoli ricorda la Tentation de Saint Antoine di Flaubert, «Et ses mains plus blanches que le hosties», e La Mort amoreuse di Gautier, «ses belles mains, plus pures, plus diaphanes que des hosties»; cui aggiungiamo la Sagesse di Verlaine, «Les chères mains qui furent les miennes, / toutes petites, toutes belles, / […] royales mieux qu’au temps des princes, / les chères mains m’ouvrent les rêves». Senza dimenticare che il candore della mano è un motivo letterario già in Petrarca e il paragone col giglio arriva a d’Annunzio per tramite biblico e dai preraffaelliti che avevano fatto del fiore un simbolo della loro arte.
Nella Chimera (1890), la raccolta che riunisce i componimenti esclusi dalla riscrittura dell’Isaotta Guttadàuro nell’Isottéo, meritano un cenno i tre sonetti scritti per le nozze della sorella Elvira. Nonostante il tema sia d’occasione, nei versi i gesti rinviano ad contesto scritturale: il poeta è l’arcangelo Gabriele che porge alla sorella un augurio evangelico e i riferimenti alle mani del poeta e di Elvira hanno una connotazione sacra. Quelle di Gabriele sono oranti: «tese le mani come quando / ne la serena puerizia orava, / io dolcemente – Ave, sorella – dico» (un eco del gesto compiuto da Sperelli quando vede Maria per la prima volta). Mentre le mani della sorella consolano il pianto della madre, «per quante volte a la soave nostra / madre ella terse con man leniente / le lacrime ch’io feci a lei versare». Poi, nella seconda strofe dell’ultimo sonetto, il poeta esalta il significato caritatevole dei gesti di Elvira recuperando la funzione curativa assegnata alla mano femminile che abbiamo segnalato nell’Isottèo: «Io muto dietro a te le braccia tendo, / o mia sorella, o mia sorella buona; la man ben usa al gesto che perdona, / la cara man che mi sanava io prendo». Ci preme rimarcare che d’Annunzio assegna questo potere taumaturgico solo alle mani femminili e quasi esclusivamente alla madre, alla sorella e alla figlia Renata, la Sirenetta del Notturno.
Nel Poema paradisiaco (1893), ultima silloge prima del ciclo laudistico, i riferimenti alla mano s’infittiscono. Ne Il buon messaggio la domanda alla sorella, «E tu hai dunque raccolta // la rugiada nel cavo de la mano?», contiene una prima spiegazione del significato attribuito dal poeta al palmo. Se nell’Isottèo e nella Chimera l’immagine era descrittiva, adesso acquista valore simbolico grazie alla «rugiada», pura e cristallina come l’acqua bevuta dai mistici e dagli asceti nelle sorgenti montane (immagine al centro del Primo centenario della nascita di Vittore Hugo in Elettra). Il cavo della mano rappresenta dunque purità e questo significato è chiarito alla fine della lirica quando il poeta stesso spera di aver una mano pura come quella della sorella: «Oh al fine io tocchi l’albero e l’arbusto / con mani monde».
Nella lirica, il pensiero del poeta torna di nuovo alla madre, triste per l’assenza del figlio. La donna è rinfrancata, come nei versi della Chimera dedicati al matrimonio di Elvira, dall’affetto della figlia: «Non pianga. Tornerà quel suo figliuolo / a la sua casa». Poi, dopo aver ricordato nel Nuovo messaggio che le mani materne sono «più pure delle rose / nuove», nell’Hortulus Animae il riferimento al cavo della mano della madre crea un’unione con la figlia nel segno della purità.
Giungiamo ai versi di Le mani, vero e proprio manifesto del tema, nei quali il poeta richiama alla mente: «Le mani de le donne che incontrammo / una volta, e nel sogno, e ne la vita: / oh quelle mani, Anima, quelle dita / che stringemmo una volta, che sfiorammo / con le labbra, e nel sogno, e ne la vita!».
Alla strofe segue un vero e proprio catalogo, nel quale ogni mano è simbolo di una particolare emozione provata dal poeta: da quelle «fredde come cose / morte» a quelle «tepide / come le rose», altre profumate da «una fragranza / così tenace» da lasciare «per una intera / notte nel cuor […] la primavera» o arse da un «fuoco estremo» ancora desiderato dal poeta: «ove sei, piccola mano, / intangibile omai, che troppo piano / strinsi?» (versi in cui si sentono gli echi dal Macbeth di Shakespeare, da Par les champs et par les grèves di Flaubert, La fille aux mains coupées di Quillard e dal Serres chaudes di Maeterlinck).
Alla memoria tornano poi le sensazioni estreme di Eros, «Da altre venne il desìo, quel violento / fulmineo desìo che ci percote / come una sferza; e imaginammo ignote / lussurie in un’alcova, un morir lento: / – per quella bocca aver le vene vuote!», e di Thanatos:
Altre (o le stesse?) furono omicide:
meravigliose nel tramar l’inganno,
Tutti gli odor d’Arabia non potranno
addolcirle. – Bellissime ed infide,
quanti per voi baciare periranno! –
Altre (o le stesse?), mani alabastrine,
ma più possenti di qualunque spira,
ci diedero un furor geloso, un’ira
folle; e pensammo di mozzarle al file.
(Nel sogno sta la mutilata, e attira.
Nel sogno immobilmente eretta vive,
l’atroce donna da le mani mozze.
E innanzi a lei rosseggiano due pozze
di sangue, e le mani entro ancóra vive
sonvi, neppure d’una stilla sozze.)
La visione allo stesso tempo macabra ed erotica, s’interrompe con la comparsa delle «mani di Maria» caste e pure «come le ostie sante», un’altra autocitazione dall’Isottèo e dal Piacere (in uno dei sonetti scritti da Sperelli si legge: «Alta, in sommo del cerchio, un’assai bianca / donna, con atto di comunicare, tien fra le pure dita l’Ostia santa»).
Il catalogo termina con un riferimento alle mani «quasi virili» che, dopo aver fugato nel poeta «ogni paura» e «ogni passione oscura», lo indirizzano verso «la Gloria» illuminando «l’opera futura». Il lessico e la distinzione dei sentimenti del “bene” e del “male” nell’ultima strofa rinviano a quelle teorie superomistiche al centro delle coeve Vergini delle rocce.
Nell’Hortulus Animae, il desiderio di “rifiorire” è in Consolazione dove ricompare la figura materna. Il poeta vuol ritornare da lei, «metterò ne la tua pura mano / tutto il mio cuore», per recuperare una «vita semplice e profonda». Questa è offerta dalla madre che, come una sacerdotessa, aiuta a purificare il figlio: «La lieve ostia che monda / io la riceverò da le tue dita», una ripresa del simbolo di purezza e castità già usato in Le mani. E, creando una significativa circolarità con Il buon messaggio, dopo la sorella anche la madre riceve l’acqua nel palmo: «Tutto sarà come al tempo lontano. / L’anima sarà semplice com’era; / e a te verrà, quando vorrai, leggera / come vien l’acqua al cavo de la mano». La memoria di questi versi riemerge nel Notturno, una conferma della creazione di un repertorio mentale d’immagini topiche cui d’Annunzio attinge per la sua scrittura: «ti ricordi tu di quel verso che ti fece sorridere e piangere? Come vien l’acqua al cavo della mano. Non sono io sempre per te l’acqua che viene al cavo della tua mano? Sempre raccogli la mia innocenza immacolata».
Il ciclo delle Laudi
La mano e il gesto scandiscono anche i versi del ciclo delle Laudi. Il primo e lungo poema della Laus vitae (1903) è tutto costruito sulla giustapposizione tra gesti positivi e negativi: a quelli eroici di Ulisse e degli scultori greci («coloro / che animavan l’umida argilla / col pollice nudo») si contrappongono gli artigli di Elena di Sparta e le abiette mani degli abitanti di Patre, una città povera, le «man tese di mendicanti», profana, «i preti / scaltri, / […] sorridean d’un perfido riso / pettinando con l’unghie / ricurve le luride barbe», e corrotta: «Correa per ladre / mani pecunia dolosa».
Nel poema, d’Annunzio arricchisce il motivo di un nuovo elemento: alla vista s’accompagna il tatto che stabilisce un legame più stretto con l’opera e il suo artefice: la statua di Evia è così perfetta da spingere gli uomini a toccarla: «ed era sì bella / che per toccarla scendemmo / tra gli scogli ardui del lido / perdendo il cammino». L’effetto dell’unione dei sensi è complicato quando il poeta ricorda d’aver trovato una selce a forma di mano sulla spiaggia di Maratona.
Il tastare la roccia rievoca la battaglia e, in particolare, l’eroismo di Cinegìro, il fratello di Eschilo, che ebbe la mano mozzata durante un assalto ad una nave persiana. I versi sono paradigmatici della lettura analogica del reale suggerita dalla poetica simbolista e dal pensiero di Leonardo che invitava a proseguire la natura: il poeta non si limita all’osservazione della forma della selce ma tastandola la trasforma nella mano di Cinegìro dando vita ad un procedimento simbolico che gli permette di rievocare le gesta di un altro greco esemplare per il suo eroismo.
Anche in Elettra (1904), l’elogio dei modelli letterari e politici passa per il loro gesto esemplare.
Nei versi A Dante, d’Annunzio ricorre ad una delle immagini più ricche di significato, quella del palmo. Il fiorentino è descritto nel momento in cui riceve nel «cavo delle mani / i messaggi delle divine speranze, i poteri sconosciuti delle verità divine». Un modo per indicare la purezza d’animo del poeta. Se questo significato era già stato spiegato nel Poema paradisiaco, nella lirica sul Primo centenario della nascita di Vittore Hugo d’Annunzio compie un nuovo paragone. Descrivendo il francese mentre beve «dal cavo della mano», chiarisce che il gesto è quello dei «profeti» confermando la derivazione biblico-simbolica dell’immagine (Giudici, Isaia, Ezechiele): solo i puri d’animo possono accogliere tra le loro mani il messaggio sacro e/o un nuovo linguaggio poetico, come Dante e Hugo.
L’elogio del toscano continua nel ricordare com’egli, di fronte all’inettitudine di «pontefici e imperatori», fu l’unico capace di alzar le mani «verso le porte dei cieli» e di attendere «un segno». Nonostante nulla apparve «fuor che la morte», il poeta mantenne la sua ferma posizione stringendo il «pugno vivo» (nella stessa postura è descritto nel poema Per la morte di Giuseppe Verdi: «Dante Alighieri che sorresse il mondo / in suo pugno»). Un esempio di caparbietà di fronte all’intera nazione che Dante, con la sua «rampogna», «rifece sacra» e con la sua preghiera «fece risplendere di purità le sue membra schiave». E non di ‘purezza’ come il fedele Tommaseo-Bellini precisa: «la purità è tra le virtù del cristiano, non già la purezza», e la preferenza per questo termine si spiega anche con il riferimento al cavo della mano, realizzato per risaltare la purità d’animo del cristiano Dante.
Alla rievocazione letteraria segue quella politica e lo spunto è offerto dal drammatico episodio dell’uccisione di Umberto I. Per d’Annunzio l’improvvisa chiamata al trono del Re giovane, il prossimo Vittorio Emanuele III, che si trovava a navigare nell’Egeo e dovette rientrare di fretta in patria, sembra un segno del destino: le sorti del paese erano ancora una volta nelle mani di chi veniva dal mare, un tema già nelle Odi navali e in Maia.
Come in Dante, la mano del futuro sovrano è descritta positivamente, «le tue mani sien pronte / alle lotte e all’opre», e il poeta spera che il nuovo re possa ripulire l’Italia corrotta dalle impure mani «dei vegli scaltri», ovvero dell’attuale classe politica.
D’Annunzio, con versi che prendono a modello l’invettiva dantesca e paragonano l’Italia all’innocente Susanna concupita dai due vecchioni, si augura che l’ambizione del re sia commisurata all’importanza del ruolo ricevuto e lo sprona alla missione con una domanda retorica che affida al movimento del braccio un significato simbolico di potere e guida: «È largo quanto il tuo orgoglio / il gesto della tua mano?».
Il libro della rinascita eroica dedica A uno dei mille e La notte di Caprera a Garibaldi. La decisione del militare di dar avvio all’azione è rievocata con un gesto del contadino, identico a quello di Giovanni di Scòrdio nell’Innocente: l’eroe ha deciso di prendere il sacco e di spargere la semente in esso contenuta, ossia è pronto a guidare i suoi soldati sul campo di battaglia.
Il ritmico gesto è ripreso alla fine della strofe, «“Guardiamo innanzi, all’alba che verrà!” / Chino la fronte, le sue semente ei sparte, / faville d’oro dall’una all’altra mano. / “Ciò che compimmo altri lo canterà”», ritorna a missione compiuta, «Nel sacco rude la sua mano s’affonda / e inerte sta, immemore dell’opra», ed è usato un’ultima volta quando Garibaldi s’arresta di fronte a Roma: «Ed ecco ei tende la mano, come chi / promette, ei tende la mano che spartiva / le sue semente con la saggezza antica, / la man che già seminò, che al mattino / seminerà là dove fu il granito».
Crediamo che d’Annunzio insista sul gesto per trasformarlo in un rito del quale Garibaldi è il sacerdote laico. Come detto, il movimento era nel Trionfo e nella Chimera assunse un significato rituale: «con un largo gesto delle braccia, / spargon li adulti la semenza / […] // nel gesto / hanno una maestà sacerdotale» (I seminatori). Ma se nella raccolta del ’90 d’Annunzio paragona il movimento ritmico della semina ad un gesto liturgico, in Elettra l’atto diventa proprio di Garibaldi e si arrichisce di un nuovo significato simbolico: il militare è l’unico capace di infondere nella gioventù italiana i valori dell’identità nazionale su cui fondare il nuovo stato.
I versi Per la morte di un capolavoro, sono un omaggio a Leonardo ma soprattutto contengono la prova del ruolo avuto dal Vinci per lo sviluppo del tema della mano.
Il primo sguardo su Cristo ritratto nell’Ultima cena, rievoca alla mente le parole evangeliche: «“In verità vi dico: quegli che bagna / la mano insieme a me nel piatto, / quegli mi tradirà.” E la man nell’atto / non tremava sopra la mensa». La mano ferma del Nazareno comunica serenità ma è anche specchio della sua anima «triste» perché consapevole dell’imminente tradimento.
Alla serie anaforica di domande retoriche «chi lo consolerà?», che dimostrano la partecipazione emotiva del poeta alle sorti di Cristo, segue il ritorno degli occhi di d’Annunzio sulla mano dipinta da Leonardo. Il poeta spiega che «leggendo» il «gesto delle sue mani» ha compreso il vero messaggio dell’affresco: guardando attentamente la postura del Cristo e i suoi occhi chini sul pane, ha saputo cogliere e interpretare, così va inteso il verbo ‘leggere’, tutti i messaggi simbolici che Leonardo ha racchiuso in quel gesto. Gesto che, negli ultimi versi della lirica, diventa un «segno» da ricordare e possibilmente da «imitare»:
Ah, per somigliarti
una volta, per esser degno
del tuo segno, innanzi ch’ei muoia
taluno di noi darà al rogo
l’error che l’ingombra!
E arderà l’anima sua pura in un atto
come in un lampo arde il potere di un cielo.
Questi versi dedicati a Leonardo svelano come l’analisi della sua arte trasformino quello che era un semplice interesse per un dettaglio fisico in un vero e proprio studio. Uno sguardo attento, come suggerivano Leonardo e la poetica simbolista, permetteva di superare la Natura e di caripire i simboli e i significati nascosti dietro l’oggettività del reale.
Già nel 1973, Luti aveva segnalato che l’immagine del cavo della mano è una delle simmetrie su cui si regge l’Alcyone (1904), a conferma che il tema ha un ruolo importante anche nella raccolta lirica più nota di d’Annunzio.
Nel terzo volume delle Laudi le mani, sia quelle umane o di una natura antropomorfizzata, sollecitano i sensi del poeta e contribuiscono al panismo. Nella Sera fiesolana la fusione corpo-natura è fin nell’attacco: il poeta si augura che le sue parole siano «fresche […] / come il fruscío che fan le foglie / del gelso ne la man di chi le coglie», cui segue una serie di sinestesie che coinvolgono tutti i sensi fino all’analogia che descrive i rami più nuovi e più alti dei pini come dei «rosei diti» che «giocano con l’aura che si perde».
Le due liriche successive sono ispirate da due piante rappresentative della campagna italiana: l’ulivo e il grano. Nel primo caso il poeta si augura cha la sacralità dell’albero non sia violata da una «mano impura», mentre la fragile spiga al momento del raccolto sentirà il conforto della «sudata mano» prima del «ferro» che la mieterà. Le due immagini, seppur descrivano le mani come sudice, hanno significato positivo. L’aggettivo ‘impuro’ era stato usato nel Poema paradisiaco per indicare la mano lussuriosa che adesso occorre tenere distante dall’ulivo per preservare i valori simbolici della castità e della purezza francescana rappresentati dalla pianta. Lo stesso discorso vale per la seconda immagine, se è vero che il sudore sporca la mano esso è connotato positivamente dal poeta in quanto rappresenta l’operosità dell’agricoltore elogiata in tutta l’opera dannunziana. E non a caso l’omaggio al «Veglio», già nel Poema paradisiaco, nell’Innocente e in Maia, torna nei versi di L’opere e i giorni e dell’Aedo senza lira, testi che formano un vero e proprio ciclo con i precedenti, come segnalato da Gibellini.
Nei versi del primo componimento, d’Annunzio elogia l’umile lavoratore dei campi e servo fedele di Pan, mentre nell’Aedo senza lira, il veglio è descritto nel gesto di invasare il miele: «Vento asolando, spira / odor di meliloto il miel dall’ombra, / colato nei mondissimi vaselli / ove la man spremette i fiali pregni». Questi quattro componimenti dipingono la semplicità della vita agreste il cui ritmo è scandito dal gesto del contadino. L’uomo, nonostante non abbia una «lira» ossia doti poetiche, è comunque considerato un aedo, pari a quelli greci che d’Annunzio aveva elogiato e tentato di emulare in Maia.
L’ambiente agreste toscano richiama alla mente Dante, già celebrato in Elettra. In Beatitudine, Beatrice compare all’imbrunire come Pan, in un riuscito sincretismo cristiano-pagano. La discesa della donna dal cielo e il gesto compiuto dalle sue mani favorisce la maturazione delle messi: «Ella col lacrimar degli occhi suoi / tocca tutte le spiche / a una a una e cangia lor colore». All’implicito riferimento al gesto della donna (in parallelo a quello del contadino in La spica), segue il ricordo della mano di Dante che stringeva un giglio, simbolo di Firenze ma soprattutto della sua purità d’animo, mentre a capo chino prendeva la via dell’esilio.
Nella descrizione del paesaggio toscano in I tributarii, il poeta usa una delle sue figure più simboliche: la forma concava di una valle è come un palmo, «Le valli son cave / come la man che beve». In Elettra, d’Annunzio aveva spiegato che il gesto di bere dal cavo era proprio dei profeti e dei puri d’animo ed ora, con l’antropomorfismo della valle in un palmo, il poeta assegna la dote della purezza anche alla natura toscana. Un’ipotesi che si rafforza se consideriamo i precedenti riferimenti a San Francesco e a Dante, ricordati con l’ulivo e il giglio, simboli appunto di purità cristiana.
La stretta unione tra natura ed essere umano continua in una seconda immagine dov’è il gesto dell’uomo a contribuire a dar forma e bellezza al paesaggio: «Si fa piú dolce il lungo / dorso del Pratomagno / come se blandimento / d’amica man l’induca a sopor lento». La mano che modella la natura ricorda quella dell’artifex greco in Maia e ritorna in I camelli dove la sabbia della spiaggia pisana è usata dalla «mano sicura» del «figulo» per dar forma ad un «purissimo vaso».
Il palmo della mano è immagine centrale anche nell’Ippocampo nel momento in cui il poeta chiede ad Aretusa di saziare il suo cavallo con «sal lucente». Se finora il cavo era stato simbolo di purità, ora il poeta dà ad esso un nuovo significato. Il gesto di Aretusa può avviare la trasumanazione del cavallo e trasformarlo in una mitica creatura marina: «Egli è forse figliuolo / degli Ippocampi / dalla coda di squamme». Inoltre, il movimento lento della mano placa il cavallo, una memoria poetica del gesto calmo di Diana che porse la sua «man nivea» per chiamare a sé i cervi nella Chimera.
Il palmo è la figura principale anche del madrigale La sabbia del tempo, costruito sul ricordo della rena scorrere nella mano, una metafora del tempo che passa avvicinando la fine della stagione estiva. Molto elegante è la costruzione analogica che unisce il gesto esteriore al sentimento di malinconia: il cavo della mano è analogo al bulbo concavo della clessidra e il fluire del tempo che passa è scandito dal battito del cuore (forse eco di Sur la grève di Henri de Régnier). Malinconia che si trasforma in ansia quando fallisce il tentativo di trattenere il fluire della sabbia e il trascorrere del tempo è inesorabilmente segnato da cupe immagini di secchi steli d’erba che, analoghi agli aghi delle meridiane, generano «ombre» sempre più lunghe.
E, per un’ulteriore conferma dell’importanza del motivo nell’Alcyone, il saluto alla Versilia espresso nel Commiato, l’ultimo componimento della raccolta, è di nuovo costruito sull’immagine del palmo nel quale il poeta spera di sorreggere la terra toscana: «Potess’io sostenerti nella mano, / terra di Luni, come un vaso etrusco!». Se finora il cavo era un vuoto da riempire e simbolo della purità cristiana, nell’Alcyone diventa il simbolo della comunione panica tra poeta e natura.
Teatro
Nel teatro dannunziano, il gesto è ovviamente parte dell’azione scenica anche se in molti drammi la mano continua ad avere un ruolo centrale con il poeta che attinge a tutto il repertorio di immagini che abbiamo finora ricostruito. Per evitare, dunque, di ripeterci presentiamo come esempio il solo dramma della Gioconda (1898) che non solo contiene un nuovo omaggio a Leonardo ma è interamente costruito sul tema qui discusso.
Con le altre protagoniste femminili dei drammi, Silvia Settala condivide l’indole innocente e buona e soprattutto la bellezza delle mani. L’anziano scultore Lorenzo è il primo a lodarle: «Care, care mani, coraggiose e belle, sicure e belle! Sono d’una straordinaria bellezza le vostre mani, Silvia. Se troppe volte il dolore ve le ha congiunte, anche ve le ha sublimate, le ha rese perfette. Sono perfette». Un elogio che si fa quasi sacro quando dice di voler donare all’allievo Lucio, il marito di Silvia, «un pezzo di marmo antico» nel quale scolpirvi gli arti della moglie «come un ex-voto».
Queste parole confermano la completa dedizione di Silvia al compagno al quale, convalescente per un tentativo di suicidio, l’unica cosa che può offrire è il conforto delle sue mani:
ora prenderò nelle mie mani quel dono, quel pezzo di creta dove egli gettò il primo seme del suo sogno come in una zolla feconda; io lo prenderò nelle mie mani, andrò verso di lui sorridendo, portandogli intatta la parte migliore della sua anima e della sua vita; ed io non parlerò, ed egli riconoscerà in me la custode di tutto il suo bene, e mai più egli vorrà partirsi da me, e noi saremo giovini ancora, saremo giovini ancora!.
Rifacendosi alla leggenda folklorica della donna dalle mani mozze, narrata in Italia tra gli altri da Straparola e Basile, d’Annunzio fa patire a Silvia il supplizio di perdere entrambe le mani quando nel tentativo di sorreggere una statua rovesciata, durante un alterco, dall’amante di Lucio, gli arti di Silvia restano schiacciati. Una volta ristabilitasi, la donna è visitata dalla Sirenetta, un personaggio al limite tra il fiabesco e il reale che si era occupata di Beata, la figlia della protagonista. Quando la fata scopre che Silvia nasconde le braccia perché monche, partecipa del dolore della donna tanto da offrirle i suoi arti, «Vorrei darti le mie mani, se non fossero tanto ruvide e scure», ma soprattutto le fa capire l’errore di essersi altruisticamente donata al marito: «Avevo tese le mani troppo violentemente verso un bene che m’era vietato dal destino». Una dedizione che però sembra essere stata compresa da Lucio il quale, nonostante scelse di vivere con l’amante, decise di non riparare la statua crollata e di lasciarla senza braccia. Una scelta che potrebbe far pensare ad un cambiamento della dedicataria dell’opera che diventa Silvia: un gesto con il quale Lucio celebra la bontà della moglie e la consacra all’eternità con un’opera in cui è proprio l’assenza degli arti a sottolineare come la benevolenza di Silvia si manifestasse nei movimenti delle sue mani.
Il personaggio della Sirenetta ritorna molti anni dopo nel Notturno (1916 ma edito nel ’21) nel quale la figlia Renata, accorsa ad assistere il padre, diventa una nuova fata. La ripresa del nome, le descrizioni esotiche della fisionomia della figlia e l’elogio della sua bontà, creano un inaspettato collegamento tra due testi molto distanti per genere e contenuto. Il volume di frammenti è scritto, com’è noto, durante la convalescenza seguita ad un incidente aereo nel quale d’Annunzio perse un occhio. In questi mesi è accudito a Venezia dalle «mani pietose» di Renata-Sirenetta che rievocano l’«infinità pietà» della fata della Gioconda. Inoltre, il tempo trascorso insieme aiuta a ristabilire un genuino rapporto tra padre e figlia allentatosi negli anni e, con il ritorno al presente, il poeta restituisce a Renata i suoi gesti caritatevoli accompagnandola nel sonno: «Fino a oggi ella ha preso cura di me. Ed ora, ecco, io prendo cura di lei» (lo stesso era accaduto nella Gioconda con Silvia che, grazie alla Sirenetta, recupera confidenza e capisce che deve continuare a vivere per amore della figlia).
Prose di ricerca
Il nostro percorso ritorna al Libro segreto che, insieme al Notturno, è l’esempio più noto della prosa memorialistica dell’ultimo d’Annunzio. In esso d’Annunzio rivela come alcuni gesti visti o compiuti nell’infanzia, si siano fissati nella sua memoria e diedero spunto a quelli delle sue opere. Ad esempio, il poeta narra l’episodio in cui il padre rivela alla madre l’adulterio e piange e crolla sulle ginocchia chiedendo di perdono. La reazione della madre, «tese la mano verso di lui a toccargli il capo […] gli asciugò le lacrime» e «lo riaccolse nella sua purità e nella sua misericordia», resta impressa nel giovane d’Annunzio che la rimedita nei suoi romanzi. Il primo gesto, quello che ristabilisce il contatto fisico, diventa fondamentale in ogni coppia di amanti e quando è negato indica la fine della relazione (come quando Barbara non offre il braccio al compagno nelle Elegie romane). Il secondo, quello di perdonare il marito, svelano al giovane poeta le qualità cristiane della “purità” e della “misericordia” della madre che diventa un punto di riferimento e un modello da emulare in tutta l’opera.
Se quest’episodio conferma l’interesse per i gesti, un altro potrebbe testimoniare l’inizio dello studio della forma delle mani. D’Annunzio ricorda che la zia Onufria guardò le sue mani per predire il futuro al nipote. Una lettura chiromantica simile a quella compiuta dagli alter ego del poeta nei romanzi:
mi prese le mani, me le voltò; e si mise ad esaminare i segni nell’una e nell’altra palma, mentre su le sue labbra vedevo disegnarsi parole non proferite. aguzzava ed eludeva la mia smania di sapere. accostandole per il lungo insieme a giumella, non restava di leggerle. prendendo di su l’inginocchiatoio un suo dittico d’avorio, disse: ‘vedi? non sono elle come queste due tavolette? non sono come due pagine che si chiudano insieme? nell’una si compendia a miracolo il Vecchio, nell’altra il Nuovo Testamento.’ iteravo io le dimande quasi in angoscia. ‘vedi? come io leggo in questo dittico d’avorio i decreti sacri, così leggo in questo di ossi le linee della tua vita.’
Con questa lunga esemplificazione abbiamo tentato di dimostrare che la mano e il gesto svolgono un ruolo decisivo in molte opere dannunziane, determinando le relazioni tra personaggi e scandendo l’azione. Il tema, nato dal tessere i fili della memoria personale con quelli di modelli letterari europei, principalmente francesi e inglesi, e con le teorie fisiognomiche di Leonardo, permette a d’Annunzio di andare oltre il simbolismo per investigare le zone d’ombra della psiche dei suoi personaggi. Un interesse che lo rende uno degli iniziatori del romanzo psicologico dal momento che un gesto non è mai fine a se stesso ma rivela il carattere di un individuo, le sue emozioni, passioni e sentimenti. Un incontro con l’interiorità che d’Annunzio ricorda nel Libro segreto quando definisce le proprie mani «le radici della mia anima», un’ennesima testimonianza del costante e attento studio dei propri gesti e di quelli altrui per comprendere meglio se stesso e gli altri.
Bibliografia
Le citazioni dei testi sono dai volumi dell’Edizione Nazionale. Mentre le citazioni dai romanzi, dai drammi e dalle prose di ricerca non inclusi in questa edizione sono da:
G. d’Annunzio, Versi d’amore e gloria, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, 1982, Milano, Meridiani-Mondadori, 2 voll.; Id. Prose di romanzi, ivi, 1998, 2 voll; Id., Prose di ricerca, ivi, 2005, 2 voll.
Isaotta Guttadàuro, a cura di R. Bertazzoli, in Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore, a cura di Pietro Gibellini, Torino, Einaudi, 1995, p. 262
G. Luti, La cenere dei sogni. Studi dannunziani, Pisa, Nistri-Lischi, 1973