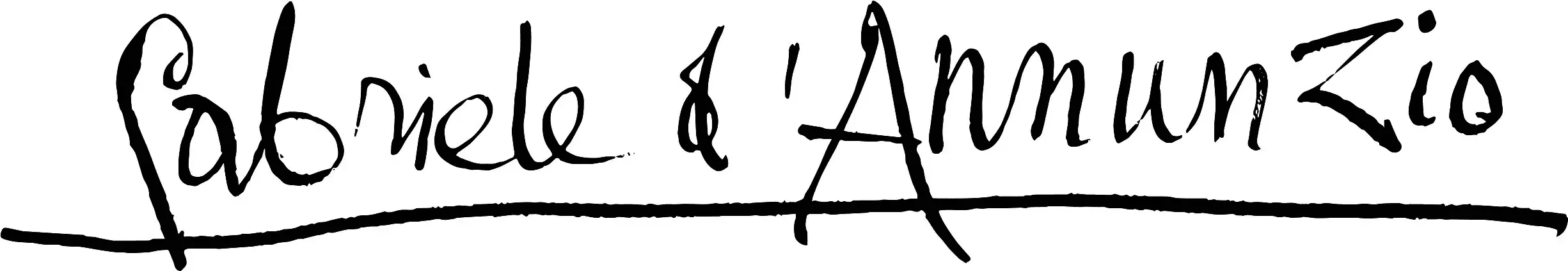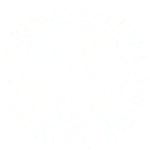Cecchi
di Paolo Leoncini, Enciclopedia dannunziana
L’attraversamento critico di d’Annunzio
Emilio Cecchi compie una ricognizione critica esauriente, puntualmente modulata sui tempi del percorso dannunziano. Il primo nucleo è costituito da Preliminari a una rassegna di poesia (1908), dalla recensione al D’Annunzio di Borgese (1909) e dall’ampio sondaggio vociano su Forse che si’ forse che no (1910), che può dirsi l’incipit di una comprensione interpretativa, ancora informe, dell’opera dell’autore abruzzese. Preliminari… comincia col riconoscimento del «riseccamento del nostro spirito poetico contemporaneo […] dopo le grandi orge liriche del d’Annunzio e la ricca vena del Pascoli». Sem Benelli e Antonio Beltramelli, ma anche Corazzini e Gozzano, sono autori del «vuoto tormentoso», «che sa […] interessare e commuovere, e interessa e commuove, perché, pur vuoto, è». Su questi rilievi, Cecchi costruisce l’ipotesi dell’attesa storica, per ritornare a individuare un discrimine precario tra passato e presente su cui si reggono gli stessi d’Annunzio e Pascoli. Leggiamo:
Se i segreti che talvolta essi [Gozzano, Corazzini] si provano a dirci son fuori di proporzione a questo tormento, e non potrebbero risolverlo mai, noi sappiamo ormai di dove tender l’orecchio, e ascoltar sotto la loro opera e la loro vita, un segreto vero, possente e necessario, che non starà forse ad essi cogliere, ma che, col loro lavoro, essi riescono in qualche modo a circoscrivere, nel disordinato sviluppo del nostro momento storico. Non soddisfatti dei valori immediatamente passati nell’arte e nel pensiero non possono foggiarne di pianta nuovi: perché? Perché son deboli? non serii? disonesti? Tutt’altro; ma perché, per dir così, la storia ancor non vuole. Son troppo artisti per poter non credere alla poesia e viver senza di lei; troppo poco artisti per saperla ridestare, dopo una più profonda elaborazione intima, in una forma che esprima un nuovo equilibrio nativo. Sono spiriti che stanno sul discrimine, pel quale dalla grande arte solare, omerica, tutta sbalzata sulla effettuale realtà delle cose, si passa all’arte scavata tutta nell’anima, e, mentre non posson più sciogliersi in quello che era l’equilibrio di ieri, s’immaginano, più che non veggano, quello che sarà l’equilibrio di domani.
Il vuoto interiore si connette ad un rifiuto storico («la storia ancora non vuole»): la «storia» non è radicata per Cecchi in una dimensione temporale, ma è intesa come passaggio dall’arte classica a quella «scavata tutta nell’anima»: quella a cui giungerà il Notturno dannunziano («Il teatro si trasportava tutto, e si chiudeva, nell’anima. L’anima non riconosceva che le sue visioni più invisibili e segrete»): quasi una prefigurazione di quello che potrà essere il “nuovo” dell’arte novecentesca, di cui – per il Cecchi di Esplorazione d’ombra – il d’Annunzio “notturno” costituisce insieme ai «giovani» e ai «maestri dei giovani», una momentanea, discontinua apparizione. Nell’estasi del d’Annunzio alcyonico, come nell’ascesi del d’Annunzio ‘notturno’, emerge la poesia. Già nei Preliminari Cecchi dice che a d’Annunzio «non bastano le sensazioni», per cui deve «reggersi» su quel «discrimine» che «senza saper varcarlo con passo sicuro», «lo portò […] al diffuso errore di gran parte dei romanzi e di quasi tutto il teatro». Nella scritto del 1909, Cecchi riprende la ‘profezia’ su d’Annunzio sul versante alcyonico della ‘natura’ (prima che la natura diventi nel Notturno la stessa interiorità):
Questa pacificazione oggettiva che la musa veggente e paziente aveva serbato al Carducci come omerico conforto della sua maturità, il poetino biondo […] la viveva ingenuamente nell’amore e nella natura, avendo gettato via […] il formidabile contrappeso di quella coscienza storica, che nel Carducci rappresentava appunto la complessità dello sforzo conquistatore. E uno vedeva «con dolci lacrime» le cavalle selvagge e le mandre bianche […] e l’altro era lui quelle cose, e risaliva a un’alba più segreta e quasi non ancora umana. Egli era il fanciullo che si era sentito cefalo e Centauro e avrebbe vent’anni dopo, nella fioritura suprema del suo genio [Alcyone], cantato sé come Glauco nel sentirsi mare, salsedine, chiaria, fortuna, bonaccia, e come Icaro, nel sentirsi aquila e nuvola; e avrebbe accolto come l’Otre nella sua anima tanti sapori: dell’acqua e del vino, dell’olio e del sangue.
Cecchi rileva uno dei risultati più notevoli del libro di Borgese, «la necessaria incapacità dell’artista a risolversi concretamente attraverso la cultura» perché «risente in sé liberato il poeta primordiale, improvvisamente dinanzi alle pianure latine, in vista ai branchi di cavalle beventi». Nella Laus vitae il critico rintraccerà sempre, sì, la formazione di quei miti che nell’Alcyone vivon d’una vita tutta sonora compatta, senza fenditure: miti non più allegorie. Quello stesso che può sembrare il primo fulcro di essa (la notte olimpia, la preghiera a Zeus, l’imagine dei fanciulli divini nei quali ridono pacificamente le intime contraddizioni) altro non è che la spiegazione immaginosa di ciò che, prima, era stato pura fantasia creatrice, ovvero «il bene di una di quelle aurore che, quando si levano sopra un cuore umano, lo impregnano di luce per sempre. La poesia […] ha cantato: ha cantato Alcyone! Verso quel bene, ormai, egli guarderà sempre […] È una crisi orientata; non più deforme come le precedenti, che si dibattevano nel vuoto e si appoggiavano a soluzioni insensate». Il bene di quelle aurore, la luce che impregna la poesia, richiamano le «emozioni profonde e elementari», inflesse e modulate, «senza toccarle», del Notturno, la cui matrice sarà nell’«infinito dolore», nella «sventura» che scoprirà la «profondità dentro se stesso»: per cui l’interiorità – dicevamo — diventa Natura. L’aurora, la luce o l’ «infinito dolore», la «sventura», sono eventi autentici, profondi, ugualmente catartici.
Nell’articolo vociano del 1910 sul Forse che sì forse che no, le cui «grandi» pagine «appartengono appunto al mondo più volatile e inafferrabile di Gabriele d’Annunzio», «la forza di questo poeta sa tracciare un fermo limite al proprio giuoco […] nelle espressioni di stati di semplicità assoluta, nell’affermazione di atti di vita elementare». Il «sensualismo» delle Laudi viene ripreso, nel Cecchi di Preliminari, nel romanzo, come «un viluppo di cose vive, una luce solare materiata, un’allegria di vento trasfusasi […] in ritmi di ilarità prodigiosa». L’analisi critica sul romanzo è discontinua e inframezzata da richiami alla lirica, in cui, come nei quadri di Segantini:
Era un dolore largo, oscuro, simile al cieco dolore della natura quello che […] questi spiriti primitivi sentivano calare sulla loro limpidità. Fuso nelle colorazioni di un paese, armonizzato di luci e di velature, onnipresente, e dappertutto dissimulato, nei quadri del Segantini esso ci conquista potentemente con la sua verginità schiva di atteggiamenti […]. In certe liriche del d’Annunzio la fusione si può dire ugualmente avvenuta in modo perfetto. Non gli bastava. Egli voleva rappresentare la gioiosità che aveva creato la schietta forma dei suoi ditirambi a contatto del dolore che egli riconosceva necessario al compiuto sapore della vita , e […] nelle forme che insegna la vita stessa nel complesso svilupparsi delle sue crisi: nel romanzo e nel dramma.
Questo mondo viene subito definito come «il mondo che abbiamo detto più difficile ed erroneo sebbene gravido di bellezza e ricchissimo di significati profondi». Ma d’altro canto «il romanzo di Gabriele d’Annunzio ed il suo dramma son tutti così inquinati d’un intrinseco inconciliabile dissidio tra lo sforzo artificioso ed inane verso una determinatezza, una coerenza, una logica concatenazionale […] ed una psicologia egoisticamente lirica che non sa apparire generata dall’urto degli avvenimenti».
Cecchi intende compiere un’indagine critica sul versante degli esiti «letterariamente» validi del poeta abruzzese, ma il sottofondo interpretativo – quello che in Esplorazione d’ombra è l’esito convinto e convincente dei sondaggi dannunziani — si forma lentamente attraverso l’accettazione di contrasti e anomalie: solo l’epifania estatica dell’«aurora» di Alcyone e l’«infinito dolore» del Notturno trasformano l’«egoismo» lirico in apertura illimitata, in visione dell’anima. Qui, sul terreno critico, Cecchi si infrange sui limiti interni di d’Annunzio che egli vorrebbe criticamente spiegare. Ma d’Annunzio non sa affrontare il dolore in termini narrativi: Cecchi evidenzia la discrasia di d’Annunzio, non rendendosi conto che, in termini critici, il poeta abruzzese sarà sempre irretito in dislivelli e in contraddizioni e non sarà mai spiegabile criticamente.
È il dialogo lirico che deve sfondare verso l’estasi o verso l’ascesi, non commisurarsi con l’oggettività esterna del romanzo e del dramma, dove l’interiorità del poeta non è «natura», e slitta sull’incompiutezza che «s’intesta a nomi che valgono appena a dargli l’indicazione del tono, l’avvertimento del modo di modulazione, simile alle concise didascalie che stanno a insegnare la perfetta guisa d’esecuzione d’una musica»: queste formulazioni circa le «concise didascalie», senza partecipazione vissuta, sono pertinenti alla inadeguatezza esplicativa per un critico-interprete come Cecchi. Tralasciando la «trama intricata ed infetta del romanzo e del dramma dannunziano […] noi possiamo esimerci da rimpianger la sua mancata esistenza come opera organica, come storia esatta e conclusa della vita spirituale di certi personaggi, e venire alle analisi di qualcuna delle liriche più centrali». Segue un passaggio esemplare della visualizzazione plastica di Cecchi: «Il metallo che incastona queste pietre elette è metallo fuso e colato nella forma, prima di essere stato veramente scelto e depurato»; e ancora: «Perché la tensione stilistica del poeta è stata sovente una tensione puramente estranea, non già intimamente connessa ai bisogni dell’ispirazione».
Anche quando, nella parte incipitaria dell’articolo, Cecchi ha voluto affrontare senza incrinature il Forse che sì forse che no, riconosce che «il nostro spirito era assordato e vuotato dal torrente verbale, e la sua vita vera soffriva, sospesa di non ritrovare se stessa. Ed ecco, a quando a quando, la trama complicata si lacerava. Ingenue voci sotterranee di vergini, di fanciulli, di forti prorompevano. E le loro parole eran tali che, udendole, quella vita smarrita si riconosceva d’un tratto, con un sussulto, nella sua profondità più profonda […] qui è lo stesso spirito che tesse l’inganno e stesse, s’aggira convulsamente per i bui meandri dell’illusione e a trovare con noi la parte soleggiata e schiusa sul vero, ad un tempo guida e ingannatore, Circe nefasta e psicagoga Athena».
Per Cecchi, nei confronti del romanzo dannunziano, la «consentaneità» interpretativa che si realizza nell’equilibrio del linguaggio è qui uno sforzo inappagato, in quanto illusione e vero si alternano e si escludono a vicenda. La discrasia dannunziana permette a Cecchi di mettere a fuoco l’intensità immaginativo-visiva, coinvolta, appassionata, ridondante, fatta di intensificazione concettuale e di allentamenti sintattici. È una tipologia critica che si affinerà, trasformandosi in adesione sensitiva univoca e convinta, quando la ‘sventura’ del Notturno lo ricondurrà all’estasi aurorale dell’Alcyone. Mentre ora, per ritrovare l’autenticità del poeta, deve spostarsi «necessariamente» sul terreno «lirico». Riferendosi a La pioggia nel pineto, il critico rileva che «la poesia che sgorga in molte pagine del romanzo da un’intimità assai più oscura e profonda [aderisce] alla poesia che canta in questi versi, figliata direttamente dal suo tronco istesso»; accetta nel romanzo trasposizioni e sovrapposizioni tra «realtà brutale» e «intimità profonda» che «abbondano nei poeti greci e segnatamente nei tragici, in Shakespeare, poi, e, per imitazione, nello Swinburne da cui forse più direttamente il d’Annunzio la imparò».
Il critico nota, ora, un movimento evolutivo nell’arte narrativa di d’Annunzio «in opere di valore disugualissimo […] addirittura somiglianti ad ammassi rovinosi di frammenti magnifici e grotteschi»; «col maturare della sua arte […] ha dato una rappresentazione oso dire sempre più lineata e vivace di fatti di coscienza profondi, di tormenti e di gioie alzati con un volto divino sopra un oscuro corpo animale, di fantasie abissali; fantasie, gioie, e tormenti che il sentimentalismo snobistico del Piacere, lo slavismo dell’Innocente, l’eroismo, pratico e intellettualistico, della Vergine, del Fuoco, della Gloria e della Gioconda, gli tennero a lungo implicati in inestricabili eterogeneità, finché la prima volta sbocciarono ignudi e cantarono audaci nel grandioso finale di quella Laus vitae […] È come un’alba tragica».
In questo profilo à rebours,che perviene di nuovo ai vertici poetici, c’è già tuttavia il riconoscimento di una rappresentazione «lineata» di «fatti di coscienza profondi» che, mentre prefigura il Cecchi “interpretativo” di Esplorazione d’ombra, rivela il discernimento di Cecchi che, se aveva manifestato l’inspiegabilità critica del non saper affrontare il dolore «in termini narrativi», accetta il «movimento evolutivo» di d’Annunzio come «fantasia, gioia, tormenti», la cui «inestricabile eterogeneità» si stempera nell’«alba tragica» della Laus vitae. E il critico si compiace della capillarità della propria perlustrazione: «non tutti son disposti ad andare studiosamente a cercare lo splendore misterioso e sublime attraverso quelle oscurità fabulose ed ingombre dove, volta a volta, vuole il caso ch’esso s’accenda».
Volendo, sarebbe illuminante soffermarsi su questa dichiarazione di metodo, dove non è soltanto il caso che permette la scoperta dello «splendore misterioso» che si nasconde nelle «oscurità fabulose ed ingombre» in cui si addentra il raffinato filologo – non dichiarato, implicito – con istanze ermeneutiche fatte di ipotesi e di geniale acribia: non esiste «caso», ma «mistero» rivelantesi. Questo articolo del 1910 è centrale nell’attraversamento cecchiano di d’Annunzio; è lo spazio dello snodo critico, dell’esperire testuale volitivamente attestato sull’istanza ermeneutica, sulla «disciplina del domandare e del ricevere che garantisce la verità», secondo Gadamer, oppure sulla identificazione tra critico e fenomeno letterario nella métacritique di Poulet e di Starobinskij.
Nel d’Annunzio francese di Le martyre de Saint Sébastien «non sentite la povertà di movimenti? […] Le frasi mozze e rettilinee sono infilate una dietro l’altra come chicchi di un rosario, e tutti i chicchi sono uguali, e il rosario è lungo lungo lungo, un rosario di quindici poste, noioso, noioso, noioso. Ma data così un’idea dello stile, bisognerebbe risalire all’invenzione, alle linee madri del lavoro. Quando ci si prova a far questo, ci si accorge invece che è impossibile. Una scena si inscatola sull’altra come gli anelli di un cannocchiale e si finisce per essere sempre alla stessa altezza», per cui «negando il fabbricante di S. Sebastiano, preserviamo il divino poeta di Alcyone». Qui non c’è inspiegabilità, ma impossibilità critica di fronte al parossismo dell’iterazione del «fabbricante di S. Sebastiano».
In Contemplazione della morte,«il recente volume […] formato di scritti ispirati al poeta dalla morte degli amici Giovanni Pascoli e Adolf Bermond», d’Annunzio – scrive Cecchi in un articolo apparso sulla «Tribuna» nel 1912 – esprime un atteggiamento «verso un ideale di vita che gli sembrava, fino a ora, quanto mai remoto: l’ideale della vita in Cristo […]. Non ci stupiremo noi, come non ci stupiremmo se domani d’Annunzio coronasse la sua evoluzione facendosi poeta dei santi affetti familiari […]. Muove con quei gesti di stile a cui ci ha abituati la sua frenesia autoesaltativa; interpreta ogni ricordo e ogni simulazione di avvenimenti di vita interiore, in una qualche sorta di mito […] e le formule della solita gnomica eroica si alternano a divagazioni iperboliche tese in un continuo sforzo verbale […]. Un lettore attento percepisce fino dalle prime righe, nell’intima contestura delle frasi, una imitazione della contestura dei versetti evangelici». Già qui, d’altro canto, si rivela in Cecchi l’istanza critica che lo condurrà ad Esplorazione d’ombra, in prossimità, cioè, del «sentimento senza trasposizioni». «Restano pagine nelle quali d’Annunzio si limita ad una semplice autoanalisi senza sciupare la notazione con interpretazioni eroiche, trascendentali […]. Irresistibile è il senso di incitamento, di arricchimento della realtà che […] il D’Annunzio riesce a comunicare».
L’analisi si connette all’attenzione: «di tutte le mie facoltà quella che più assiduamente stimolo e aguzzo è l’attenzione». Cecchi rileva che «quando il d’Annunzio esercita questa attenzione strettamente sulla natura e sui fatti della propria anima […] è rivelatore profondo e, spesso, formalmente perfetto». Affermazione, quest’ultima, che rinvia all’umiltà di d’Annunzio connessa al rovello di riuscire, qualunque cosa scrivesse, «il più possibile nobile e perfetto», come Cecchi scrive in Esplorazione d’ombra; qui c’è già l’interiorità, l’anima come natura; a cui si aggiunge l’analogia sensoriale, consentanea alla sensibilità plastico-visiva di Cecchi, che già sulla «Tribuna» del 29 maggio 1911 osservava: «taluni rapporti di sensazioni auditive e di sensazioni visive […] mai sono stati descritti meglio che in certe di queste pagine dannunziane». La visività ritorna nel D’Annunzio giornalista, in questa pagina apparsa sullo stesso giornale il 27 maggio 1913.
Si capisce che gli aspetti plastici di Roma e della vita romana dovettero essere i primi ad eccitare un temperamento visivo come quello del d’Annunzio […] Il pittore campestre si faceva paesista cittadino. Vedeva la chiesa barocca come «immensi pezzi di argenteria oscurati dal tempo» […] Il palazzo dei Borghese gli appariva quale «un gran clavicembalo d’argento». I «richiami dotti» passavano nelle sue note con qualcosa di assai vicino alla veemenza tutta pittorica dei “paesaggi” di Giulio Laforgue».
E possiamo richiamarci a Esplorazione d’ombra, in cui leggiamo:
Con Rimbaud, e magari con Laforgue (Fleurs de bonne volonté, XXVI ecc), e altri ancora, gli avranno servito nell’imparare a dividere e a ricomporre il giuoco dei sensi, dove i sensi sembrano scorporarsi, mescolarsi e scambiarsi negli organi e nel carattere della funzione; dove le impressioni tattili si impregnano di fosforo e diventano visive.
Nella «tragedia lirica» Parisina (1913), leggiamo sulla «Tribuna» del 16 dicembre 1913, l’«ispirazione scenica manca del tutto di spinta interiore, di agenti organici». Con la musica di Pietro Mascagni sarà altra cosa: avremo la sintesi della miniatura antica e delle stornelle rustiche. Ma «tra l’esteriorità pittorica e il grido dei momenti supremi […] che forse daranno musica […] è, intatta, la zona psicologica che il dramma doveva appunto scavare». Non c’è ancora l’interiorità (natura quale movente vissuto e interpretabile): «ai primi brividi della coscienza ricerca artificiosamente il suo eterno punto fermo nelle certezze sensuali». La Leda senza cigno prende avvio dall’«attenzione», ma, scrive Cecchi sullo stesso giornale il 18 gennaio 1917, «è un’attenzione […] più intenzionale che naturale e istintiva»; anziché lasciare «le impressioni rituffarsi e subire il transito misterioso e la legge del sangue, finché rimangano trasformate e leggere nell’aria alacre dello stile», il d’Annunzio preferisce cristallizzarle volta a volta in sostanza scritta: nucleo ben significativo, questo, della eterogeneità tra Cecchi e d’Annunzio rispetto alle risorse interiori, in quanto Cecchi (1962, p. 786), all’opposto di d’Annunzio, traduce il sensibile in visivo prima che si cristallizzi nell’«argilla delle parole».
Cecchi confronta il d’Annunzio «scrittore contemporaneo» – per cui «il primo dovere […] è di accettarsi e sfruttare in tutte le particolarità e gli incidenti del suo temperamento» – e l’«artista classico», che «si affida al silenzio del proprio sangue», mentre d’Annunzio «s’affida […] all’attenzione grammaticalmente intesa» (Cecchi 1972, p. 243). Il critico ritorna al Forse, che fu «tra i libri più sventurati del d’Annunzio», ma nel quale il poeta abruzzese «fiutò i tempi nuovi, o almeno il mutamento dei tempi […] la sua visione entusiastica trepidava e vacillava […] Son brividi, scoloramenti, presentimenti […] e allora cominciò la sua arte notturna, nera, la sua “esplorazione d’ombra” […] Cominciò la sua “speranza di creare un sentimento nuovo, capace di condurre le più torbide forze dell’istinto e di salire più alto che la voluttà». Istanza, quest’ultima, che per Cecchi presuppone il possesso morale, ma a «uno stato pre-tragico: il tragico delle cose» che deve ancora realizzarsi nella «profondità dentro se stesso», quando l’«infinito dolore» dissolve «l’essere e l’anima non riconosce che le sue visioni più invisibili e segrete». Qui tra il Forse e la Leda è la stessa anima, lo stesso rapporto che regge ormai tutto d’Annunzio, fra il lirismo e la gravità plastica, e il grottesco mondano e un estremo disperato nulla: in un equilibrio che ha l’estasi, la preoccupazione, il tetro anche d’un rito naturale e gli scatti di matta bestialità e del diabolico. «Rendimi la mia giovinezza», dice d’Annunzio, e Cecchi commenta: «Ma come la ritroverà chi non l’ha vissuta che nelle cose, e non ha riconosciuto la strada del suo sentimento se non sulla strada del mondo cinico e carnale ?». «Stanco l’uomo; ma l’artista ha predato insaziabilmente anche in questa stanchezza».
In Esplorazione d’ombra, un linguaggio metaforico e non problematico, pertinente alla consistenza dei testi dannunziani, capta in una adesione sensitiva e non più ‘interrogativa’ le «musiche sommesse e vagabonde»: «Si tratta nel Notturno di una suite […] di motivi apparentati da una tonalità misteriosa che echeggia l’uno dell’altro, e sembra non sciogliersi espressamente in alcuno»: l’elemento musicale riguarda la natura del testo verbale trasformato nel tono, nel mistero di un’eco: un essenziale indefinitezza costituisce un trascendimento dei limiti della parola verbale. Come scrive Pietro Gibellini (2023, p. 49): «Nella fase più matura d’Annunzio affinerà gli aspetti ritmici della sua scrittura, dando pieno valore musicale alle ‘pause’ […] la piena sonorità dei testi giovanili cede a un più discreto e sottile dettato […] il catalogo di segni-oggetto indecifrabili e taciturni volge verso l’esplorazione d’ombra della prosa notturna la poesia solare di ieri. Laus vitae si converte in Contemplazione della morte». Questo passaggio all’«esplorazione dell’ombra» può costituire il nucleo metamorfico del poeta abruzzese, in cui non c’è mutamento esterno, ma mutamento percettivo dalle cose all’anima.
Cecchi costituisce, nei confronti di d’Annunzio, un paradigma unico di coesistenza alterna di critica analitico-interrogativa e di ermeneutica sensitivo-sintonica: innervate nel linguaggio, dal coinvolgimento ridondante degli anni vociani alla distensione all’accostamento paratattico della metaforicità visivo-sensibile, fondante del rapporto di Cecchi con i testi, col mondo, in Esplorazione d’ombra.
Nel Cecchi del secondo dopoguerra, quando il Novecento ha tradito le attese “classiche”, i suoi riferimenti a d’Annunzio ritornano a proposito di Gozzano, in senso antifrastico, esternamente letterario: «Comincia dannunziano» leggiamo in Di giorno in giorno «in una maniera assoluta, letterale […] Dannunziano fino poi a inorridirne, con una sorta d’incantato spavento, con una ribellione quasi puerile»; e ancora a proposito Pietro Paolo Trompeo, che dedica uno dei saggi di La pantofola di vetro (1952) a L’ultima donna di D’Annunzio:vi «trae argomenti da una raccolta di circa duecento lettere e biglietti autografi […] a una amica, probabilmente ligure-lombarda; variamente chiamata da Manah, a Maya, a Tormentilla, più spesso Titti […] che lungamente dimorò al Vittoriale […] fino al febbraio 1938, qualche settimana prima della morte del poeta settantacinquenne»; «il Trompeo […] dell’estrema vecchiezza del d’Annunzio ha resa un’immagine da intendere con profonda pietà» (Cecchi, 1959, p. 364). Nel centenario di d’Annunzio (1963), il critico confronta il poeta abruzzese con Leopardi sul versante del “provvisorio” e dell’intensità del “credere”; la poesia del Leopardi è la totalità umana, senza «intervallo», «stacco», «strappo» quasi «calamitoso», «se un lume di bellezza non fosse restato infine anche ad Alcyone»: «Ci ripetevamo i primi versi della Sera fiesolana, di Undulna o di Versilia (sempre l’Oleandro, il Fanciullo, i Ditirambi avevano funzionato meno). Eppoi si ripeteva “Silvia, rimembri ancora”, o “Dolce e chiara è la notte e senza vento”. E si sentiva un’intima differenza di ton , o, direi meglio, di ‘fatalità’». La «differenza» – scriveva sul «Corriere» il 12 marzo 1963 – «era insormontabile». Ezio Raimondi (1969, p. 445), a proposito del Notturno, osserva che
le visioni di questo mondo stregato non durano a lungo, perché il presente si frange di continuo e l’arabesco lunare della memoria declina nel vuoto ‘improvviso’ di una pausa, di un’immobilità silenziosa. La spirale delle sensazioni interiori si consuma nella luce intermittente delle analogie liriche prima di essersi coagulata in ritmo di racconto, come un mosaico di figurazioni discontinue in un universo non omogeneo.
Il mosaico di figurazioni discontinue di d’Annunzio è nettamente diverso dalle «tessere nel riquadro d’un mosaico» dove la «soluzione strofica […] è quasi sempre in chiave di poesia», di cui dice Enrico Falqui (1970, p. 449) sul Cecchi critico: nel mosaico è l’esigenza di passare – ha osservato Daniela Rizzi – dall’arte alla religione, di rappresentare «come un mosaicista bizantino, un pittore di San Clemente dei fatti della nuova umanità», di tracciare «i diagrammi secondo i quali si ordina […] la vita morale; di coglierli secondo ogni attimo delle particelle minime della realtà». L’istanza religiosa implica un’intensità della vita interiore che richiama nel «mosaicista bizantino», la «tattilità» della «parola-mosaico» di Emilio Cecchi. Dall’istanza eticamente onnicomprensiva si staccano le figurazioni discontinue del mosaico nell’universo disomogeneo di d’Annunzio; Cecchi, invece, trova impossibile una via di riscatto senza toccare la spiritualità, anche tragica, del vissuto esistenziale; è su questo terreno che critica ed ermeneutica si sono correlate, secondo modulazioni alterne, nell’attraversamento dannunziano.
Altri sondaggi critici
Giacomo Debenedetti è parallelo a Cecchi nel nesso Alcyone/Notturno: «Un altro periodo di ombra […] si stende tra l’Alcyone e il Notturno. Da capo d’Annunzio tenta di dedurre poesia dai nuclei lirici che si è conquistati nel precedente unissono con se stesso. Ma ormai l’industria è più meccanica, lo sforzo meno fruttuosamente tormentato. Si pensi alla Fiaccola, alla Nave, alla Fedra […] al Forse che si forse che no. Ma ecco viene il Notturno a ripetere […] il medesimo processo di Canto Novo e dell’Alcyone». Come Cecchi aveva colto nella «sventura» le radici del Notturno, così Debenedetti ne coglie la rivelazione nella «fisicità», nel «corpo»: «la stessa arte che aveva tracciato i suoi segni nella luce delle più colme giornate d’Abruzzo o della Versilia, ora li traccia […] nella notte che è solida come l’una e l’altra coscia come un’asse inchiodata».
Sul versante stilistico, Alfredo Schiaffini rileva nel Notturno la «sintassi franta, semplificata […] immagini in successione visiva […] parole leggere e affilate, circulata melodia che non è più quella oratoria di Terra vergine. «Frangimento e semplificazione […] significano la parola che campeggia isolata, avvolta nel silenzio». Cita Momigliano: nel Notturno, d’Annunzio «coordina tutto, non subordina nulla». Emerico Giachery prende avvio dal Forse che sì forse che no in cui d’Annunzio «sembra avere affrontato definitivamente il mito e come liberato il poeta dalla sua ossessiva presenza. Romanzo del labirinto, ma anche romanzo della vittoria sul labirinto»; cita ancora Borgese a proposito di Alcyone: «ritmi di segreti impenetrabili, poesie dedalee che si chiudono in ambagi voluttuose […] che non sappiamo quasi che dicano, che vogliano; non sappiamo dove comincino, dove finiscano […] in una fluida continuità senza pause»; e Momigliano: «la vera, definitiva fisionomia della lirica dannunziana […] arabeschi, ghirigori lievi di parole, labirinti, andirivieni di suoni, ambagi guidate dalla divina malinconia»; e Marcazzan: «quel ritmo dedaleo, inafferrabile, nel quale ogni aderenza col reale labilmente si dissolve»; e Salvatore Battaglia: «la sua ultima mira non è tanto narrare […] quanto di formare atmosfere cariche di violenza e insieme di repentino languore e stabilirvi dentro, come in un labirinto, la sorte equivoca degli uomini». Giachery afferma: «La condannata ‘astoricità’ del romanzo dannunziano sottolineata dall’immobilità decorativa portata a forme così estreme (un’astoricità in re) diverrebbe un pò paradossalmente una forma di storicità post rem, garantita dalla convergenza tra una peculiarità essenziale del poeta e un momento della storia del gusto», «perciò bisogna sbarazzarsi di qualsiasi pregiudizio classicistico per giudicare i risultati e la presenza storica di questo poeta» cosi «anticlassico per temperamento». Cecchi commisura l’arte di d’Annunzio non già al classicismo, ma all’etica classica. L’analogia sensoriale demitizza la viziosa ricerca labirintica; è questo il limite del moderno a cui giunge d’Annunzio; il poeta rinuncia alla costruzione mitica, ha incorporato il labirinto nella fluidità distesa dell’analogia sensoriale. Nel momento notturno della rinuncia, emerge l’unico fondo vero dell’arte dannunziana.
Come afferma Walter Binni (1936, p. 93), «nel d’Annunzio del Novecento […] prevale un superuomo che ricorda e del suo ricordo fa arte: cioè la negazione e la fine del superuomo […] Nel Notturno ciò si vede ancor meglio: fondere totalmente l’artista e l’uomo in un racconto che, nella sua ambiguità di presente e di passato, sia quasi vita, vangelo, ricordo».
Diverso è il punto di vista della critica marxista di Salinari: «il D’Annunzio “notturno” è, non meno dell’altro, impastato di superuomo, il quale si manifesta nell’impegno linguistico e tecnico di rendere i colori, la visione, i barbagli, le allucinazioni dati dalla cecità». Bàrberi Squarotti dissente dalla continuità Alcyone–Notturno e li rende opposti: il Notturno è un «celebrato modello per la ‘prosa d’arte’ ovvero una sorta di esemplificazione dell’autenticità di tale poetica vociana e postvociana» piuttosto che «una vera e propria fase diversa dell’opera dannunziana, che segna un confine nettissimo fra il d’Annunzio alcionio e sensuale e vitalistico e il d’Annunzio di “esplorazione d’ombra”». Pietro Gibellini sostiene che la scrittura del Notturno «anticipa il frammentismo vociano e influenza profondamente il capitolo rondesco: la nuova generazione di scrittori, raccolta attorno a «Solaria» e «Letteratura», sarà ostile agli aspetti più retorici ed enfatici di d’Annunzio, ma lo riconoscerà maestro di un’ascesi letteraria, di una sensualità rapita fuori dai sensi».
Valter Leonardo Puccetti punta nettamente sulla «metafora del vuoto rivelatore», riferendosi a Cecchi interprete di d’Annunzio, a proposito del «linearismo» nel Notturno quale simbolo di un affiorare labile ma sincero della coscienza:linearismo che «vale assoluto», e allegorizza la nostalgia di un’ancestrale pienezza perduta in scrittori come Coleridge, d’Annunzio, Flaubert, Mallarmé: dalla deserta stupefatta immobilità della prosa del Notturno dannunziano viene attratta e viene contaminata la prosa di Esplorazione d’ombra, di cui Puccetti cita quali esempi di contaminatio i seguenti passaggi di Cecchi a proposito del Venturiero:
Raccolta su di sé, in una triste quiete, cui l’estinguersi della volontà conferisce qualcosa di funereo e deserto, tutta la personalità precipita e si coagula, a così dire, intorno a queste apparizioni, comunque labili e fuggiasche; come un mare fatato, che cristallizzi intorno a un fatato anello gittatovi dentro, e riveli, in quella istantanea immobilità, e in aspetti che appaiono definitivi e indistruttibili, la nervatura delle correnti, il fondiglio dei sedimenti più antichi e le marcide larve dei naufraghi, sublimandoli in una materia preziosa e straordinariamente varia; cerea, cristallina, corallina, diasprea […] Ho visto una volta, unico abbellimento in una stanza severa, sopra una grande tavola di lavagna, un largo bacile di vetro pieno d’acqua fino all’orlo, e dentro una sommersa selvetta di arborescenze marine: rami di corallo, conchiglie verdi come foglie pietrificate, spugne vermiglie come entragni, trine di madrepore, bissi, e chiome di morte sirene, nido di perle. È incredibile il senso di sospensione, di silenzio, e di non so quale splendido orrore, che si spandeva da quella vista sovranamente quieta, come di cose scorte dall’altra parte dell’esistenza.
Su questo terreno di contaminatio testuale, ben diverso dalla consentaneità interpretativa, si pone Simona Costa quando afferma che «d’Annunzio [è] per Cecchi un referente di tutto rilievo e di primo piano, lo dicono ampiamente i suoi scritti critici, pervicacemente intesi negli anni a saldare via via i conti in contemporanea all’apparizione di nuove opere dannunziane. Un referente vivo, discusso, contraddetto, rifiutato e consentito, comunque sempre problematizzato, un nodo critico che costituisce uno dei possibili legami con Serra, con il quale (ma anche con Borgese) condivideva anche il nome di Kipling».
Margherita Ghilardi (1987, pp. 168-169) si riferisce ben opportunamente alla sintonia interpretativa Cecchi-d’Annunzio: «la conclusione del processo interpretativo della stagione notturna, risoltosi in un consenso quasi incondizionato, sembra dunque verificarsi per Cecchi nel momento in cui si riesce a stabilire una pur parziale sintonia tra l’oggetto della sua esperienza di lettore e il proprio, personale modo di interferire e di realizzare la scrittura». Cita dai Taccuini del 1912 a proposito delle note preparatorie a Contemplazione della morte:
Eppure, seguitando a leggere, e leggendo con intenzione amorosa […] In lui è un assiduo stato rappresentativo, prodotto sull’affluenza sorvegliatissima delle sensazioni: la sua vita interna è tutta una trama consapevole di sottili impressioni, di rispondenze, di rievocazioni; alle rispondenze di queste impressioni attribuendo egli strani significati profondi; leggendo egli, in esse singolari leggi fatali. […] Ma soltanto chi sia […] completamente cieco da non accorgersi in quale infinita notte arda faticoso, per noi creature umane, il lume della coscienza, contro la foschezza dei sensi, contro le opache disabitudini della disattenzione, può reputare inutile l’esempio e l’avvertimento: «di tutte le mie facoltà quella che più assiduamente stimolo e aguzzo è l’attenzione».
Quando il d’Annunzio esercita questa attenzione strettamente sulla natura e sui fatti della propria anima, al di fuori delle influenze corruttrici dei sentimenti dell’orgoglio, dell’enfasi, della mania di prevalere, ciò che egli ne ricava […] è rivelatore profondo e, spesso, formalmente perfetto.
Che questo sia il pernio centrale – dice Ghilardi – intorno a cui ruota tutto il sistema dell’analisi cecchiana, lo dimostra agilmente la recensione a La Leda, deputata a svolgere internamente ad esso una funzione di esplicito collegamento tra l’intervento sulla Contemplazione e quello sul Notturno». Con questo rilievo di Margherita Ghilardi sulla sintonia interpretativa Cecchi-D’Annunzio sostanzialmente concordiamo. E citiamo, in definitiva, un passaggio dell’ultimo scritto di Cecchi su I Taccuini di d’Annunzio: «è certo che ne risulta approfondita e sviluppata un’immagine molto veritiera, ricca di tremenda vitalità, e ben diversa da quell’odioso simulacro del d’Annunzio anche recentemente riverniciato a volgare uso polemico, che sia per la decenza che per l’utilità sarebbe meglio fossero accantonati una volta per tutte».
Bibliografia
Scritti di Emilio Cecchi
Preliminari a una rassegna di poesia, «La Voce», 8 luglio 1908; ora in Paolo Leoncini, Cecchi e d’Annunzio. Cecchi critico tra novecentismo e antinovecentismo: con appendice di testi critici rari, Roma, Bulzoni, 1976, pp. 167-172.
Gabriele D’Annunzio, «La critica», novembre 1909; poi in Idem, Studi critici,Ancona, Puccini, 1912, pp. 37-53.
Forse che sì forse che no, «La Voce», marzo 1910; ora in Idem, Letteratura italiana del Novecento, cit., pp. 203-204.
Le martyre de Saint Sébastien, «La Tribuna», 29 maggio 1911; ora, col titolo D’Annunzio francese, in Idem, Letteratura italiana del Novecento, cit., p. 223.
Contemplazione della morte, «La Tribuna», 24 giugno 1912; ora in Idem, Letteratura italiana del Novecento,I, Milano, Mondadori, 1972, p. 224.
Pagine disperse di Gabriele D’Annunzio, «La Tribuna», 27 maggio 1913; ora in Id., Letteratura italiana del Novecento, cit., pp. 229-234.
La Leda e la licenza, «La Tribuna», 18 gennaio 1917; ora in Idem, Letteratura italiana del Novecento, cit., pp. 242-247.
Di giorno in giorno,Milano, Garzanti, 1948.
Statuine,in Saggi e vagabondaggi, Milano, Mondadori, 1962, p. 786.
D’Annunzio vivo, «Il Corriere della Sera», 12 marzo 1963; ora in Letteratura italiana del Novecento, cit., p. 269.
I Taccuini di d’Annunzio, in Id., Letteratura italiana del Novecento, cit., p. 274.
Bibliografia generale
Walter Binni, La poetica del decadentismo italiano, Firenze, Sansoni, 1936.
Ermanno Circeo, Ricezione critica del d’Annunzio «notturno», in D’Annunzio notturno, Atti dell’VIII Convegno di studi dannunziani (Pescara, 8-10 ottobre 1986), Pescara, Centro nazionale di studi dannunziani, 1987, pp. 153-159 (anche per i riferimenti a Carlo Salinari e a Giorgio Bàrberi Squarotti).
Simona Costa, D’Annunzio «notturno» e la “prosa d’arte”, in D’Annunzio notturno, cit., pp. 137-151.
Giacomo De Benedetti, Nascita del d’Annunzio (1927),in Idem, Saggi critici. Seconda serie, Milano, il Saggiatore, 1971.
Enrico Falqui, Novecento letterario, vol. III, Firenze, La Nuova Italia, 1970.
Margherita Ghilardi, Il lettore che sa leggere D’Annunzio notturno per Cecchi, in D’Annunzio notturno, cit., pp. 163-174.
Emerico Giachery, Verga e D’Annunzio, Milano, Silva, 1968.
Pietro Gibellini, Un’idea di D’Annunzio. Trent’anni di studi,Lanciano, Carabba, 2023.
Paolo Leoncini, Cecchi e d’Annunzio. Cecchi critico tra novecentismo e antinovecentismo: con appendice di testi critici rari, Roma, Bulzoni, 1976.
Valter Leopardo Puccetti, “Esatta maschera verbale”. La critica per immagini di Emilio Cecchi, in Percorsi per immagini e per narrazioni,Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione dell’Università del Salento, Lecce, Manni, 2006.
Ezio Raimondi, Gabriele D’Annunzio, in Storia della letteratura italiana, IX, Il Novecento, Milano, Garzanti, 1969.
Daniela Rizzi, Emilio Cecchi ‘russista’,in C. Diddi e D. Rizzi, Paralleli. Studi di letteratura e cultura russa per Antonella d’Amelia,Roma, Salerno, 2014, pp. 423-436.
Alfredo Schiaffini, Arte e linguaggio di Gabriele D’Annunzio, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia-Gardone Riviera, 7-13 ottobre 1963, Milano, Mondadori, 1968.