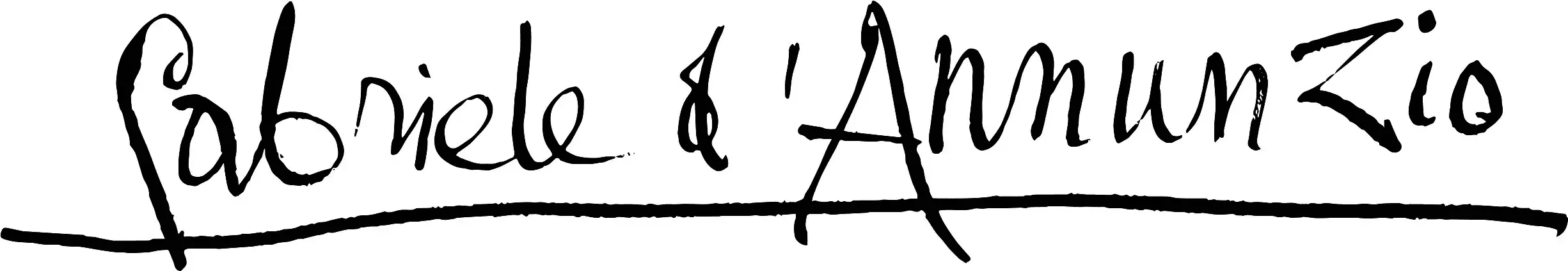di Gianni Oliva, Enciclopedia dannunziana
La vicenda editoriale
Giovanni Episcopo apparve in tre puntate nella «Nuova Antologia» (1, 16 febbraio e 1 marzo 1891) con il pre-titolo «Dramatis personae». Dato lo stretto legame tra l’Episcopo e L’Innocente, prodotti entrambi dalla volontà di sperimentare una nuova forma d’arte, d’Annunzio propose all’editore Emilio Treves la pubblicazione delle due opere in un unico volume (5 agosto 1891). Treves però respinse la richiesta e l’Episcopo fu stampato nel gennaio 1892 nella tipografia Bideri di Napoli per conto dell’editore Luigi Pierro (nel 1899 Pierro e Vivaldi proposero una nuova edizione conforme a quella del 1892). Il libro fu poi presentato al pubblico francese nell’antologia Episcopo e C., Paris, Calmann-Levy, 1895, con una scelta di novelle. In seguito (1931), unitamente a Terra vergine, comparve nel X vol. dell’Edizione Nazionale dal titolo «Le primavere della mala pianta».
Oltre il naturalismo
Se il distacco definitivo e cosciente dal naturalismo è testimoniato in d’Annunzio da alcuni articoli sparsi degli anni 1892-93 (Il romanzo futuro, in «La Domenica del Don Marzio», 31 gennaio 1892; L’arte letteraria nel 1892. La prosa, «Il Mattino», 28-29 dicembre 1892; La morale di Zola, in «La Tribuna», 3-10-15 luglio 1893) va detto che già dal 1888, in quello intitolato L’ultimo romanzo («La Tribuna, 26 maggio 1888), egli aveva tentato di prendere le distanze dalla scuola francese, ormai ritenuta degenerata e incoerente. Gli stessi frequentatori di Médan annaspavano in uno schema angusto, che li costringeva all’osservazione della realtà esteriore senza poterla adeguatamente conciliare con la logica degli stati d’animo. Gli assertori di quel metodo erano convinti «che le cose esteriori esistano fuori di noi, indipendentemente, e che quindi debbano avere per tutti gli spiriti umani una medesima apparenza».
Il Giovanni Episcopo è dunque il libro che, venuto dopo Il Piacere (1889), mira ad integrare la resa oggettiva del fenomeno con le impalpabili tortuose profondità dell’analisi interiore. Ansioso di rinnovarsi per tener fede ad una linea sperimentale mai confessata, d’Annunzio si trova a coniugare non più Zola con Bourget, il metodo documentario con la fine psicologia, come nel primo romanzo, ma Zola con Dostoevskij, ossia con il racconto-confessione, che è trascrizione del delirio e dell’angoscia, manifestazione della mente criminale. Del resto, l’interpretazione corrente mirava in quegli anni a evidenziare nello scrittore russo caratteristiche che andavano ben oltre la semplice tranche de vie, la quale si caricava di complicate ideologie a sfondo sociale con qualche venatura di evangelismo. Attento alle novità, d’Annunzio non si lascia sfuggire la tentazione di immergersi nello squallido mondo dei diseredati per studiarne i comportamenti irrazionali, tant’è che trasforma la capitale dello stato unitario disegnando un paesaggio urbano molto simile alla fosca Pietroburgo.
Roma come Pietroburgo
Se la Roma del Piacere era la città dei sontuosi monumenti barocchi, dell’aristocrazia lussuosa e sofisticata, degli eleganti ritrovi mondani, dei giochi sottili di allusioni e di schermaglie amorose, dell’avidità dei sensi, quella dell’Episcopo è il suo rovescio: ha vicoli bui e maleodoranti, gente minuta e di malaffare, che frequenta pensioncine equivoche ed osterie, animata da passioni brutali spinte fino alle estreme conseguenze. In questa umanità sofferente il personaggio protagonista non è più il dandy innamorato delle bellezza, ricco e colto intellettuale che si divide tra salotti e botteghe d’antiquario, tra duelli e corse di cavalli, tra sensualità e spiritualità, ma un timido e modesto impiegato dalla vocazione perdente, vittima dei soprusi del più forte, raggirato da loschi individui e da donne senza scrupoli. D’Annunzio ha cambiato registro creando un unicum nella sua produzione narrativa. La sua ambizione sperimentale lo porta ad assimilare le voci del sottosuolo, della confessione spasmodica sull’esempio della letteratura russa allora in auge in Europa. Egli continua così la sua ricerca attraverso un ulteriore sforzo di rinnovamento imboccando quella strada che lo porterà più avanti anche alla familiarità con Wagner e Nietzsche.
Avvertendo i limiti del primo romanzo, delle cui «lucide forme verbali» si dichiarava nauseato, d’Annunzio per uscire dalla crisi profonda, dà mano ad un racconto-lungo o romanzo breve, che se non fa certo gridare al capolavoro, conserva se non altro il suo esplicito valore documentario in quanto frutto di una stagione culturale inquieta, di spasmodica esplorazione di forme nuove in sintonia con le più aggiornate esperienze e mode europee. La prefazione indirizzata a Matilde Serao, a prescindere dagli obiettivi effettivamente raggiunti dalla scrittura, indica chiaramente la volontà di ripartire da zero («O rinnovarsi o morire»), di eliminare le ridondanze dello stile alla ricerca di una prosa più asciutta e concreta, ma anche l’ambizione di caricare la narrazione di una valenza ideologica dopo la descrizione del delirio estetizzante e aristocratico del protagonista del Piacere.
La questione del roman russe
D’Annunzio, come si diceva, è attratto dalla moda del roman russe, lanciata in Francia fin dal 1885-1886 dal visconte Eugéne Melchior de Vogué, ma i suoi rapporti con quel genere narrativo costituiscono una questione controversa, molto più di quanto attesti la tradizione critica a riguardo, che spesso si avvale di luoghi comuni. In prima istanza va controllata la data di avvio della questione, che due studiosi come Eurialo De Michelis e Ettore Paratore sembravano aver fissato non prima del 1890, quando cioè la figura del padre ritratta nell’Invincibile (pubblicato a puntate sulla «La Tribuna» dal 6 gennaio al 2 marzo 1890) era risultata modellata su quella di Fjodor Karamazov. In realtà, il momento dell’approccio ai russi risale per D’Annunzio almeno a qualche anno prima (1888-1889), come provano indirettamente alcune lettere di Angelo Conti al conte Primoli, dalla cui biblioteca privata è sicuro che provenissero le traduzioni francesi di Tolstoi e di Dostoevskij date in lettura agli amici romani: «Ora preparo un libro per il Treves e mi occorre subito il libro del Visconte di Vogué ove si parla di cose russe» scriveva il Conti. Me lo può mandare subito? E mi può mandare anche Katia di Tolstoi?». E ancora: «Ho letto la Puissance del ténebres. E’ una bellissima cosa ed ha tre o quattro scene d’una potenza irresistibile. Ho parlato a d’Annunzio che è contentissimo».
Il Doctor Mysticus è quindi affascinato da Dostoevskij e dal modo in cui egli imposta e suggerisce i grandi problemi umani nella loro globalità. Peraltro, dopo la lettura dei Souvenirs de la maison des morts, Conti osserva di aver pensato ad una contraddizione che è in fondo alla natura umana, il rapporto tra necessità e libertà.
D’Annunzio, che nella prefazione all’Episcopo ricorda non a caso il Conti e che comunque in quegli anni romani ha con lui un’assidua e notoria frequentazione, non poteva non risentire delle discussioni che erano nell’aria. Conti stesso, ospite di precarie abitazioni durante la sua bohème capitolina, può avergli fatto da guida nei meandri subdoli e lerci delle osterie alla ricerca di un Christus patiens inducendolo peraltro a riflettere sul rapporto tra libertà e necessità a proposito del delitto compiuto dal protagonista. Episcopo, insomma, uccide perché ha per destino la vocazione del criminale o perché costretto dalle circostanze, dalle insopportabili angherie di Wanzer. Sono considerazioni che rendono ancora più importante il sodalizio d’Annunzio-Conti, già denso di scambi culturali, di dialoghi proficui e di esperienze comuni
La lettera-prefazione esplicita poi e rafforza il contesto ambientale in cui nasce il «piccolo libro»: «La persona di Giovanni Episcopo era stata già da me osservata e studiata con intensa curiosità, due anni innanzi. Il filosofo Angelo Conti l’aveva conosciuta per la prima volta nel gabinetto d’un medico, all’ospedale San Giacomo. Io, quel nobile filosofo e il pittore simbolico Marius de Maria avevamo poi frequentato una mortuaria taverna della via Alessandrina per incontrarci col doloroso bevitore. Alcune circostanze bizzarre avevano favorito il nostro studio».
I traduttori italiani del romanzo russo
Se tutto ciò costituisce un elemento che concorre alla retrodatazione del rapporto d’Annunzio-romanzo russo, non va taciuto che la diffusione in Italia della letteratura slava e russa in particolare non era certo una novità e che non necessariamente essa si era verificata per il tramite francese. Un impulso alla divulgazione era venuto da alcuni tempestivi traduttori italiani operanti nell’ambiente napoletano (quello frequentato da d’Annunzio dopo il periodo romano) come Domenico Ciampoli e Federico Verdinois, nonché dall’attività linguistica e letteraria dell’Istituto Universitario Orientale e dalle segnalazioni critiche di Vittorio Pica (un suo saggio sui Romanzieri russi è del gennaio 1887). Ciampoli in special modo, conterraneo di D’Annunzio e robusto narratore in proprio prima di lui, si era prodigato fin dal 1879 nella pubblicazione di poesie russe, fino a quando nel 1881 aveva steso per il «Fanfulla della domenica» una serie di profili dedicati a Pushkin, a Gogol, a Turgenev, del quale tradurrà nel 1884 i Racconti russi (Milano, Treves), Nel 1887 era uscita la traduzione di Anna Karenine di Tolstoi con un saggio introduttivo apparso fin dal 1885 (19-26 settembre) sulla «Gazzetta Letteraria» di Torino. Vi si parlava già dell’importanza della redenzione etica più che sociale dell’individuo e si faceva cenno alle problematiche di Dostoevskij di Povera gente, di Umiliati e offesi, di Delitto e castigo, dei Demoni, oltre che a quelle del Turgenev di Padri e figli. A questo elenco va aggiunto come particolare niente affatto trascurabile la pubblicazione della sua Storia delle letterature slave (2 voll., Milano, Hoepli, 1889), nonché la traduzione, uscita presso Treves nel 1889, di Delitto e castigo ad opera di Federico Verdinois. Non si comprende perché dunque D’Annunzio avrebbe dovuto solo guardare alle versioni transalpine dei russi ignorando quelle che gli giravano comodamente in casa, realizzate da specialisti per giunta conosciuti personalmente.
Negli interventi di Ciampoli, che a Napoli si batteva da autentico operatore culturale in favore della linea russa in opposizione a quella francese, come sarà poi per d’Annunzio, la creatività slava era rimasta integra rispetto all’ingerenza transalpina. Se in un primo momento egli aveva sondato l’anima romantica di Pushkin considerandone i risvolti etnici, si era in seguito dedicato al naturalismo di Turgenev, fino a giungere, appunto, alle profondità psicologiche di Dostoevskij. In particolare quest’ultimo, in linea con i risvolti decadenti della cultura contemporanea, gli appariva proprio l’artefice dello scavo interiore, lo scrittore delle nevrosi e delle psicopatie dell’uomo moderno. L’anima slava mostrava con lui la sua vera natura divenendo simbolo della spiritualità umana, della dimensione intellettuale degli individui. Per una sorta di effetto climatico lo spirito mediterraneo, portato all’eros e alla solarità, era agli antipodi di quello nordico-orientale, che la natura ingrata conduceva verso l’angoscia e lo sconforto. Insomma, l’intimismo meditativo di Dostoevskij incarnava le lacerazioni della coscienza e i suoi personaggi avevano (come si legge nella premessa al Demone d’oro nell’edizione Voghera, Roma 1902) una «complessità dolorosamente bizzarra».
D’Annunzio è dunque attirato nella sua ansia di rinnovamento dalla logica delle passioni e dalle passioni della logica e costruisce un personaggio che in qualche modo incarna questa tipologia. Egli vira improvvisamente verso l’ambiente piccolo-borghese degli impiegati e l’inferno dei bassifondi urbani, dando vita ad un mondo sordido e malfamato tra incubi, litigi e squallore. Rispolvera a proposito anche suggestioni scapigliate e forse ricordi che fanno capo al Bersezio di Monssù Travet, in cui un impiegato debole, umiliato, persino masochista, da pecora diventa leone, esplodendo con tutta la violenza repressa del debole. Caratterizzazione, questa, su cui insisterà il film di Alberto Lattuada interpretato dal giovane Aldo Fabrizi, intitolato Il delitto di Giovanni Episcopo (1947), liberamente tratto dal romanzo di d’Annunzio.
La tecnica della confessione e la temperatura stilistica del libro
Il metodo seguito nella rappresentazione è quello dell’osservazione diretta («Bisogna studiare gli uomini e le cose direttamente, senza trasposizione alcuna» scrive nella dedica alla Serao), così come è di marca zoliana il materiale preparatorio raccolto durante gli incontri con il personaggio, secondo una consuetudine che d’Annunzio non abbandonerà mai e che risale alla sua formazione positivistica. Tale piattaforma servirà da trampolino di lancio per l’invenzione, per la scelta e la selezione dei particolari da associare, fino ad arrivare a comporre infine dal noto l’ignoto. Egli sceglie la tecnica della confessione, come sarà per Tullio Hermil nell’Innocente, ma il narrato non ha nulla a che vedere con il lucido e armonico memorialismo romantico (tra i precedenti è stato fatto persino il nome di Nievo). Semmai la convulsa e nevrotica esposizione di Episcopo si apparenta meglio con alcuni racconti-confessione di delitti di Maupassant, o con quelli di Poe, dal Cuore rivelatore al Gatto nero. La critica si è poi sbizzarrita nel formulare raffronti con i russi, quasi fosse d’obbligo trovare pezze d’appoggio per uno scrittore da sempre accusato di plagio come D’Annunzio. Sono state a tal proposito sottolineate consonanze tra il personaggio di Episcopo e Marmeladov di Delitto e Castigo, fra Ciro e Iljusa, fra Wanzer e il principe Valkovskij di Umiliati e Offesi, per non dire della novella Kròtkaja richiamata fin dai tempi della recensione di Capuana; mentre altre tracce produttive si sono scovate nelle Memorie del sottosuolo, nel Ladro onesto e via dicendo. Sono analogie che più o meno colgono nel segno, ma che sottovalutano la capacità dannunziana del ritrovamento e del conseguente adattamento delle suggestioni in una rinnovata dimensione creativa. Il lungo sfogo di Episcopo, attraverso cui si snodano a ritmo alternato gli avvenimenti, determina la temperatura stilistica del libro, ora fredda, ora tiepida, ora incandescente. Il racconto procede a singhiozzo , tra pause e volute ripetizioni che imitano il flusso reale del parlato. Il discorso, tra continue esclamazioni e interiezioni, si fa frammentario, con evidenti sbalzi temporali dal presente al passato e viceversa, laddove il lettore ha il compito di seguire la dinamica del delirio e di ricomporre i tasselli sparsi del mosaico.
Nel disarticolato racconto emerge la storia di un vinto, di un uomo nato schiavo e che nonostante tutto non riesce ad emanciparsi. Tuttavia, la debolezza del libro non sta tanto nella forma scelta, che a lungo andare può risultare monotona, quanto nel non aver saputo l’autore conciliare il dettato dell’io con la corposità dei personaggi. Wanzer, Ginevra, il vecchio Battista, la madre megera, sono stereotipi evanescenti che finiscono per restare sullo sfondo senza entrare nettamente nella coscienza del lettore. La forma, insomma, non si combina con il contenuto a tal punto da creare quello spiraculum vitae di desanctisiana memoria che starà tanto a cuore al recensore Capuana. L’osservazione diretta non basta se non soffia il vento dell’arte che la vivifica. Lo stesso d’Annunzio, nella lettera a Vincenzo Morelli del 15 lugio 1889, non aveva negato per la stessa ragione il valore artistico de Le Disciple di Bourget? («Ci sono pagine assai belle nelle Confession. Ma dov’è l’arte? Mi pare che l’elemento scientifico sia troppo preponderante. E’ più facile scrivere venti pagine di analisi che una sola di rappresentazione vitale»). Gli appunti, l’intera documentazione raccolta, resta fine a se stessa se non si trasforma e si solidifica in eventum, che è il risultato finale prodotto dalla scintilla misteriosa fatta scattare dall’artefice.
Nell’Episcopo evidentemente il meccanismo si era inceppato e d’Annunzio se ne mostra pienamente consapevole quando nella prefazione definisce il suo lavoro non una prova d’arte, ma «un semplice documento letterario pubblicato a indicare il primo sforzo istintivo di un artefice inquieto verso una finale rinnovazione». Indubbiamente però quell’esperienza era servita se non altro a spianare il campo verso risultati meno labili, di cui l’Innocente costituirà un passaggio non secondario. Lì d’Annunzio, che pur si troverà alle prese con un’altra confessione, quella dell’infanticida Tullio Hermil, avrà affilato gli strumenti dell’analisi e la narrazione sarà affidata ad un ritmo più sorvegliato e maturo. Il ritorno agli ambienti aristocratici faciliterà non poco il suo compito, visto il disagio provato a contatto con i bassifondi in quella sorta di affresco pseudo-popolare pur caro alla Serao. I principi di fondo ispiratori del romanzo, infine, saranno più chiari e il protagonista non brancolerà nell’inconcludenza, ma sarà dibattuto tra un esagerato egoismo e la volontà utopistica di rigenerazione. Dostoevskij lascerà il posto a Tolstoi, anche se i temi della bontà e dell’umanitarismo cristiano si dissolveranno di lì a poco nelle anomalie comportamentali e nelle prime avvisaglie del superuomo.
Bibliografia essenziale
Bibliografia principale
Gabriele d’Annunzio, Giovanni Episcopo, «Nuova Antologia», 1, 16 febbraio e 1 marzo 1891.
Gabriele d’Annunzio, Giovanni Episcopo, Napoli, Pierro, 1892.
Gabriele d’Annunzio, Giovanni Episcopo, Napoli, Pierro e Vivaldi, 1899.
Gabriele d’Annunzio, Le primavere della mala piante. Terra vergine. Giovanni Episcopo, Verona, Bodoni (Mondadori), 1931 (Istituto Nazionale per l’Edizione di Tutte le Opere di Gabriele d’Annunzio).
Gabriele d’Annunzio, Giovanni Episcopo, a cura di Clelia Martignoni, Milano, Mondadori, 1979.
Gabriele d’Annunzio, Giovanni Episcopo, in Idem., Prose di romanzi, I, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 1988, pp. 1023-1095.
Gabriele d’Annunzio, Giovanni Episcopo, a cura di Gianni Oliva, Roma, Newton Compton, 1995.
Bibliografia secondaria
Luigi Capuana, G. D’Annunzio: Giovanni Episcopo e l’Innocente, «La Tavola Rotonda», 24 aprile 1892, poi in id., Gli “ismi” contemporanei, Catania, Giannotta, 1898.
Gabriele d’Annunzio, Lettere ai Treves, a cura di Gianni Oliva, Milano, Garzanti, 1999.
Eurialo De Michelis, Tutto D’Annunzio, Milano, Feltrinelli, 1960.
Gianni Oliva, I Nobili spiriti. Pascoli, D’Annunzio e le riviste dell’estetismo fiorentino, Bergamo, Minerva Italica, 1979.
Ettore Paratore, D’Annunzio e il romanzo russo, «Lettere italiane», n. 3, luglio-settembre 1976 (poi in Nuovi studi dannunziani, Pescara, Centro Nazionale di studi dannunziani, 1991).
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)