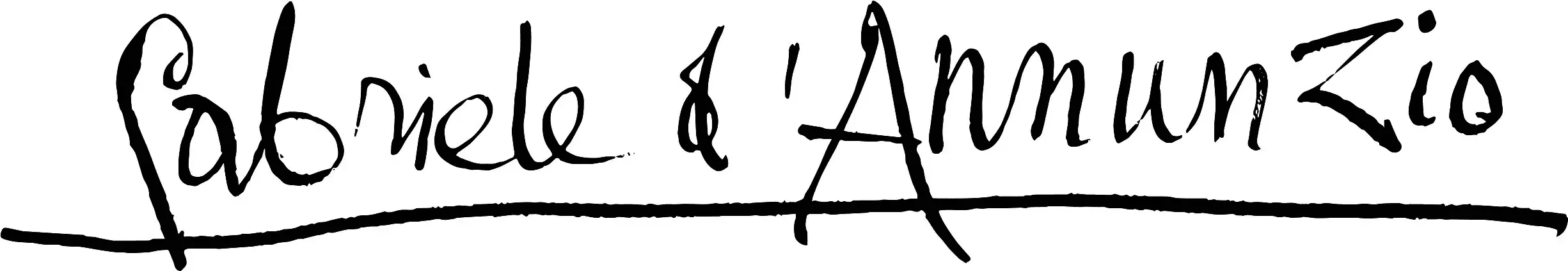di Edoardo Ripari, Enciclopedia dannunziana
Genesi, elaborazione, vicenda editoriale
Fedra è una tragedia in tre atti di 3221 versi (endecasillabi e settenari) scritta da Gabriele d’Annunzio alla Villa La Capponcina di Settignano tra metà dicembre del 1908 e inizio febbraio del 1909, in un periodo di grandi difficoltà economiche e nel centro della crisi finanziaria che lo avrebbe costretto a lasciare l’Italia. Le date di composizione sono presenti sull’autografo, conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con segnatura ARC 21.56/1, la cui versione digitalizzata è consultabile online all’indirizzo http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittomoderno/ARC21561/BNCR_DAN18874_001. Più nello specifico, l’atto primo è stato scritto tra il 18 e il 31 dicembre 1908, il secondo tra il 9 e il 29 gennaio 1909, mentre il terzo è stato concluso nella notte tra il 2 e il 3 febbraio successivo. La genesi dell’opera è affidata alle lettere che d’Annunzio invia a Treves e a Nathalie de Goloubeff, l’amante del momento ribattezzata Donatella Cross. Le prime confermano che le tappe del processo di scrittura della tragedia è stato intenso e ininterrotto; le seconde sono rivelatrici soprattutto dei turbamenti emotivi che accompagnano la creazione del dramma, in una progressiva sovrapposizione tra la vicenda sentimentale ed erotica privata e quella letteraria dell’eroina cretese. In entrambi i casi, esse consentono di ricostruire con andamento quasi quotidiano il processo di scrittura della tragedia.
La parola «fine» a Fedra viene scritta la notte di mercoledì 3 febbraio 1909 alle ore 2 e 40 minuti «precise». Pochi giorni dopo, il 10 febbraio, d’Annunzio legge la tragedia nel salotto di Clemente Origo ad alcuni amici intimi: Francesco Paolo Tosti, Emma Gramatica, Domenico Trentacoste, Alberto Franchetti, Silvio Tanzi, Giulio Piccini e madame Herbillon. È assente Nathalie de Goloubeff: il poeta sarà con lei a Cap Martin tra il 18 e il 24 febbraio, le leggerà la nuova fatica e la donna se ne infiammerà al punto da proporsi come interprete scenica e accingersi a volgerla in francese, anche se la traduzione, cui è interessato anche Ricciotto Canudo, uscirà poi in una versione in prosa ritmica a opera di André Doderet.
Il periodo che segue è dedicato alla preparazione del debutto scenico del 10 aprile 1909 al Teatro Lirico di Milano; alla prima rappresentazione, che segna un sostanziale insuccesso, segue una seconda il 25 maggio al Teatro Argentino di Roma, ma neppure questa volta il poeta riesce a incontrare i gusti del pubblico. Per la consacrazione di Fedra sulle scene bisognerà aspettare il decennio successivo, quando la tragedia sarà rappresentata prima a Roma, per volontà delle istituzioni di rendere omaggio al poeta, en plein air al Palatino il 22 ottobre 1922, poi, con scenografia e costumi di Léon Bakst, all’Opera di Parigi il 7 giugno 1923 in presenza di numeroso pubblico plaudente, fra cui troviamo Paul Valéry e Jean Cocteau.
Lo stesso 10 aprile 1909 esce per Treves l’elegante prima edizione della tragedia, contenente le xilografie ellenizzanti di Adolfo de Carolis, vero corredo ermeneutico al testo, denso di simbologie. Alla princeps seguono tre ristampe in versione economica (1919, 1922, 1927), mentre nel 1928 Fedra è inserita nell’àmbito del progetto promosso dall’Istituto nazionale per l’Edizione di Tutte le Opere di Gabriele d’Annunzio, stampata presso l’Officina Bodoni di Hans Mardersteig di Verona ed edita da Arnoldo Mondadori. Nel 1937 esce a Roma l’edizione per i tipi dell’Oleandro, l’ultima apparsa in vita dell’autore. Le varianti tra la princeps e le stampe successive riguardano perlopiù aspetti grafici e interpuntivi; fa eccezione l’assenza, a partire dall’edizione del 1928, del Rerum insignium index posto dall’autore in calce al testo della tragedia.
L’attuale edizione di riferimento è quella a cura di chi scrive, apparsa per l’Edizione Nazionale delle Opere di Gabriele d’Annunzio, che mette a disposizione numerosi documenti inediti e offre, secondo i principi della più aggiornata filologia d’autore, un apparato genetico che permette di studiare il processo compositivo della tragedia attraverso le varianti e dunque di entrare nell’officina dannunziana.
Subito prima del debutto al Lirico, Gabriele parla di Fedra in un’intervista rilasciata a Renato Simoni del «Corriere della Sera»: tra i principali suoi propositi, c’è stato quello di rappresentare intorno alla figura della cretese figlia di Pasifae e Minosse «l’intero mondo classico prima della guerra di Troia»; e poi di restituire «sangue pagano» all’eroina tutta «cristiana» di Jean Racine, nei confronti della quale egli esprime sostanziale dissenso mostrando l’ironia che gli è propria nel rivendicare il rilancio della tragedia mediterranea. Nell’intervista, Gabriele concede molto all’archeologia, di vitale importanza già per il suo esordio drammaturgico con La città morta: le rovine di Cnosso, di Haghia Triada e di Festo hanno riacceso la passione e la fantasia dello scrittore, che vede confermata l’idea secondo cui le discipline archeologiche costituiscono un ponte ideale fra tragedia antica e sua moderna risurrezione; riemerge in lui anche quel fascino per il mito cretese già manifestato nel Ditirambo IV di Alcyone (in cui si rievocava l’amore di Pasifae per il toro bianco e il Labirinto fatto costruire da Dedalo per nascondervi il frutto di quell’insana passione: il Minotauro) e ancor prima in alcune pagine del Fuoco (con la rievocazione del mito di Arianna). Gabriele, in particolare, sottolinea che la sua eroina è davvero la cretese «che il vizio della patria arde e il suo vizio», mostrando così la sua vicinanza, fra i precedenti antichi e moderni, soprattutto con la Phaedra di Seneca, in cui si coglie il significato tragico della protagonista; giacché Fedra è certo, come in Euripide, come in Racine, «tutta invasa dal morbo insanabile», ma non è né «la gemebonda che giace nel suo tormentoso letto e non osa parlare a Ippolito né osa parlare a Tèseo, ma sol morire legando alle sue mani esangui le tavolette accusatrici»; né tantomeno la «grande dame» raciniana. Nella creazione del nuovo personaggio, Gabriele ha così registrato «prontamente» e in parte precorso «le acquisizioni di archeologi e mitografi», facendo della sua scena lo «spazio della diversità» (Bàrberi Squarotti) e della sua eroina la portatrice di una trasgressione dionisiaca, in linea col pensiero nietzschiano e l’Origine de la tragédie.
Nel rimetter mano alla vicenda mitologica, d’Annunzio si rivolge a un pubblico in cui presuppone la conoscenza degli eventi che andrà a narrare (Gibellini) e si permette di dialogare con l’intera tradizione apportando, ove ritiene necessario, le opportune modifiche e varianti.
Le altre Fedre
Il vero ‘grado zero’ del percorso intertestuale e interculturale che dalle Grandi Dionisie del 428 a.C. giunge a d’Annunzio è rappresentato dall’Ippolito velato di Euripide, un’opera che ricevé un’accoglienza così negativa da meritare la damnatio memoriae e quindi la quasi totale scomparsa. Tradizione vuole che motivo dello scandalo fosse una scena ben precisa: Ippolito apprendeva direttamente dalla matrigna l’insano desiderio erotico di questa nei suoi confronti, e, còlto da sùbito orrore, si velava il capo (da qui il titolo della tragedia). Euripide dovette riscrivere l’opera attribuendo convenientemente a Enone, nutrice della cretese, la responsabilità della rivelazione. È da questo momento che prende vita un progressivo cambiamento nell’eroina, divenuta col tempo sempre meno vittima pietosa di dee rivali (Artemide e Afrodite) e sempre più ribelle. L’Ippolito coronato — titolo che allude alla ghirlanda che il giovane figlio di Tèseo, all’inizio della tragedia, appende alla statua di Artemide — è dunque il secondo tentativo di Euripide di raccontare la torbida passione di Fedra per l’efebo figliastro. Ora la vicenda si svolge tra due epifanie divine: nel prologo, che apre su un theologèion, Afrodite rimprovera la superbia di Ippolito, che la ignora dando tutto se stesso ad Artemide; subito dopo ella descrive, al passato, gli effetti della sua vendetta sui personaggi, soprattutto su Fedra, strumento divino per la punizione del giovane; di seguito ella parla al futuro: cosa sarà di Fedra e cosa accadrà a Ippolito? Nell’epilogo è Artemide a prendere la parola: ella svela l’innocenza di Ippolito e promette di vendicarsi sulla dea rivale provocando la morte del giovane Adone, di cui Afrodite si è invaghita; Fedra, invece, sarà resa immortale dalla poesia. La prospettiva tragica viene all’improvviso rovesciata: Ippolito, colpevole, diventa innocente, il padre Tèseo un assassino incolpevole e Fedra — che resta strumento della dea dell’amore — degna di essere ricordata per la nobiltà d’animo. L’eroina, che si suicida convinta di affermare così la propria volontà, accondiscende a quanto Afrodite ha già stabilito per lei, trovandosi dunque annichilita tra due forze opposte; non si uccide perché non può avere Ippolito, né perché intende utilizzare la morte come strumento di vendetta, ma «per la disperazione del proprio mistero, perché la condizione umana vuole che si muoia senza conoscere» (Del Corno). Niente di più lontano dalla soluzione deliberata dall’«indimenticabile» dannunziana: il poeta, per sottolineare la distanza della sua opera dalla tradizione, inserisce infatti l’episodio di Capanèo ed Evadne quale esempio di empietà e ribellione per la sua eroina. Proprio la «bella morte» dei due darà inizio al percorso che condurrà Fedra alla piena consapevolezza del proprio destino e del modo di imporsi su di esso liberandosi per sempre dalla persecuzione divina. Simbolo di liberazione diventa così il velo che ella stende sul cadavere dell’efebo, richiamo palese al Velato euripideo.
Nella IV delle Heroides ovidiane, Fedra torna a essere protagonista con una lettera rivolta proprio a Ippolito: l’amore, qualunque ne sia la natura, qualunque aspetto assuma o sofferenza provochi, è sempre legittimo; l’efebo metta da parte l’ossessione venatoria e riconosca i diritti di Afrodite. Pronta a tradire il tabù dell’incesto, la cretese è ormai priva di ogni pudore e invoca l’amore e il perdono dell’amato. All’epistola di Ovidio molto deve d’Annunzio, che pure, insistendo sulla volontà di emulare il pagano Euripide in dissenso col cristiano Racine, non nomina il pur amatissimo autore dei Metamorphosĕon libri; ma è proprio nel Sulmonese che egli trova «la rimozione dell’influsso divino quale causa scatenante della passione proibita, radicata invece nel cuore umano e coltivata con il soccorso della mente», come pure vi trova «il coraggio della confessione aperta, anzi dell’invito palese corredato dallo scaltro avvertimento che vivere sotto lo stesso tetto allontanerà ogni sospetto» (Gibellini).
Nella Phaedra senecana, l’eroina è affetta, come in Euripide, da un morbus che la consuma ma la cui eziologia si distanzia da quella del tragediografo greco: non la «gemebonda inferma» euripidea sarà la Fedra di d’Annunzio, che guarda più da vicino proprio a Seneca; nella cui tragedia la protagonista si confessa esplicitamente a Ippolito senza l’intermediazione della nutrice o filtri epistolari. Se, in Euripide, Afrodite e Artemide giocano la loro eterna partita utilizzando i mortali come pedine di una crudele scacchiera, nel latino esse vengono interiorizzate, lottano cioè nell’anima della protagonista, che chiama gli dèi a testimoni della sua lacerazione tra voluntas e ratio. Ma il tragediografo insiste soprattutto sull’odio di Afrodite per la stirpe del Sole, facendo della vicenda tragica l’ultimo episodio della saga di Pasifae e del Minotauro. Fedra diventa così la cretese che riconosce in sé il nefando male già materno: ecco la principale eredità senecana nel remake di d’Annunzio, che pure recupera i livelli della dizione poetica caratterizzata dall’enfasi sul pathos secondo un gusto che l’autore novecentesco sente appropriato alla sua poetica.
La Phèdre di Racine differisce sostanzialmente ancor più che formalmente da tutti i precedenti, giacché l’eroina, divenuta cristiana, è costruita secondo la morale giansenista: cosciente di compiere il male, di compierlo in modo involontario spinta da forze irresistibili, ella sa di non essere libera, che è del tutto vano contrapporsi al mondo e al male, cercare di sconfiggerlo avvalendosi di strumenti puramente modani; priva della grazia divina, combattuta dall’amore e dal terrore della colpa, è perduta a priori, condannata alla morte e all’oblio ma allo stesso tempo «indimenticabile»; non certo dannunzianamente, ma «nella pietà segreta, nell’inconfessabile tremore del poeta» (Raboni). Come in Seneca, Fedra confessa il suo amore direttamente all’efebo; e Ippolito, trasformato in amante e cortigiano, come da tradizione rifiuta le profferte incestuose e viene calunniato davanti al padre. Questi scaglia la sua maledizione, ma Fedra lo scongiura di risparmiare il figlio, salvo poi apprendere da Tèseo dell’amore del giovane per Aricia e gelosa tramare contro di lei. Così, di fronte al cadavere dell’amato per sempre perduto, ella sceglie il suicidio utilizzando il veleno che Medea ha portato ad Atene.
Una Phaedra pubblica nel 1866 anche Swinburne, nella prima serie dei Poems and ballads. L’eroina è ora una donna senza scrupoli, dalla dilagante e sfrenata forza erotica, secondo una fenomenologia delle passioni più accese e violente che certo non è nuova nell’opera del poeta inglese; e violento è lo stesso linguaggio della donna. Le consonanze con la tragedia di d’Annunzio, per strategia narrativa e tono, sono tali che questi viene accusato di plagio in un duro articolo di Gian Pietro Lucini.
Opera tutta novecentesca, la Fedra dannunziana vive in realtà della sua arte combinatoria e della capacità di contaminare tradizione e innovazione nei diversi elementi che la compongono: nei toni come nelle scelte narrative, nella lingua come nella caratterizzazione dei personaggi. Da un lato l’intreccio tragico recupera personaggi ed episodi maggiori, dall’altro inventa motivi e circostanze senza precedenti. Pensiamo ad esempio a Tèseo e Ippolito. Assente da casa al principio di tutte le Fedre, Tèseo si trova ora nell’Ade con Piritoo, ora, sempre con questi, in Epiro per aiutare l’amico a rapire la moglie del re; ora è in esilio a espiare la sue efferatezze contro rivali politici ora infine, in d’Annunzio, a Tebe per riscattare i cadaveri dei sette eroi defunti. Ovunque, se si eccettua Euripide, ha un passato da stupratore; anche nel giansenista Racine, in cui pure si accenna, fra le sue varie imprese, a quella che lo vede coinvolto nel rapimento di Elena di Sparta. Giovane, bello e avventuroso, l’Ippolito euripideo è il casto amante della caccia, allevato al costume degli orfici. Solo in Racine, in cui per la prima volta viene meno l’insensibilità amorosa che costituisce il fulcro del dramma euripideo, egli sente la forza d’amore e la confessa ad Aricia. Non certo innamorato, in d’Annunzio il giovane, perduto ogni carattere efebico e diventato emulo e riflesso del padre, prova desiderio erotico per Ipponoe, la schiava tebana dono di Adrasto, che vorrà sostituire con la bellissima Elena dopo che la gelosa cretese l’ha sacrificata alla notturna Ecate. Personaggio che crea il massimo dissidio fra le attese del pubblico e ciò che accade sul palco, Ipponoe immette nel remake dannunziano elementi propri di Cassandra quale l’ha descritta Eschilo nell’Agamennone. Ripresa e amplificazione del motivo raciniano, ella entra a far parte di temi cari a d’Annunzio, su tutti la rivalità erotica fra donna matura e vergine nel fiore degli anni. Maledetto da Tèseo, Ippolito ora perdona il padre prima dell’ultimo respiro (Euripide) o addirittura gli raccomanda l’amata (Racine), ora è riportato in scena già defunto, tra il pianto di chi non può che lamentarne la perdita e ricomporne le spoglie. A ucciderlo, nella tradizione, è un mostro marino, mentre in Gabriele il responsabile della morte è il cavallo Arione dai muscoli che «guizzano» e la «schiumeggiante onda crinita» dal «negrore di gorgo» e «gonfia d’ira belluina» (vv. 1521-4), con il quale il poeta ripropone in chiave di assoluta modernità il mito acquoreo della tradizione, ora recuperando tessere del passato alcionio, dall’Onda all’Ippocampo, ora presentendo centauri e motori del vicino futurismo (Andreoli). Invenzione dannunziana è anche Eurito, creatura composita memore di Eschilo e Euripide, di Virgilio e Dante. Innamoratosi di Fedra, divenuto per suo amore aedo, egli è soprattutto il portavoce del poeta, che vi si identifica. Al suo fianco c’è Chèlubo, il pirata fenicio che ripropone la figura del mercatante della Francesca da Rimini: egli porta con sé prodotti preziosi e inconsueti, nonché un rimedio pratico per l’insonnia della tormentata Fedra; vanta la sua esperienza per terre e mari, descrive imprese e luoghi, è a sua volta alter-ego dannunziano, interprete inedito e fedele dei fondamenti della sua vita e ulisside che conosce popoli e luoghi per esperienza diretta. Ma fra le tante varianti del racconto, «microtessere formali spesso fedeli fino alla parafrasi delle fonti» in mezzo alle quali sta lo stesso poeta, «secondo la pratica consueta dell’autocitazione», una macrovariante spicca su tutte e prima di tutte e costituisce verosimilmente il più importante dei mutamenti introdotti da d’Annunzio per «rinnovare il soggetto» tragico: il cambiamento dello statuto di genere, con un’inedita contaminatio tra epopea e dramma (Gibellini).
Contenuto e struttura
La tragedia si apre con l’enigma, posto nel frontespizio, che poi Fedra rivolgerà alla schiava tebana Ipponoe alla fine del primo atto. Ogni atto è preceduto dalla citazione dal Filottete di Eschilo: «Ω ΘΑΝΑΤΕ ΠΑΙΑΝ» (o morte risanatrice).
Atto I (totale vv. 1229). Trezene, davanti alla reggia di Tèseo re di Atene. Le madri dei sette eroi caduti sotto le mura di Tebe nel corso della battaglia contro Eteocle si sono recate in città come supplici per scongiurare Tèseo di recuperare i corpi dei figli. Con loro, in scena, c’è Etra, madre del «domatore di centauri». Tutte attendono che le navi ateniesi tornino dalla loro spedizione (vv. 1-83).
Dalle stanze interne della reggia, si avverte la voce della nutrice Gorgo che chiama Fedra. Le ancelle, nella funzione di coribanti, percuotono il bronzo per coprire i lamenti di Fedra tormentata dalla passione amorosa e alleviarne la pena. Le supplici equivocano e scambiano quei suoni per un presagio funesto: Tèseo è forse morto durante le sua missione? Ai lamenti delle supplici, Fedra esce dalla reggia e infastidita si reca presso di loro per fugare l’equivoco (vv. 83-161). Intanto Gorgo annuncia il prossimo arrivo di un messaggero «coronato con segno di vittoria» (v. 163). Fedra prosegue il suo scontro verbale con una delle supplici, la madre di Ippomedonte: questa è paga nel suo dolore perché potrà piangere sull’urna contenente le ceneri del figlio, ma per il male che tormenta Fedra sembra non esserci rimedio (vv. 164-281).
Giunge finalmente il messo, Eurito d’Ilaco, auriga del carro dell’eroe Capanèo, che sulle mura di Tebe ha osato sfidare il padre degli dèi ed è stato da questi folgorato (vv. 282-326). Fedra ascolta con attenzione il racconto e se ne dice appagata. Eurito prosegue, mentre la cretese è sempre più coinvolta dalle esaltanti parole che ascolta (vv. 327-421). Eurito, rivolgendosi ora direttamente ad Astinome madre di Capanèo, riferisce che Tèseo, dopo aver riscattato i corpi dei sette eroi, ha dato loro giusta sepoltura secondo la legge di tutta l’Ellade. Il suo resoconto riprende poi il filo interrotto: durante il rogo dei cadaveri è giunta anche Evadne, che si è autoimmolata in un eroico sacrificio ierogamico gettandosi sulle fiamme del marito Capanèo: Fedra è sempre più rapita dalle parole del messo, sembra rivivere di persona in una visione le azioni narrate ed è come la Musa che ispira l’aedo al canto (vv. 422-602).
Eurito, prima di seguire le supplici verso le urne dei figli, annuncia che Adrasto re di Argo, che ha condotto la guerra a Tebe contro Eteocle, ha portato tre doni a Ippolito: il cavallo semidivino Arione, un cratere d’argento e una schiava tebana, Ipponoe; e Fedra, colta da sùbita gelosia, pretende di incontrare la schiava: ha già deciso di sacrificarla agli dèi inferi, contravvenendo alle leggi che regolano il rito. Intanto, le appare Afrodite per tormentarla ed ella, memore della maledizione della dea contro la stirpe del Sole, le si scaglia contro con il suo ago crinale (vv. 667-870).<
Giunge Gorgo recando con sé la schiava, mentre sull’Acropoli e nel porto divampa un incendio. Il duello verbale tra la cretese e Ipponoe si fa sempre più acceso, finché quest’ultima non si rende conto delle vere intenzioni di Fedra, che col suo ago crinale la sgozza e sacrifica a Ecate e agli dèi inferi(vv. 871-1220).
Atto II (totale 1447 vv.). All’interno della reggia trezenia, Fedra parla con Eurito, da poco iniziato aedo, e ordina a un’ancella di preparare per lui una corona con i rami dei vicini cipressi. Eurito scopre il suo amore alla cretese, ma questa arde di passione per il figliastro e invoca la medicina del sonno (vv. 1221-1383).
Annunciato dal latrato dei suoi cani, Ippolito torna dal suo tentativo di domare Arione. La sua attenzione è tutta per Eurito: a lui racconta la sua lotta con il cavallo semidivino, mentre Fedra ascolta tra l’eccitazione e la preoccupazione. L’efebo rivela che i suoi sogni sono in realtà divenuti ancor più grandi: egli, deciso a emulare il padre, vuole la gloria che nasce dalla imprese eroiche e dalla guerra; a nulla serve il tentativo di Fedra di corromperlo con l’offerta del regno del padre Minosse; Ippolito è già proiettato all’impresa organizzata da Tèseo e Piritoo: recarsi a Sparta per rapire la bellissima Elena, compenso per la perdita di Ipponoe. La gelosia mai sopita di Fedra arde più forte: sia fatto entrare il pirata fenicio, Chèlubo, giunto a Trezène, tra le cui mercanzie ella potrà trovare un farmaco per il suo dolore (vv. 1384-1693).
Mentre offre le sue preziose merci, frutto delle numerose scorrerie piratesche, Chèlubo ricorda di aver visto Elena danzare nuda fra i cadaveri di efebi sgozzati nell’altare della sanguinaria Artemide Ortia; passa poi in rassegna i tanti possedimenti del re di Creta, già offerti da Fedra al figliastro. Il cui pensiero, però, è tutto proteso alle future imprese di gloria, a cominciare dal tentativo finora fallito di domare Arione. Le preoccupazioni di Fedra non lo distolgono dai suoi propositi. La cretese, intanto, si fa consegnare dal pirata del nepente, un sonnifero, e dell’aconito, un veleno (vv. 1694-2049).
Eurito e Chèlubo lasciano la scena. Ippolito, che si è assopito, sogna Elena e nel dormiveglia ne pronuncia più volte il nome; Fedra, in ascolto, è di nuovo morsa dalla gelosia. Improvvisamente, si avvicina al figliastro e lo bacia sulla bocca, rivelando nel gesto il suo amore (vv. 2050-2105). Al risveglio, Ippolito è sconvolto e respinge con forza le profferte della matrigna, la quale gli chiede di ucciderla con la sàgari lasciatagli dalla madre amazzone e che il giovane porta sempre con sé. Nel respingerla, Ippolito si scaglia contro la sua natura di cretese sorella del Minotauro, suscitando una riposta risentita: Tèseo ha una natura diversa da quella cui crede il figlio; egli anzi ha ucciso l’amazzone madre di Ippolito e ha ingannato Arianna, seducendola e uccidendone il fratello mostruoso per poi abbandonarla in un’isola; ha rapito e sottoposto allo stupro anche Fedra, ancora giovanissima. Ippolito, incredulo e sconvolto, fugge lasciando cadere a terra la sua sàgari (vv. 2106-2446).
All’arrivo di Tèseo, Fedra accusa l’efebo di averla stuprata: la sàgari che giace a terra ne è la prova. Il domatore di centauri, in preda all’ira, invoca Poseidone: adempia il suo voto, provocando la morte del figlio (vv. 2446-2667).
Atto III (totale vv. 554). Ambientato sulla spiaggia tra la «marina di Limna» e «la radice della rupe trezenia», l’atto si apre su una scena dominata da un lato dal cadavere di Ippolito, steso a terra e coperto dal vello di un leone, pianto da Etra, Tèseo, Eurito e dagli efebi, dall’altro dalla pira dove ancora arde ciò che resta del toro bianco che lo stesso Ippolito ha voluto sacrificare a Poseidone. Etra, resa ormai veggente dal dolore e incapace di piangere, rivolge al nipote defunto una toccante trenodia (vv. 2668-2715). Gli efebi guidati da Procle chiedono a lei e a Tèseo di poter lavare il cadavere e prepararlo all’ultimo rito; a Eurito viene invece chiesto di narrare le ultime gesta del giovane eroe: nel corso del sacrificio del toro bianco, Arione è imbizzarrito e ha trascinato in una furiosa galoppata verso il mare anche Ippolito; i due sembravano una sola entità nella furiosa lotta fra le onde, ma il cavallo alla fine ha prevalso, provocando la morte del giovane, gli ha lacerato il ventre e ne ha sbranato gli inguini (vv. 2716-2941).
Commosso dal racconto, Tèseo confessa di essere lui il vero responsabile della morte del figlio, maledetto di fronte a Poseidone (vv. 2942-2990).
All’improvviso, sul suo carro, giunge Fedra e sul cadavere dell’amato rivela la verità: Ippolito è puro e incolpevole, è stata lei a calunniarlo. A Etra e Tèseo che le rivolgono sprezzanti parole di odio, la donna si rivolge con pari sprezzo e inaudita fierezza, rivendicando la nobiltà delle sue origini e del suo destino, ormai libera dal «servaggio degli dei», libera nella morte di amare Ippolito, che «velato all’Invisibile» può portare con sé. Nulla può fare contro di lei neppure le dea Artemide, che compare minacciosa e impotente di fronte a un Fedra «indimenticabile» e vittoriosa nell’abbracciare la «bella morte» che si è scelta.
Stile e interpretazioni
Fedra è opera di parola più che azione, di racconti più che di rappresentazioni, caratterizzata com’è da diversioni descrittive e narrative, da numerosissimi dettagli mitologici, geografici, etnografici e onomastici ellenici secondo un «feticismo» tutto dannunziano «per le minuzie» (Caliaro) e un gusto per il preziosismo che simula e dissimula le svariate fonti cui il poeta ha attinto. A cominciare già dall’enigma sfingeo a triplice scansione che la protagonista rivolge a Ipponoe, posto sul frontespizio e citazione di un epigramma anonimo tratto dall’Antologia Palatina, IX, 449 (Accardi); o ancora dall’exergo posto all’inizio di ogni atto, ricavato da un verso del perduto Filottete eschileo che Gabriele riprende dai Tragicorum graecorum fragmenta collezionati da August Nauck.
Tra le fonti più immediatamente individuabili, ci sono certo i tragediografi greci, a cominciare da Sofocle, che col suo Edipo re presta il motivo dei rami di ulivo in mano alle supplici, ed Eschilo, con le Supplici appunto, da cui Gabriele recupera il rituale funebre che accompagna al rogo i sette eroi morti a Tebe, mentre Euripide, con la tragedia omonima, è utilizzato per la macrosequenza narrativa iniziale. Ancora Eschilo, questa volta coi Sette contro Tebe, fornisce tutti i materiali tratti dalla saga tebana (i sette eroi, le loro madri, Capanèo ed Evadne, il re d’Argo …), mentre l’Agamennone è utilizzato al fianco dell’Ifigenia euripidea per la costruzione del personaggio di Ipponoe. Si noti però che d’Annunzio legge queste due ultime opere nella versione francese di Leconte de Lisle e con commento di Paul de Saint-Victor.Svariate sono le fonti greche antiche: Apollodoro (Biblioteca), Diodoro Siculo, Senofonte (con il Cinegetico e l’Ipparco), Plutarco (Vita di Teseo), Paolo Orosio (con le Storie lette nel volgarizzamento di Bono Giamboni), Strabone (Geografia), Erodoto (Storie), Silio Italico, Nonno di Panopoli, lirici e innografi vari (ma in particolare Pindaro), Plinio il Vecchio (Naturalis historia). Su tutti, maggior rilievo ha Pausania con la Periegesi, consultata e citata sia nella traduzione italiana di Sebastiano Ciampi sia nella latina di Ludwig August Dindorf.
Di importanza non minore per la ricostruzione del mondo greco, sono storici e antropologhi moderni, soprattutto francesi (Caliaro; Andreoli): Paul Decharme, con la Mythologie de la Grèce antique, presta informazioni utili per la scena dell’immolazione di Ipponoe; Elena è invenzione mediata da Plutarco, letto però assieme col Voyage de Sparte di Maurice Barrès, mentre la reggia di Tèseo a Trezene è ricostruita tenendo sottomano il baedecker di Charles Diehl Excursions Archéologique en Grèce, letto assieme a Heinrich Schliemann (Tirynthe), Arthur Evans (The Micenean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean Relations), Salomon Reinach (Répertoire de la statuaire greque et romaine e Cultes, mythes et religions), Gabriel Thomas (Ètudes sur la Grèce. Beaux-arts, les sites et la population) ed Angelo Mosso (Escursioni nel Mediterraneo). Spesso, inoltre, i moderni sono collettori di fonti, ed è soprattutto in questo senso che viene utilizzato, con abbondanza di riprese, Victor Bérard autore di Les Phéniciens et l’Odyssée.
Discorso a parte meritano due autori letti sia in originale sia mediati da volgarizzamenti e traduzioni, come mostrato da numerose carte preparatorie conservate in APV, ms: Omero e Ovidio. Il primo rivive in tessere carpite dalle versioni di Ippolito Pindemonte, Paolo Maspero, Vincenzo Monti, Victor Bérard e soprattutto Giovanni Pascoli, che in Epos, Sul limitare e Poemi conviviali ha già mostrato inedita capacità di immedesimazione nell’antichità mitologica; alle Metamorfosi del secondo d’Annunzio attinge soprattutto attraverso il volgarizzamento medievale di ser Arrigo Simintendi da Prato, che consente all’autore novecentesco di raggiungere quella langue totalmente ricreata che è sua cifra stilistica e linguistica, nonché strumento privilegiato per conferire un più profondo spessore psicologico ai suoi personaggi. Con attenta auscultazione e compulsazione di testi antichi e moderni, in versi e in prosa, Gabriele muove anche alla ricerca, oltre che delle consuete invarianti (Andreoli), di toni e sfumature musicali in grado di far risuonare un particolare stato d’animo creativo o colorire un dato ambiente storico e geografico. Immagini, tessere lessicali, sintagmi e suoni vengono sottratti dal contesto di partenza e ridistribuiti nel testo di arrivo, in un processo compositivo che pare situarsi a valle del lavoro di natura erudita e archeologica vòlto invece al recupero delle fonti documentarie. In entrambi i casi, quella di d’Annunzio si conferma una filologia d’artista garante della cura straordinaria nell’ideazione di una base concreta e reale del mito di Fedra, poggiato sul contesto culturale più specifico possibile. Con una sinergica contaminatio tra antico e moderno, il poeta approda così a un modernissimo mosaico le cui «pietruzze» sono scavate in un secolare strato di cultura.
Attraverso di esso, d’Annunzio procede a realizzare un’altra tragedia superomistica del sacrificio e del destino, sulla scia di Più che l’amore e soprattutto della Nave. Anche l’eroina cretese infatti giunge a comprendere che l’unica via per sfuggire al destino è abbracciarlo scegliendo l’autoimmolazione; anche lei, così agendo, è figura dell’Übermensch, la cui derivazione da Nietzsche e dal suo Così parlò Zarathustra (o meglio, con tutta probabilità, dall’Ainsi parlait Zarathoustra nella versione francese di Henri Albert, da cui il drammaturgo attinge e traduce), è confermata da alcuni appunti dell’APV, ms. 16643, con stralci da un capitolo del primo libro intitolato De la mort volontaire, attraverso cui d’Annunzio può rileggere le vicende degli eroi tragici con le parole del profeta nietzschiano e le sue riflessioni sulla «bella morte» che, si leggerà nelle Faville del maglio, «compisce» e «pei viventi è uno stimolo e una promessa».
Con Fedra, dunque, d’Annunzio torna a orientare le sue strategie narrative privilegiando il superomismo di protagonisti che, con loro istinto alla ribellione, si scoprono pronti alla suprema affermazione negando se stessi con un atto la cui purezza niente e nessuno può scalfire. Come già Basiliola della Nave, Fedra è «superfemmina» in tutta la sua volontà di potenza: nel rifiuto dei valori prestabiliti, nell’orgoglio della propria eccezionalità, nel desiderio di dominare le più svariate possibilità realizzando la propria esistenza come possibilità infinita.
Bibliografia essenziale
Edizione critica di riferimento:
Gabriele d’Annunzio, Fedra, edizione critica e commentata a cura di Edoardo Ripari, Gardone Riviera, Il Vittoriale degli Italiani («Edizione nazionale delle Opere di d’Annunzio), 2024: https://edizionedannunzio.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/03/dan-fedra-ripari-completo.pdf.
Edizioni apparse in vita:
Gabriele d’Annunzio, Fedra, Milano, Treves, 1909 (editio princeps).
Gabriele d’Annunzio, Fedra, Milano, Treves, 1919.
Gabriele d’Annunzio, Fedra, Milano, Treves, 1922.
Gabriele d’Annunzio, Fedra, Milano, Treves, 1927.
Gabriele d’Annunzio, Fedra, Verona, Bodoni (Mondadori), 1928 (Istituto Nazionale per l’Edizione di Tutte le Opere di Gabriele d’Annunzio).
Gabriele d’Annunzio, Fedra, Roma, Per l’Oleandro, 1937.
Edizioni commentate:
Gabriele d’Annunzio, Fedra, a cura di Pietro Gibellini, Milano, Mondadori, 1986.
Gabriele d’Annunzio, Fedra, introduzione di Pietro Gibellini, a cura di Tiziana Piras, Milano, Mondadori, 2001.
Gabriele d’Annunzio, Fedra, in Tragedie, sogni, misteri, 2 voll., a cura di Annamaria Andreoli, con la collaborazione di Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori («Meridiani»), 2013, vol. II, pp. 367-525.
Bibliografia secondaria:
Giuseppe Fulvio Accardi, L’enigma di Fedra. Sulla poetica drammaturgica d’una citazione dannunziana, «Rivista di letterature moderne e comparate», vol. LXIX, n.s., fasc. 1, gennaio-marzo 2016, pp. 43-54.
Stefano Amendola, Presenza e rappresentazione del divino tra Euripide e d’Annunzio: Afrodite e Artemide nel dramma di «Fedra», in Lorenzo Resio (a cura di), D’Annunzio e l’innovazione drammaturgica, «Sinestesie», n. 24, 2022, pp. 353-370.
Giorgio Bàrberi Squarotti, Lo spazio della diversità: la Fedra, in D’Annunzio e il classicismo, «Quaderni del Vittoriale», IV, 23 (settembre-ottobre 1980), pp. 115-41.
Ilvano Caliaro Fonti della «Fedra» dannunziana, «Quaderni dannunziani», 5-6. (1989), pp. 117-134
Ilvano Caliaro, Nell’officina della «Fedra», in Id., D’Annunzio lettore-scrittore, Firenze, Leo Olschki editore, 1991, pp. 11-60.
Michel David, Mito e tragedia di Fedra nella letteratura psicanalitica, in Fedra da Euripide a d’Annunzio. D’Annunzio a Harvard, «Quaderni dannunziani», 5-6 (1989), Milano, Garzanti, 1990, pp. 9-46.
Dario Del Corno, Sull’«Ippolito di Euripide, in Fedra da Euripide a D’Annunzio, cit., pp. 47-50.
Angelo Fàvaro, Una rilettura della “Fedra” dannunziana: l’incomprensione dell’eroe nella tragedia della passione, «Fragmentos», n. 36, giugno 2009, pp. 27-42.
Maria Rosa Giacon, D’Annunzio epistolografo. Per una fonte pascoliana della «Fedra», in Ead., I voli dell’Arcangelo. Studi su D’Annunzio, Venezia ed altro, Piombino, Il Foglio, 2009, pp. 312-361.
Francesco Giancotti, Profilo della «Fedra» di Seneca (con raffronti dannunziani, specie in rapporto al finale), in Fedra da Euripide a d’Annunzio, cit., pp. 51-75.
Pietro Gibellini, Gabriele e Fedra, in Id., Dal gesto al testo, Milano, Mursia, 1995, pp. 112-137.
Marziani Guglielminetti, La «Fedra» di d’Annunzio e le altre Fedre della tradizione classica, «Atti delle giornate di studio su Fedra», Torino, 7-8-9 maggio 1984, Torino, Edizione della Regione Piemonte, 1985, pp. 85-97.
Gian Pietro Lucini, L’indimenticabile risciacquatura delle molte «Fedre», «Ragione», 27 giugno 1909.
Gianni Oliva, La guerra per la Fedra rivisitata, in D’Annunzio. Tra le più moderne vicende, Milano, Bruno Mondadori, 2017, pp. 143-157.
Gianni Oliva, Da Roma antica al Vittoriale. Fedra dalle Heroides a d’Annunzio, in Id., I luoghi delle parole. Geografie letterarie dopo l’unità, Milano, Bruno Mondadori, 2020, pp. 127-141.
Massimo Pavan, Modelli strutturali e fonti della mitologia greca nella «Fedra» di G. d’Annunzio, in D’Annunzio e il classicismo, Atti del Convegno, Gardone Riviera, 20-21 giugno 1980, «Quaderni del Vittoriale», settembre-ottobre 1980.
Giovanni Raboni, Introduzione a J. Racine, Fedra, trad. it. di G. Raboni, apparati e note di R. Held, Milano, BUR, 2022
Edoardo Ripari, D’Annunzio, Fedra e un volgarizzamento ovidiano, «Archivio d’Annunzio», 10, 2023, pp. 105-122.
Edoardo Ripari, D’Annunzio, Etra e una trenodia fra fonti antiche e moderne, «Per leggere», 23, n. 45, 2023, pp. 85-100.
Carlo Santoli, Fedra di d’Annunzio. Dall’Ellade all’interpretazione del mito, prefazione di Annamaria Andreoli, Venezia, Marsilio, 2019.
Renato Simoni, L’origine e il significato della Fedra dannunziana. Una conversazione col Poeta, «Corriere della Sera», 9 aprile 1909, poi in Gianni Oliva (a cura di), Interviste a D’Annunzio (1895-1938), Lanciano, Carabba, 2002, pp. 137-51.
>Valentina Valentini, La Fedra: un labirinto senza Minotauro e senza fili d’Arianna, in Ead., Il poema visibile. Le prime messe in scena delle tragedia di Gabriele d’Annunzio, Roma, Bulzoni, 1993.