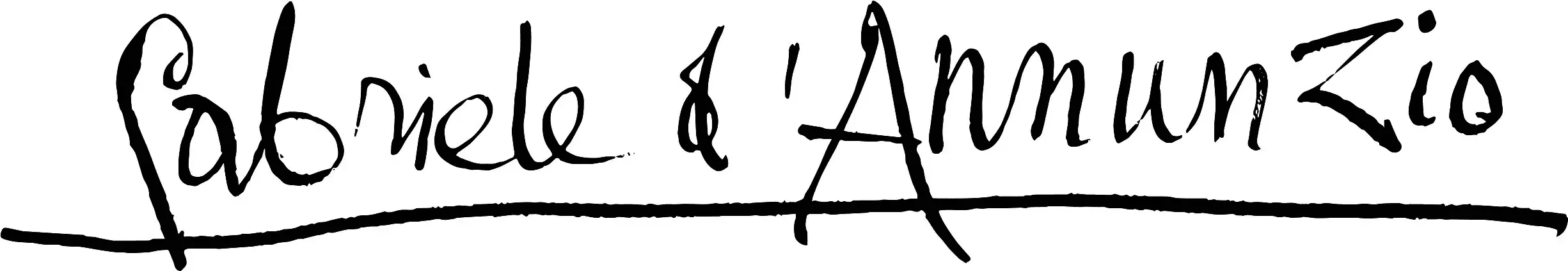di Cecilia Gibellini, Enciclopedia dannunziana
Il Leonardo decadente della Chimera e del Piacere
La figura e l’opera di Leonardo da Vinci percorrono tutta la produzione dannunziana: la rappresentazione e la reinvenzione del genio rinascimentale nell’opera del nostro autore evolvono nel tempo, in una vicenda affascinante all’interno della quale è possibile mettere a fuoco alcuni momenti di svolta.
La prima fase è quella strettamente legata alla cultura tardoromantica e decadente europea: il d’Annunzio degli anni Ottanta prende le mosse dal mito leonardesco, così come era stato elaborato da autori inglesi, come Walter Pater, e soprattutto francesi come Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Alfred Dumesnil, Hyppolite Taine, Maurice Barrès e Joséphin Péladan. Contrassegno della bellezza leonardesca è l’ambiguità, che si polarizza in due motivi di grande fortuna: quello dell’ambiguità sessuale e dunque dell’Androgino, indicato da Péladan come sesso artistico per eccellenza, incarnato soprattutto dal San Giovanni del Louvre, e quello della bellezza medusea, misto di dolcezza e crudeltà, affascinante e terribile al tempo stesso; e qui i testi figurativi chiamati in causa sono soprattutto la Gioconda e la Medusa degli Uffizi, in realtà un apocrifo, dal momento che si tratta di opera fiamminga del Seicento, ma all’epoca attribuita a Leonardo e già cantata da Percy Bysshe Shelley (On the Medusa of Leonardo da Vinci in the Florentine Gallery, 1819).
Le quartine di Gorgon, composte nel 1885 e poi confluite nella Chimera, sono dedicate a una figura femminile che avrebbe il suo archetipo in Leonardo – attraverso il filtro di Paul Bourget (Heures de regret, II, 7-8; in Au bord de la mer, 1872):
Ne la bocca era il sorriso
fulgidissimo e crudele
che il divino Leonardo
perseguì ne le sue tele.
Quel sorriso tristamente
combattea con la dolcezza
de’ lunghi occhi e dava un fascino
sovrumano a la bellezza
de le teste feminili
che il gran Vinci amava […].
(La Chimera, Gorgon, vv. 5-14; in Versi d’amore e di gloria, vol. I, p. 467)
L’immagine gorgonica, modulata sul contrasto sorriso-sguardo-chioma, si fonde con quella dell’androgino nelle terzine dedicate Al poeta Andrea Sperelli, dunque all’alter ego dell’autore, che chiudono La Chimera. La «creatura bella ed omicida» amata dal poeta viene gradualmente a identificarsi, come segnala Tosi (2012, pp. 855-941), con la Gioconda leonardesca:
E anch’ella simigliava oscuramente
l’Essere ambiguo, il prodigioso Mito
che Leonardo amò ne la sua mente.
Ell’era l’ideale Ermafrodito,
era il pensato Andrògine. Lo sguardo
suscitava un affanno indefinito,
mordeva il cuore, acuto come un dardo;
senza mai tregua, né tristi né liete
sorridevan le labbra… O Leonardo,
insonne Prometèo, sottile Ermète,
bel semidio, quali Anime divine
chiudesti ne le tue Forme segrete?
Una di quelle mute anime al fine
un giorno mi parlava d’improvviso;
Anima con pupille sibilline,
Anima con le labbra e con un riso,
un riso inestinguibile ed esiguo,
che le labbra effondean per tutto il viso.
Intento mi guardò l’Essere ambiguo.
Dietro il suo capo risplendea lontano
sotto un ciel dolce un bel paese irriguo.
Mi guardò e mi disse: – In vano, in vano,
Giovine, t’affatichi a penetrarmi.
Il mio grande segreto è sovrumano.
Il tuo desire è contro me senz’armi.
Non giunge fino a me la tua preghiera.
Vincermi tu non potrai, né puoi stancarmi.
Io son la Sfinge e sono la Chimera.
O tu che sogni, qui ne le mie dita
la trama del tuo sogno è prigioniera.
O che tu soffri, io so la tua ferita.
Ma nulla più mi turba e più m’accora.
Io conosco le leggi de la Vita.
Io guardo in me. Le tènebre ch’esplora
Il mio sguardo profondo, internamente,
m’attraggon più d’ogni più bella aurora.
Che è l’aurora? Che è mai l’ardente
spira de li astri, il mar blando e feroce?
Io guardo in me con le pupille intente.
Sola io contemplo, sola e senza voce,
un mar che non ha fondo e non ha lido.
O tu che soffri, il tuo soffrire è atroce;
ma non saprai giammai perché sorrido.
(La Chimera, Al poeta Andrea Sperelli, vv. 43-85; in Versi d’amore e di gloria, pp. 588-590)
I confini dell’ekphrasis si dilatano dapprima per evocare la figura di Leonardo, artefice divino assimilato a Prometeo ed Ermete (nel solco dell’immagine di un Leonardo alchimista e mago divulgata a metà Ottocento da Alfred Dumesnil), quindi per dare voce alla donna del dipinto, che si anima secondo un altro fortunato topos romantico-decadente. La figura femminile, proiettata in un’aura sovrumana, circonfusa di mistero, diventa irraggiungibile; e alla fusione di genere connessa alla sua androginia si aggiunge anche un divino imbestiamento, che aggiunge alla donna-serpente della Medusa la donna-leonessa della Sfinge e la triforme Chimera: un oggetto del desiderio «impenetrabile» e dunque perennemente concupito, in linea con la sindrome del dongiovanni Andrea (e Gabriele).
Si ricordi che alcuni anni più tardi, nella Gioconda (1898), la tragedia che dichiara già nel titolo la derivazione leonardesca del personaggio di Gioconda Dianti, musa conturbante e fatale, il ‘capolavoro’ realizzato da Lucio Settala, e per salvare il quale la nobile Silvia sacrificherà le proprie mani, rappresenterà la bellissima donna proprio in forma di Sfinge. Nel Piacere, tratti leonardeschi sono assegnati a Elena Muti, la cui ambiguità evoca da principio la Medusa:
Quelle cose frivole o maligne uscivano dalle stesse labbra che allora allora, pronunziando una frase semplicissima, l’avevan turbato fin nel profondo; uscivano dalle stesse labbra che allora allora, tacendo, eragli parsa la bocca della Medusa di Leonardo, umano fiore dell’anima divinizzato dalla fiamma della passione e dall’angoscia della morte. «Qual era dunque la vera essenza di quella creatura? Aveva ella percezione e conscienza della sua metamorfosi costante o era ella impenetrabile anche a sé stessa, rimanendo fuori dal proprio mistero?». (Il piacere, p. 57)
A un altro ritratto vinciano, quello della giovane amante di Ludovico il Moro che si riteneva fosse ritratta nella Belle Feronnière, è paragonata Elena mentre ascolta le note di Beethoven, con l’indecifrabile contrasto tra il sorriso delle labbra e la tristezza dello sguardo:
Quasi constretta dal soverchiante desiderio del giovine, Elena si volse un poco; e gli sorrise d’un sorriso così tenue, direi quasi così immateriale, che non parve espresso da un moto delle labbra, sì bene da una irradiazione dell’anima per le labbra, mentre gli occhi rimanevan tristi pur sempre, e come smarriti nella lontananza d’un sogno interiore. Eran veramente gli occhi della Notte, così inviluppati d’ombra, quali per una Allegoria avrebbeli forse imaginati il Vinci dopo aver veduta in Milano Lucrezia Crivelli. (Il piacere, pp. 73-74)
La più ampia emergenza della memoria vinciana si inscrive nella riflessione sulla misteriosa dialettica tra carne e spirito che segna il rapporto amoroso tra Elena e Andrea:
Questa «spiritualizzazione» del gaudio carnale, causata dalla perfetta affinità dei due corpi, era forse il più saliente tra i fenomeni della loro passione. Elena, talvolta, aveva lacrime più dolci dei baci.
E nei baci, che dolcezza profonda! Ci sono bocche di donne le quali paiono accendere d’amore il respiro che le apre. Le invermigli un sangue ricco più d’una porpora o le geli un pallor d’agonia, le illumini la bontà d’un consenso o le oscuri un’ombra di disdegno, le dischiuda il piacere o le torca la sofferenza, portano sempre in loro un enigma che turba gli uomini intellettuali e li attira e li captiva. Un’assidua discordia tra l’espression delle labbra e quella degli occhi genera il mistero; per che un’anima duplice vi si riveli con diversa bellezza, lieta e triste, gelida e passionata, crudele e misericorde, umile e orgogliosa, ridente e irridente; e l’ambiguità suscita l’inquietudine nello spirito che si compiace delle cose oscure. (Il piacere, pp. 108-109)
A questo punto interviene la menzione di Leonardo, in coppia con Botticelli, l’autore prediletto dal gusto dei preraffelliti cui tanto deve il d’Annunzio di questi anni, in nome di una comune maestria psicologica svolta con lo strumento della pittura:
Due quattrocentisti meditativi, perseguitori infaticabili d’un Ideale raro e superno, psicologi acutissimi a cui si debbon forse le più sottili analisi della fisionomia umana, immersi di continuo nello studio e nella ricerca delle difficoltà più ardue e de’ segreti più occulti, il Botticelli e il Vinci, compresero e resero per vario modo nell’arte loro tutta l’indefinibile seduzione di tali bocche. (Il piacere, p. 109)
Nel Trionfo della morte (1894), il romanzo che chiude la trilogia della Rosa, il riso enigmatico di Monna Lisa passa in secondo piano, e Leonardo è evocato come paesista, nel passo legato alla Basilica di San Clemente a Casauria:
Cingevano la valle quieta due corone: la prima di colli tutti a vigne e ad olivi, la seconda di rocce nude e aguzze. Ed era nello spettacolo, secondo il detto di Demetrio, qualche cosa di simile al sentimento oscuro che anima quella tela di Leonardo, ove sopra un fondo di rupi desolate ride una donna affascinante. Ed anche, a rendere più acuta l’ambiguità che li turbava entrambi, sorgeva da una vigna remota un canto, preludio della vendemmia precoce; e dietro di loro rispondeva la litania dei pellegrini che riprendevano il viaggio. E le due cadenze, la sacra e la profana, si confondevano… (Trionfo della morte, p. 860)
Trasposta dalla figura umana al paesaggio, l’ambiguità si precisa ora come misterioso contatto tra sacro e profano.
Il Leonardo apocrifo delle Vergini delle rocce
Un maggior tasso di originalità nell’appropriazione e nella rielaborazione della figura e dell’opera leonardesca è ravvisabile nelle Vergini delle rocce (1895), il romanzo-poema che porta il titolo del celebre dipinto vinciano, e che è tutto pervaso da un’atmosfera leonardesca, come già nel 1949 notava Bianca Tamassia Mazzarotto:
Paesaggi incantati e spettrali su cui risaltano meglio a contrasto le tre soavi figure femminili dalla grazia declinante, dalle nuche curvate sotto il peso delle folte capigliature, dalle bocche curvate sul silenzio delle anime gonfie di chiuse essenze inesauste, dalle palpebre chine a velare un troppo intenso sguardo interiore. Figure che sembran tutte trattate dal pennello di Leonardo, dal suo più suggestivo chiaroscuro fumoso. (Tamassia Mazzarotto 1949, p. 411)
La promozione in primo piano della cifra leonardesca, corroborata dall’attenta lettura del Léonard de Vinci di Gabriel Séailles (1892), trova conferma nei taccuini coevi, in cui d’Annunzio comincia a registrare le sue impressioni di spettatore dinanzi ai capolavori vinciani (cfr. Granatella 1982), e insieme quelle del lettore che inizia a conoscere ed apprezzare gli scritti di Leonardo.
Nel romanzo, la dialettica leonardesca carne-spirito è ciò che regge il velleitario disegno di Claudio Cantelmo, quello di rinnovare i valori perduti della civiltà italiana procreando un futuro re di Roma attraverso il connubio con una delle tre sorelle di una stirpe nobile e decaduta. Il sogno di Cantelmo si propone di rispondere ai richiami di un démone socratico (laddove Socrate serve ad affermare la superiorità dell’estetica sull’etica e sulla logica) e dell’insegnamento di Leonardo, che Cantelmo indica come «il Maestro».
Alle suggestioni figurative si aggiungono ora quelle letterarie. Frasi tratte dagli scritti leonardeschi (il Trattato della pittura, i pensieri sulla morale e sulla scienza) sono disseminate lungo tutto il romanzo, e ne innervano la struttura segnando le epigrafi delle sue parti: la prima figura sul frontespizio («Io farò una finzione, che significherà grandi cose»); seguono quelle in testa al Prologo («una cosa naturale vista in un grande specchio»; ma all’interno del Prologo cade anche una seconda citazione, «E il ricettacolo delle virtù sarà pieno di sogni e vane speranze») e ai libri: il primo («Non si può avere maggior signoria che quella di sé medesimo»; «E se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo»); il secondo («Grandissima grazia d’ombre e di lumi s’aggiunge ai visi di quelli che seggono sulle porte di quelle abitazioni che sono oscure…»); il terzo («… a sedere, con le dita delle mani insieme tessute, tenendovi dentro il ginocchio stanco»; «Dov’è più sentimento, lì è più martirio»). Citazioni che poi sono riprese e variate all’interno del romanzo-poema, come nella domanda retorica a proposito di Anatolia: «Non era ella forse la vera custode dell’abitazione oscura?», o nel ritratto di Massimilla: «Ella stava a sedere, con le dita delle mani insieme tessute, tenendovi dentro il ginocchio stanco».
D’Annunzio si prende notevoli libertà, con la vera e propria invenzione di un apocrifo leonardesco, il ritratto dell’immaginario antenato del protagonista, il condottiero rinascimentale Alessandro Cantelmo conte di Volturara, custodito gelosamente da Claudio, che il Vinci avrebbe dipinto nel 1493-94. L’invenzione del quadro immaginario dà modo a d’Annunzio di realizzare una distesa e dettagliata ekphrasis:
Eccolo ancóra dinnanzi a me, eguale sempre e pur sempre nuovo! Un tal corpo non è la carcere dell’anima ma ne è il simulacro fedele. Tutte le linee del volto quasi imberbe sono precise e ferme come in un bronzo cesellato con insistenza; la pelle ricopre d’un pallor fosco i muscoli asciutti, usi per certo a palesarsi con un tremito ferino nel desiderio e nella collera; il naso diritto e rigido, il mento ossuto e stretto, le labbra sinuose ma energicamente serrate esprimono la volontà temeraria; e lo sguardo è come una bella spada, all’ombra d’una capellatura densa e greve e quasi violetta […]. Egli sta in piedi, visibile dal ginocchio in su, immoto […]. «CAVE ADSVM»: ben gli si addice l’antica insegna. Vestito d’un’arme leggerissima, damaschinata certo da un artiere sommo, egli ha le mani ignude: mani pallide e sensitive ma pur con un non so che di tirannico e quasi di micidiale nel lor disegno netto: la sinistra appoggiata su la górgone dell’elsa, la destra contro lo spigolo d’un tavolo coperto di velluto cupo, del quale appare un lembo. Accanto alle manopole e al morioncello, posano sul velluto una statuetta di Pallade e una melagrana che porta sul gambo anche la sua foglia aguzza e il suo fiore ardente. Dietro il capo allontanasi per entro al vano d’una finestra una campagna spoglia terminata da una chiostra di colline su cui si eleva un còno, solo come un pensiero superbo. E in basso, su un cartiglio, leggesi questo distico: FRONS VIRIDIS RAMO ANTIQVO ET FLOS IGNEVS VNO TEMPORE [PRODIGIVM] FRVCTVS ET VBER INEST. (Le vergini delle rocce, pp. 40-41)
In realtà, risulta iconograficamente poco plausibile, per un ritratto leonardesco, sia il taglio dell’effigiato, dal ginocchio in su, sia l’apparato di emblemi e oggetti simbolici – la testa di gòrgone sull’elsa, la statuetta di Pallade, il melograno –, che portano più in direzione della ritrattistica di un Lotto, un Tiziano o un Tintoretto.
L’apocrifo figurativo viene poi corroborato da quelli letterari: per dare consistenza storica alla figura dell’antenato, e per metterla direttamente in relazione con il Maestro Leonardo, D’Annunzio inserisce nel romanzo delle citazioni costruite manipolando i commentari leonardeschi e inserendovi la figura del Volturara (per il quale si ispira probabilmente al personaggio storico di Galeazzo Sanseverino: Tamassia Mazzarotto 1949, p. 413). Claudio immagina il primo incontro avvenuto tra Leonardo e Alessandro a Milano, nel palazzo della favorita di Ludovico il Moro Cecilia Gallerani, «dove gli uomini militari ragionavano di scienza bellica, i musici cantavano, gli architetti e i pittori disegnavano, i filosofi disputavano delle cose naturali, i poeti recitavano i loro e gli altrui componimenti»; anzi, un amore segreto avrebbe legato ad Alessandro Cantelmo la Gallerani – che altri non è se non la leonardesca Dama con l’ermellino oggi custodita a Cracovia.
Dall’opera all’uomo, dall’uomo all’eroe
Nella stagione successiva, quella che dal Fuoco (1900) e attraverso le Laudi (1903) conduce al Forse che sì forse che no (1910) e alle imprese del poeta-soldato, è possibile ravvisare uno spostamento dell’interesse di d’Annunzio dall’opera leonardiana all’uomo Leonardo.
Già nel 1895, la Glosa dell’Allegoria dell’autunno (il discorso effettivamente pronunciato da d’Annunzio per la grande esposizione d’arte veneziana, che poi entrerà nel Fuoco, attribuito a Stelio Effrena) si sofferma sul problema del rapporto tra artista e scienziato, che nella figura di Leonardo è risolto nel senso di una complementarità, anzi di una interdipendenza. Anche nel saggio Dell’arte di Francesco Paolo Michetti (1896, ma risultato della fusione e del rimaneggiamento di due articoli del 1889 e del 1893 già dedicati al pittore abruzzese che all’esposizione veneziana aveva presentato trionfalmente il grande dipinto La figlia di Iorio), D’Annunzio torna a riflettere sulla complessità del genio leonardesco:
Il quattrocentista meditativo che gli stessi contemporanei nomavano Prometeo ed Ermete, appassionato e infaticabile investigator di misteri, psicologo acutissimo a cui si debbon forse le più sottili analisi della fisionomia umana, immerso di continuo nello studio e nella ricerca delle difficoltà più ardue e dei segreti più occulti; l’artefice che disegnando un ramo coperto di foglie scopriva una legge; lo scienziato che studiando l’acqua trovava nelle liquide ondulazioni il movimento delle dolci capigliature prolisse e la linea del sorriso femminile; quegli a me par veramente il divino padre intellettuale […]. (L’allegoria dell’autunno, p. 2260)
Nel romanzo-saggio Il fuoco, il predominio pittorico del colorismo veneto non emargina la memoria di Leonardo, definito da Stelio Effrena, alter ego di d’Annunzio, «maestro incomparabile» (p. 34). Nelle descrizioni di Foscarina sentiamo riaffiorare i tratti di Monna Lisa, pur senza più citazioni esplicite dei testi figurativi leonardeschi: Stelio vede «passare in lei quelle larghe onde di vita, quelle straordinarie espressioni, quelle luci e quelle ombre alterne»; e la donna «sorrideva, sorrideva del suo sorriso infinito, silenziosa» (pp. 284 e 129).
Ma ciò che conta di più è l’incremento nella sintesi teorica e critica (dovuto anche allo stretto legame con Angelo Conti, il Daniele Glauro della finzione romanzesca) nella riflessione sull’artista maieuta. Nella Venezia che d’Annunzio non vede come città del silenzio ma città di vita, Leonardo è l’esempio dell’artista che ne scruta il turbinio:
Bisogna guardare nel turbinio confuso della vita con quello stesso spirito fantastico con cui i discepoli del Vinci erano dal maestro consigliati di guardare nelle macchie dei muri, nella cenere del fuoco, nei nuvoli, nei fanghi e in altri simili luoghi per trovarvi «invenzioni mirabilissime» e «infinite cose». Allo stesso modo, aggiungeva Leonardo, troverete nel suono delle campane ogni nome e vocabolo che vi piacerà d’imaginare. Quel maestro sapeva bene che il caso – come già dimostrò la spugna d’Apelle – è sempre amico dell’artefice ingegnoso. (Il fuoco, pp. 26-27)
Ma Leonardo è anche l’artista maieuta:
Quel Vinci, che ha fitto il suo sguardo in ogni cosa profonda, ha voluto certo significare tal verità con quella sua favola del grano di miglio che dice alla formica: «Se mi fai tanto piacere di lasciarmi fruire il mio desiderio del nascere, io ti renderò cento me medesimi». Ammirate qual tócco di grazia in quelle dita che spezzavano il ferro! Ah, egli è pur sempre il maestro incomparabile. (Il fuoco, pp. 33-34)
D’Annunzio inizia ad attribuire al maestro rinascimentale tratti che rivendicherà orgogliosamente a se stesso, in questo caso la prodiga generosità compendiata nel motto «io ho quel che ho donato».
Si schiude la stagione delle Laudi (1903). Assente nel libro di Maia, Laus vitae e lode della Grecia classica, Leonardo affiora nel congedo dalla magica estate alcionia. Nei Sogni di terre lontane dell’Alcyone, le nebbioline autunnali che salgono dal fiume che «vapora» e scorre tra gli «antichi ingegni» delle chiuse, evocano il «divino Leonardo»:
Il sorriso tu sei del pian lombardo,
o Ticino, il sorriso onde fu pieno
l’artefice che t’ebbe in signoria;
e il diè constretto alle sue chiuse donne.
(Alcyone, La muta, vv. 17-20)
Leonardo figura invece più volte in Elettra, il libro che contiene le laudi degli «eroi» nel senso più alto, quello teorizzato da Thomas Carlyle; eroi dell’azione e dell’amor di patria, certo, come Garibaldi o i fratelli Bronzetti, ma anche del pensiero, come il «distruttore» Nietzsche, o i maestri dell’arte pittorica, come Segantini, e di quella musicale, quali Bellini e Verdi.
La canzone Per la morte di Giuseppe Verdi presenta, chini accanto alla salma del «creatore estinto», Dante, Leonardo e Michelangelo, tre giganti del genio italico. E Leonardo vi è celebrato come indagatore dell’ignoto e pensatore eccelso, oltre che come creatore dell’Ultima cena e dei volti dai sorrisi infiniti:
Si chinaron su lui tre vaste fronti
terribili, col pondo
degli eterni pensieri e del dolore:
Dante Alighieri che sorresse il mondo
in suo pugno ed i fonti
dell’universa vita ebbe in suo cuore;
Leonardo, signore
di verità, re dei dominii oscuri,
fissa pupilla a’ rai de’ Soli ignoti;
il ferreo Buonarroti
che animò del suo gran disdegno in duri
massi gli imperituri
figli, i ribelli eroi
silenziosi onde il Destino è vinto.
[…]
E Leonardo: «Innanzi ebb’io la nuda
faccia del Mondo immensa,
come quella dell’Uom che a dentro incisi.
Creai la luce in Cristo su la mensa
e creai l’ombra in Giuda.
Dell’Infinito feci i miei sorrisi.
Poi, nel vespro, m’assisi
calmo alla sommità della saggezza
ed ascoltai la musica solenne.
Per quali vie convenne
meco quest’aspra forza a tale altezza?
Come questa vecchiezza
semplice e sola attinse
il culmine ove regna il mio pensiero?
Fratello m’è chi vinse
il suo fato e tentò novo sentiero».
(Elettra, Per la morte di Giuseppe Verdi, vv. vv. 1-14, 97-112)
Dietro questi versi non sta solo l’idea di una stretta parentela tra le arti, ma anche del loro radicamento nel pensiero possente e creativo. Al sorriso «divino» fermato da Leonardo il poeta allude anche nel terzo sonetto dedicato a Pistoia nel ciclo delle Città del silenzio; nei versi per il Centenario della nascita di Vincenzo Bellini, Leonardo è ricordato come colui che «temprò il sorriso, penetrò le ambagi / del corpo umano, dominò la forza / della corrente», dunque come pittore, disegnatore notomista e ingegnere idraulico. Ma il testo di Elettra in cui Leonardo campeggia in primo piano è l’ode Per la morte di un capolavoro, dedicata all’irreparabile deterioramento dell’Ultima cena che Leonardo dipinse, sperimentando una tecnica diversa dall’affresco, sulla parete del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie a Milano. In verità ben pochi dei 256 versi del lungo componimento sono espressamente dedicati al dipinto leonardesco, e cadono in prossimità della chiusa. Fino ad allora, se si esclude il riferimento al capolavoro che figura nel paratesto titolatorio, alle soglie dell’incipit, la poesia pare riferirsi solo alla morte del Cristo: i non molti riferimenti al Vangelo discendono direttamente dal testo sacro, senza presupporre la mediazione del dipinto, e l’ode segue l’appressamento alla morte del «Galileo»; se il titolo e poi un breve cenno allo svanire dell’«effigie» non ci avessero informati che l’oggetto dei versi era la morte del dipinto, la poesia sembrerebbe una passio verseggiata, un racconto cristologico, ma in chiave che non può definirsi cristiana. Si apre infatti con la lode delle creature vegetali, celebrate con accenti accostabili alle Nourritures terrestres di André Gide: «voluttà della Terra, o fronde, o fiori, o frutti», figlie della «Divina madre», che nelle «stagioni sacre» nascono, crescono e muoiono per poi rinascere. Al tempo circolare della natura, al ciclo morte-rigenerazione non corrisponde però il tempo lineare del figlio dell’Uomo: e su questo voluto equivoco tra la persona del Cristo e la figura del dipinto d’Annunzio svolge il suo filo poetico-narrativo: Cristo – mai nominato – non è il Dio fatto uomo ma l’uomo fatto Dio:
Ma la creatura infinita,
in cui la mente
dell’uom fatto dio
continuò l’opera della divina
Madre e trasfigurò la vita
sotto la specie dell’Eterno;
ma l’effigie pura
in cui l’uom solo nell’oblìo
di sé mutamente
svelò la virtù del dolore
sotto la specie dell’Eterno […].
(Elettra, Per la morte di un capolavoro, vv. 33-48)
Il cenno a un ente supremo ha una vaghezza massonica più che cristiana: è il «segreto artefice», il «Prometeo meditabondo»; non stupisce perciò che, oltre, la Pasqua sia vista come una pagana «festa d’ogni ritorno», che la tristezza di Gesù non preveda resurrezione, che dopo il Calvario Cristo s’incammini sui prati d’asfodelo. Il Cristo senza nome dell’ode, del resto, è una sorta di Zarathustra ebreo, alla Nietzsche, o un illuminato alla Schuré, «Colui che annuncia che rivela e che inizia». Dopo aver fissato con l’inchiostro dei versi la sua personale immagine di Gesù, d’Annunzio accenna espressamente a Leonardo, suggerendo una sovrapponibilità della propria visione con quella del quattrocentista:
Ahi, che rimane oggi fra i cieli
e le tombe, nella notte ove s’oscura
la tua bellezza,
nella gente cui tu raggiavi
con la bellezza la tua muta dottrina,
nella patria divina ove Leonardo
ti fece misura d’eroi,
specchio dell’Ideale, norma dell’opre,
culmine delle speranze sovrumane,
or che rimane per l’ultimo tuo sguardo,
che mai ti si scopre se non allegrezza
d’irrisori ed onta di schiavi?
Il sole declina
come te, fra i cieli e le tombe.
Su l’ampia ruina
inane caligine incombe.
(Elettra, Per la morte di un capolavoro, vv. 225-240)
Ancora una volta, il prorompente egotismo di d’Annunzio forza la materia: e il senso profondo dell’ode nasce da uno slancio che è fatto insieme di fraternità e di emulazione: fissare con l’inchiostro, in un’ode per lui non deperibile, quello che il pennello di Leonardo aveva dipinto con colori destinati a rovinare.
mito di Leonardo artista-scienziato si evolve e precisa, nella stagione matura di d’Annunzio, nell’immagine del novello Dedalo che ha voluto dare ali ai novelli Icari. Il Leonardo degli studi sul volo è riferimento importantissimo per il romanzo aviatorio Forse che sì forse che no (1910): così, nella descrizione del circuito aereo di Montichiari, «d’improvviso i latini rimemoravano il sogno del Nibbio, che visitò in culla il novo Dedalo creatore d’imagini e di macchine, il Prometeo senza supplizio, colui ch’ebbe in sé “la radice e il fiore della volontà perfetta”» (Forse che sì forse che no, p. 48).
Gli studi per il volo umano vengono poi evocati in scritti destinati ad aviatori, come quello del 1928, A Francesco De Pinedo, il celebre trasvolatore (poi in L’allegoria dell’autunno):
Nella Biblioteca del Galeone, ci soffermammo dinanzi al mappamondo sferico dove in una lontana sera tu m’avevi indicato sicuramente per quali punti disegnavi «dirizare il temone alli tua cammini»: ché anche allora il Vinci con alcuna parola era a noi prossimo «sanza battimento d’alie». (L’allegoria dell’autunno, p. 2342)
E nel Discorso agli aviatori del 9 luglio 1919 (L’ala d’Italia è liberata) si arricchisce di un motivo patriottico:
L’istinto icario, l’istinto umano del volo, che già travagliava l’inquietudine del Vinci e si rivelava nei disegni esatti e nei congegni reconditi, non s’è approfondito e non ha preso vigore e ardore in nessuna stirpe come nella nostra.
Anche il Libro ascetico (1926), che sviluppa la sacralizzazione della patria avviata nella guerra, presenta il Vinci come artista-veggente ma anche come esemplare della italica «razza perfetta», secondo i due versanti interconnessi del poeta-soldato. Nell’arringa agli «uomini milanesi» del 2 febbraio 1916, il Comandante addita il monumento a Leonardo in piazza della Scala:
Guardate là, in mezzo all’arengo, la figura di Leonardo. Non sembra ingrandita? Non sembra inspirata dal fiato del popolo onde nacque?
È il Vinci, è il nostro Vinci, è l’esemplare della razza perfetta, è il compiuto Sapiente, è il compiuto Artefice, è l’uomo «modello del mondo».
Ha la fronte nel mistero delle costellazioni, ha le calcagna ben piantate nella terra giusta. […] È un’imagine, è un emblema, è un mito. È un ammonimento, è un comandamento. (Il libro ascetico della giovane Italia, pp. 523-524)
Leonardo, che diviene eponimo di Milano (la città «di Leonardo e del Codex Atlanticus»), acquista la potenza di un titano, intento a «scrutare il vero e di dominar con gli ingegni le forze naturali»; riaffiora così, acquisendo maggior carattere sapienziale, anche la memoria dei capolavori pittorici, l’Ultima cena dipinta dallo «spirituale Eroe che pareva fosse in punto di scendere dal suo piedestallo per dipingere un’altra volta in un altro cenacolo la sublimità di Gesù tradito e la solitudine di Giuda con in pugno il sacchetto dei trenta denari»; il San Giovanni Battista «che fuori dell’ombra fa un gesto così luminosamente indicatore»; e la Gioconda, che tuttavia già qui d’Annunzio racconta di aver restituito al Louvre, dopo il celebre furto, «per sazietà e per fastidio».
Leonardo specchio di Gabriele
Il d’Annunzio degli anni Venti e Trenta tende a riassorbire la figura di Leonardo in sé, assecondando un soggettivismo sempre più marcato, che non di rado sconfina in egolatria. Ecco dunque, nel Secondo amante di Lucrezia Buti, il proprio accostamento a Leonardo nella somma arte del rilievo:
e io ero proprio nato per doventare un gran maestro di rilievo, un gran fonditore di medaglie […]; e io già […] m’ingegnavo di condurre la mia propria medaglia a quell’altezza di rilievo ch’io volevo che avesse, ch’io voglio che abbia: a quel «sommo rilievo» che Leonardo, solo in parte come il Saladino e come me, volle dare a sé medesimo e alle cose ch’egli faceva.
Gli autografi che ingombrano la scrivania di d’Annunzio sono costellati «di segni ingegnosi che sembrano estratti dal Codex Atlanticus» (Il secondo amante di Lucrezia Buti); e nel Libro segreto l’ombra del maestro rinascimentale torna a essere evocata attraverso i due motivi cruciali del mistero – le «annodature e legature delle corde» in cui «Leonardo ritroverebbe il suo stretto stile» – e della musica («Quel teschio di cavallo ingegnato da Leonardo in guisa di cithara, come d’un guscio di testuggine avea già fatto un altro dio»; Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire, p. 106). Al Vittoriale, oltre alla riproduzione fotografica della Gioconda, presente nella Veranda dell’Apollino (come già nella Colombaia della Capponcina: Palmerio, p. 64), quattro sentenze di Leonardo campeggiano sull’architrave della libreria nello Scrittoio del Monco: «Acciocché tu più cose possa, più ne sostieni», «Niuna casa è sì piccola che non la faccia grande un magnifico abitatore», «Se tu vuoi che la tua casa ti paia grandissima pensa al sepolcro», «Chi non ha sepoltura è coperto dal cielo».
C’è dunque da chiedersi a chi, se non a Gabriele d’Annunzio, il ladro della Gioconda poteva consegnare il capolavoro sottratto al Louvre nell’agosto del 1911. È, questo, un motivo su cui d’Annunzio scrive a più riprese, in forma privata e pubblica, a partire dallo stesso 1911, e fino agli anni Venti (cfr. Tragedie, sogni e misteri, vol. II, pp. 1734-1741). Il primo interlocutore è Luigi Albertini, a cui il poeta comunica in anteprima la notizia clamorosa: «Aspetto stasera l’uomo che ha rapito la Gioconda. Le manderò poi il colloquio. Da Bordeaux è venuto a nascondersi nelle Lande. Sono ansiosissimo» (27 agosto 1911). Sulle prime l’idea è di dedicare al furto del capolavoro e all’incontro con il suo artefice una favilla, da passare anche all’editore dell’«Excelsior» Pierre Lafitte; ma presto d’Annunzio delinea un disegno più ampio, comunicandolo sempre ad Albertini (9 settembre 1911):
Studiando il caso della Gioconda per farne una favilla (di data recentissima), m’è accaduto di adunare intorno al soggetto alcune immaginazioni. E queste immaginazioni mi tentano così che le ordinerò in un racconto, in una specie di storia meravigliosa, mista di realtà e di fantasia. Se io le dicessi che il rapitore (l’uomo della Gare d’Orsay) è venuto qui a portarmi il quadro, Ella non mi crederebbe. Forse mi crederà quando leggerà la mia narrazione. Questa histoire extraordinaire intitolata L’homme qui a volé la Joconde sarà pubblicata nell’Excelsior, in novembre.
Diverse sono state le ipotesi circa il rapporto tra realtà e finzione in queste dichiarazioni dannunziane, a partire da un perplesso Albertini («Non posso immaginare dove cominci il fantastico e finisca il reale nelle Sue parole. Mi spieghi meglio il mistero. La prego», lettera del 12 settembre 1911), che più tardi, dopo un incontro a Parigi con d’Annunzio, annoterà sul suo diario (il 9 gennaio 1914):
Mi racconta la tela […] de L’homme qui a volé la Joconde. La Gioconda è stata ad Arcachon da lui per 20 giorni subito dopo il furto, portatavi da un fiammingo […] che l’ha fatta rapire per tentare di estrarre dalla Gioconda la vita, le sensazioni che Leonardo, la Gioconda stessa hanno emanato attorno al quadro, per far rivivere anzi la donna fiorentina valendosi dello spirito che è raccolto nel quadro. […] Sarebbe un matto che avrebbe anche ucciso un uomo per arrivare ad estrarre la sostanza del cervello. Ma d’Annunzio dice che tutto questo è assolutamente vero, che il suo romanzo partirà da questa verità, che egli ha predetto il giorno prima la restituzione della Gioconda a Firenze […]. È una plaisanterie? Impossibile arrivare ad acquistarne la certezza; la persuasione però sì.
La versione viene ribadita da d’Annunzio nel già citato Libro ascetico, così come nel Ritratto di Luisa Baccara (1920) poi confluito nelle Faville (Il compagno dagli occhi senza cigli, con il titolo Di una pausa musicale nel tumulto di Fiume):
Mi ricordo che, quando il ladro sublime della Gioconda portò al mio rifugio nella Landa la tavola avvolta in una vecchia coperta di scuderia, mi posi ad abominare le mani molli di Monna Lisa costretto ad averla sotto gli occhi per giorni interi, durante la speculazione metafisica che mi aveva proposta il rubatore.
Fatto sta che l’idea si concretizza nello scenario cinematografico intitolato appunto L’uomo che rubò la Gioconda, e che nel 1920 giunse addirittura nelle mani del grande regista statunitense David Wark Griffith, il quale non poté però soddisfare il suo autore, il quale, allora verso la sessantina, avrebbe voluto figurare sullo schermo nel ruolo dell’eroe.
Lo scenario dannunziano (cfr. Tragedie, sogni, misteri, pp. 1435-1562), oltre a rappresentare una singolare incursione di d’Annunzio nelle atmosfere del fantastico, lo vede tornare a distanza di anni sul grande mito dell’immaginario fin de siècle da cui egli stesso era partito.<
In una curiosa ambientazione fiamminga, il «pittore mistico» Pieter van Blömen, soprannominato «Orizzonte», è riuscito a trovare il metodo per trasformare «alchimisticamente» in apparizioni di vita l’«atmosfera spirituale» depositata nei dipinti; e dopo aver sottratto la Gioconda dal Museo, si rivolge per compiere insieme l’opera al poeta Gabriele d’Annunzio, «rifugiato nelle Lande, fra le dune dell’Atlantico», noto per essere «uno dei più acuti amanti della Gioconda». La metamorfosi impone però un sacrificio cruento, quello del giovane assistente del maestro fiammingo, a cui d’Annunzio stesso strapperà il cuore, seguito da quello di Sonia, l’amante del poeta, che resa folle dalla gelosia muore in quella stessa notte «come una regina barbara», lanciandosi con il suo cavallo nella pineta in fiamme.
Segue la sequenza in cui la figura viva della Gioconda si stacca dalla tavola davanti agli occhi del poeta:
Il prodigio.
L’animazione dell’imagine. La figura viva si stacca dalla tavola. Esce intera.
Posa i piedi sul pavimento. È Monna Lisa del Giocondo.
Respira. Si muove… Scompone il suo gesto leonardesco. Vive. Non sorride più. Si smarrisce, si stupisce.
Nella tavola senza figura rimane il divino paesaggio di rocce, dove l’acqua tortuosa sembra perpetuare divinamente il sorriso umano.
«Siete voi, messer Leonardo?»
La voce della Gioconda
Monna Lisa ha parlato!
Ha ricominciato a vivere dal punto in cui il suo pittore venne a dare l’ultima velatura al suo dipinto.
Il poeta vede realizzarsi il sogno estetizzante del Piacere, quello di possedere in una donna l’opera d’arte. Ma una volta uscita dal quadro che ne custodiva l’immagine più vera, Monna Lisa appare paradossalmente più lontana:
Nessuna comunione. I secoli stanno tra lui e lei.
La Gioconda non sorride più. Non ha più il sorriso misterioso che Leonardo trasse con la musica da quell’anima mediocre e ignara.
È smarrita, è trasognata.
Sembra talvolta ascoltare il delirio del poeta, che porta nell’anima sconvolta tutto il peso di quella notte incredibile.
Ma non comprende. […]
L’interrogazione ansiosa e ostinata di tanti anni, davanti all’imagine inesplicabile, egli la ripete alla figura incarnata.
Invano.
«Ho ucciso il mio amore per te: il mio ultimo amore, per te che sei il mio amore unico e vero.
Ho cercata te in tutte le amanti.
Ho cercato su tutte le labbra voluttuose il tuo sorriso. Sei viva e respiri. Sei viva e parli.
O eri più viva quando non respiravi, quando non parlavi?
O eri più vicina a me quando avevi dietro le spalle le rocce inaccessibili e le acque tortuose?Rispondi! Rispondi!
Làsciati conoscere! Làsciati possedere!»
Il desiderio del poeta rimane frustrato: di lì a poco, l’apparizione dileguerà. L’ultima sequenza ci riconduce al Louvre: il dipinto è stato restituito al museo, dove irrompe, folle, il poeta, che agita davanti al quadro il pugno chiuso, scagliando infine contro l’enigmatico sorriso la cenere della donna reale da lui sacrificata:
La tavola rimessa nel suo luogo, richiusa nella sua cornice.
L’emozione, all’annunzio.
La ressa alle porte.
Gli amanti della Gioconda che si precipitano a ritrovare il sorriso perduto. Il poeta maniaco giunge, anelante. Fende la calca.
Ha il pugno chiuso. Leva il pugno chiuso, e grida, fra l’agitazione dei presenti.
Ha nel pugno la cenere dell’incendio lontano.
È folle.
Grida: «Ho dato tutto al fuoco. Ecco il mio amore! Ecco il mio amore! Ecco il mio amore!».
E getta sul sorriso inesplicabile il suo pugno di cenere fredda.
Agitazione. Indignazione. Tumulto. È afferrato da cento mani. È trascinato a forza. La calca si riforma davanti al fàscino perpetuo.
Il cerchio si chiude, come sembra suggerirci lo stesso d’Annunzio, autocitando l’ode Al poeta Andrea Sperelli, scritta una quarantina d’anni prima e fatta qui pronunciare da un «giovine poeta capelluto» che sfoglia una rosa in cui non è difficile indovinare un portrait of the artist as a young man; a lui il vecchio d’Annunzio sembra guardare ormai con un misto di rimpianto e di autoironia:
Un giovine poeta capelluto sfoglia una rosa e getta le foglie verso il sorriso inesplicabile:
Tu non saprai giammai perché sorrido.»
Bibliografia essenziale
Gabriele d’Annunzio, Alcyone, edizione critica a cura di Pietro Gibellini, Venezia, Marsilio, 2015
Gabriele d’Annunzio, Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire, a cura di Pietro Gibellini, Milano, Rizzoli, 2010
Gabriele d’Annunzio, Elettra, edizione critica a cura di Sara Campardo, Gardone, Il Vittoriale degli Italiani-Edizione Nazionale delle opere di Gabriele d’Annunzio, 2017
Gabriele d’Annunzio, Forse che sì forse che no, a cura di Raffaella Castagnola, Milano, Mondadori, 1998
Gabriele d’Annunzio, Il fuoco, introduzione di Pietro Gibellini, note di Filippo Caburlotto, Milano, Rizzoli, 2009
Gabriele d’Annunzio, Il libro ascetico della giovane Italia, in Prose di ricerca, a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2005, tomo I, pp. 415-737
Gabriele d’Annunzio, Il Piacere, introduzione di Pietro Gibellini, note di Enrica Gambin, Milano, Rizzoli, 2009
Gabriele d’Annunzio, L’ala d’Italia è liberata (Roma, La Fionda, 1919, pp. 19-56), in Prose di ricerca, cit., tomo I, pp. 879-894
Gabriele d’Annunzio, L’allegoria dell’autunno, in Prose di ricerca, cit., tomo II, pp. 2187-2369
Gabriele d’Annunzio, Le faville del maglio, in Prose di ricerca, cit., tomo I, pp. 1208-1656
Gabriele d’Annunzio, Le Vergini delle rocce, introduzione di Pietro Gibellini, note di Nicola Di Nino, Milano, Rizzoli, 2010
Gabriele d’Annunzio, L’uomo che rubò la Gioconda, in Tragedie, sogni e misteri, a cura di Annamaria Andreoli con la collaborazione di Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2013, vol. II, pp. 1435-1462
Gabriele d’Annunzio, Trionfo della morte, in Prose di romanzi, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 2005, vol. I
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 1982
Donatella Dell’Aquilano, D’Annunzio e il leonardismo fin de siècle, in «Critica letteraria», 100, 1998, pp. 553-577
Cecilia Gibellini, Gabriele d’Annunzio e Leonardo da Vinci, in D’Annunzio in Italia e nel mondo a ottant’anni dalla morte, Atti del Convegno internazionale di studi, in «Rassegna dannunziana», 72, 2018, pp. 220-234
Cecilia Gibellini, Il Leonardo apocrifo di Gabriele d’Annunzio, in Leonardo e la scrittura, numero monografico a cura di Cecilia Gibellini, «Rivista di letteratura italiana», 2, 2019, pp. 117-124
Laura Granatella, L’arte rinascimentale nei Taccuini, in D’Annunzio, la musica e le arti figurative, «Quaderni del Vittoriale», n. 34-35, luglio-ottobre 1982, pp. 158-159
Sandra Migliore, Tra Hermes e Prometeo. Il mito di Leonardo nel Decadentismo europeo, Firenze, Olschki, 1994
Gianni Oliva, Leonardo e leonardismo nella cultura decadente italiana, in «Studi rinascimentali», 8, 2010, pp. 75-82
Fernanda Palma, Influenze vinciane nel personaggio femminile dannunziano, in I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo, Atti del XVIII congresso dell’ADI, a cura di Guido Baldassarri, Valeria Di Iasio, Giovanni Ferroni, Ester Pietrobon, Roma, Adi editore, 2016
Benigno Palmerio, Con D’Annunzio alla Capponcina (1938), Firenze, Vallecchi, 1995
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930), Firenze, Sansoni, 1996
Ricciarda Ricorda, Angelo Conti e il leonardismo di fine secolo, introduzione a Angelo Conti, Leonardo pittore (1910), Padova, Programma, 1990
Bianca Tamassia Mazzarotto, Le arti figurative nell’arte di Gabriele d’Annunzio, Milano, Fratelli Bocca, 1949
Guy Tosi, D’Annunzio e la cultura francese. Saggi e studi (1942-1987), a cura di Maddalena Rasera, Lanciano, Carabba, 2012
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)