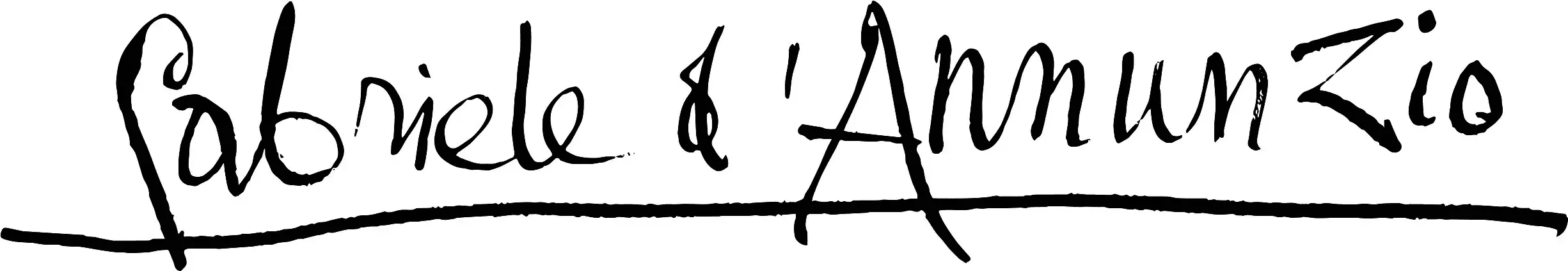di Chiara Bianchi, Enciclopedia dannunziana
Gabriele d’Annunzio ha avuto durante la sua vita l’opportunità di incontrare i maggiori musicisti della sua epoca, attirati dalla musicalità del verso del Poeta, ma anche dalla personalità forte e presente nella cultura del primo Novecento. In particolare i giovani musicisti della cosiddetta Generazione dell’80 furono spesso accolti, sostenuti, riconosciuti da d’Annunzio, anche in questo letterato con atteggiamento differente ed anomalo verso la musica rispetto ai colleghi nel mondo a lui contemporaneo. Tra gli altri, Alfredo Casella fu onorato dell’amicizia del Poeta, insieme a Gian Francesco Malipiero e Ildebrando Pizzetti, come testimoniato da un non corposo ma interessante scambio di corrispondenze intercorso tra i due.
Il carteggio risale agli anni tra il 1910 e il 1936. Non è ricco come in altri casi, ma significativo per la comprensione dell’atteggiamento di d’Annunzio verso la musica contemporanea. L’amicizia forse non è stata continuativa, e inizialmente pare di leggere più un rapporto tra discepolo e maestro; tuttavia col passare del tempo alcuni particolari, come il tono scherzoso e spesso leggero, fanno pensare alla nascita di qualcosa di più profondo. Casella aveva un carattere concreto, pragmatico, mirato ai suoi progetti musicali; d’Annunzio si era adeguato. Non troveremo spesso come in altri carteggi momenti di intimità e anche rivelatori di sentimenti privati, ma in ogni caso resta la testimonianza di un vero rapporto al di là della collaborazione artistica.
Casella non incontrò subito d’Annunzio: nel 1910 il Poeta si era iscritto alla S.M.I (Societé Musicale Indépendante), di cui Casella fu segretario generale dal 1911 al 1919. Ogni anno riceveva l’assegno di d’Annunzio e una lettera di accompagnamento «su carta già intestata col famoso motto me ne frego». La conoscenza diretta risale al 4 maggio 1915, quando un amico avverte il musicista che d’Annunzio sta partendo per Quarto per pronunciare l’Orazione per la Sagra dei Mille. Casella si precipita alla Gare de Lyon e viene accolto in modo cordiale: il Poeta aveva assistito ai suoi concerti italiani.
Bisogna arrivare al 1923 per trovare un progetto comune che favorisce la vicinanza tra i due. Si tratta della fondazione della Corporazione delle Nuove Musiche, creata da Casella e Malipiero con il coinvolgimento immediato di d’Annunzio. In realtà questa Corporazione nacque come conseguente ad un’altra organizzazione, la Società italiana di musica moderna del 1917. Entrambe miravano alla promozione della musica contemporanea, non solo italiana ma anche i capolavori che all’estero si stavano moltiplicando ma che in Italia non trovavano spazio esecutivo. In questo senso, il lavoro di Casella e Malipiero divenne importante per aprire la musica italiana ad un respiro più europeo. D’Annunzio era già molto incuriosito e partecipe delle novità musicali che man mano si stavano prospettando. Questo è significativo nel Poeta: mentre in quegli anni non si mostrava molto attirato dalle novità nel campo delle arti figurative, o nel campo della letteratura a lui coeva, invece si mostrava attento verso i nuovi ambiti di ricerca musicale, anche formali, compositivi, con una sensibilità particolare. Lo interessava non soltanto la musica contemporanea, ma anche quella riscoperta del passato musicale italiano che si stava delineando e prendendo forza, a partire dalla collana I classici della musica italiana, da lui patrocinata e curata tra gli altri dall’amico Malipiero, e di quest’ultimo i primi studi che porteranno alla redazione dell’Opera Omnia monteverdiana. Nel 1922 aveva aderito alla Camerata per la musica italiana, fondata da Mezio Agostini a Venezia, e dalle iniziali C.P.L.M.I. aveva tratto un motto: Celsa Potestas Lyras Manet Invicta. Anche per la Corporazione di Casella trasse un motto dalle iniziali C.D.N.M.: Concentus Decimae Nuncius Musicae. Altro motivo che spiega la sua partecipazione alla Corporazione è più personale. In quegli anni d’Annunzio stava immaginando di diffondere una vasta cultura musicale alla massa, pensiero espresso nel paragrafo LXV dello Statuto Fiumano del 1920. Creava idealmente una vasta orchestra con coro a cui affidare la riscoperta delle musiche antiche della tradizione italica. Nelle attività degli amici musicisti, quindi, vedeva una via per la realizzazione del suo ideale. Durante una conferenza stampa tenuta da Casella a Roma nel gennaio 1924 (riportata nell’Eco della Stampa del 22 gennaio), si preannunciava la fondazione di una società corale con il compito di far conoscere al pubblico un repertorio di opere d’arte che finora gli era sconosciuto. Il problema, secondo i dettami di d’Annunzio, era «l’educazione musicale del popolo. Problema vasto che verrà studiato e certamente risolto con l’organizzazione di concerti per gli operai».
L’ideale dannunziano risultò di difficile realizzazione. Senza parlarne apertamente, i fondatori Casella e Malipiero lasciarono man mano decantare le grandiose idealità dell’amico. In realtà, fine della Corporazione era la «migliore conoscenza e diffusione della musica contemporanea», anche attraverso una migliore conoscenza del passato. Dopo un incontro tra Casella, Malipiero e d’Annunzio, testimoniato da una lettera del 22 settembre 1923, fu stilato un pro memoria che fungeva da manifesto e regola dell’associazione. In esso si predisponeva anche la realizzazione di una rivista di studi, che doveva accompagnare e spiegare a tutti le idealità, e probabilmente presentare i contenuti dei concerti man mano proposti. Tale rivista avrebbe dovuto avere come presidente d’Annunzio, vice Arturo Toscanini, consiglieri Ildebrando Pizzetti, Gian Francesco Malipiero, Bernardino Molinari (direttore d’orchestra), segretario generale Alfredo Casella; sede a Roma, ma inizialmente essendo Casella occupato all’estero, si indicava come indirizzo momentaneo la residenza di Alma Mahler a Vienna. Venne coinvolto da subito anche l’allievo e poi segretario di Casella, Mario Labroca, che poi scrisse dei primi passi dell’Associazione in un suo volume di memorie. Attività principali della Corporazione: «concerti di musica moderna e pure antica, che giovi alle finalità estetiche della Corporazione». La rivista vide infine la luce con il titolo La Prora, mensile diretto da Casella stesso, prima uscita nel febbraio 1924, edita a Roma dalla Libreria della Cultura.
Non era ancora nata questa società musicale che partirono le prime critiche. Giovanni Danova, libraio antiquario e direttore del “Bollettino bibliografico musicale”, attaccò il progetto. Si recò da Labroca senza sapere che era amico di Casella, dicendo che la rivista la voleva far lui, e che non ci pensava proprio di affidare l’impresa ad una persona “d’avanguardia”. Pare ci fosse dietro a questo personaggio secondario la mano di Toscanini, che non aveva nessuna simpatia per Casella e Malipiero. Intanto, Pizzetti si mostrava perplesso sulla creazione di una nuova società poiché non vi si riconosceva; e si sarebbe fermato alla discussione con Casella, se non che Alceo Toni firmò un articolo, nel Popolo d’Italia, in cui diresse un attacco contro i fondatori della Corporazione, lasciando intravedere il nome di Pizzetti. Casella rispose agli attacchi con serenità, ma fermezza, e comunicò a d’Annunzio il tutto, il quale offrì il suo sostegno ed anche l’aiuto del suo avvocato, Antonio Masperi. In realtà, Pizzetti già era stato coinvolto nella precedente Società italiana di Musica moderna, condividendo degli ideali tutto sommato identici a quelli della Corporazione. Dopo pochi giorni si trovò a dover scrivere a Casella una lettera più dimessa, di scuse, dopo aver letto la risposta a Toni. D’Annunzio venne invitato a parlargli, e il problema rientrò, seguito da una riconciliazione anche con Malipiero. Toscanini richiese un colloquio con d’Annunzio: non ne conosciamo gli esiti, in ogni caso non partecipò infine alle attività della Corporazione.
Intanto Casella aveva deciso le quote di iscrizione, tra soci Fondatori, Vitalizi, Abbonati, Universitari (i Goliardici), Aderenti, con invio della rivista e partecipazione ad una nuova idea, quella di una biblioteca circolante di libri e spartiti (prevalentemente a Roma). Nella strutturazione definitiva i Soci fondatori erano d’Annunzio, Casella, Malipiero, i consiglieri Bernardino Molinari, Ildebrando Pizzetti, tesoriere Avv. Emilio Mendicini, segretario generale Mario Labroca. A questo punto il grosso problema era quello finanziario. Come sostenere le attività, i concerti? D’Annunzio, come spesso faceva, si era dichiarato sostenitore ma non finanziatore. Per fortuna, Malipiero conosceva una delle più generose finanziatrici di opere musicali, la signora Elisabeth Sprague Coolidge, che aveva commissionato oltre venticinque opere di musica da camera di compositori moderni, e che aveva l’abitudine di partire da un finanziamento di 1000 dollari di base. Già nel novembre 1923 aveva deciso di sostenere con quella cifra l’inizio delle attività della Corporazione. Si aggiunse un contributo anche di Riccardo Gualino, imprenditore fondatore della LUX, ditta di produzione cinematografica, mecenate e collezionista d’arte.
La C.D.N.M. visse cinque anni, durante i quali furono organizzati una cinquantina di concerti a Roma, una ventina tra provincia ed estero. Dal 1928 fino alla Seconda guerra mondiale (con notevoli problemi nel 1939 quando il Regime fascista bloccò i rapporti con l’estero) diventò la sezione italiana della Società internazionale per la musica contemporanea, su richiesta del presidente, il musicologo Edward Joseph Dent. Questa era anch’essa nata nel 1923, ma inizialmente c’erano state delle remore a far entrare gli italiani; nel 1928 Casella decise sulla scia delle proprie tendenze europeiste. L’opera sicuramente più importante portata in Italia da Casella fu il Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg. Per la sua presentazione furono organizzate tournée toccando le città principali, Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Padova, Torino, Milano. Ottimi gli esecutori, e spesso lo stesso Schönberg era presente in veste di direttore d’orchestra.
A tal proposito, un curioso episodio è testimoniato nel carteggio. Al termine di una tournée, con ultimo spettacolo a Milano, nell’aprile 1924 la compagnia prima di sciogliersi per tornare nelle rispettive città in tutta Europa, decise di proporre uno spettacolo privato per d’Annunzio, recandosi tutti i musicisti al Vittoriale. Si trattava di Schönberg stesso, l’attrice Erika Wagner, il quartetto Pro Arte di Bruxelles, e altri musicisti rinomati come il flautista Fleury, il clarinettista Delacroix, il pianista Steuermann. Oltre al Pierrot Lunaire, avrebbero eseguito brani di Malipiero, Casella, e quartetti di Stravinskji. L’impresa non andò in porto. Esiste soltanto una lettera alla Baccara da Casella, che si dispiace per questo, non potendo più ritrovare in futuro una tale occasione. Non si conoscono le ragioni della disdetta di d’Annunzio.
Negli anni la Corporazione porterà sulla scena italiana opere oggi ritenute fondamentali nella storia della musica. Oltre al passato appena riscoperto, da Monteverdi a Vivaldi a Bach, grandi autori contemporanei furono invitati e loro musiche eseguite per la prima volta. Emergono opere come l’Histoire du soldat e l’Ottetto per fiati di Igor Stravinskij e, in occasione del sesto festival della Società internazionale di musica contemporanea tenutosi per iniziativa di Casella a Siena nel settembre del 1928, Les noces, sempre di Stravinskij. Vennero invitati in Italia compositori come Béla Bartók e Paul Hindemith e si fecero conoscere le opere di Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric, Karol Szymanowski, Ernst Křenek, Ernst Bloch, Zoltán Kodály, Francis Poulenc, Maurice Ravel e quelle di numerosi giovani musicisti italiani (Respighi, Castelnuovo-Tedesco, Labroca, Clausetti e molti altri). Malipiero era l’incaricato a seguire la sezione antica. Ripropose il Socrate Immaginario di Giovanni Paisiello, Il filosofo di campagna di Baldassarre Galuppi, l’Amfiparnaso di Orazio Vecchi, lo Stabat Mater di Pergolesi, e di Monteverdi varie opere sacre ma soprattutto l’Orfeo.
Dal 1924 le lettere denotano un progressivo affievolirsi dell’interesse di d’Annunzio verso la Corporazione. Casella scriveva aggiornando sulle attività: la rivista procedeva, si organizzavano attività corali grazie a una associazione intitolata a Claudio Monteverdi, la signora Coolidge continuava a finanziare. Tuttavia non otteneva mai direttive o consigli dall’amico, e se ne doleva. Nel 1924 inoltre Pirandello aveva fondato a Roma un nuovo teatro moderno (il Teatro d’Arte), che offriva spazi ai concerti organizzati dalla Corporazione. Casella in questa cornice intendeva rimettere in scena l’Orfeo di Monteverdi; realizzare per la prima volta in Italia l’integrale dei Concerti Brandeburghesi di Bach; e ancora brani sconosciuti di Mozart, Beethoven; ma anche e soprattutto autori moderni.
Pare che d’Annunzio non rispondesse, preso da nuovi progetti e idealità. Il carteggio segnala una minore frequentazione tra il 1926 e il 1931. In quest’ultimo anno, una lettera annunciava l’arrivo al Vittoriale di Antonio d’Annunzio, fratello di Gabriele, musicista e direttore d’orchestra ormai trapiantato negli Stati Uniti; occasione rara sia per la lontananza, sia per le difficoltà di rapporto tra i fratelli, uno famoso, l’altro purtroppo bisognoso e che spesso aveva richiesto aiuti economici al Vate. Questo arrivo non consentiva al Poeta di andare ad un concerto di Casella. Negli anni successivi in effetti l’unico contatto tra i due riguardava concerti offerti da vari musicisti della cerchia di Casella e che si recavano appositamente a Gardone Riviera. Le lettere o telegrammi quindi sono soltanto di tipo organizzativo. Una lettera del 1932 è più intima e nostalgica, d’Annunzio ricordava il passato in cui sognavano ritorni gloriosi della musica nella vita d’Italia, ma anche si diceva deluso per le aspettative tradite. Tuttavia ammirava il coraggio di Casella nel continuare a proporre il suo modo di intendere la musica, soprattutto quella sinfonica così poco apprezzata. D’Annunzio invecchiava, si sentiva sempre più isolato. Rifiutava quindi le offerte degli amici per uscite, concerti, occasioni d’incontro. Le ultime missive risalgono al 1936. Ormai, il senso della fine di un’epoca pervadeva tutto.
In conclusione di questa narrazione, può incuriosire il lettore quali siano state le opere su testo dannunziano musicate da Casella: in realtà, soltanto una, La sera fiesolana op. 37, Lauda per soprano e pianoforte, edita da Ricordi nel 1924. Al Vittoriale c’è il manoscritto del 1923, non la versione stampata. Anche questa assenza di opere in comune è significativa per la comprensione di un’amicizia nata da vicinanze intellettuali coincidenti con il comune interesse per la musica sia antica sia contemporanea; non si è realizzata mai concretamente e forse la ragione sta nella diversità di vedute artistiche personali. Casella si può riassumere nella frase dell’amico Malipiero: “continua e multiforme operosità”; in questa operosità si ritrovò coinvolto per un certo periodo anche il grande Poeta Gabriele d’Annunzio.
Bibliografia
La fonte primaria riguardo alla vicenda dell’amicizia è il carteggio:
– Il carteggio Alfredo Casella – d’Annunzio, a cura di Maria Adelaide Caponigro, in Italianistica,
Anno I n. 2, maggio-agosto 1972, pp. 268-291.
Inoltre:
Alfredo Casella, I segreti della Giara, Milano, Il Saggiatore, 2016
Mario Labroca, L’usignolo di Boboli (cinquant’anni di vita musicale italiana), Venezia, Neri Pozza, 1959, pp. 97-101.
Fiamma Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, Fiesole, Libreria Universitaria, 2018
Gabriele d’Annunzio e la musica, scritti di Alfredo Casella, Alberto De Angelis, Mario Giannantoni, Ildebrando Pizzetti, Luciano Tomelleri, Milano, Fratelli Bocca, 1939.
La voce in DBI: https://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-casella_(Dizionario-Biografico)/
Paola Sorge, Musica e musicisti nell’opera di Gabriele d’Annunzio, Lanciano, Carabba, 2018, pp. 112-117.
Walter Tortoreto, il Vittoriale: un’officina musicale, in atti del XXXV Convegno Nazionale Dannunziano “Gli anni del Vittoriale”, Pescara 13 dicembre 2008, in «Rassegna Dannunziana», anno XXVII, n. 56, ottobre 2009, pp. 27-38.
Atti di convegni
D’Annunzio la musica e le arti figurative, in Quaderni del Vittoriale 34-35, Gardone Riviera/Milano, 1982.
D’Annunzio e la musica, Atti del Convegno internazionale di studio Gardone Riviera-Milano, 22-23 ottobre 1988, Gardone Riviera/Milano, Il Vittoriale degli Italiani/Civiltà Musicale, 1989.
D’Annunzio musico immaginifico, Atti del convegno internazionale di studi, Siena, 14-16 luglio 2005, Firenze, Olschki, 2008. In questo volume, in particolare, Virgilio Bernardoni, Il Sogno dannunziano di Malipiero, pp. 301-318.
D’Annunzio e l’arte dei suoni – Ebbi nella musica la mia natività e la mia sorte, Atti del 49° Convegno di Studi dannunziani, Pescara 2-3 dicembre 2022, Pescara/Milano, Centro Nazionale di Studi dannunziani, 2024.