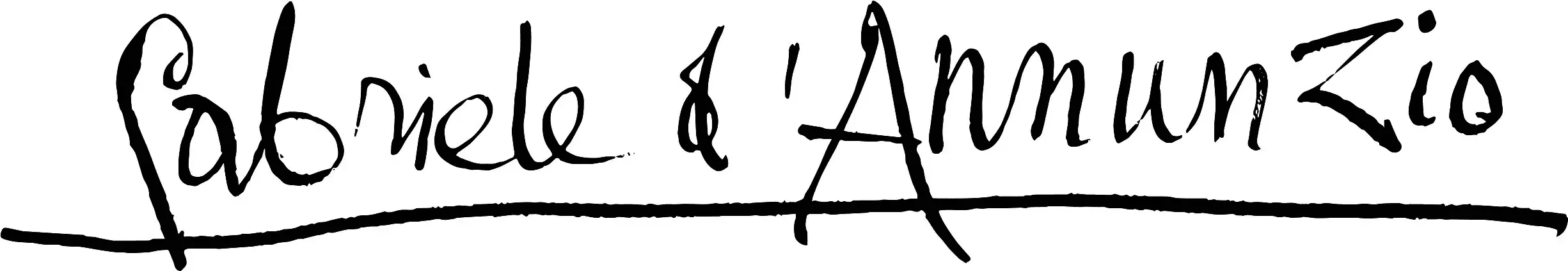di Mario Cimini, Enciclopedia dannunziana
Prima ricezione del modello zoliano e naturalistico
In una celebre intervista rilasciata ad Ugo Ojetti nel gennaio 1895, Gabriele d’Annunzio sembra decretare la fine dell’influsso di Emile Zola (1840-1902) sulla letteratura italiana, esprimendo al contempo un giudizio limitante sulla sua portata. Dichiara, infatti, senza mezzi termini: «Fino a qualche anno fa, romanzieri e novellieri praticavano le anguste teorie zoliane rappresentando con molta cura delle particolarità esteriori certi aspetti della vita borghese o contadina studiati nelle singole regioni natali […]. Ma, poiché il cerchio era angusto e inferiore, gli spiriti più complessi e più inquieti sentirono il bisogno di uscirne; e, per questo bisogno, si protesero con avidità verso le correnti spirituali che attraversano la vita europea e la conturbano, fecondandola. E fu bene» (U. Ojetti, 1987, p. 307).
Si tratta, in realtà, di una posizione che dietro il tono tranchant non nega quanto di buono avesse prodotto quell’influsso in termini di svecchiamento della nostra tradizione narrativa, sia pure facendo la tara di certi manierismi che avevano portato molti a comporre secondo una facile «ricetta divulgata». In un altro passaggio dell’intervista, lo scrittore di Pescara sottolinea come, all’interno del «flutto impuro e versicolore» della letteratura d’ispirazione zoliana, emergessero «alcune vive opere d’arte, specialmente d’artisti del Mezzogiorno», e, tra queste, quelle di un solo alluso Verga, capace di rappresentare «con vigore e sobrietà alcuni tragici idilli piscatorii e campestri», in cui i personaggi, «dai detti e dai gesti veementi», si muovono «all’urto di una passione semplice e brutale» (Ivi, p. 308).
Tale ambiguità di giudizio, del resto, ben riassume l’atteggiamento ancipite di d’Annunzio nei confronti di Zola e, in genere, della lezione naturalista, dagli esordi della sua attività letteraria ed almeno fino al 1890-92. Ne ripercorriamo ora le tappe salienti per meglio far emergere i tratti distintivi di un diagramma evolutivo che, sì, è quello personale dello scrittore, ma lo è anche di un’epoca caratterizzata da continui e repentini sommovimenti ideologico-culturali.
La scoperta di Zola e dei naturalisti da parte di d’Annunzio è assai precoce. Il diciottenne studente del Collegio Cicognini di Prato – siamo nel 1881-82 – legge avidamente non solo gli scrittori nostrani (Carducci, sul versante poetico, è il suo idolo in questi anni) ma anche l’avanguardia della letteratura europea, quasi sempre negli originali francesi. Ne manda addirittura a memoria lacerti consistenti, come avrebbe attestato il suo traduttore francese, Georges Hérelle, a proposito dei romanzi del ‘divino’ Flaubert. Coeva è anche la frequentazione di quella letteratura scientifica che del Naturalismo è alimento primario, a partire da Darwin e le teorie evoluzioniste, ma senza tralasciare la fisiologia.
Il giovane d’Annunzio è senz’altro già un lettore con il ‘rampino’, per dirla con Giambattista Marino, ossia proteso a immagazzinare un repertorio più o meno sconfinato di situazioni, nessi espressivi, parole, immagini, ritmi, un bagaglio mentale insomma da cui attingere prontamente nel momento della composizione. Tale sarebbe rimasto per il resto dei suoi giorni (e da qui anche le continue e controverse accuse di plagio che la critica passata e recente gli avrebbe rivolto).
Ecco allora che l’esordio narrativo dello scrittore – con le novelle composte tra il 1880 e il 1882 (poi confluite in Terra vergine, raccolta edita presso Sommaruga nel 1882) – palesa da subito non pochi debiti nei confronti non solo, e non tanto, del Verga di Vita dei campi, quanto del Naturalismo zoliano. Si tratta di una materia ampiamente accertata in sede critica; si veda, per esempio, il primo convegno del Centro Nazionale di Studi Dannunziani di Pescara, nel 1979, che è dedicato proprio a D’Annunzio giovane e il Verismo, e contiene una serie di interventi che fanno abbondantemente luce su tale argomento. Innegabilmente d’Annunzio orecchia la lezione zoliana e naturalistico-veristica, ma la interpreta a suo modo: «Chi aderisce di solito a una poetica – ha scritto a questo proposito Carlo Bo – si impegna a rispettare le leggi della scuola, porta il suo contributo alla dottrina che ha scelto, in d’Annunzio avviene esattamente il contrario, la dottrina essendo un abito da vestire o un repertorio di stimoli e soluzioni puramente strumentali ed esterni. […] Forse sarebbe più esatto dire che anche le dottrine letterarie erano per lui dei calchi, dei cartoni: fingeva di sposarle, in realtà si limitava e ripetere le occasioni, adoperando le formule, anzi esasperandole al massimo» (C. Bo, 1981, p. 15).
D’Annunzio lettore di Zola
Persino nella prima produzione del non ancora ventenne scrittore, per quanto s’è detto, ci sarebbe il segno di un d’Annunzio già ‘dannunziano’, a cui non interessa la rappresentazione oggettiva della vita in sé, ma «il drappeggio della vita, i suoi colori, i suoi suoni» (Ivi). Ragion per cui il d’Annunzio verista non sarebbe diverso dal d’Annunzio decadente. Per converso, altri critici hanno parlato di una sorta di naturalismo ‘perenne’ che farebbe capolino anche nella sua produzione matura. Del resto, egli sarebbe rimasto un fedele lettore di Zola a lungo: sebbene avesse letto sicuramente molto del ciclo dei Rougon-Macquart in prossimità della prima pubblicazione dei volumi, al Vittoriale, dello scrittore francese, si conservano solo edizioni tarde (La curée, Paris, Charpentier et Fasquelle,1895; Rome, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1896; Contes a Ninon, Nouvelle, Paris, Fasquelle, 1906; La faute de l’abbé Mouret, Paris, Charpentier & Fasquelle, 1900; Germinal, Paris, Fasquelle, 1900; L’assommoir, Paris, Charpentier & Fasquelle, 1900, queste ultime con notevoli tracce di una lettura attenta e minuziosa), segno inequivocabile che l’interesse nei suoi confronti non venne meno con il passare degli anni. Per completezza, va detto che, insieme ai volumi citati, gli archivi del Vittoriale conservano 3 dispense (pubblicate da Treves nel 1898) contenenti i resoconti stenografici dei processi Dreyfus e Esterhazy, con tutta la documentazione di interesse zoliano (lettere e articoli). Non si ha notizia, comunque, di rapporti epistolari diretti tra i due.
Sta di fatto che le suggestioni che egli acquisisce da Flaubert, Zola, i De Goncourt e Maupassant sono considerevoli e lasciano tracce ben documentabili nelle sue opere, non solo narrative, tra l’altro. E si tratta di un’assimilazione che avviene costantemente all’insegna di una rimodulazione personale nel laboratorio alchemico della sua sensibilità. Basterebbe citare la consistente e duratura influenza che su di lui ha un romanzo zoliano come La faute de l’abbé Mouret (1875), in cui trova una singolare sintonia con la sua sensualità panteistica. È, per esempio, letteralmente affascinato dalle descrizioni del giardino del Paradou, il panico sfondo agli amori dei protagonisti, Serge Mouret e Albine, una sorta di eden in cui natura e personaggi si compenetrano a vicenda. A tal punto che – come ha notato Guy Tosi, che al tema dell’influenza di questo romanzo su d’Annunzio ha dedicato un illuminante saggio (Cfr. G. Tosi, 2013, pp. 745-760) – ad esso lo scrittore s’ispira ripetutamente e variamente non solo nelle novelle di Terra Vergine e de Il libro delle vergini, ma anche in Canto novo e forse persino in Primo vere, replicando situazioni diegetiche, immagini, nessi espressivi ed espedienti retorici (sintomatico quello delle sinestesie). È appena il caso di osservare che, dall’imponente produzione zoliana, trasceglie uno dei romanzi in cui predominano le aure romantiche o proto-decadenti, a conferma della sua vocazione predatoria di motivi che più collimano con la sua sensibilità estetica.
Di certo, nel corso degli anni Ottanta, questa sensibilità va corroborandosi in direzione decadente tramite il supporto di altri ‘spiriti fraterni’ con cui trova sempre maggiori sintonie. Se Zola o Maupassant continuano ad alimentare la sua ispirazione mitopoietica ancora fino ai primi anni Novanta – si vedano a tal proposito le aspre polemiche critiche circa gli echi del Lourdes di Zola nel Trionfo della morte o la sospetta prossimità de L’Innocente con alcune novelle maupassantiane (Cfr. M. Cimini, 2016, pp. 61-84) – gradualmente a essi subentrano come territorio di caccia i Paul Bourget, i Maurice Barrès, i Frédéric Amiel, modelli di quel roman d’analyse che per un buon tratto costituirà per d’Annunzio l’incarnazione emblematica di una narrativa autenticamente moderna. Senza contare che, sempre attraverso la mediazione francese, viene a contatto con il ‘pessimismo slavo’ dei grandi scrittori russi – Tolstoj e Dostoevskij in primo luogo – i quali rinsalderanno in lui il convincimento che anche il romanziere non può esimersi dal farsi esploratore – secondo i precetti di un Rimbaud sul poeta ‘veggente’ – degli abissi della psiche umana.
Già sul finire degli anni Ottanta, d’Annunzio va sviluppando un’acuta percezione riguardo all’evoluzione delle tendenze letterarie della sua epoca al punto da dimostrarne una conoscenza aggiornatissima, cosa che gli è possibile solo grazie al rapporto simpatetico con la cultura d’avanguardia francese.
Così, non gli sfugge, ‘in tempo reale’, che in Francia le cose stanno mutando rapidamente e che il Naturalismo, così come il favore per Zola, sono giunti al capolinea. È a conoscenza sicuramente della pubblicazione del cosiddetto Manifeste des Cinq (uscito su “Le Figaro” del 18 agosto 1887), in cui giovani scrittori della terza generazione naturalista – Paul Bonnetain, i fratelli J.-H. Rosny, Lucien Descaves, Paul Margueritte et Gustave Guiches – attaccano Zola (che aveva appena pubblicato La terre) accusandolo di volgarità e ossessioni degne di cure psichiatriche. Pochi mesi dopo, il 26 maggio 1888, pubblica su “La Tribuna” un articolo – L’ultimo romanzo – in cui mette alla berlina il disorientamento e gli errori di quegli scrittori che, pur professando ancora un certo ossequio verso il padre del romanzo sperimentale, ne avvertono chiaramente tutti i limiti metodologici: «Tra i romanzatori di Francia – scrive – la confusione è grande. Lo spettacolo de’ loro dubbi e delle loro esitazioni estetiche è singolarissimo. […] Che vogliono, che cercano i giovini letterati di Francia? Qual è mai il loro ideale d’arte? Quali sono i loro criteri estetici? Da quali leggi il loro gusto è governato? In verità, essi non sanno più quel che si fanno. Il romanzo naturalista è all’agonia. […] Quelli stessi scrittori che già furono la speranza della scuola naturalista, i collaboratori delle Soirées de Médan, sembrano ormai stanchi e disgustati d’una forma che un tempo difendevano con tanto accanimento. La perplessità loro è miserevole. Essi dalle abitudini d’una volta sono ancora tenuti alla osservazione esteriore, alla descrizione esatta; e, insieme, dalla vigente moda letteraria, son trascinati alla ricerca dell’analisi psicologica, in cui si smarriscono» (G. d’Annunzio, 1988, p. 1193). Da qui l’incapacità di creare coerenti ed organiche opere d’arte in cui risultino armonizzate le componenti descrittive con quelle analitiche. E dunque, prosegue: «Questo fondamentale error letterario de’ romanzieri naturalisti trasformati proviene da un errore scientifico. Essi credono che le cose esteriori esistano fuori di noi, indipendentemente, e che quindi debbano avere per tutti gli spiriti umani una medesima apparenza (Ivi, p 1194).
Con quest’ultimo pezzo, siamo a tutti gli effetti di fronte ad un vero e proprio manifesto di poetica che erode alle basi il presupposto stesso della letteratura naturalistica: l’osservazione oggettiva della realtà non è possibile perché la realtà non esiste in sé e per sé, ma è il frutto di una proiezione del soggetto. Occorre una nuova idea di scienza. Lo scrittore, in sostanza, preso atto della crisi del Naturalismo e del magistero zoliano – cosa che, tra l’altro, non gli provoca grandi rammarichi, per i motivi a cui abbiamo accennato – appare già prontamente sintonizzato su una temperie post-naturalista che egli capta avidamente nel clima estetico europeo. Guy Tosi ha ben rimarcato come l’articolo in questione non sia altro che una traduzione, più o meno adattata, di un saggio di Teodor De Wyzewa, paladino della ‘letteratura wagneriana’, comparso sulla “Revue Indépendante” nel marzo 1887. Da esso, tra l’altro, d’Annunzio traeva e faceva propria l’idea di una letteratura capace di costituirsi come sintesi di tutte le arti sulla base del comune denominatore della musicalità dell’espressione: «all art constantly aspires towards the condition of music» – aveva scritto Walter Pater nel 1873 – ed ora quel precetto diveniva ineludibile per liberarsi dalle secche della prosaicità naturalistica e concepire forme autenticamente moderne. Ma egli contamina variamente anche altre fonti che va metabolizzando da qualche tempo, in primis quella della filosofia schopenhaueriana che gli fornisce solide basi concettuali per l’immagine di un mondo che è proiezione della soggettività e rappresentazione continuamente cangiante dell’io individuale.
Sul piano creativo, il frutto di questi convincimenti è senz’altro il suo primo romanzo, Il Piacere: «dall’elogio del romanzo ‘fisiologico’ che escludeva ‘la soggettività’ – scrive sempre Tosi – eccoci in presenza dell’ideale contrario, quello del romanzo soggettivo la cui preoccupazione essenziale, trascurata dai naturalisti, dovrà precisamente consistere nel mettere in accordo la descrizione dei luoghi e degli avvenimenti con le speciali condizioni intellettuali del personaggio (G. Tosi, 2013, p. 895).
Considerando che il 1889 è l’anno di pubblicazione sia de Il Piacere che del secondo ed ultimo romanzo del ‘ciclo dei vinti’ di Verga, opportunamente s’è potuto dire che Mastro-don Gesualdo muore in casa di Andrea Sperelli (Cfr. G. Oliva, 1992, p. 21), non solo perché quest’ultimo ha molti tratti in comune con il duca di Leyra, nel cui algido palazzo effettivamente scompare il self-made-man verghiano, ma anche perché la concomitanza dell’uscita dei due libri sembra rappresentare emblematicamente un passaggio di consegne tra due modi opposti di intendere l’arte del romanzo.
D’Annunzio critico di Zola: oltre la barriera del Naturalismo
Parallelamente all’impegno creativo, d’Annunzio non demorde dal suo attivismo critico attuando quella che egli, in altre occasioni, definisce una vera e propria strategia ‘ossidionale’, ovvero di assedio battagliero nei confronti della già vacillante cittadella naturalistica. Il biennio 1892-93 fa registrare un fuoco di fila di articoli che mirano alla demolizione delle teorie zoliane e al consolidamento di un nuovo sistema di riferimento per la modernità letteraria. Il 31 gennaio 1892 pubblica sulla “Domenica di Don Marzio” Il romanzo futuro. Frammento d’uno studio su l’Arte Nuova, in cui – sempre centellinando la linfa che gli giunge dalla Francia (questa volta il riferimento è all’Enquête sur l’évolution littéraire di Jules Huret uscita nel 1891) – rileva senza mezzi termini che un «ciclo d’arte» è «ormai compiuto». Continua ad usare un frasario per certi versi naturalistico e zoliano, fatto di nessi come «osservazione esatta», «assoluta sincerità», vita rappresentata con «impeccabile esattezza», ma in un’accezione totalmente diversa rispetto alla grammatica naturalistica perché, da ora in poi, l’obiettivo deve essere – secondo l’esempio di scrittori come «Teodoro Dostojewski» e «Leone Tolstoi» – quello di infondere nella pagina «i fremiti più occulti dell’essere umano», ricreare «un nuovo esemplare della realtà scomparsa», rivelare una «particolare visione dell’universo», utilizzando «mezzi d’espressione potentissimi e nel tempo medesimo semplici»: lo stile dei nuovi artefici non dovrà più essere un mero esercizio letterario «ma quasi una diretta continuazione della vita» (G. d’Annunzio, 1892, pp. 17-20).
Tali concetti, non senza un’integrazione a sfondo sociologico sulla necessità che l’arte moderna risponda all’esigenza di dare soddisfazione ai bisogni estetici di un pubblico sempre più vasto, sono reiterati pressoché testualmente in un articolo pubblicato sul “Mattino” di Napoli il 1° settembre 1892, Note su l’arte: il bisogno del sogno. Ma tornano, sempre con qualche ulteriore aggiunta o variazione, anche in altri articoli usciti sul quotidiano partenopeo – L’arte letteraria nel 1892 (la prosa), 29 dicembre 1892, Una tendenza, 31 gennaio 1893 – e su “La Tribuna” di Roma. In particolare, nei pezzi usciti su quest’ultima testata è dato assistere ad una sorta di climax che, da un lato contempla una sempre più meticolosa pars destruens nei confronti della mentalità naturalistica e, dall’altro, una progressiva pars construens che è chiaramente orientata in direzione estetico-decadente. L’azione dannunziana va dispiegandosi nel dettaglio di un’acuta riflessione circa il rapporto tra scienza ed arte, proprio con l’obiettivo di scardinare l’adagio naturalistico e zoliano che è l’arte ad assumere dalla scienza positiva saldi addentellati metodologici. Lo scrittore rovescia il senso di questo rapporto; e dunque, rimarca in un articolo – Elogio dell’epoca – uscito il 23 giugno 1893 su “La Tribuna”: «L’arte, esprimendo con più forza e con più lucidità quel che la natura esprime oscuramente, rappresentando con la maggior possibile esattezza verbale i più complessi fenomeni interiori per rendere visibili i loro rapporti nascosti, decomponendo gli elementi per organare nuove forme e dando a queste tutta l’intensità del reale, in fine scoprendo nelle rappresentazioni le analogie che le collegano l’una all’altra, può fornire alla scienza non soltanto indizi preziosi ma rendere evidente ciò che ancora non è dimostrabile (G. d’Annunzio, 1893, p. 204).
L’arte, insomma, precedendo o andando oltre la scienza, può sondare il mistero che a questa sfugge, non limitandosi alla superficie fenomenica del reale, dal momento che le «cose non sono se non i simboli dei nostri sentimenti, e ci aiutano a scoprire il mistero che ciascuno di noi in sé racchiude» (Ivi, p. 206). Vista in questi termini, la scienza assume un ruolo ancillare rispetto all’arte rendendole «l’antico elemento che pareva dovesse per sempre mancarle: IL MERAVIGLIOSO» (Ivi, p. 207).
Il vertice della campagna antinaturalistica di d’Annunzio è rappresentato da una serie di tre articoli dedicati a La morale di Emilio Zola, usciti sempre su “La Tribuna” il 3, il 10 e il 15 luglio 1893. In essi, prendendo spunto dalla pubblicazione del ventesimo ed ultimo romanzo del ciclo dei Rougon-Macquart, Le Docteur Pascal (uscito nei primi mesi del 1893), egli ne approfitta per condurre in porto la sua liquidazione definitiva del sistema zoliano gravato, a suo dire, da inguaribili errori di metodo proprio nel concepire un fallace rapporto tra arte e scienza: «Emilio Zola, – scrive in conclusione del trittico di articoli – non soltanto in questo romanzo ma in tutta quanta la sua opera immane, non ha tenuto conto se non d’un piccolo numero di «fattori» della società contemporanea, avendo preso alla scienza una vaga apparenza di metodo e avendo ristretto il cerchio di quella vita alla cui diversità innumerevole egli leva l’inno finale. Per ciò, contro l’apparenza, l’edificio ch’egli ha costruito è vasto di dimensioni ma non è moltilatero come quello di Balzac; e s’impone più per la mole che per la materia e il disegno (G. d’Annunzio, 1893, p. 232).
Tutta l’opera di Zola, secondo d’Annunzio, è dunque basata su un sistema arbitrario, convenzionale, che «non ha e non può avere nessun valore scientifico» (Ivi, p. 226); e si tratta di un sistema che, per di più, risulta approssimativo sul piano estetico, per esempio nella creazione dei personaggi che «non ci appaiono come esseri studiati semplicemente, immediatamente, ma come le parti di un sistema precogitato». E si chiede: «che cosa ha di comune questa maniera col metodo sperimentale della scienza positiva?» (Ivi, p. 225). All’interrogativo retorico non può trattenersi dal rispondere reiterando la sua posizione: «Io penso – e ho ripetuto più volte – che nella esplorazione del rinnovato mondo l’arte debba andare innanzi alla scienza e che alla scienza, la quale va coordinando la verità esperimentale, l’arte debba proporre ipotesi, fornire indizii di verità ancora nascoste, presentare documenti rivelatori» (Ivi, p. 225).
È abbastanza ovvio che, per d’Annunzio, Zola non può essere lo scrittore-guida della modernità letteraria. Non è un caso che, a distanza di una sola settimana, inizi a pubblicare – sempre su “La Tribuna” (23 luglio, 3 e 9 agosto 1892) – una serie di altri tre articoli dedicati a Il caso Wagner in cui, sempre attingendo dal contesto europeo, e in polemica tra l’altro con Nietzsche, vede proprio nel compositore del Tannhäuser l’artista emblematico della modernità, per la sua capacità di interpretare magistralmente il «bisogno metafisico» della sua epoca, esprimendone i turbamenti, le inquietudini, le ansie, i sogni. Altrettanto emblematico è il fatto che il modello wagneriano dell’opera ‘totale’ agisca come struttura portante del romanzo che lo scrittore va concludendo tra il 1893 e il 1894, quel Trionfo della morte, «ideal libro di prosa moderna» che programmaticamente mira ad armonizzare «tutte le varietà del conoscimento e tutte le varietà del mistero», alternando «le precisioni della scienza alle seduzioni del sogno», posto che bisogna «non imitare ma continuare la Natura». A quest’altezza cronologica, Zola è ormai a tutti gli effetti un sorpassato.
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Le citazioni degli articoli dannunziani sono tratte da Gabriele d’Annunzio, Scritti giornalistici. 1882-1888, vol. I, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori (“I Meridiani”), 1996, e Gabriele D’Annunzio, Scritti giornalistici. 1889-1838, vol. II, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori (“I Meridiani”), 2003.
Bibliografia secondaria
Renato Barilli, La barriera del Naturalismo, Milano, Mursia, 1964-1980.
Raffaella Bertazzoli, Lourdes – Casalbordino: a proposito dei plagi dannunziani, in Trionfo della morte, Atti del III Convegno Internazionale di Studi Dannunziani, Pescara 22-24 aprile 1981, Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani, 1983, pp. 261-268.
Carlo Bo, D’Annunzio giovane e il verismo, in D’Annunzio giovane e il verismo, Atti del I Convegno Internazionale di Studi Dannunziani, Pescara, 21-23 settembre 1979, Pescara, Centro Nazionale Studi Dannunziani, 1981.
Mario Cimini, D’Annunzio, la Francia e la cultura europea, Lanciano, Carabba, 2016.
Mario Cimini, D’Annunzio, Zola e la frontiera del Naturalismo, in Rappresentazioni narrative. Realismo, verismo, modernismo tra secondo Ottocento e Primo Novecento. Sperimentazione italiana e cornice europea, Atti del convegno Internazionale di studi, Catania, 3-5 ottobre 2019, a cura di Gabriella Alfieri, Rosario Castelli, Sergio Cristaldi, Andrea Manganaro, Catania, Fondazione Verga, 2020, pp. 157-167.
Gianni Oliva, D’Annunzio e la poetica dell’invenzione, Milano, Mursia, 1992.
Ugo Ojetti, Alla scoperta dei letterati (1895), Roma, Gela Editrice, 1987.
Guy Tosi, D’Annunzio et “La faute de l’abbé Mouret”, «Quaderni del Vittoriale», n. 14 (1979), pp. 5-16; ora, in versione italiana, in Id., D’Annunzio e la cultura francese. Saggi e studi (1942-1987), a cura di M. Rasera, t. II, Lanciano, Carabba, 2013, pp. 745-760.
Guy Tosi, Incontri di D’Annunzio con la cultura francese (1879-1894); in Id., D’Annunzio e la cultura francese, cit., t. II, pp. 855-915.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)