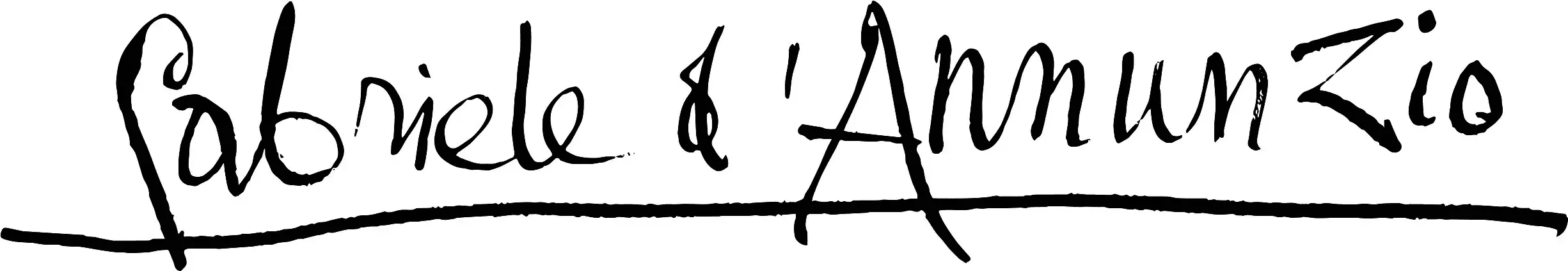di Pietro Della Sala, Enciclopedia dannunziana
Amicizia carsica
«Sorrido all’operosa nostra amicizia lontana» (Fugazza 2006, p. 64), scrive nel 1931 Gabriele d’Annunzio a Giulio Aristide Sartorio. In quel periodo, Sartorio progetta il monumento commemorativo dedicato a Luisa de Benedictis, madre del poeta: l’anno successivo, malgrado gli auspici dell’amico, le sue condizioni di salute peggioreranno impedendogli di realizzare l’opera e, infine, morirà nell’ottobre del 1932. La lettera testimonia della longeva vicinanza artistica e affettiva fra d’Annunzio e Sartorio, iniziata negli anni Ottanta dell’Ottocento e approdata all’estrema maturità. Sarà infatti sul triplice versante delle collaborazioni artistiche, della sintonia estetico-ideologica e del rapporto amicale, che si dipanerà il legame fra Giulio Aristide Sartorio e Gabriele d’Annunzio.
Sartorio, le opere e i giorni
Giulio Aristide Sartorio nasce a Roma l’11 febbraio 1860. Figlio di padre scultore, si forma in parte in famiglia, in parte al seguito del pittore Podesti dell’Accademia di San Luca: «scultore, no, – sentenziò mio padre» (De Rosa, Trastulli 2005, p. 200), ricorderà l’artista nella sua maturità. A diciannove anni apre il primo studio in via Borgognona sperimentando precocemente numerose tecniche e generi artistici: dall’olio al pastello, dal paesaggio alla decorazione. Assimila rapidamente la tendenza neo-settecentista di Villegas e Fortuny dipingendo «donnine alla Watteau» e raffigurando, al contempo, vedute di ambientazione laziale secondo una propensione per la pittura di paesaggio che, sulle orme di Nino Costa, coltiverà per tutta la vita.
Parallelamente all’eclettico apprendistato artistico, Sartorio non trascura la formazione letteraria e inoltre, poco più che ventenne, a Parigi ha modo di conoscere le tendenze impressioniste e postimpressioniste. Collaboratore grafico della «Cronaca Bizantina» dal 1883, entra in contatto con personalità del milieu intellettuale romano fin-de-siècle quali Edoardo Scarfoglio, Diego Angeli e, soprattutto, il giovane Gabriele d’Annunzio. Dalla collaborazione col pescarese gemma, nel 1886, il contributo all’edizione dell’Isaotta Guttadàuro, silloge di testo e immagine cui partecipano, fra gli altri, Mario de Maria e Giuseppe Cellini. Frattanto, alle mostre organizzate in seno all’associazione, fondata da Costa, «In Arte Libertas» (1886) Sartorio ha modo di conoscere la produzione pittorica dei Preraffaelliti inglesi, che in seguito s’impegna ad approfondire personalmente attraverso viaggi in Inghilterra presso l’atelier di Edward Burne-Jones e studiando le opere di George Frederic Watts, Frederic Leighton e, soprattutto, Dante Gabriel Rossetti.
Visitatore di esposizioni e collezioni artistiche fra Parigi, Basilea, Bruxelles e Anversa, non lesina le collaborazioni col milieu letterario italiano, illustrando in particolare le opere del sodale d’Annunzio, con cui inoltre condivide l’amicizia con «la Mastre», il pittore Francesco Paolo Michetti, anfitrione dei due giovani amici nel suo convento-atelier in Abruzzo. L’apprendistato sartoriano, avviato fra anni Ottanta e Novanta sulla triplice traccia dell’eclettismo visivo, della cultura internazionale e delle collaborazioni letterarie, elegge la pittura preraffaellita a paradigma di una concezione estetica volta a una «rinascenza» artistica, attraverso un recupero dell’illustre tradizione nazionale incarnata dai Primitivi del Quattrocento – di cui è esempio il dipinto-manifesto Madonna degli Angeli (1895), echeggiante la Madonna del Magnificat botticelliana (ca. 1483). Tale approdo estetico, congiunto all’assimilazione di opzioni cromatiche, tematiche e compositive della coeva pittura simbolista di area tedesca durante il soggiorno come insegnante a Weimar (1896-99), troverà esito nel dittico Diana di Efeso e gli schiavi – La Gorgone e gli eroi (1890-99), esposto fra encomi e reprimende alla terza Biennale veneziana (1899).
Nei primi anni del Novecento, impegnato in opere di genere decorativo (influenzato anche dalla nuova vague liberty; cfr. Bossaglia 1997, pp. 78 ss.) e paesaggistico, Sartorio non trascura l’attenzione e l’impegno per la tutela del patrimonio artistico in seno, per esempio, all’Accademia di San Luca, né l’antica vocazione letteraria, pubblicando nel 1905 il romanzo Romae Carrus Navalis (C. Gibellini 2020) ispirandosi al cangiante milieu artistico della Roma umbertina. A sintesi, infine, del suo virtuosismo pittorico, del prestigio nazionale e dei contatti istituzionali, fra il 1908 e il 1912 compone il fregio decorativo per l’Aula parlamentare di Palazzo Montecitorio, compendio simbolico degli «elementi vitali della nostra resurrezione nazionale, che è perciò il fulcro della civiltà universale» (Damigella, Mantura 1989, p. 72).
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruola volontario, è fatto prigioniero, ma torna al fronte come «corrispondente di guerra», impegnandosi al contempo nella composizione di racconti e scene di ambientazione bellica. Al ritorno dal Carso si dedica all’attività artistica, a viaggi extra-europei e alla neonata famiglia nella sua dimora lungo la via Appia, gli Horti Galateae. Ritiratosi dalla scena pubblica, prosegue l’attività pittorica affiancando alla schiaritura della tavolozza la sperimentazione di nuovi strumenti visivi, come il cinema (cfr. i film, fra gli altri, Il mistero di Galatea, 1919 e San Giorgio, 1921; De Santi 2006), o il raffinamento dell’antica perizia grafica in opere quali il poema drammatico Sibilla (1922) secondo un’inedita ed eclettica sintesi visivo-verbale. Di ritorno da una spedizione di promozione dell’arte italiana in Sud America, riemerge gradualmente sulla scena pubblica diventando Accademico d’Italia nel 1929. Non viene meno, frattanto, la vis creativa, che esprime in dipinti a tema familiare (Bambini in riva al mare, 1927 c.; Maternità – La famiglia, 1928) ed evangelico (Il Precursore, 1927-28), unitamente all’attività disegnativa (Christus) e a estremi progetti letterari rimasti, tuttavia, incompiuti. Immerso nei bozzetti per la decorazione musiva del Duomo di Messina, malato da tempo muore a Roma il 3 ottobre 1932.
Nella Roma “bizantina”
Il primo atto della duratura amicizia fra Sartorio e d’Annunzio si apre presso la redazione della rivista «Cronaca Bizantina». Autore dei frontespizi a partire dal 1883, Sartorio non solo entra in contatto con numerosi letterati del milieu bizantino, ma coltiva frequentazioni artistiche destinate a future collaborazioni, fra cui in particolare con d’Annunzio. Succeduto alla direzione Sommaruga fra il 1885 e il 1886, il pescarese opta per una più sofisticata veste grafica cui Sartorio non manca di contribuire, ma una più proficua occasione di collaborazione artistico-letteraria emerge con l’editio picta della raccolta poetica Isaotta Guttadàuro (cfr. Andreoli, Lorenzini 2001, pp. 1027 ss.). Progettata sotto il prisma della tradizione letteraria francese a tema erotico-cavalleresco, nonché plasmata secondo le fogge ritmico-semantiche della poesia trecentesca italiana, tale silloge di testo e immagine raduna artisti di varia sensibilità tecnica e di comune abilità grafica, quali l’incisore Giuseppe Cellini, il pittore Marius Pictor (alias Mario de Maria) e, naturalmente, Giulio Aristide Sartorio: dell’artista romano si enumerano quattro illustrazioni, fra cui l’immagine incipitaria introdotta dal frammento «il biondo Astìoco e Brisenna reina…», raffigurante i protagonisti immersi in una monocromia terrosa, destinata invece a declinarsi nello spettro del blu per il disegno Isaotta nel bosco, «una sorta di palinodia, dunque, rispetto all’indirizzo veristico fino ad allora prevalente» (Fugazza 2006, p. 57). «Novissimum agmen», secondo Angelo Conti, proposto da una compagine di artisti e letterati «pronta a rinforzare le file dei caduti e a combattere le battaglie dell’avvenire» (Oliva 2020, p. 25), l’Isaotta sembra porsi come programma estetico al contempo oppositivo e alternativo rispetto alle esauste sensibilità realiste nonché, sul fronte ideologico, nei confronti della montante tendenza liberal-mercantile di una società postunitaria votata al solo profitto. Non ultime fra le istanze di rinnovamento estetico dell’Isaotta, emergono le note di gusto preraffaellita evocate a tratti dalle opzioni gestuali e ambientali delle immagini della silloge. Ammirati nella Roma di fine secolo grazie alle mostre dell’associazione «In Arte Libertas», i Preraffaelliti – in particolare Dante Gabriel Rossetti – sono prontamente celebrati da d’Annunzio, come Sartorio ricorda:
Chi fu il primo a parlarmi dell’opera di Rossetti? Gabriele d’Annunzio che allora, ospite di Michetti, scriveva Il piacere e che aveva innumeri riproduzioni dei quadri dell’enigmatico artista. Io le guardavo attratto e Francesco Paolo sorrideva diffidente. (De Rosa, Trastulli 2006, p. 208)
A conferma della profonda, benché temporanea, incidenza della vague preraffaellita nell’immaginario visivo del poeta e dell’artista emerge la coeva produzione lirica dell’uno e pittorica dell’altro, come dimostrano l’atmosfera medievale-bizantineggiante di tele sartoriane quali Visione medievale o La Vestale (1889 c.) o il successivo dipinto dall’aura rossettiana Dante e Beatrice (1896).
Fra Il Piacere e «Il Convito»
Tre anni dopo la collaborazione all’Isaotta, è la pubblicazione del primo romanzo dannunziano, Il Piacere (1889), a fornire un ulteriore terreno di collaborazione fra i due sodali. Le peregrinazioni erotico-antiquarie del protagonista, il conte Andrea Sperelli, risentono senz’altro delle cronache mondane pubblicate su «La Tribuna» o il «Fanfulla della Domenica» dal giovane poeta-giornalista che, da sempre amante delle arti visive, fa del suo alter ego romanzesco un incisore dilettante. Entro tale circolarità di realtà e finzione si inserisce l’idea di una grafica a opera dell’amico Sartorio, intitolata Acquaforte dello Zodiaco e firmata «A. Sperelli Calcographus», evocante nel nome la sovrapposizione fra l’artista e il personaggio, autore di un’incisione dal medesimo titolo. Raffigurante la co-protagonista femminile del romanzo Elena Muti ammantata di un tessuto a motivi astrologici, l’immagine incisa riproduce l’acquaforte realizzata da Andrea Sperelli in ricordo di uno dei convegni amorosi con la donna: «L’acquaforte rappresentava appunto Elena dormente sotto i segni celesti. La forma muliebre appariva secondata dalle pieghe della stoffa, col capo abbandonato un poco fuor della proda del letto, con i capelli pioventi fino a terra, con un braccio pendulo e l’altro posato lungo il fianco» (D’Annunzio, Il Piacere, Milano 2005, p. 96). Ulteriore contrappunto poetico-pittorico sembra emergere nella risonanza tematica fra un passo del romanzo e un successivo dipinto dell’artista grazie all’accenno di un oggetto presente nella camera-boudoir del protagonista: «Un paliotto, raffigurante la Parabola delle vergini sagge e delle vergini folli, e due pezzi di pluviale componevano la tappezzeria del caminetto» (ivi, p. 233); il medesimo soggetto è, infatti, rappresentato in un celebre trittico di Sartorio commissionato dal conte Giuseppe Primoli intorno al 1890, Le vergini savie e le vergini stolte (1890-1891; cfr. Miracco 2006, p. 176) e tornerà, infine, nella Parabola delle vergini fatue e delle vergini prudenti, pubblicata da d’Annunzio nel 1897 sulla «Nuova Antologia».
A tale altezza risale inoltre la comune amicizia con l’amico pittore Francesco Paolo Michetti, che, oltre a rappresentare una fonte di contatti umani e artistici fra d’Annunzio e Sartorio, svolge un ruolo decisivo nell’elaborazione di una poetica e di una tecnica destinate a rafforzarsi negli anni seguenti nella diversa declinazione espressiva: se, infatti, Sartorio, con sguardo e pennello, può giovarsi dell’«intelligenza animatrice» del maestro per trarne la «visione del mondo vivo e vero» del suo «classicismo», d’Annunzio profitta dell’atmosfera conventuale per ultimare il primo romanzo e, più tardi, per scrivere il Trionfo della morte (1894), dedicato non casualmente al «Cenobiarca» Michetti. Precedentemente, tuttavia, alla prima edizione in volume per Treves, d’Annunzio ne avvia una prima pubblicazione per «La Tribuna Illustrata» col titolo L’Invincibile, di cui Sartorio offre un contrappunto figurativo nei numeri editi nei primi mesi del 1890. Pubblicazione interrotta e proposta in volume solo nel 1915, L’Invincibile offre materia diegetica e psicologica per il Trionfo della morte, oltreché un’occasione di collaborazione di tipo illustrativo, replicata due anni dopo per l’edizione napoletana del romanzo «slavo», L’Innocente (1892). Se per le illustrazioni dell’Invincibile Sartorio opta per dipinti dalla resa mimetica non ancora trasfigurati secondo l’incipiente gusto preraffaellita, come testimoniano le immagini dell’Oratorio di via Belsiana («La Tribuna Illustrata», a. 1, n. 3, 19 gennaio 1890), o l’enigmatica veduta del Lago di Nemi («La Tribuna Illustrata», a. 1, n. 4, 26 gennaio 1890), L’Innocente risulta più semplicemente corredato da un disegno con Cristo sulla Croce eseguito a pastello a tinte fredde ed evocante il simbolico nucleo morale dell’opera di riflesso all’incipit della preghiera «Beati immaculati…» citata in esergo (D’Annunzio, L’Innocente, Milano 2005, p. 360). La pratica d’illustrazione sartoriana si estende in seguito al côté poetico del pescarese, corredando nel marzo 1893 le tre poesie Le Statue – presentate con numerazione romana progressiva (I, II e III) e confluite successivamente nell’edizione napoletana del Poema Paradisiaco con titolatura al singolare – di un’immagine unica ne «La Tribuna Illustrata». All’artista è parallelamente affidata l’elaborazione grafica degli ex-libris dannunziani, volti a personalizzare con figurazioni emblematiche i volumi del poeta attualmente consultabili al Vittoriale degli Italiani: grazie alla tecnica della zincografia meccanica, Sartorio ne compone un esemplare nel 1890 e un altro più noto nel 1898 dal titolo Per non dormire, tratto da un motivo ispirato a Max Klinger dell’eterno memento di contro al rischio d’inerzia del genio creativo, precocemente adagiato sulle effimere gratificazioni della gloria artistica.
Frattanto, le letture di testi di Nietzsche, Barrès e Carlyle alimentano la struttura ideologica di d’Annunzio romanziere oltreché giornalista, spingendolo a nuovi approdi estetici e letterari concretati nella stesura del Trionfo della morte, delle Vergini delle rocce e, parallelamente, degli articoli pubblicati su «La Tribuna». Un engagement giornalistico ancor più netto, tuttavia, sembra emergere grazie alla co-fondazione del «Convito» di Adolfo de Bosis, cui Sartorio stesso partecipa sul fronte artistico, giornalistico e finanziario (De Rosa, Trastulli 2005, p. 202). Attorno a tale progetto editoriale si riunisce una compagine intellettuale di estrazione al contempo bizantina (Scarfoglio) e simbolista (Pascoli) avviata sul tracciato estetico delineato dal filosofo neoidealista Angelo Conti. Sotto l’egida contiana, «Il Convito» vagheggia una rinascita culturale nazionale attraverso un rinnovamento artistico ispirato a un ideale di bellezza eterna, indefettibile, foriera di «sollievo» rispetto al contingente scorrere del tempo: una «Bellezza consolatrice» destinata a riemergere fra i ricorsi umani. A tale concezione estetica si salda uno slancio conservatore sotteso all’iniziativa editoriale tramite il recupero di stilemi visivo-verbali evinti dalla tradizione artistica nazionale, già definito «rinascimentalismo» (Maltese 1960, p. 250), che d’Annunzio enuncia nel Proemio al Libro I:
Ebbene, c’è ancóra qualcuno che in mezzo a tanta miseria e a tanta abjezione italiana serba la fede nella virtù occulta della stirpe, nella forza ascendente delle idealità trasmesseci dai padri, nel potere indistruttibile della Bellezza, nella sovrana dignità dello spirito, nella necessità delle gerarchie intellettuali, in tutti gli alti valori che oggi dal popolo d’Italia sono tenuti a vile, e specialmente nell’efficacia della parola. […] noi vorremmo portare in trionfo un simulacro di Bellezza così grande che la forza superba della forma – quella vis superba formae esaltata da un poeta umanista – soggiogasse gli animi abbrutiti. (D’Annunzio, Scritti giornalistici. 1889-1938, Milano 2003, pp. 285-286).
A questo ideale recupero artistico di contro alla «barbarie» contemporanea si allinea la collaborazione che Sartorio esprime non solo «con un piccolo contributo finanziario», ma anche attraverso l’attività grafica e giornalistica, pubblicando il disegno della già citata Madonna degli Angeli di gusto botticelliano e alcune composizioni rappresentanti la figura della Gorgone, preludenti al dittico esposto alla terza Biennale veneziana a conferma di scelte formali al contempo debitrici dei Primitivi italiani e dei Simbolisti tedeschi. Tale mélange iconografico è confermato dalle osservazioni esposte nelle Cronache della prima Biennale veneziana nonché nella Nota su D.G. Rossetti. Pittore, in cui, tracciando la parabola della Confraternita preraffaellita, il pittore indica la via necessaria per una rinascita artistica (e culturale) dell’Italia:
Ora, se di tale movimento non fossimo pensosi noi italiani, depositari avventurati del più ricco materiale estetico, commetteremmo il più crudele suicidio. Dinanzi al luminoso incontro della somma intellettuale europea col nostro genio, noi abbiamo il dovere di affermarci assertori non fiacchi dello spirito di quest’istesso popolo che ha data la Rinascenza. (Sartorio, Nota su D.G. Rossetti. Pittore, «Il Convito», libro IV, 1895, p. 285)
Conclude, quindi, ribadendo la necessità di rinascita nazionale su spinta di un rinnovato spirito artistico:
Noi siamo giovani ed abbiamo la necessità di essere, finalmente, noi […] Per le nobili notizie del sangue e per il consenso felice delle cose che ne circondano, noi possiamo veramente giungere, senza lo sforzo ed il lungo cammino cui furon costretti i popoli del Nord, alla cima donde l’Arte ne accenna. (ivi, p. 286)
Debitore della concezione contiana dell’arte affine al sodale d’Annunzio, Sartorio delinea nel «Convito» un posizionamento estetico di gusto neo-quattrocentista evocato, peraltro, nel romanzo Le vergini delle rocce, che contestualmente il pescarese pubblica a puntate sulla rivista. La rinascita culturale (e morale) attraverso il repêchage di un prestigioso paradigma estetico del passato che affratella d’Annunzio e Sartorio è, infine, ribadita nella recensione di d’Annunzio al saggio di Conti su Giorgione, Note su Giorgione e su la critica, in particolare nella sezione conclusiva del saggio echeggiante locuzioni rintracciabili nella Nota sartoriana, come «stile», «arte futura», «antichi maestri» e «stirpe»:
Poiché lo stile fu creato dai Greci e poiché esso ricorre spontaneo alla mano d’ogni sommo artefice […] appare evidente che anche l’arte futura dovrà la sua elevazione al rinnovato insegnamento di quelli antichi maestri i quali riuscirono ad esprimere […] tutte le aspirazioni di nostra stirpe». (D’Annunzio, Scritti giornalistici. 1889-1938, Milano 2003, p. 296)
Sulle medesime note, qualche anno più tardi, d’Annunzio accorderà la riflessione sulla demiurgia artistica nel romanzo veneziano, Il Fuoco, cui il Giorgione contiano e le due Note avranno offerto una preliminare partitura teorica.
Sintonie e dissonanze d’inizio secolo
I regolari contatti di natura giornalistica ed editoriale intrattenuti fra d’Annunzio e Sartorio nel decennio 1885-1895 vanno diradandosi progressivamente negli anni seguenti sulla scorta della rispettiva affermazione artistica. All’eclettica profusione creativa di d’Annunzio sullo scorcio del secolo espressa fra riviste, prosa, teatro e poesia, corrisponde l’impegno artistico, didattico ed espositivo che Sartorio svolge tra Roma, Weimar e Venezia. Malgrado l’allentamento della reciproca collaborazione, non può negarsi un comune sperimentalismo di generi e tecniche, ciascuno nel suo linguaggio, congiunto all’approfondimento di consimili temi e stilemi. Parallelamente alla stesura del Fuoco, d’Annunzio si dedica al crescente impegno teatrale (La Città morta, Sogno d’un mattino di primavera, Sogno d’un tramonto d’autunno, La Gioconda, La Gloria) e alla produzione lirica delle Laudi, tralasciando progressivamente l’attività prosastica e imponendosi, infine, sulla scena letteraria italiana ed europea come massimo scrittore contemporaneo, erede-vate dell’antico maestro Carducci. Alla stregua dell’amico poeta, Sartorio concilia la prolifica produzione pittorica con l’attività letteraria e con un impegno istituzionale – in particolare nella conservazione del patrimonio artistico –, diversificando la sua tavolozza con vedute paesistiche a soggetto italiano e tedesco (cfr. Vesuvio, 1895 c.; Interno di palazzo a Norimberga, 1896), con temi di memoria dantesco-rossettiana (Dante e Beatrice, 1896) e, inoltre, con tele d’ispirazione mitologica influenzate dall’immaginario monacense quali il dittico Diana di Efeso e gli schiavi – La Gorgone e gli eroi. È pertanto all’insegna di una tangibile convergenza nell’eclettismo dei generi, nella sperimentazione tecnica e nella rielaborazione di suggestioni antiche e recenti, che d’Annunzio e Sartorio – ognuno nel suo linguaggio – si affacciano al nuovo secolo, pur in assenza di dirette collaborazioni. Apice dei maturi approdi estetici dell’artista e del poeta sarà la pubblicazione dei primi tre libri delle Laudi (1903) da parte di d’Annunzio e la realizzazione del Fregio (1908-1912) per l’Aula di Palazzo Montecitorio a opera di Sartorio.
Il Fregio, posto al di sopra delle tribune lignee sovrastate dalla copertura vitrea a copertura dell’Aula, costituisce l’approdo finale delle ricerche sulla pittura decorativa condotte per decenni dall’artista romano. Ispirato ai fregi del Partenone e ai Trionfi mantegneschi ammirati gli anni precedenti in Inghilterra, il fregio raffigura il cammino del popolo italiano dai Comuni medievali sino all’epopea risorgimentale in direzione della libertà incarnata dalla Giovane Italia, coincidente col centro geometrico del lato curvilineo dell’Aula, a tutela dell’esercizio del potere della Terza Italia. Recupero e rinnovamento, quindi, del patrimonio visivo nazionale e, al contempo, celebrazione del travagliato percorso di rinascita del suo popolo, il fregio ribadisce la visione estetico-ideologica fondata sul binomio tradizione-rinascita già formulata ai tempi del «Convito» in consonanza con d’Annunzio.
Dal «radioso maggio» alla Città di Vita
Se le maggiori collaborazioni artistico-editoriali terminano sullo scorcio del secolo, prosegue a distanza un’attività dalle ricorrenti sintonie estetico-ideologiche parallelamente a un’affermazione sulla scena intellettuale. In Sartorio alberga senz’altro uno slancio patriottico che alle porte della Grande Guerra si tinge d’interventismo, senza tuttavia declinarsi nei ruoli illustri o preminenti riscontrabili nella condotta dannunziana. Lo slancio ideologico-politico dell’artista si traduce piuttosto in una concreta partecipazione, conciliata con l’attività creativa attraverso la rappresentazione a olio e a pastello di scene di guerra, «il solo documento dipinto sul vero della guerra nostra», secondo Ugo Ojetti (Ojetti 1948, p. 368), esposte in una mostra romana immediatamente dopo il conflitto e pubblicate in Guerra vista rappresentata. Impressioni di G.A. Sartorio dall’editore Bestetti & Tumminelli. Alla fase finale del conflitto risale una lettera di Sartorio indirizzata a d’Annunzio, datata 26 aprile 1918, che accenna all’elaborazione di un’illustrazione per La Riscossa, breve raccolta di orazioni belliche edita nel 1918 presso il medesimo editore e raffigurante una mano che impugna una spada: «Gabriele carissimo», esordisce l’artista, «hai perfettamente ragione, il motto và innestato nel disegno ed il disegno inciso della stessa grandezza del riquadro xilografico» (Fugazza 2006, p. 62). L’immagine, estratta da una tavola dell’opera drammatica sartoriana Sibilla, allude a San Giorgio che uccide il drago, adombrando l’azione militare italiana contro l’Idra austriaca. A conferma del vivo contatto amicale, la pur breve missiva prosegue con un rapido aggiornamento sulla marcia militare seguita da Sartorio: se non fosse che «la burocrazia in Italia è talmente serpente che ne [sic] io ne [sic] tu, San Giorgio riusciremo mai a vincerla», vorrebbe «andare in Francia con le divisioni italiane», a conferma dell’indefessa vis patriottica che lo congiunge al poeta.
Fra buen retiro e luci della ribalta
Simili nelle dinamiche temporali sono alcune scelte private operate dopo il rientro dal fronte nel primo dopoguerra. In momenti e con modalità diverse, entrambi optano per un progressivo ritiro dal proscenio verso un ménage privato – diversamente declinato – presso una dimora appositamente prescelta per la maturità: il futuro Vittoriale del poeta, gli Horti Galateae per l’artista. Nel 1921-1924 entrambi condividono l’inclinazione al ritiro dalla scena pubblica, il riserbo privato e una rinnovata attività artistica, non esente da più ambiziosi progetti – i contatti col milieu irredentista e reducista postbellico, la progettazione della FILM (Federazione Italiana Lavoratori del Mare) e altre aspirazioni politiche per d’Annunzio; in direzione più disimpegnata tra viaggi e attività artistiche verso mete extra-europee, come la Siria, la Terra Santa e l’Egitto, per Sartorio.
Il 1924, anno decisivo per le sorti politiche, ideologiche e morali della Penisola a seguito dell’assassinio di Giacomo Matteotti, squassa lo scenario e la coscienza intellettuale nazionale facendo paventare la caduta del governo e, secondo la speranza di molti, del neonato fascismo. In concomitanza con i fatti del 1924 e del 1925, d’Annunzio e Sartorio, ormai dediti a una vita prevalentemente ritirata o ideologicamente poco implicata, non sembrano esporsi in appoggi né in reprimende pubbliche: benché nella seconda metà del 1924 d’Annunzio abbia diradato i contatti epistolari con Mussolini, le comunicazioni non cessano e riprendono progressivamente a partire dal gennaio 1925, per stabilizzarsi con regolarità su uno scambio di profferte del duce e memoranda del poeta, interessato all’opera omnia, alla «fabrica» del Vittoriale e a favori agli amici (soprattutto negli Abruzzi), pur senza espliciti appoggi. Sartorio, accettato l’incarico di promotore dell’arte italiana, si imbarca per il Sud America sulla Regia Nave Italia (cfr. Mantura 1999) e non interrompe i contatti col milieu culturale ed espositivo nazionale senza trascurare il côté famigliare.
Sullo scenario della svolta autoritaria della Penisola e dello iato civile fra intellettuali fascisti e intellettuali antifascisti nel corso degli anni Venti, comune all’artista e al poeta è la deviazione di temi e stilemi creativi delle loro opere rispetto a traiettorie improntate alla traccia ideologica del regime. Sartorio, traendo ispirazione dai suoi viaggi extra-europei (Medio Oriente, Egitto, Sud America e Giappone) e dedicandosi a nuovi progetti creativi (la grafica e il cinema), compone tele di ambientazione domestica o evangelica, di cui resta traccia nelle opere esposte alle Biennali degli anni Venti, come rivelano, per esempio, il catalogo del 1922 o del 1926, o tele quali Il Precursore (1927-1928). Allo stesso tempo, d’Annunzio elabora le «prose di ricerca», gemmate dal ricordo del passato (prossimo della Guerra, o remoto negli Abruzzi), o su cascami ideologici-irredentisti (cfr. P. Gibellini 2023, p. 179-181, p. 363 ss.). La produzione creativa del poeta e dell’artista, dunque, non risulta influenzata dal coevo clima intellettuale o ideologico, ma si accorda prevalentemente su note evasive, memoriali, introspettive.
Accoglieresti la mia dimanda?»
Fra le opere cui Sartorio si dedica negli ultimi anni della sua vita va ricordato il monumento funebre per donna Luisa de Benedictis, madre di d’Annunzio, estrema occasione di vicinanza amicale fra i due antichi sodali. Dopo anni di riserbo e distacco, lo scambio epistolare riattiva l’antico confronto amicale a partire da una lettera datata 31 dicembre 1929; Sartorio, probabilmente con l’occasione di qualche festività di fine anno, invia a d’Annunzio una lettera di saluti, cui il poeta risponde «con un misto di gioia e di rancore»:
Dopo anni e anni di chiuso silenzio, finalmente ti ricordi di me! E per anni tu fosti il mio amico diletto: amico di tavolozza e di poesia: a volta a volta commensale nella carnosa osteria di Via Flaminia e nella casa marina “de la Mastre”. (Fugazza 2006, p. 63)
Il gradito saluto di Sartorio permette a d’Annunzio di rievocare il ricordo dell’antica amicizia, sorta fra le collaborazioni artistiche della Roma bizantina e i soggiorni abruzzesi sotto la guida ispiratrice «de la Mastre», Francesco Paolo Michetti; augurandosi, infine, un imminente incontro, il poeta allude probabilmente alla sfilata del Costume Italiano organizzata quell’anno per le nozze del Principe di Piemonte:
Come sarei contento di rivederti! Se non verrai al Vittoriale, verrò io stesso a cercarti nell’Accademia. Mi piace che un pittore poeta sia oggi un de’ più schietti animatori dell’adunata; e mi piacerà esser da te condotto per mano a rivedere la Farnesina.
Auguro a te e ai tuoi cari ogni bene; e vedo i tuoi pennelli trasfigurarsi in raggi operosi.
Ti abbraccio.
Il tuo sempre
Gabriele d’Annunzio
A conferma, quindi, dell’intatta amicizia, d’Annunzio rivolge calorosi auguri all’artista, ricordandone la luminosità della tavolozza matura. Nella lettera successiva, datata 3 dicembre 1930, Sartorio ricambia la festosa accoglienza condividendo i medesimi «ricordi francavillesi» e scusandosi per il prolungato silenzio, cui vorrebbe far ammenda con una visita in compagnia dell’«amica dei miei giorni felici», la moglie Marga Sevilla:
Gabriele carissimo,
L’animo tuo è fresco come quello d’un fanciullo e le parole tue assomigliano a una fioritura. Gli ultimi anni vissuti hanno sconvolta la compagine dell’esistenza e la tua figura, ingigantita, pareva si fosse come allontanata da noi […]. Pareva che dovessi, per necessità delle circostanze, seppellire i ricordi come fardello inutile.
[…]
Viceversa io ho troppa ragione per non dimenticare. Nella tua carissima evochi “il Maestro” ed è come se mi ricordassi un altro Gabriele. […] Il suo caro spirito ilare, sagace, savio ha aperte per noi tante finestre per vedere, amare e sorridere, nella sua Francavilla ridente è immancabilmente vivo. Gabriele, amico grande, tu non sei mancato a te stesso […]: non sai dimenticare e l’animo tuo cristallino mantiene a lato dei grandi solchi qualche tenue scalfittura che non manca di grazia per una sua fede. Appena potrò io verrò a trovarti e lì condurrò l’amica dei miei giorni felici incominciati quando pareva la sera. […]
Salve Gabriele, con indimenticabile affetto ti saluta il tuo giustificabile Aristide (Ibidem)
Il tono caloroso di Sartorio illumina retrospettivamente non solo la figura del d’Annunzio post-bellico, ma decenni di intatta amicizia spesi fra sintonia spirituale e collaborazione artistica che entrambi, «quando pareva sera», sembrano voler rinnovare nel segno del ricordo umano e creativo. Nella lettera successiva, datata 6 gennaio 1931, d’Annunzio assicura all’amico il piacere del ricordo relativo al passato condiviso, congratulandosi per la sua attuale operosità nella decorazione musiva del Duomo di Messina:
Penso molto spesso a te; e sorrido dell’operosa nostra amicizia lontana, quando nell’aprire i miei libri scorgo alcuno de’ tuoi Ex-libris.
Non so dirti quanto mi piaccia che tu sia tuttora pieno di ricche opere e di lievissimi anni. Antonio Bruers mi parla, attonito, della tua giovinezza; e mi racconta come tu sia per animare di figure a miriadi un luogo sacro di Messina la dorata. (Ivi, p. 64)
Sarà questa, dunque, l’occasione per introdurre all’amico l’intenzione di erigere una chiesa dedicata alla madre, Luisa de Benedictis, e proporgli la realizzazione di un’opera commemorativa:
Anch’io sto per edificare nella mia città natale una chiesa novella: o, meglio, una chiesa intorno a una Cappella di sublime amore, ove traslaterò la salma della mia Madre.
Te ne ricordi? Tu le baciasti la mano, nella casa di Pescara, dove talvolta andavamo con Ciccillo Michetti.
Se io ti domandassi di ornare la Cappella interpretando alcuna mia parola in memoriam, accoglieresti la mia dimanda? (Ibidem)
La risposta dell’amico non solo non si fa aspettare (data 8 gennaio 1931), ma risulta estremamente affettuosa nel ricordo degli anni abruzzesi, nonché devota nell’accogliere la «dimanda» dell’amico, mostrando il consueto piglio operativo nell’organizzare i passaggi pratici della messa all’opera per il monumento alla madre del poeta:
Tu mi trovi con le mani benedette ed immagina se mi lusinga onorare la memoria di Donna Luisa che ricordo perfettamente. Ospite della cortese terra d’Abruzzo maturai là il mio embrionale carattere e non scorderò mai nessuna delle figure che amai e che mi vollero bene.
Stamane ho parlato con Cesare Bazzani e quanto prima faremo un sopraluogo a Pescara. (Ibidem)
Poco tempo dopo, il 5 aprile 1931, Sartorio torna a scrivere al poeta per chiedere precisazioni circa le sue preferenze per la decorazione: se mosaico, pala d’altare o affresco, prospettando le sue disponibilità di tempo parallelamente alla decorazione musiva di Messina:
Dovrei cominciare l’esecuzione dei cartoni per Messina, ed una volta incominciati non avrei la possibilità di decorare la cappella votiva di donna Luisa d’Annunzio. Potrei eseguirla prima, ma necessiterebbe perciò prestabilita l’indole della decorazione e, da un giorno all’altro, motto, dimensioni. Desideri musaici? Freschi? La pala d’altare?
[…]
Scrivimi in proposito. Io sono desideroso di collaborare con te animatore e sarei disposto a darti adesso i bei mesi di primavera e d’estate con un’attività fitta, intensa, immediata.
Per meglio intenderci potrei venire al Vittoriale, solo, in questi giorni. (Ivi, p. 65)
Come le lettere dimostrano, i contatti fra il poeta e l’artista sono calorosamente recuperati e mantenuti fra 1930-1931 in nome di un’affettuosa amicizia, mentre si rinnova su note fraterne la volontà di collaborazione. Tuttavia, la solitaria visita al lago non deve mai essere avvenuta, se alcuni mesi dopo Sartorio scrive all’amico: «non ho risposto alla tua lettera “primaverile” perché aspettavo il compimento del vaticinio così opportunamente annunciato», riferendosi alle ragioni di salute che gli hanno impedito di rispondere prontamente. Riferiti rapidamente gli aggiornamenti contingenti, in particolare relativi alla sua salute, Sartorio annuncia con entusiasmo la sua proposta per il monumento commemorativo: «ti completo l’idea», riferisce, proseguendo:
Vorrei rappresentare la madre di Dio che sostiene il pargolo divino ed intorno a Lei madri e bambini parafrasando il detto di Cristo “Sinite parvulos venire ad me”. Il fulcro del quadro dovrebbe essere la fisionomia della Madonna. Io rammento perfettamente la fisionomia di Donna Luisa e vorrei che, come tutte le madri sono necessariamente tante Madonne, questa ricordasse evidentemente D. Luisa.
Tu sai troppo bene che in quanto io ti dico non c’è ombra d’irriverenza alla santità della Religione, perché la maniera più certa per arrivare al mistero della vita è quella d’invocare ad adorare il grande segreto della maternità. (Ibidem)
Sartorio, dunque, avanza una proposta artistica volta a fondere l’acume tecnico della resa somatica e la suggestione devozionale, sempre più cara all’artista negli anni della maturità, trascorsi fra viaggi in Terra Santa e opere pittoriche d’ispirazione famigliare e, in parte, evangelica. Il monumento alla madre di d’Annunzio, estremo esempio della collaborazione fra i due sodali, costituisce inoltre la sintesi delle tarde scelte estetiche di Sartorio, operate fra pittura ad argomento sacro e ripiegamento sugli affetti famigliari. Alacremente impegnato in numerosi progetti, l’artista si ammala e, pur riprendendosi brevemente, fra 1931-1932 peggiora desistendo dal lavoro, sicché l’opera non sarà mai realizzata secondo le proposte dell’artista e gli auspici del poeta, che si troverà costretto a commissionare all’amico scultore Arrigo Minerbi un sarcofago di marmo, ultimato nel 1937. Sartorio muore, infine, nell’ottobre 1932.
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Gabriele d’Annunzio, Pagine sull’arte, a cura di Pietro Gibellini e Stefano Fugazza, Milano, Abscondita, 2012.
Gabriele d’Annunzio, Prose di ricerca, vol. I, a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, saggio introduttivo di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 2005.
Gabriele d’Annunzio, Prose di ricerca, vol. II, a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, saggio introduttivo di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 2005.
Gabriele d’Annunzio, Prose di romanzi, vol. I, edizione diretta da Ezio Raimondi, a cura di Annamaria Andreoli, intr. Di Ezio Raimondi, Milano, Mondadori, 2005.
Gabriele d’Annunzio, Prose di romanzi, vol. II, edizione diretta da Ezio Raimondi, a cura di Niva Lorenzini, intr. Di Ezio Raimondi, Milano, Mondadori, 2011.
Gabriele d’Annunzio, Scritti giornalistici. 1883-1888, a cura e con un’introduzione di Annamaria Andreoli, testi raccolti e trascritti da Federico Roncoroni, Milano, Mondadori, 1996.
Gabriele d’Annunzio, Alcyone, edizione critica a cura di Pietro Gibellini, commento di Giulia Belletti, Sara Campardo ed Enrica Gambin, scheda metrica di Gianfranca Lavezzi, Venezia, Marsilio, 2018.
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, vol. I, edizione diretta da Luciano Anceschi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 2001.
Gabriele D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, vol. II, edizione diretta da Luciano Anceschi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 2010.
Giulio Aristide Sartorio, Nota su D. G. Rossetti. Pittore, «Il Convito», II, febbraio 1895; IV, aprile 1895.
Giulio Aristide Sartorio, Romae Carrus Navalis. Favola contemporanea, Milano, Treves, 1905.
Giulio Aristide Sartorio, Le confessioni e le battaglie di un artista, «Il Secolo XX», VI, VIII, 1907.
Giulio Aristide Sartorio, Per l’avvenire dell’arte italiana in America Latina, Roma, Direzione Nuova Antologia, 1924.
Giulio AristideSartorio, Il ritorno di Raffaello. Romae Carrus Navalis, introduzione e cura di Cecilia Gibellini, Milano, Medusa, 2020.
Bibliografia secondaria
Annamaria Andreoli, Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 2000.
Diego Angeli, Le cronache del Caffè Greco [1930], a cura di Stefano Stringini, Roma, Bulzoni, 2001.
Achille Bertini Calosso, Mostra delle pitture di Giulio Aristide Sartorio nella R. Galleria Borghese (9 marzo–24 aprile 1933–XI), Roma 1933.
Pietro Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 1988.
Riccardo D’Anna, Roma preraffaellita. Note su Gabriele D’Annunzio, Diego Angeli, Giulio Aristide Sartorio, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1996.
Renzo De Felice, D’Annunzio politico. 1919-1938, Roma-Bari, Laterza, 1978.
Renzo De Felice, Mussolini. Il fascista. I La conquista del potere 1921-1925, Torino, Einaudi, 1966.
Renzo De Felice, E. Mariano (a cura di), Carteggio d’Annunzio – Mussolini. 1919-1938, Milano, Mondadori, 1971.
Eurialo De Michelis, Tutto d’Annunzio, Milano, Feltrinelli, 1960.
Eurialo De Michelis, Gli anni romani di d’Annunzio, «Studi Romani», a. 24, II, aprile-giugno 1976.
Bruno Mantura, Sartorio 1924. Crociera della Regia Nave Italia nell’America Latina, Roma, De Luca, 1999.
Renato Miracco (a cura di), Giulio Aristide Sartorio. 1860-1932, Firenze, Maschietto-Mandragora, 2006.
Gianni Oliva (a cura di), D’Annunzio. Vita e letteratura. Documenti, testimonianze, immagini, Lanciano, Carabba, 2008.
Vito Salierno, La censura occulta e palese nei confronti di d’Annunzio. Giovanni Rizzo, l’«occhiuto carceriere al Vittoriale e i suoi rapporti segreti a Mussolini, Lanciano, Carabba, 2011.
Bibiana Borzí, «Sibilla» di Giulio Aristide Sartorio. Fra testo e immagine, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.
Angelo Conti, La beata riva. Trattato dell’oblio [1900], a cura di Pietro Gibellini, Venezia, Marsilio, 2000.
Ilaria Crotti, Lo scrittoio dell’imaginifico. Volti e risvolti di d’Annunzio narratore, Avellino, Sinestesie, 2016.
Anna Maria Damigella, La pittura simbolista in Italia. 1885-1900, Torino, Einaudi, 1981.
Anna Maria Damigella, B. Mantura (a cura di), Giulio Aristide Sartorio. Figura e decorazione, Catalogo della Mostra di Roma 1989, Milano, Ricci, 1989.
Pier Andrea De Rosa, Paolo Emilio Trastulli, Giulio Aristide Sartorio. Il realismo plastico tra sentimento e intelletto (mostra di Orvieto maggio – luglio 2005), Orvieto, Arte Cultura Sviluppo, 2005.
Corrado Maltese, Storia dell’arte in Italia. 1785-1943, Torino, Einaudi, 1960.
Simone Maiolini, Patrizia Paradisi, I motti di Gabriele d’Annunzio. Le fonti, la storia, i significati, Milano, Silvana, 2022.
Cecilia Gibellini, L’opera letteraria di Giulio Aristide Sartorio tra memorialistica e autobiografismo, in «Studi medievali e moderni», XXIV, 1, 2020.
Pietro Gibellini, Logos e mythos. Studi su Gabriele d’Annunzio, Firenze, Olschki, 1985.
Pietro Gibellini, D’Annunzio dal gesto al testo, Milano, Mursia, 1995.
Pietro Gibellini, Un’idea di d’Annunzio. Trent’anni di studi, Lanciano, Carabba, 2023.
Renato Miracco (a cura di), Il fregio di Giulio Aristide Sartorio, Catalogo della Mostra di Roma 2007, Milano, Leonardo International, 2007.
Benito Mussolini, Scritti e discorsi dal 1925 al 1926, Milano, Hoepli, 1934.
Gianni Oliva, I nobili spiriti e le riviste dell’estetismo fiorentino, Bergamo, Minerva Italica, 1979.
Ricorda Ricciarda, Dalla parte di Ariele. Angelo Conti nella cultura di fine secolo, Roma, Bulzoni,1993.
John Woodhouse, D. G. Rossetti, d’Annunzio e il preraffaellismo, Gianni Oliva (a cura di), I Rossetti tra Italia e Inghilterra, Atti del Convegno internazionale di studi (Vasto settembre 1982), Roma, Bulzoni, 1984.
Cataloghi della Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia
Prima Esposizione d’Arte della Città di Venezia, Venezia, Visentini, 1895.
XIII Esposizione Internazionale d’Arte della Citta di Venezia, Firenze, Bestetti & Tumminelli, 1922.
XV Esposizione Internazionale d’arte della Città di Venezia, 1926, Venezia, Officine Grafiche Ferrari, 1926.
XVI Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia, 1928, Venezia, Officine Grafiche Ferrari, 1928.
XVII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, 1930, Venezia, Ferrari, 1930.