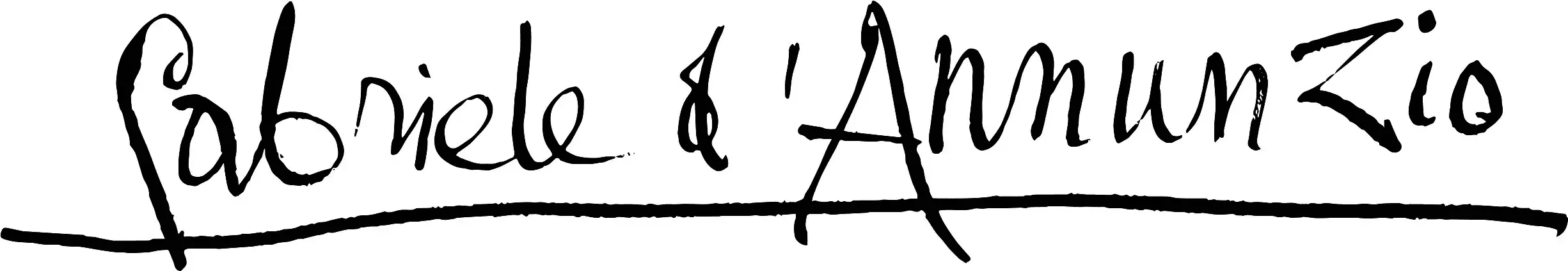di Adriana Vignazia,
Enciclopedia dannunziana
La casa editrice Insel di Lipsia
La casa editrice Insel di Lipsia assume un ruolo particolare nella storia dell’editoria tedesca e solo conoscendo la sua storia è possibile capire il comportamento del suo direttore nei confronti di d’Annunzio e dei suoi traduttori. Il nome deriva dall’omonima rivista fondata nel 1899 da Alfred Heymel, Rudolf Alexander Schröder e Otto Julius Bierbaum. Alfred Heymel (pseudonimo di Alfred Demel, 1878-1914) era scrittore, collezionista, mecenate e promotore dell’arte libraria tedesca. Erede di un immenso patrimonio aveva trasformato la sua casa di Monaco in un punto d’incontro per gli artisti del suo tempo che, in caso di bisogno, aiutava anche finanziariamente. Già ai tempi del ginnasio aveva pensato di fondare una rivista sul modello della Kelmschott Press inglese insieme al cugino Rudolf Alexander Schröder (1878-1962), poeta lirico, saggista, traduttore e pittore. Della rivista «Insel» Heymel e Schröder erano i proprietari, Otto J. Bierbaum (1865-1910), poeta e scrittore satirico, il redattore; insieme formavano un comitato redazionale costituito da «due milionari privi di talento» e un «famoso scrittore privo di scrupoli», secondo le caustiche parole del redattore (Bierbaum, 1965, p. 23). La nuova rivista aveva fini ambiziosi: pubblicava saggi di arte e letteratura e seguiva il principio dell’unità di testo, scrittura, illustrazione e carta, la ‘unity of book’ postulata dagli inglesi (Eyssen 1985, p. 5).
Nel 1901 la rivista si trasformò in casa editrice: Rudolf von Poellnitz (1865-1905) ne assunse la direzione e cercò di dare all’impresa un’impronta più commerciale investendoci anche capitale proprio. La direzione artistica restò tuttavia nelle mani di Bierbaum e Schröder. Nel 1905 la direzione della casa editrice ormai in difficoltà passò a Anton Kippenberg (1874-1950), un borghese onesto dal pensiero poco originale (Schuster 1984, B 131).
Con lui la politica editoriale non cambiò molto, tuttavia egli riuscì ad armonizzare l’aspetto artistico con quello economico rivolgendosi a un gruppo di lettori e bibliofili interessati alle squisite pubblicazioni Insel. Gli autori qui editi erano consapevoli di sacrificare il vantaggio di un vasto numero di lettori a favore della qualità e esclusività delle edizioni. Kippenberg, pur attento all’aspetto economico dell’impresa, rifiutava le moderne tecniche pubblicitarie di cui invece si serviva p.es. S.Fischer per affermare un autore sul mercato. La sua concezione del successo era idealista: un libro doveva affermarsi per forza propria o essere dimenticato. Quest’atteggiamento poco moderno di considerare il mercato letterario gli creava spesso conflitti con i suoi autori e traduttori, come risulta dalla corrispondenza tra lui e Binding che spesso rimproverandogli la scarsa iniziativa si profondeva in consigli per acquisire nuovi clienti e mercati. Per quanto riguarda le traduzioni di d’Annunzio Binding suggeriva di presentarle anche a Roma, Venezia e Firenze perché «…solo là il tedesco pensa che l’Italia ha un poeta vivente di rango e molto popolare, troppo difficile da leggere per lui nella lingua originale…» (Binding a Kippenberg, 20 aprile 1910).
Per la concezione elitaria di libro e letteratura, e cura tipografica nella stampa l’Insel Verlag avrebbe potuto essere l’editore ideale delle opere di d’Annunzio in Germania, invece qui vennero pubblicate solo:
In memoriam Friedrich Nietzsche. Auf den Tod eines Vernichters [Per la morte di un distruttore] nel 1906
; Die Auferstehung des Kentauren [La resurrezione del centauro] nel 1909
; le tragedie
Das Schiff [La Nave] e
Phädra [Fedra], e il romanzo
Vielleicht, vielleicht auch nicht [Forse che sì, forse che no] nel 1910; e nel 1911
Mehr als die Liebe [Più che l’amore]
.
Nel programma della casa editrice Insel d’Annunzio è l’unico scrittore italiano contemporaneo, gli autori italiani pubblicati, fino alla seconda guerra mondiale, sono Dante, Boccaccio, Leopardi, Carducci, antiche novelle italiane, Machiavelli e
I fioretti di San Francesco.
In memoriam Friedrich Nietzsche. Auf den Tod eines Vernichters
[
Per la morte di un distruttore]
La prima opera di d’Annunzio pubblicata presso la Insel è l’ode
In memoriam Friedrich Nietzsche – Auf den Tod eines Vernichters, tradotta da Otto von Taube. Taube (1879-1973), scrittore e traduttore dal francese, italiano, spagnolo, portoghese e russo, discendeva da una nobile famiglia tedesca dell’Estonia e era nipote del conte Alexander Keyserling, amico di gioventù di Bismarck. Per accontentare il padre studiò giurisprudenza ed entrò nella pubblica amministrazione, ma lasciò presto la sua posizione di funzionario per dedicarsi alla letteratura e all’arte. Nel 1905, allo scoppio di gravi disordini sociali in Russia, la famiglia si trasferì a Weimar.
In uno dei suoi numerosi viaggi in Italia, il giovane barone aveva scoperto
Il Fuoco di d’Annunzio, e leggendo fino a notte fonda aveva provato «un’immensa nostalgia per il Sud» (Taube 1950, p. 162). Pochi anni dopo, di nuovo in Italia, aveva letto l’ode
Per la morte di un distruttore e su consiglio di Francesco Orestano, un amico di famiglia, (Ebd., p. 50) ne aveva cominciata la traduzione, aiutato dall’amico medico Gino Frontali (1889-1963) di Firenze. E insieme a lui dopo la prima guerra mondiale leggeva le
Laudi di d’Annunzio.
Per la pubblicazione dell’ode Taube si rivolse all’Insel Verlag, con cui era in contatto fin dal 1904 quando Poellnitz gli aveva proposto di tradurre la
Fiammetta di Boccaccio. Nella lettera a Kippenberg egli comunica di aver tradotto e letto l’ode di d’Annunzio alla sorella del filosofo, Elisabeth Förster-Nietzsche, in Weimar. La sua richiesta dei diritti a Treves era però rimasta senza risposta. (Taube a Kippenberg, 23 maggio 1906).
Per il lavoro di traduzione Taube chiedeva 100 marchi e 25 copie non di lusso (Taube a Kippenberg, 17 giugno 1906). Kippenberg accettò pregandolo di rivolgersi a d’Annunzio tramite la sorella di Nietzsche, visto che Treves non aveva reagito neppure alla lettera della casa editrice. (Kippenberg a Taube, 18 giugno e Insel a Treves, 6 giugno 1906. Vittoriale, A.G. XLIX, 2).
Questa volta la risposta non si fece attendere e pochi giorni dopo Taube fece avere a Kippenberg la lettera di risposta di Elisabeth Förster-Nietzsche a cui d’Annunzio scriveva «Mon Ode est à vous, entièrement et pour toujour!» (Förster-Nietzsche a Taube, 9 luglio 1906).
L’ode, in una traduzione piuttosto libera, poté finalmente essere stampata, dopo che in agosto erano state corrette le prime bozze e discussa la veste grafica. (Taube a Kippenberg, 5 settembre e Kippenberg a Taube, 13 settembre 1906). Il 22 novembre il testo era pronto. Se ne fecero 400 copie numerate, di cui 25 in pergamena; Taube ricevette 5 copie in pergamena, 20 in carta e i 100 marchi richiesti.
L’edizione era molto elegante, stampata su carta a mano, in caratteri latini con messa in rilievo dell’inizio di ogni strofa tramite lettere maiuscolette. I versi finali dell’ode furono pubblicati nell’annuario della casa editrice Insel del 1908 (Insel 1908, pp. 41-44).
Dopo la pubblicazione dell’ode Taube divenne il traduttore della casa editrice per l’italiano e lo spagnolo; Kippenberg, dopo la fine della prima guerra mondiale, aiutò più volte lui e la sua famiglia che aveva perduto i suoi possedimenti in Estonia dopo la rivoluzione di ottobre. Il loro carteggio arriva fino alla seconda guerra mondiale.
Di d’Annunzio si parlò di nuovo solo nel 1920, quando Taube pensava di pubblicare una scelta delle migliori poesie, tratte dalle
Laudi. La lettera è interessante perché mostra come la guerra non avesse scalfito l’interesse per d’Annunzio né in lui, né nell’amico Kurt Breysig, storico, sociologo e antropologo culturale, che lo aveva esortato a continuare il suo lavoro di traduzione con un’«ammirazione estatica» per d’Annunzio. Le poesie scelte erano le odi a Dante, al Cenacolo di Leonardo e a Segantini, morto da poco, più madrigali e sonetti, in tutto avrebbero formato un libro di 60-70 pagine (Taube a Kippenberg, inizio maggio 1920).
Gli rispose Katharina Kippenberg, moglie dell’editore e lettrice presso l’Insel Verlag, dicendo: «non possiamo pubblicare d’Annunzio per motivi patriottici; non ho bisogno di dare spiegazioni: peccato, perché la poesia inviata è veramente bella. Ma il suo comportamento è ancora impresso nella memoria di tutti noi come un marchio a fuoco» (Katharina Kippenberg a Taube, 18 maggio 1920). In questa maniera si è persa l’occasione di veder tradotta e pubblicata una buona scelta della lirica matura di d’Annunzio, perché le raccolte di poesie pubblicate fanno conoscere soprattutto la lirica della gioventù. Dopo la fine della seconda guerra mondiale Taube fece pubblicare su riviste alcune traduzioni dal libro dell’
Alcione:
Fünf Sommermadrigalen [Cinque madrigali dell’estate], «Schweizer Monatshefte» 44 (1965), pp.1048-1049;
Lobgesang auf Fiesole [Sera fiesolana], «Neue deutsche Hefte» 2 (1955/56), pp.52-54; prima della guerra aveva pubblicato
Anrufung [Invocazione], «Hyperion» 1 (1908), fascicolo 3, p.1, ristampato nell’«Hyperion-Almanach» del 1911, pp. 152-154 e infine su «Die Aktion» 6 (1916), col. 93-94.
Die Auferstehung des Kentauren [
La resurrezione del centauro]
Tre anni dopo Rudolf von Binding propose a Kippenberg la pubblicazione di un’opera di d’Annunzio. Nel loro carteggio, che continua fino alla morte di Binding, le lettere concernenti le traduzioni di d’Annunzio sono degli anni 1909 – 1911, in seguito d’Annunzio è citato solo raramente.
Rudolf von Binding (1867-1938), figlio dello stimato giurista tedesco Karl von Binding, aveva studiato giurisprudenza e medicina e conclusi gli studi si era dedicato per alcuni anni all’allevamento di cavalli. Per ristabilirsi da una lunga malattia, nel 1907 aveva intrapreso un viaggio in Italia e in Grecia durante il quale aveva capito che la sua vocazione era per l’arte e la scrittura. La traduzione di una breve opera dannunziana segnò l’inizio di questa nuova vita.
Nell’autobiografia Binding ricorda il periodo fiorentino, lo studio dell’italiano e il giovane insegnante, l’avvocato Guido Tutino, che gli aveva dato come compito la traduzione di una poesia dall’
Alcione, La morte del cervo (Binding 1956, pp.116-121). Inizialmente pensato come esercizio, il lavoro fu poi presentato da Tutino a d’Annunzio che parve esserne entusiasta ed aver detto: «Chi è questo poeta tedesco, il Binding?» (Ebd., p. 118). Quando si conobbero di persona d’Annunzio affidò all’ aspirante scrittore la traduzione di una breve prosa non ancora pubblicata in Italia:
La resurrezione del c
entauro. Il testo, scritto nel febbraio dello stesso anno, si riferiva a una scultura del marchese Clemente Origo che rappresentava la lotta tra il centauro e il cervo. ‘Resurrezione’ indicherebbe qui il rivivere dei miti nell’arte figurativa. I due testi erano considerati da d’Annunzio un’unità in quanto reciprocamente ispirati (Salierno 1987, p. 82).
Il fatto che d’Annunzio gli avesse concesso gratis i diritti di traduzione e stampa di un piccolo poemetto in prosa, era stato tanto importante per Binding da fargli superare i dubbi sulle sue capacità (Binding 1956, p. 119) e tornato in Germania nel febbraio 1909 cominciò a cercare un editore rivolgendosi a Kippenberg.
La prima risposta dell’editore fu negativa: la poesia sarebbe già stata pubblicata in tedesco e la breve prosa, da sola, non era sufficiente a farne un libro (Kippenberg a Binding, 15 febbraio 1909). Consigliò quindi a Binding di rivolgersi alla rivista «Süddeutschen Monatshefte» nel cui comitato redazionale si trovavano anche Heymel e Schöder. Binding non si arrese assicurando che la poesia non era stata ancora pubblicata in tedesco e la prosa neppure in italiano, e per convincere l’editore aggiunse che non chiedeva nessuna ricompensa trattandosi piuttosto di fare un piacere a d’Annunzio (Binding a Kippenberg, 17 febbraio 1909). A queste condizioni Kippenberg accettò di pubblicare i testi (Kippenberg a Binding, 22 febbraio 1909).
Le lettere seguenti trattano la veste grafica del piccolo libro, la strategia editoriale da seguire e l’ortografia, p.es. della parola Kentauren (Binding a Kippenberg, 23 aprile 1909). Binding avrebbe gradito la presenza delle belle xilografie di Adolfo de Carolis che corredavano l’edizione italiana di Staderini, perché agevolavano la comprensione della relazione tra la nuvola e il centauro nel mito di Issione (Binding a Kippenberg, 23 febbraio 1909). Era suo desiderio farne un bel libro e tenere basso il prezzo per invogliare all’acquisto un numeroso gruppo di lettori anche al di fuori dalla Germania perché, mentre in Italia d’Annunzio era conosciutissimo, lo stesso non si poteva dire per la Germania. Mettere in vendita il libro sul mercato italiano, a Venezia o a Roma, poteva essere interessante per i molti tedeschi che vi vivevano e non erano in grado di leggere il testo in italiano.
Kippenberg propose allora un’edizione maggiore: 400 copie al prezzo di 4 marchi per ogni esemplare in brossura; al traduttore sarebbero andate 12 copie. Pianificata per la primavera, la pubblicazione subì dei ritardi a causa della trascuratezza di un tipografo (Kippenberg a Binding, 7 giugno 1909) e uscì solo a metà giugno, nonostante le ripetute proteste di Binding che voleva partire per l’Italia e portare una copia del libro a d’Annunzio e al marchese Origo come ringraziamento. Nell’occasione intendeva chiedere i diritti per
La Nave e la
Fedra la cui traduzione gli era stata proposta già nel marzo dello stesso anno dal Deutsches Theater di Max Reinhardt.
Il libro non fu un successo per la casa editrice; le vendite restavano al di sotto delle aspettative e Kippenbergs già in ottobre se ne era lamentato con Binding (Kippenberg a Binding, 27 oktober 1909). La situazione non cambiò neppure in seguito e quando Binding dopo tre anni lo pregò di fargliene avere tre copie «a fini pubblicitari», gli rispose a giro di posta che «poteva dargliene così tante da tappezzargli lo studio» (Binding a Kippenberg e Kippenberg a Binding, 22 e 23 settembre 1912).
Nei materiali d’archivio del Vittoriale si trovano alcune lettere con giudizi negativi sulla traduzione della poesia e della prosa. Due sono state scritte dal filologo romanista Pio Rajna (1847-1930), amico di d’Annunzio. Rajna riferisce il giudizio di Oskar Hecker (1867-?), professore universitario di italiano a Berlino e traduttore, pregando d’Annunzio di concedere anche a lui il permesso di pubblicare la sua traduzione, a suo giudizio migliore e giudicata positivamente anche da Paul Heyse (Rajna a d’Annunzio, 27 febbraio e 8 aprile 1912).
Al Vittoriale è conservata pure la lettera di Oskar Hecker con i ringraziamenti a d’Annunzio (Hecker a d’Annunzio, 15 aprile 1912). La sua versione fu pubblicata nello stesso anno sull’ «Internationale Wochenschrift» (1912, colonne 1205-1212) e seguita da un articolo critico del romanista Karl Vossler (Ebd., col. 1213-1218), un esperto di Dante. Vossler presenta la poesia come una creazione «puramente estetica» e di grande virtuosità, motivo per cui per la traduzione era necessaria la stessa abilità. Interessanti sono le osservazioni sulle differenze tra l’italiano e il tedesco circa le possibilità espressive per le percezioni sensoriali. Mentre l’italiano si può servire del tesauro delle parole antiche, e avrebbe bisogno di un minore sforzo e di minori mezzi stilistici, in tedesco è necessario ricorrere «qualche volta a uno stile più alto, un’altra a uno più basso … per questo motivo l’espressione sembra … meno equilibrata. La melodia resta la stessa, però la voce ha preso un tono eccitato e tremolante» (Ebd., col.1218).
Un altro giudizio si legge nel carteggio tra Karl G.Vollmoeller e Binding che a fine giugno 1910 gli aveva spedito il libro con la preghiera di comunicargli la sua opinione. La lettera originale di Vollmoeller non si è conservata, noi conosciamo il suo giudizio solo dalla risposta di Binding che accettava l’osservazione di Vollmoeller – il verso tedesco aveva una maggiore lunghezza di quello originale – rimarcando però la difficoltà di essere concisi quando non si voleva fare come Stefan George che si permetteva latinismi impropri al tedesco (Binding a Vollmoeller, 17 luglio 1909).
Das Schiff [La Nave] e Phädra [Fedra]
Mentre si stampava
Die Auferstehung des Kentauren, Binding propose a Kippenberg la traduzione della tragedia
La Nave, rappresentata con successo nel gennaio 1908 a Roma. Binding, che l’aveva vista recitata, aveva iniziato a tradurla nella sua fase di entusiasmo per l’opera di d’Annunzio e l’aveva offerta a diversi teatri per la messinscena. Quando si era rivolto al Deutsches Theater, gli avevano consigliato di assicurarsi i diritti della
Fedra. La nuova gestione del Deutsches Theater si era già interessata tre anni prima a
La Nave quando la tragedia non era ancora terminata e aveva pregato Linda von Lützow, traduttrice dei drammi dannunziani presso la casa editrice S.Fischer, di procurarsi i diritti, ma alla sua richiesta (Lützow a d’Annunzio, 17 novembre 1906, Vittoriale A.G. XV,3) non era seguita risposta. d’Annunzio infatti giudicava il suo lavoro scadente (Vedi Fischer)
L’interesse del Deutsches Theater per i drammi dannunziani si basava sui nuovi programmi e sulla regia innovativa di Max Reinhardt che, come d’Annunzio, abbandonava i canoni del teatro naturalista per dare libero sfogo alla fantasia, alla musica e ai colori, per «dare di nuovo gioia agli uomini … strapparli dalla loro quotidiana miseria sollevandoli nell’aria pura e serena della bellezza. … in una vita nobilitata» (Reinhardt, cit. in Rühle 2007, p. 86). Nel suo programma aveva incluso gli scrittori greci classici perché intendeva restituire al coro la sua funzione originaria, e attirare un pubblico più vasto rendendolo partecipe dello spettacolo.
La Nave lo interessava in quanto dramma moderno, ma anche perché la sua messinscena avrebbe richiesto un grande numero di comparse.
La possibilità di una messinscena da parte di Reinhardt suscitò l’interesse di Kippenberg alla pubblicazione di entrambi i drammi (Kippenberg a Binding, 8 marzo 1909). Così a inizio marzo Binding si mise al lavoro per assicurarsi i diritti di traduzione, stampa e rappresentazione delle due opere: scrisse a Fischer per sapere se esistevano ancora vincoli contrattuali tra lui e il poeta italiano, a d’Annunzio per avere l’autorizzazione a tradurre (Binding a d’Annunzio, 20 marzo 1909. Vittoriale, A.G. XLIX,2) allegando un’ulteriore lettera del Deutsches Theater con la richiesta della
Fedra. Da ultimo si rivolse insieme a Kippenberg a Treves. Fischer si prese tempo prima di rispondere, cosa che irritò Binding che la interpretava come una mossa dell’editore berlinese per avanzare pretese sulle opere di d’Annunzio, non sapendo che il contratto tra lui e d’Annunzio era ormai scaduto (Binding a Kippenberg, 24 aprile 1909). Quando però venne a sapere da Kippenberg che Treves pretendeva 5.000 Lire per i diritti della
Fedra, la sua rabbia si concentrò sull’editore italiano in quanto richiesta illegittima e per l’Insel Verlag inaccettabile (Kippenberg a Binding, 26 marzo 1909).
Intanto anche Vollmoeller aveva cominciato ad attivarsi entrando però in un ruolo diverso da quello solito del traduttore che in quel tempo era solito cercare una casa editrice e trattare con l’editore per la pubblicazione di un’opera di cui si era procurato i diritti di traduzione. Quando il 26 marzo 1909 aveva proposto a Kippenberg la pubblicazione di:
Fedra,
La figlia di Jorio e il romanzo – non ancora scritto –
Forse che sì, forse che no, Vollmoeller affermava di essere stato incaricato da d’Annunzio a rappresentare i suoi diritti in Germania. Un’affermazione non del tutto vera perché dai materiali d’archivio (Vittoriale, A.G. XV,2) risulta che a quel tempo la procura che lo incaricava formalmente a rappresentare d’Annunzio nei confronti di teatri, agenzie teatrali, giornali e editori non era ancora stata firmata. Tuttavia Kippenberg passò a regolare con Vollmoeller, più informato sui rapporti contrattuali, la parte giuridica e finanziaria escludendo Treves e consigliando a Binding di aspettare (Kippenberg a Binding, 29 aprile 1909).
Il consiglio è ovviamente da contestualizzare nel rapporto concorrenziale tra le due case editrici dal diverso profilo: moderno e un po’ aggressivo sul mercato quello del S. Fischer Verlag, tradizionale e conservatore quello dell’Insel Verlag. Inoltre, fin dal 1904 le relazioni tra le due case erano tese perché Pollnitz, stanco di mandare inutilmente a Fischer copie di opere da recensire sulla rivista «Neue deutsche Rundschau», aveva accusato il redattore Oskar Bie (1864-1938) di favorire soltanto gli editori ebrei. Più moderato, Kippenberg si diceva orgoglioso di vedere un autore della casa editrice Fischer rivolgersi a lui per una pubblicazione (Kippenberg a Vollmoeller, 1 luglio 1910)
Anche nelle lunghe e difficili contrattazioni per le opere di d’Annunzio Kippenberg si mostrò moderato e diplomatico tentando di mediare tra i due possibili traduttori: nelle sue lettere a Vollmoeller citò l’esistenza di una traduzione de
La Nave e i progetti di pubblicazione della
Fedra senza fare il nome del traduttore (Kippenberg a Vollmoeller, 27 marzo 1909). Cautela inutile perché Vollmoeller era al corrente dei progetti e conosceva il nome del traduttore, ma avendo capito quanto fosse importante per Kippenberg la traduzione di Binding se la fece mandare suggerendo la possibilità di un lavoro comune (Vollmoeller a Kippenberg, 6 aprile 1909). Favorevolmente impressionato da questa proposta, Kippenberg confermò il nome di Binding (Kippenberg a Vollmoeller, 16 aprile 1909.) e Vollmoeller rimandò la risposta definitiva al dopo aver confrontato la traduzione con il testo italiano originale (Vollmoeller a Kippenberg, 24 maggio 1909). Quando Kippenberg comunicò a Binding la richiesta di Vollmoeller di vedere il manoscritto prima di approvare la traduzione (Kippenberg a Binding, 24 aprile 1909), egli scrisse subito a Vollmoeller per assicurarlo che la traduzione inviatagli era solo una prima versione da rielaborare e menziona alcuni problemi di traduzione, p.es. del Sirventese e del discorso di Gratico. Nella lettera racconta dei suoi incontri con d’Annunzio e lascia trapelare anche i suoi dubbi sull’esistenza del contratto che Vollmoeller diceva di avere, perché «era molto difficile venire a sapere qualcosa di vincolante da d’Annunzio» che poteva «non essere consapevole dell’esistenza di un simile accordo» e si dichiara poi disposto a incontrare Vollmoller per discutere la questione, anche nei confronti delle richieste avanzate da Treves (Binding a Vollmoeller, 3 maggio 1909).
Vollmoeller non rispose né a questa, né a altre due lettere, aspettando la conclusione delle trattative con Kippenberg. Il suo ostinato silenzio dipendeva probabilmente dall’essere in contatto con diverse case editrici e non sapere ancora con chi avrebbe concluso. Nella lettera del 6 aprile a d’Annunzio scrive infatti che era in contatto con Fischer, ma che questo non mostrava un grande interesse per la pubblicazione della
Fedra avendo fatto un pessimo affare con la
Francesca, s’interessava invece al romanzo ma non avrebbe dato una risposta prima di averlo letto. Vollmoeller non cita il nome degli altri tre editori con cui era in contatto, ma dice solo che avrebbe dato la precedenza Fischer (Vollmoeller a d’Annunzio, 6.4.1909). Il motivo è da cercarsi nella migliore organizzazione delle vendite di questa casa e nei contatti che Vollmoeller aveva già dai tempi della
Francesca. Il silenzio nei confronti di Binding si spiega invece sia con il fatto che la procura non era ancora stata firmata e quindi la sua posizione di fronte ai dubbi avanzati da Binding non era sicura, sia con la necessità di avere l’autorizzazione di d’Annunzio per una traduzione de
La Nave fatta da Binding.
La Nave non aveva mai interessato Vollmoeller che invece aveva chiesto già in marzo a d’Annunzio il diritto di tradurre la
Fedra ricevendone la promessa: «Je voudrais bien vous confier ma
Phedre…» (d’Annunzio a Vollmoeller, Telegramma marzo 1909) e il manoscritto mentre lo stava ancora scrivendo. In attesa del terzo atto, Vollmoeller gli comunica la sua approvazione facendogli anche un po’ di pressione per una rapida conclusione (Vollmoeller a d’Annunzio, 6 aprile 1909). Insieme a Reinhardt avrebbe voluto assistere alla prima, il 10 aprile a Milano, per farsi un’idea concreta di come arrangiare il dramma per la messinscena della tragedia in Germania e per far incontrare autore e possibile regista, consapevole che la tragedia ben s’adattava al repertorio di Reinhard. L’incontro non fu però possibile e Vollmoeller chiese notizie a d’Annunzio sulla prima non trovandone abbastanza sui giornali tedeschi (14 aprile 1909).
Mentre mandava avanti le faticose e lunghe trattative per il contratto generale, Vollmoeller si occupava delle traduzioni. A fine maggio comunicò a Kippengerg che la traduzione de
La Nave di Binding era usabile sebbene non priva di «sviste e durezze» (Vollmoeller a Kippenberg, 24 maggio 1909) e propose una rielaborazione comune del testo. Informato da Kippenberg (7 giugno 1909) sull’esito positivo dell’esame, Binding scrisse a Vollmoeller una lettera molto franca esponendo dubbi e proposte sulle opere in questione. Le sue preferenze andavano a
La Nave, entusiasmo condiviso dal drammaturgo del Deutsches Theater nonostante il contenuto nazionalistico della tragedia. La
Fedra poteva sembrare meno problematica, ma dopo averla letta Binding la trovava «troppo brutta» per interessare la direzione del Deutsches Theater, il «secondo atto era buono, il primo brutto e il terzo semplicemente insopportabile dal punto di vista del teatro». Avrebbe preferito proporre
La Nave, che messa giustamente in scena, con la Durieux come Basiliola, avrebbe potuto avere successo e forse – ma solo in seguito – presentare anche la
Fedra, e non al contrario perché il sicuro insuccesso della
Fedra avrebbe spaventato il regista che non avrebbe più messo in scena
La Nave, giudicata da Binding «un pezzo forte» (Binding a Vollmoeller, 10 giugno 1909). In luglio Vollmoeller rispose mettendosi d’accordo per rivedere insieme
La Nave. Il lavoro comune fu soddisfacente per entrambi e in ottobre Vollmoeller confermò a Kippenberg il talento letterario di Binding e il suo desiderio di collaborare con lui anche in futuro accettando che comparisse come unico traduttore de
La Nave.
Vollmoeller decise perciò di lasciare fare a Binding anche una prima traduzione della
Fedra da rielaborare insieme, (Vollmoeller a Binding, 1 ottobre 1909). L’approvazione di d’Annunzio l’ottenne presentando il lavoro come già fatto da Binding e conveniente perché avrebbe accelerato la pubblicazione delle due tragedie e permesso di iniziarne altre. (Vollmoeller a d’Annunzio, 20 ottobre 1909). Vollmoeller avrebbe infatti voluto tradurre anche
La figlia di Iorio, ma Kippenberg in maggio l’aveva rifiutata «per non invadere il mercato» con troppe opere dannunziane.
A fine ottobre
Das Schiff era pronto, Binding mandò il manoscritto insieme al testo originale a Kippenberg confermando il suo entusiasmo per la lingua della tragedia, cosa che non poteva confermare per la
Fedra. (Binding a Kippenberg, 25 ottobre 1909).
La stampa andò a rilento, – a febbraio le prime bozze e a maggio le ultime – a causa delle resistenze all’interno della casa editrice dovute al contenuto nazionalistico della tragedia: in quell’anno infatti per espresso desiderio dell’imperatore (Fischer 1969, p. 103) e di alcuni influenti rappresentanti militari, dell’industria e dell’università si propagandava l’ascesa della Germania a potenza militare marittima con il conseguente rafforzamento della flotta (Violante 1991, pp. 53-92). Nel clima politico ideologicamente surriscaldato di quel periodo la pubblicazione di
Das Schiff con la sua dedica al mare Adriatico costituiva uno scandalo e metteva in allarme soprattutto l’Austria. Leopold Freiherr von Clumecky in un lungo articolo pubblicato sulla «Österreichische Rundschau» sottolineava le mire espansionistiche italiane celate nel testo e metteva in guardia nei confronti di un’arte che prestava la parola alla politica imperialista delle nazioni. Clumecky riferiva anche del compiacimento provato dal re italiano, delle sue ripetute presenze alla rappresentazione della tragedia e del suo contributo finanziario.
La Nave entusiasmando gli spettatori italiani «sarebbe poi effettivamente salpata giustificando le pretese sull’Adriatico con ben altri argomenti» (Clumecky 1908, p. 244). La sua proposta per arginare quest’entusiasmo consisteva nel rapido rafforzamento delle opposte mire espansionistiche e della flotta militare austriaca, nel legare economicamente e politicamente la Dalmazia e le popolazioni slave alla monarchia austriaca e infine nel rafforzato controllo militare dell’Adriatico meridionale e delle comunicazioni verso la Grecia e la Turchia.
I traduttori sembravano non essere consapevoli di questi problemi, a loro interessava solo l’aspetto artistico e sottovalutavano le possibili implicazioni politiche (Binding a Vollmoeller, 11.06.1910). Ritardi ci furono anche nel pagamento dei compensi per le traduzioni. Quando Kippenberg a metà aprile ricevette il secondo manoscritto – la
Phädra – chiese una dilazione dei pagamenti perché forse aveva difficoltà a giustificare i costi per le opere di d’Annunzio nei confronti del comitato redazionale. Binding accettò cercando di sostenere Kippenberg con argomenti quali la qualità e il senso della scelta fatta, soprattutto in relazione alla strategia editoriale di S.Fischer che pubblicava letteratura del Nordeuropa, «educando i lettori tedeschi alla noia” (Binding a Kippenberg, 20. 04. 1910). In un’altra lettera a Vollmoeller metteva in dubbio le difficoltà economiche della casa editrice Insel, pensando piuttosto che la difficoltà si celasse nel giustificare di fronte al comitato di redazione il numero dei manoscritti di d’Annunzio da pubblicare (Binding a Vollmoeller, 11.06.1910).
Nel maggio 1910 Binding, temendo di apparire eternamente in cattiva luce presso d’Annunzio se il nome di Vollmoeller non compariva come co-traduttore di
Das Schiff, gli propose di aggiungerlo, essendo quella l’ultima occasione possibile, e elencò diverse formulazioni per indicare il lavoro comune (Binding a Vollmoeller, 2 maggio 1910). Il 5 maggio Vollmoeller rispose a Kippenberg che il suo nome non doveva comparire perché quello di Binding era stampato solo alla fine dell’opera, insieme a quello dello stampatore. Nella
Phädra invece bisognava indicarlo nella formulazione «Unter Mitwirkung» [con la collaborazione di] (Vollmoeller a Kippenbeg, 17.7.1910) secondo quanto concordato con d’Annunzio
.
Ai primi di giugno
Das Schiff è sul mercato con grande gioia di Binding.
Traduzione, correzione e stampa della
Phädra furono molto più veloci: Binding aveva cominciato in ottobre a tradurre il secondo atto (Binding a Vollmoeller, 3 ottobre 1909) e in aprile il lavoro era già stato corretto da entrambi e pronto per la stampa che comincerà a metà maggio 1910. Ai primi di giugno erano pronte le prime bozze con la sollecitazione di Kippenberg a una rapida correzione (Kippenberg a Binding, 7. 06.1910). Il 5 settembre la
Phädra era sul mercato.
Siccome i due drammi non furono un affare per la casa editrice, in ottobre in occasione della pubblicazione de
I fioretti di San Francesco, Kippenberg propose a Binding, il traduttore, di rinunciare ad una parte del compenso per coprire almeno minimamente le perdite dell’editore (Kippenberg a Binding, 10.10.1910). Nei confronti di Vollmoeller invece l’editore aveva cercato di garantirsi dalle perdite assicurandosi una futura collaborazione e chiedendogli l’autorizzazione a pubblicare il suo futuro ciclo di novelle e il dramma, progetti che Heymel, amico di Vollmoeller, gli aveva comunicato (Kippenberg a Vollmoeller, 15 ottobre 1909). Le richieste includevano inoltre la possibilità di pubblicare una raccolta di fiabe islandesi a sfondo nazionale e persino la pubblicazione di opere antecedenti uscite presso il S.Fischer Verlag (Kippenberg a Vollmoeller, 29 dicembre 1909).
Vielleicht, vielleicht auch nicht [
Forse che sì forse che no]
Scrittura, traduzione e stampa del romanzo avvennero in condizioni estremamente difficili. Vollmoeller aveva deciso di tradurre il romanzo da solo sia perché trovava la prosa «straordinariamente bella», sia perché l’impegno lavorativo era prevedibile, a differenza delle opere in versi (Vollmoeller a Kippenberg, 6 e 21 aprile 1909). Il romanzo d’Annunzio lo aveva progettato già nel 1907, ma scritto solo tra agosto e dicembre 1909 dopo aver avuto esperienze di volo e essersi ritirato a Bocca d’Arno per sfuggire ai creditori. Le bozze, man mano che erano corrette dall’autore, venivano mandate in Francia per la traduzione in francese e in Germania, a Vollmoeller che in quel periodo era spesso ricoverato al sanatorio di Davos e traduceva le bozze man mano che le riceveva. Le ultime le ricevette nel gennaio 1910, a Davos, e le finì a fatica nell’aprile. Il manoscritto fu subito stampato e entro la fine di giugno erano state corrette le bozze in tedesco. Il lavoro di stampa e correzione procedeva spedito, solo una volta si legge un rimprovero di Vollmoeller per lo zelo eccessivo di un lettore che abbondava in punti esclamativi, non amati da d’Annunzio, e apportava «cambiamenti stilistici» senza l’approvazione del traduttore (Vollmoeller a Kippenberg, 13 giugno 1910). A fine estate il volume era pronto.
Pubblicazioni in anteprima
Nelle trattative per la stesura del contratto generale Vollmoeller aveva ottenuto il diritto di pubblicare drammi e romanzo in anteprima su riviste e giornali, un diritto per nulla ovvio perché la pubblicazione a puntate avrebbe potuto diminuire il numero dei potenziali lettori aumentando però gli introiti di autore e traduttori. Per questo motivo la casa editrice S.Fischer aveva fondato una rivista su cui pubblicare in anteprima i testi che sarebbero poi usciti in forma di libro, verificando le reazioni del pubblico senza perdere potenziali lettori.
Kippenberg concesse invece questo diritto e prese anche contatto con la rivista «Süddeutsche Monatsheften», legata all‘Insel Verlag tramite la persona di Heymel, in quel periodo membro del comitato redazionale della rivista. Kippenberg offrì la
Phädra, che venne però rifiutata per mancanza di spazio (Kippenberg a Vollmoeller, 10 maggio 1909). La stessa sorte toccò ai traduttori, come mostrano le lettere di Binding a Vollmoeller in cui sono esposti i tentativi intrapresi, le riflessioni su cosa fosse meglio offrire prima (Binding a Vollmoeller, 28 ottobre, 17 novembre e 6 dicembre 1909), finché nel febbraio 1910 Binding si rassegnò a non veder pubblicata in anteprima nemmeno una parte de
La Nave e chiese a Vollmoeller se anche la
Phädra veniva rifiutata (Binding a Vollmoeller, 21 febbraio 1910).
Più ostinato si mostrò Vollmoeller con il romanzo che sperava di pubblicare in anteprima e contemporaneamente sulla «Neue Freie Presse» di Vienna, che rifiutò già nel gennaio 1910 (Vollmoeller a d’Annunzio, 11 gennaio 1910), e sul «Berliner Tagblatt». In genere, però, le redazioni chiedevano di poter leggere il testo per intero prima di prendere una decisione definitiva (Vollmoeller a Kippenberg, 15 maggio 1910), e il testo non era ancora disponibile; inoltre la programmazione delle pubblicazioni per il 1910 era già stata fissata.
Kippenberg, dal canto suo, premeva per mettere in vendita il romanzo il prima possibile per sfruttare l’interesse dei lettori tedeschi per d’Annunzio. E siccome la prima edizione di Treves era già disponibile nel gennaio 1910 in due volumi, temeva che molti se lo sarebbero procurato in italiano (Kippenberg a Vollmoeller, 7 febbraio 1910) e che la prestampa a puntate avrebbe sottratto altri lettori. Per lo stesso motivo Treves aveva pubblicato l’opera senza le previste decorazioni di Giuseppe Cellini volendo anticipare la versione francese di Calmann-Lévy. Secondo Binding e Vollmoeller il romanzo era un’assoluta novità in quanto univa le nuove conquiste della tecnica ad un mondo mitico, a sentimenti oscuri e tormentosi. Il mondo eroico dei due protagonisti maschili, Paolo Tarsis e Giulio Cambiaso, amici ‘guerrieri’, è costituito da gare aviatorie, costruzione di aerei, velocità; quello femminile delle due sorelle, Isabella e Vana, è concentrato sul sentimento, sulla sensualità e su legami incestuosi. Contrapposti anche i luoghi in cui si svolge l’azione: il circuito aviatorio di Brescia, la profondità dei cieli e il paesaggio infernale delle Balze di Volterra, la reggia di Mantova con i suoi specchi e il labirinto sul soffitto delle stanze di Isabella d’Este. Barilli definisce il romanzo «un’opera di frontiera» che anticipa l’estetica futurista e Tarsis «un eroe applicato, la cui audacia aderisce ai mezzi del progresso tecnologico» (Barilli 1993, p.194). Quando il testo fu disponibile, molte redazioni ne rifiutarono la stampa per motivi morali, così a fine giugno Vollmoeller propose a Kippenberg un compromesso per recuperare una parte del guadagno perduto con la mancata pubblicazione in anteprima (Vollmoeller a Kippenberg, 29 giugno 1910). Il direttore, irritato per la situazione creatasi, per i ritardi che ostacolavano i suoi piani, si dichiarò a malincuore disposto ad accettare il compromesso per lui molto costoso di garantire non sei ma dieci edizioni del libro. (Kippenberg a Vollmoeller, 1 luglio 1910). Questa proposta venne ancora modificata da Vollmoeller per recuperare i 540 marchi di guadagno perduto: dividere al 50% tra lui e d’Annunzio le percentuali della settima fino alla decima edizione; garantendo a lui 4 edizioni e a d’Annunzio tre, e una percentuale del 6% sulla undicesima e dodicesima fino ad arrivare alla detta somma di 540 marchi.
Dal punto di vista giuridico la proposta era coperta dal fatto che il contratto gli lasciava mano libera per quanto riguardava la prestampa del libro. Approfittando del viaggio di un fratello a Parigi, Vollmoeller – che non poteva lasciare il letto – gli affidò con una lettera il compito di regolare la questione con d’Annunzio (Vollmoeller a Kippenberg, 4 luglio 1910). Nella lettera con data 5 luglio, oltre all’elenco delle 15 riviste contattate, Vollmoeller cita le difficoltà sorte per la pubblicazione a puntate attribuendone il rifiuto essenzialmente al contenuto ‚amorale‘ del testo, senza dilungarsi sulle trattative e le difficoltà con l’Insel Verlag e prega d’Annunzio di accettare le tre edizioni garantite inviando un telegramma in francese.
La formulazione suggerita per rispondere a Kippenberg era tale che si poteva interpretare come una completa accettazione delle condizioni stabilite tra Kippenberg e Vollmoeller e nello stesso tempo non lasciava intendere quanto d’Annunzio fosse stato informato, mettendo però il traduttore al sicuro da problemi giuridici.
Vous autorise renoncer pubblication journaux si Inselverlag me garantie (sic.) trois editions en plus selon votre lettres amities = Gabriele d’Annunzio (d’Annunzio a Kippenberg, telegramma del luglio 1910).
Risolto il problema della prestampa Vollmoeller cominciò a cercare riviste disposte a pubblicare una dettagliata recensione con brani del romanzo. La recensione e pubblicazione, p.es. dei due ultimi capitoli del romanzo, sarebbero stati un’ottima pubblicità per il romanzo stesso e nella stessa lettera informa l’editore che nel frattempo l’edizione francese aveva raggiunto la ventesima ristampa (Vollmoeller a Kippenberg, 17 luglio 1910). A fine agosto due giornali, la «Frankfurter Zeitung» e il «Berliner Tagblatt», s’erano dichiarati disposti alla stampa di brani dal romanzo (Vollmoeller a Kippenberg, 30 agosto 1910).
La notizia che il romanzo sarebbe stato pronto per la distribuzione il 13 settembre, un’ottima data per sfruttare il mercato natalizio, raggiunse Vollmoeller poco prima di una sua ripetuta partenza per Davos: Kippenberg si augura che il romanzo possa in qualche modo compensare la casa editrice delle grandi somme spese anche per i due drammi e prega Vollmoeller di occuparsi della pubblicità prendendo contatto con altri giornali (Kippenberg a Vollmoeller, 1 settembre 1910).
In novembre Kippenberg gli comunica il buon andamento delle vendite chiedendo per la prossima edizione che alcune poesie, lasciate in italiano nel romanzo, venissero tradotte, perché alcuni critici l’avevano segnalato come una mancanza (Kippenberg a Vollmoeller, 25 novembre 1910). Vollmoeller rifiuta: aveva lasciato in italiano i versi delle nenie infantili e ingenue non per pigrizia, ma per motivi stilistici e anche perché intraducibili, a meno di non inventarsene altri completamente diversi. In tedesco era impensabile una nenia infantile con la parola “Oger” (orco). Poi chiede a Kippenberg di inviargli alcune recensioni essendo a lui arrivati solo giudizi personali e privati (Vollmoeller a Kippenberg, 27 novembre 1910).
Tra i giudizi privati è rimasto quello molto critico di Binding:
…le singole descrizioni sono di nuovo splendide, p.es. quella del volo dei due amici e simili, uno deve provare a imitarla… Ma in altri episodi descritti lungamente che ne è di ‘ciò che conta’ per il romanzo e in generale? Tutto molto bello, delicato, dolce e morboso nel miglio senso della parola: il concerto dei fratelli, la scena con la piccola rondine alla finestra, la ninna nanna per la bambola e simili: ma cosa c’entrano? – In certe descrizioni prive di gusto e di forza si lascia andare con un tale autocompiacimento che lascia impressionati: p.es. il porgere a un bacio “il piccolo frutto duro della mammella” p.227. Non si giustifica neppure con la scusa del gusto italiano e se Lei come traduttore riesce a renderlo sopportabile, allora il Signor d’Ann deve solo ringraziarla (Binding a Vollmoeller, 2 marzo 1910).
Mehr als die Liebe (Più che l’amore)
In una pausa della traduzione del romanzo Vollmoeller cominciò a tradurre il dramma in prosa
Più che l’amore, una «tragedia moderna» scritta nel 1906 per la cui traduzione si era inutilmente interessata nel novembre dello stesso anno Linda von Lützow (Lützow a d’Annunzio, 17 novembre 1906, Vittoriale A.G. XV,3.) Vollmoeller, dopo aver comunicato la sua intenzione a d’Annunzio (Vollmoeller a d’Annunzio, 9 dicembre 1909), contattò Kippenberg per poterla offrire, una volta stampata, a diversi teatri. Il lavoro di traduzione sperava di poterlo finire insieme a quello del romanzo, data la relativa semplicità della lingua (Vollmoeller a Kippenberg, 15 gennaio 1910).
Kippenberg esitava perché non avrebbe voluto pubblicare altri drammi dannunziani costosi e privi di successo, e quello proposto era miseramente fallito alla prima del 29 ottobre 1906 al teatro Costanzi di Roma; inoltre, secondo lui, le opere di d’Annunzio poco dopo la loro pubblicazione sembravano ‘usurate’ e non suscitavano più lo sperato interesse presso il pubblico.
Dopo circa quattro mesi Vollmoeller presentò di nuovo il testo a Kippenberg, deciso a far valere il suo diritto di opzione come previsto nel paragrafo sei del contratto generale. Per rendere più accettabile la sua proposta si dichiarava disposto a rinunciare a una parte della garanzia che gli spettava come traduttore. Il giornale viennese «Die Zeit» nel numero di Pasqua aveva già pubblicato una scena del dramma e Kippenberg, poteva leggerla per farsene un’idea. La somma che richiedeva era solo di 900 marchi invece di 1200 (Vollmoeller a Kippenberg, 2 aprile 1910).
Kippenberg si dichiarò disposto a pubblicare il dramma solo a condizione che autore e traduttore si fossero limitati ad accettare un pagamento legato alle vendite del libro (Kippenberg a Vollmoeller, 4 aprile 1910). Vollmoeller accettò chiedendo però 700 marchi di garanzia, corrispondenti a due edizioni del libro al prezzo di 3,50 marchi per copia – e per d’Annunzio la garanzia di una solo edizione, ossia 350 marchi. La differenza di pagamento era per lui giustificata dal doppio lavoro di traduzione e arrangiamento del dramma per la scena. Le vendite del libro avrebbero presto parificato la situazione.
Kippenberg stese un regolare contratto in italiano e tedesco fissando la pubblicazione per la primavera 1911 non trovando giusto pubblicare a ritmo serrato troppe opere dannunziane. Nel caso di una messinscena la casa editrice era disposta ad accelerarne la pubblicazione (Kippenberg a Vollmoeller, 23 aprile e 2 maggio 1910). Vollmoeller comunicò a d’Annunzio la decisione della casa editrice di esercitare il diritto di opzione sull’opera pregandolo di firmare il contratto che porta la data del 12 maggio (Vollmoeller a d’Annunzio, 10 maggio 1910, Vittoriale, A.G. XV,2). Siccome d’Annunzio non reagiva Vollmoeller ripetè la sua richiesta dopo un mese e mezzo sottolineando la necessità di preparare il dramma per la prossima stagione teatrale (Vollmoeller a d’Annunzio, 20 giugno 1910). d’Annunzio firmò il contratto solo a inizio luglio, quando un fratello Vollmoeller si recò da lui per la firma.
Il contratto di
Più che l’amore, in due lingue (al Vittoriale e all’archivio di Marbach) segue il contratto generale, solo al quinto paragrafo si garantiscono a Vollmoeller 2 edizioni da pagarsi alla consegna del manoscritto e a d’Annunzio solo una pur restando uguale la divisione dei proventi da vendite e percentuali delle rappresentazioni. Questa differenza irritò fortemente d’Annunzio e spiega i successivi eventi legati a
Le Martyre de Saint Sébastien.
Il dramma non risulta essere mai stato rappresentato in Germania, sicuramento non fu messo in scena da Reinhardt e non fu mai stampato in forma di libro perché non compare in nessun catalogo o annuario della casa editrice Insel. Solo nell’archivio di Marbach è conservata una piccola parte del dramma, scritta a macchina e con correzioni.
I contratti con la casa editrice Insel
Dopo i primi contatti con Kippenberg a fine marzo 1909 Vollmoeller passò subito a discutere le condizioni finanziarie del lavoro. Nonostante l’atteggiamento generoso della casa editrice, le trattazioni furono molto complicate e si conclusero soltanto a metà giugno. Vollmoeller si mostra qui un manager ostinato che non cede subito a compromessi e cerca di affermare la propria volontà. Soprattutto vorrebbe pubblicare drammi e romanzi già usciti in Italia insieme a quelli anche solo progettati da d’Annunzio, convinto che l’offerta fosse interessante solo se fatta
en bloc. Tra questi: i drammi
Fedra, La figlia di Jorio, Più che l’amore, il romanzo di prossima pubblicazione
Forse che sì forse che no, La fiaccola sotto il moggio, come pure un secondo romanzo
La madre folle che d’Annunzio pianificava per l’anno successivo (Vollmoeller a Kippenberg, 6 aprile 1909). A fine maggio risale la prima bozza di contratto che per espresso desiderio di Kippenberg includeva anche
La Nave. Siccome l’editore non pubblicare troppe opere di d’Annunzio, nelle contrattazioni successive si limitò ad accettare i drammi
Fedra,
La Nave e il romanzo
Forse che sì, forse che no.
A metà giugno il contratto era pronto e Vollmoeller pregò Kippenberg, di mandare a lui la copia per d’Annunzio «perché voleva aggiungervi qualche parola di spiegazione» (21.06.1909).
Il 6 agosto d’Annunzio confermò il contratto apportandovi alcuni cambiamenti: accorciò a un anno invece di tre il diritto di opzione della casa editrice su opere già pubblicate come p.es.
La figlia di Iorio,
Più che l’amore e
La fiaccola sotto il moggio, e a 15 giorni, invece di 30, il termine per esercitare il diritto di opzione su manoscritti di opere non ancora pubblicate chiedendo le stesse garanzie di pagamento concesse a Vollmoeller per la pubblicazione del romanzo. (13.08.1909)
Vollmoeller pregò Kippenberg di accettare per evitare altre perdite di tempo e magari offerte da altre case editrici, e di mandare L.4.000, pari a marchi 3240, a d’Annunzio come acconto (Vollmoeller a Kippenberg, 20 agosto 1909). Spedizione confermata il 28 agosto 1909 (SUA: Insel Verlag, DLA Marbach). In tutta fretta furono fatti i cambiamenti al contratto con data 30 agosto e il 28 agosto Kippenberg comunicò a Vollmoeller che il contratto era stato firmato da d’Annunzio.
Il contratto generale tra la casa editrice Insel, d’Annunzio e Vollmoeller prevedeva al primo paragrafo la cessione del diritto d’autore per la pubblicazione delle opere
La Nave,
Fedra e
Forse che sì forse che no all’Insel Verlag che si impegnava a pubblicare le opere entro i due anni.
Il secondo regolava la posizione di Vollmoeller nei confronti dell’autore e della casa editrice che gli concedevano il diritto di tradurre le opere sopra indicate, mentre lui si impegnava a tradurle entro un anno e nove mesi, a organizzare una prestampa e a distribuirle ai teatri. Lo stesso paragrafo prevede anche la possibilità che fosse un altro traduttore a tradurre le opere previo consenso dell’autore e di Vollmoeller.
Il terzo paragrafo fissa a 10 per edizione il numero delle copie per le recensioni e concede alla casa editrice il diritto di stampare tante edizioni quante stimate necessarie dopo averlo comunicato all’autore e al traduttore.
Il quarto stabilisce il compenso dovuto a d’Annunzio: per i drammi il 10% del prezzo di vendita del libro per ciascuna copia garantendo la prima edizione, e per le successive a seconda delle vendite effettive; per il romanzo il 13% del prezzo di ciascuno copia venduta fino alla decima edizione e il 18% dall’ undicesima in poi.
Il quinto paragrafo regola il compenso dovuto a Vollmoeller: per i drammi valgono le stesse condizioni di d’Annunzio, per il romanzo il 7% fino alla decima edizione e il 6 % dalla undicesima in poi. Inoltre un acconto di 1200 marchi alla consegna del manoscritto di ciascun dramma; per il romanzo era previso il pagamento di sei edizioni garantite.
Il sesto paragrafo concerne il diritto di opzione sulle opere già pubblicate:
La figlia di Jorio, La fiaccola sotto il moggio, Più che l’amore e su quelle che saranno pubblicate nei tre anni successivi.
Il settimo paragrafo tratta delle copie omaggio.
Al contratto generale Kippenberg volle aggiungerne un altro che regolava i rapporti tra Binding, Vollmoeller e la casa editrice Insel, e la cessione dei diritti delle opere tradotte alla casa editrice Insel. Binding non lo riteneva necessario, fidandosi della parola data, ma Kippenberg per prudenza lo esigeva. Anche qui fu Vollmoeller a condurre le trattative: la prima stesura prevedeva che Binding avrebbe ricevuto 500 marchi alla consegna del manoscritto de
La Nave e
Fedra, e parte dei proventi di una eventuale prestampa e messinscena dell’opera; queste percentuali sarebbero state divise come segue: 50% a d’Annunzio e 25%+25% a ciascun traduttore. I due traduttori si sarebbero accordati sulla formulazione con cui sarebbe comparso anche il nome di Vollmoeller come traduttore. Vollmoeller si dichiara disposto a elaborare una versione scenica e a aiutare Binding nella traduzione ogniqualvolta fosse necessario.
Soltanto sulla somma prevista e garantita di 500 marchi Binding non si dichiarò d’accordo, perché la traduzione richiedeva «oltre alle conoscenze dell’italiano e del tedesco, anche quelle di greco e latino, arcaico e bizantino (nella fantasia)» e ne propose 600 dichiarandosi disposto a rinunciare a quanto avrebbe superato i 150 marchi in caso di una prestampa (Binding a Vollmoeller, 3 ottobre 1909).
Nel contratto definitivo di fine ottobre 1909 al terzo paragrafo è fissata la somma di 600 marchi alla consegna del manoscritto come acconto del 15% sul prezzo di vendita di ogni copia in brossura. Nel caso in cui le vendite superassero la somma garantita di 600 marchi, la differenza doveva essere pagata al comparire sul mercato della nuova edizione.
I compensi derivanti dalle percentuali delle rappresentazioni teatrali erano già regolate nel contratto tra Vollmoeller e d’Annunzio e in quello con l’agenzia di teatro Eduard Bloch (divisione del 50% a d’Annunzio e del 25+25% a ciascun traduttore) del 10 novembre 1910.
Rappresentazioni teatrali
Lo scopo principale della traduzione dei drammi era naturalmente la messinscena in tempi relativamente brevi. Binding e Vollmoeller cercavano con ogni mezzo di convincere Reinhardt a farlo essendo secondo Vollmoeller l’unico regista in grado di garantirne il successo che, a sua volta, avrebbe garantito la buona vendita del libro. Nel loro carteggio si leggono le riflessioni su quale opera fosse più adatta ad essere messa in scena per prima e, in tono scherzoso, i piani di battaglia elaborati per farle leggere al regista, del tipo: ritrovarsi seduti di fronte, in treno, in un lungo viaggio e presentare
La Nave a Reinhardt; «essere come un pidocchio nei capelli», ossia insistere e non demordere mai per non venir subito dimenticati (Binding a Vollmoeller, 11 e 16 ottobre 1909)
Oltre agli agguati, si pensava di ricorrere all’aiuto di altre persone, come p.es. Maria Carmi, moglie di Vollmoeller, convinta proprio da Reinhardt ad abbracciare la carriera di attrice, e Tilla Durieux, famosa attrice e ballerina nel teatro tedesco, interessata al ruolo di Basiliola ne
La Nave (Binding a Vollmoeller, 11 luglio 1909).
Questi sforzi non portarono a nulla, visto che nell’ottobre 1910 Vollmoeller propose a d’Annunzio di firmare un contratto con l’agenzia di teatro Eduard Bloch per la diffusione e la rappresentazione di tutti i drammi pubblicati presso l’Insel Verlag. Bloch era l’unica agenzia disposta a pagare qualcosa in anticipo, condizione ineludibile per Vollmoeller onde garantire il lavoro dell’agenzia, la somma era piccola, 400 marchi per ciascuna delle seguenti opere:
Phädra, Das Schiff e
Mehr als die Liebe. Tre quarti delle percentuali delle rappresentazioni sarebbero andati a Vollmeller che ne avrebbe mandato due quarti a d’Annunzio. Il restante quarto sarebbe andato a Binding per le opere tradotte in comune. In compenso l’agenzia chiedeva il diritto di opzione per le prossime opere pubblicate in tedesco. Vollmoeller consigliò a d’Annunzio di approvare e di mantenersi il diritto di richiedere di più (25 ottobre 1910).
Ma d’Annunzio dapprima non rispose perché a Parigi stava allacciando nuovi contatti internazionali con personaggi del mondo della letteratura e dello spettacolo e sembrava che si aprissero nuovi orizzonti per la diffusione delle sue opere teatrali; il regista americano Edgard Strakosch (1859-1942) sembrava infatti interessato a mettere in scena l’ultimo lavoro di d’Annunzio «per il Vaudeville». Di quale opera si trattasse non si trova cenno nei materiali consultati (Vollmoeller a d’Annunzio, 8.6.1911), né si sa se il contratto con Bloch entrò mai in vigore come risulta dalla stessa lettera di Vollmoeller.
Poco dopo sembrava che
Das Schiff interessasse al Circo Schumann di Berlino dove Reinhardt stava appunto sperimentando nuove messe in scena che coinvolgessero le masse nello spettacolo. A questo fine attribuiva al coro la funzione di «sottolineare collettivamente le azioni del singolo …trasformandolo in un antagonista dell’attore in quanto gruppo animato da una sola volontà che dialogava con l’attore»; la massa delle comparse assunse un proprio carattere diventando «un conglomerato di individui cui erano propri tutti gli stati d’animo umani come lo erano all’attore, che recitava secondo un testo» (Braulich 1966, pp. 105-106). Lo scopo perseguito con la nuova regia era il coinvolgimento di nuovi ceti sociali al teatro, graduando il prezzo dei biglietti. Un numero maggiore di spettatori avrebbe portato in ogni caso un guadagno, sebbene i costi per una messinscena di questo tipo fossero molto elevati. Il dramma di d’Annunzio,
Das Schiff era uno dei pochi drammi moderni che sembrava soddisfare le esigenze di Reinhardt.
Più vicini allo scopo si arrivò tramite i tentativi del conte Harry von Kessler (1868-1937), dopo la rappresentazione de
Le Martyre de Saint Sébastien.
Dopo quest’opera nella corrispondenza con l’Insel Verlag si trovano soltanto poche lettere riferite a d’Annunzio e concernenti la traduzione de
Le Martyre de Saint Sébastien che Kippenberg rifiuta dopo aver visto la prima a Parigi.
Il contratto tra d’Annunzio e l‘Insel Verlag era valido fino all’agosto 1912, tuttavia l’editore non esercitò più nessun diritto di opzione. Il motivo è da ricercarsi negli alti costi per la pubblicazione dei testi dannunziani causati dalle richieste di autore e traduttore e dalle mancate messeinscena delle opere.
Le traduzioni pubblicate presso la casa editrice Insel pur essendo più accurate di quelle di S.Fischer e dal punto di vista grafico impeccabili non garantirono a d’Annunzio il successo avuto con la casa editrice berlinese. Un motivo è da vedersi sicuramente nella tipologia dei testi qui pubblicati, in prevalenza poesie e drammi in versi, più difficili da leggere e da vendere; un altro nella strategia seguita dall’editore: mentre S.Fischer invadeva il mercato con le opere di d’Annunzio e tramite la quantità creava un’aura di importanza intorno a un autore, il secondo aspettava l’autentica reazione del pubblico e si era affidato all’iniziativa costante dei suoi traduttori per la pubblicità delle opere. Samuel Fischer invece aveva potuto pubblicare più opere perché non aveva pagato le traduzioni tanto quanto l’Insel Verlag, aveva potuto sfruttare al meglio la novità costituita dall’autore essendo il primo editore tedesco di d’Annunzio e aveva pubblicato in prevalenza romanzi e novelle, opere più facilmente accessibili al pubblico.
La guerra e l’impegno militare di d’Annunzio contro la Germania interruppe i rapporti editoriali con questa casa che, a differenza di S.Fischer, non si interessò più alla pubblicazione di opere dannunziane e rifiutò le proposte dei traduttori.
Bibliografia
La corrispondenza citata, quando non diversamente indicato, è pubblicata in Adriana Vignazia,
Die deutschen d’Annunzio Übersetzungen. Entstehungsgeschichte und Übersetzungsprobleme, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1995, pp.58 -117, in appendice pp. 301-311, i contratti pp.323-329.
Gli originali della corrispondenza tra Binding e Kippenberg si trovano alla Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar, collocazione G.S.A. 50/126,9 per l‘anno 1909 e 50/127,9 per l’anno 1910; Lo stesso vale per la corrispondenza tra Vollmoeller e Kippenberg, alla collocazione G.S.A. 50/127,55.
Le lettere di Vollmoeller a d’Annunzio sono al Vittoriale, A.G. XV,2; quelle di d’Annunzio a Vollmoeller e di Binding a Vollmoeller all’archivio al Deutsches Literatur Archiv (DLA) di Marbach.
La corrispondenza tra Otto von Taube e Anton Kippenberg si trova alla Nationale Forschungs- und Gedenkstätte der klassischen deutschen Literatur in Weimar, G.S.A. 50/123, 172 come pure quella tra Otto von Taube e Katharina Kippenberg alla collocazione G.S.A. 50/137, 183
La corrispondenza tra Pio Rajna e d’Annunzio si trova al Vittoriale, A.G.XIII,4 come pure quella tra Oskar Hecker e d’Annunzio, A.G.XLIX,2
Paolo Alatri,
Gabriele d’Annunzio, UTET, Torino, 1983
Renato Barilli,
d’Annunzio in prosa, Mursia Editore, Milano, 1993
Otto Bierbaum, «Die Insel», Heft 11/12; da
Die Insel, Eine Ausstellung zur Geschichte des Verlages unter Anton und Katherina Kippenberg, Deutsches Literaturarchiv im Schillermuseum, Marbach am Neckar, 1965.
Rudolf von Binding,
Erlebtes Leben, S:Fischer, Frankfurt/Hamburg/Berlin 1956
Rudolf von Binding,
Vorwort, in Gabriele d’Annunzio,
Auferstehung des Kentauren, Insel Verlag, Leipzig, 1909, senza numerazione delle pagine.
Heinrich Braulich,
Max Reinhardt. Theater zwischen Traum und Wirklichkeit, Henschel, Berlino, 1966.
Leopold Freiherr von Clumecky,
Politische Dramen-dramatische Politik, «Österreichische Rundschau» 14 (1908), pp.239-244
Gabriele d’Annunzio,
Der Tod des Hirsches, im Versmaß des Originals übertragen von Oskar Hecker, «Internationale Wochenschrift» 6 (1912), col. 1205-1212
Jürgen Eyssen,
Die Insel und die moderne deutsche Buchkunst, Auktion 257, bei Hauswedell & Nolte, Hamburg, 1985.
Fritz Fischer,
Der Krieg der Illusionen: die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Droste, Düsseldorf, 1969
Insel-Almanach, Insel Verlag, Leipzig, 1908.
Günter Rühle,
Theater in Deutschland: 1887-1945; seine Ereignisse – seine Menschen, Fischer, Frankfurt am Main, 2007
Gerhard Schuster,
“…das in deutschem Sinn Conservative”, «Buchhandelsgeschichte», 1984/4, B 131.
Otto von Taube,
Wanderjahre, K.F. Koehler Verlag, Stuttgart, 1950
Piero Violante,
Il navalismo di Otto Hintze, in
Otto Hintze: Stato e esercito, Flaccovio, Palermo 1991, pp. 53-92.
Karl Vossler,
Zu d’Annunzios “Morte del cervo”, «Internationale Wochenschrift» 6 (1912), col. 1213-1218.