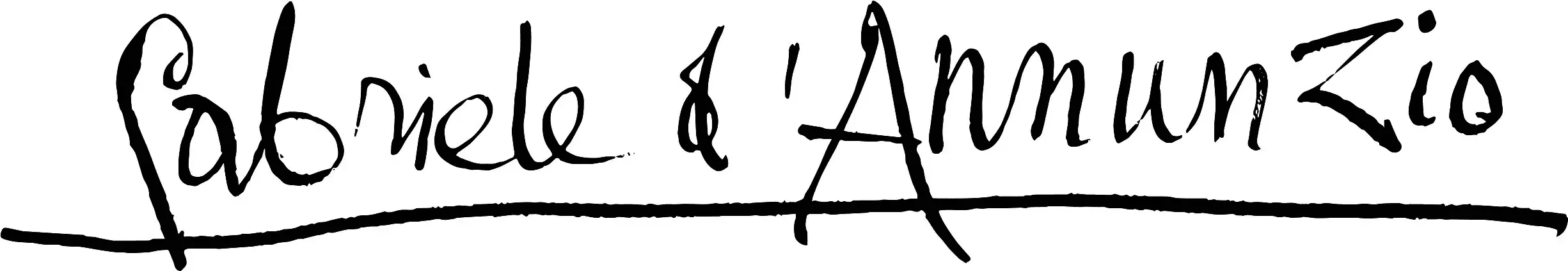di Gianni Oliva, Enciclopedia dannunziana
1. Trasfigurare la realtà
Nella prosa ritmata a respiro breve del Libro segreto d’Annunzio tornava qualche volta con la memoria alle letture dell’infanzia, alla voglia di avventura respirata sulle pagine di capitan Cook. La rievocazione del «rapimento gioioso e tormentoso», peraltro mai più avvertito con tale intensità, e l’anelito al sogno meraviglioso simboleggiato nel blu in margine alle terre, più che una nostalgia di sentimenti perduti e comunque legittimi nel vecchio solitario, possono leggersi soprattutto come riaffermazione della sua precoce tendenza a trasfigurare, magari fantasticando sulla carta geografica all’inseguimento di paesi esotici e di mondi sconosciuti. È un modo per sottolineare il suo istintivo rapporto con il reale, inteso non come riproduzione fotografica, esattezza di dati oggettivi, ma come precoce e dinamico controllo dei fenomeni esterni attraverso il filtro della mente creativa. L’esperienza infinita gli aveva insegnato che «Viaggiare non giova», perché la diretta conoscenza dei luoghi non conta più dell’immaginazione nella solitudine della stanza, a ulteriore esibizione della poetica decadente che rivendicava l’indiscusso primato del sogno. A queste confessioni tardive fa da pendant la consapevolezza, maturata già dagli anni verdi, della sua prorompente inclinazione a cercare «oltre l’aspetto delle cose», a dare ad esse «un significato», «uno spiracolo di vita», a individuare, insomma, i «pensieri della natura».
2. Terra vergine: esplorare l’Italia remota
Ma allorché d’Annunzio avviò la sua attività di narratore con le novelle di Terra vergine (1882), il panorama culturale dell’Italia post-unitaria, vario e complesso, esigeva ben altro che il vagheggiamento di terre lontane. Al contrario, si diffondeva sempre più l’esigenza di aderire al concreto e di riprodurne le sfaccettature regionali dietro l’influsso del naturalismo. La nuova nazione stimolava gli scrittori a restringere i propri campi d’indagine alle province e alle zone periferiche, in modo che l’osservazione dei costumi offrisse un quadro particolareggiato di un unico corpo territoriale, le cui singole voci partecipassero al coro, a quella che Croce chiamerà con espressione felice «la grande conversazione». Lo scopo era di rendere nota un’Italia remota e sconosciuta con le sue abitudini, tradizioni e bisogni dissimili da un luogo all’altro, facendo magari balzare in primo piano le questioni sociali del Mezzogiorno, le «miserie », gli «affetti» e le «condizioni presenti delle classi bisognose». Erano propositi sostenuti energicamente da riviste molto lette come la “Rassegna settimanale” di Franchetti e Sonnino, che non a caso ebbe tra i suoi collaboratori anche Verga. E c’è forse da dire che senza tali direttive entrate nella coscienza comune, difficilmente avremmo avuto nell’ Italia degli anni Settanta e Ottanta la vasta fioritura di romanzi e novelle del realismo provinciale o verista.
Con gli altri narratori della nuova stagione, in cui suo malgrado si trova a operare, d’Annunzio ha in comune il punto di partenza, ma non gli esiti. Da Verga, ad esempio, si discosta nella tecnica riproduttiva, giungendo per suo conto a costruire una realtà quasi rovesciata rispetto a quella dello scrittore siciliano. E le ragioni di tale diversità non sono forse da cogliere unicamente nei rispettivi temperamenti individuali, l’uno concreto e positivo, l’altro esuberante e fantasioso, ma anche nelle diverse condizioni culturali e nelle suggestioni specifiche che d‘Annunzio ricava dal mito della terra d’origine attestato nella tradizione antica e recente.
3. Abruzzo esotico
Fin dai tempi del Boccaccio, che nelle novelle di Calandrino e di fra’ Cipolla aveva alimentato una curiosa mentalità popolare, l ‘Abruzzo era stato addirittura identificato con una regione esotica, pressoché confinante con quella della pietra filosofale. Gli stessi viaggiatori delle età successive, pur cogliendo gli aspetti realistici del paesaggio e delle abitudini, avevano mantenuto in vita certe credenze spesso fraintendendo i comportamenti degli abitanti, esagerando le incursioni dei briganti, correndo dietro alla suggestione delle asperità naturali, delle montagne, dei sentieri impervi e delle foreste impenetrabili. Di questo Abruzzo «pittoresco» era inevitabile che si impadronisse poi la letteratura gotica inglese, di cui offre un calzante esempio Anne Radcliffe, l‘autrice de L’Italiano ovvero il confessionale dei penitenti neri ( 1797), opera di ampia risonanza, non ultimo per i suoi influssi su Keats, Byron, Scott , Coleridge. Il paesaggio descritto è quello di una geografia di carta con gole rocciose, «pianori lontani e vette montuose », con un fiume dalla «forza impetuosa » che scorre negli abissi «come a voler reclamare il dominio esclusivo di quel luogo selvaggio e solitario »: «Il suo letto occupava l’intero fondo del crepaccio, formatosi probabilmente da qualche convulsione della terra, tiranneggiando lo spazio persino alla strada lungo il suo margine. Il suo tracciato pertanto era portato più in alto, fra i dirupi che sovrastavano il fiume, e pareva sospeso nell’aria mentre la paurosa vastità dei precipizi che torreggiavano al di sopra e affondavano sotto, unita alla forza sorprendente e al ruggito delle acque impetuose, contribuiva a rendere quella gola più terrificante di quanto la penna possa descrivere o la lingua raccontare».
D’altro canto, la tradizione narrativa indigena, anche se scarsa e di poco rilievo, non era stata da meno nell’offrire esempi che confermavano il piacevole stereotipo: dai novellieri di educazione romantica presenti nel “Giornale abruzzese” di Pasquale De Virgiliis ( si pensi al modesto racconto di imitazione manzoniana di Raffaele d’Ortenzio dal titolo I fidanzati abruzzesi), a un attardato scrittore come Ignazio Cerasoli, autore di un volumetto di Novelle abruzzesi intonato alle fattezze del racconto storico in pieno 1880 (Milano, Ambrosoli) , al primo Ciampoli, con i suoi paesaggi di fantasia dalla natura vergine ed esuberante.
D’Annunzio, dunque, pur prendendo l’intonazione dal Verga di Vita dei campi, aveva certo di che nutrirsi, sia pure indirettamente, nell’ambito della letteratura regionale e di quella non specifica. Rispondeva così al richiamo dei tempi alimentando dal canto suo un’immagine della terra d’origine confacente al collaudato e un po’ desueto cliché, di certo lontano dai criteri di rappresentazione promulgati dai naturalisti e dai veristi. In più si affidava all’ esuberanza carnale della sua giovinezza, allo straripamento delle energie vitali, all’ orgia di profumi, di colori e di sensazioni che gli venivano dal temperamento sensuale e dalla innata capacità a deformare il fenomeno.
La sua pagina si carica di elementi esotici, di tipo vegetale e zoologico (non si dimentichino i riferimenti alla pantera, al giaguaro), che si ricollegano alla decisa volontà di attuazione del sogno inappagato di terre lontane. Come quando fantasticava dietro i resoconti di Cook, egli disegna un Abruzzo in qualche modo somigliante all’Africa, mito dei suoi giorni, dopo la scoperta del Continente nero da parte dei grandi esploratori, da Livingstone a Stanley. Un riflesso di quel clima si scorge anche nella contemporanea produzione poetica e nelle lettere a Elda Zucconi, corrispondente di quei giorni. Come del resto non è solo un caso che d’Annunzio associ nella novella Egloga fluviale l’idea del viaggio a quella del vagabondaggio come simbolo dell’errare umano. La raccolta Terra vergine non a caso è dedicata a Giovanni Chiarini da Chieti, morto in Africa equatoriale nel 1879 in una malcapitata missione nel Regno di Ghera («A Giovanni Chiarini-abruzzese- che giace lontano – sotto una capanna di bambusa nel cuore dell’Africa»), quasi a voler sottolineare un’affinità di intenti tra esploratori di terre vergini. Se il Chiarini era partito dalla terra natìa in compagnia del marchese Orazio Antinori e dell’amico Antonio Cecchi per restituire l’immagine di civiltà primitive, d’Annunzio dal canto suo si sentiva investito della missione di illustrare a suo modo gli usi e i costumi di un popolo per molti aspetti ignoto alla società postunitaria. Di questo passo, informato al darwinismo vigente, trasformava gli animali e le piante in uomini e questi in piante e animali, accreditando un comune denominatore tra gli esseri viventi e un grado zero dell’ esistenza. D’altra parte, l’oggettività naturalistica era anche tradita dall’assecondamento di una forza primigenia collegata all’impeto della giovinezza e dell’istintualità. Non meraviglia dunque se già dagli anni del Cicognini d’Annunzio diventi lettore di Darwin e si riconosca nelle sue intuizioni. L’uomo è avvicinato all’animale e l’amore si identifica nell’ ardore e nella potenza seminale. Spesso il calore estivo, sinonimo di libido, si trasmette ai giovani corpi tonificandoli e risvegliando in essi il fuoco interiore.
4. Modelli francesi
Stando così le cose, va da sé che il modello verghiano, sul quale la critica da sempre ha forse eccessivamente insistito, rimane un elemento esterno e decorativo, che non trova sostanziale applicazione né nei contenuti, né nello stile. Semmai, il referente più diretto per il giovane d’Annunzio è lo Zola de La faute de l’ abbé Mouret (apparso in Francia nel 1875 e in Italia nel 1880), che riversa nel romanzo una vera e propria collezione di nomi di fiori, di frutti, di alberi, di insetti, di uccelli, quasi a voler raccogliere tutte le specie viventi nel parco del Paradou , una sorta di mitico Eden. Peraltro, lo scrittore francese attuava già la vivificazione della natura che si rinnova nel suo immenso e perpetuo travaglio di fecondazione, nella giovinezza, nella potenza, nella sensualità e d‘Annunzio vi riscontrava, molto più che in Verga, le cadenze, le simmetrie sintattiche variate, le ripetizioni ravvicinate o a distanza di verbi, di sostantivi e di aggettivi. Le fonti francesi del d’Annunzio novelliere, del resto, sono state accuratamente accertate e si è visto come soprattutto Maupassant faccia sentire la sua presenza nelle raccolte successive a Terra vergine, dal Libro delle vergini (1884) al San Pantaleone (1886), che confermano l’energia creativa materializzata nella scrittura breve. Certo, il suo rapporto con il naturalismo, sempre problematico perché in sostanza anticostituzionale, in questa fase si intensifica molto più che in passato, ma non ha mai come fine la resa oggettiva e impersonale dei fatti. Anzi, si precisa sempre più attraverso la strada della fisiologia patologica e l’attenzione rivolta ai casi abnormi, alla psicologia distorta degli individui. La scena si fa mobile e passa dal selvaggio-naturale al selvaggio-comunitario o elitario, mentre restano costanti gli atteggiamenti violenti e crudeli, decritti nei minimi particolari con compiaciuta partecipazione. Si insiste, infine, sulle allucinazioni e sulle superstizioni delle masse, sulle brutture del mondo, che sono alle radici dell’atteggiamento nauseato e sprezzante degli anni futuri.
Un’esperienza, comunque, quella del novelliere, non trascurabile nell’ economia generale della produzione dannunziana, tanto che l‘autore stesso non ritenne di doverla dimenticare. E se fu fin troppo severo con il primo laboratorio di Terra vergine, attinse invece a piene mani dalle altre prove e ne aggiornò stilisticamente i risultati per confezionare Le novelle della Pescara (1902), il libro retrospettivo che doveva attestare la sua precoce, geniale vocazione sperimentale anche sul terreno del racconto. Il grande banco di prova era comunque il romanzo.
5. La seduzione del romanzo
Sia pure sotto l’influenza di fonti francesi, spesso pedissequamente riecheggiate (Séailles, Guyau, Théodore de Wyzewa, ecc.), d’Annunzio elabora più avanti negli anni la sua teoria del romanzo. Il progetto di lavoro nasce ancora una volta da un tentativo di superamento del metodo naturalista proprio in un momento in cui il contesto culturale sembrava non prevedesse altro. Se il moto di corrosione del naturalismo è connaturato con l ‘inclinazione istintiva dello scrittore, più tardi esso diventa programma inseguito e chiaramente espresso. Sulla sua sensibilità organica fanno breccia a poco a poco la necessità del sogno e il piacere della finzione, così come ai cinque sensi già ampiamente esperiti se ne aggiunge uno nascosto che permette le percezioni impossibili e dà significato profondo ai piccoli fatti. Le cose diventano simboli e l’universo intero ne è permeato, sicché allo scrittore, che ha la capacità di coglierli, si aprono mondi sconosciuti. La facoltà di invenzione o di ritrovamento, così sviluppata nel vero artefice, aiuta a comporre l’ignoto mediante il già noto. E laddove l’estetica naturalistica appariva limitata nel mettere in sintonia i luoghi e gli avvenimenti con le condizioni intellettuali del personaggio, il nuovo metodo apriva le porte a una realtà spiritualizzata e allucinatoria, che anteponeva l’audacia onirica alla equivoca precisione della scienza. La macchina del romanzo, di conseguenza, diveniva una sorta di partitura musicale in cui si prolungava l’esperienza lirica del simbolismo. Le stesse strutture tradizionali, dall’intreccio congegnato secondo un lineare svolgimento di episodi, alle categorie temporali e spaziali perfettamente correlate tra loro, erano sradicate da una scrittura fluida di andamento ellittico, da un’ architettura sghemba prodotta dal gioco del tempo a ritroso, resuscitato dalla memoria asincronica rispetto al presente storico, e persino dal diario come strumento indiretto di narrazione. L’autore, dal canto suo, usciva dall’eclissi e si identificava smaccatamente con il protagonista, al quale cedeva le sue esperienze di vita e di pensiero.
6. Andrea Sperelli e la malattia della volontà
Pur non ammettendolo esplicitamente, anzi negandolo, d’Annunzio proiettava in Andrea Sperelli, protagonista del Piacere, almeno le sue aspirazioni e coglieva nella sua creatura la malattia della volontà e il dangereux esprit d’ analyse (Bourget) che erano dei tempi. Ne scaturiva un uomo dalla coscienza priva di centro, che anteponeva il senso estetico a quello morale e che si dilettava nelle possibilità combinatorie delle associazioni mentali. Il suo spirito camaleontico era acuito «dalla consuetudine della contemplazione fantastica», dalla «pienezza della vita rivelata», frutto di una lucidità spiccata a tal punto da produrre angoscia. Lo speciale rapporto con le cose costituisce una costante della complessa personalità sperelliana e la base per individuare i meccanismi segreti che l’alimentano. Ciò che egli vede e sente non è mai registrato fedelmente, ma ricreato, «reinventato» alla luce di un ‘attitudine straordinaria che conferisce significati inediti al mondo esterno. Le sue facoltà percettive tendono, insomma, a interpretare la realtà adattandola al proprio essere. Il rigoroso descrittivismo naturalista cede il passo al fading, all’invenzione neoplatonica e l’eroe dannunziano ha non solo la capacità di rinnovellare la sua visione del mondo, ma addirittura di resuscitare la natura morta, di conferirle un’anima. La stessa dimora (il buen retiro di Andrea) diventa così house of life, una sorta di «perfettissimo teatro» modellato a propria immagine dall’ «abilissimo apparecchiatore». L’identificazione tra autore e personaggio in questo senso è fin troppo evidente: « Ho fatto di me la mia casa; e l’amo in ogni parte», scriverà d’Annunzio nel Libro segreto, così come nel Compagno dagli occhi senza cigli ribadirà che «il più sensuale piacere» è una casa fatta a propria «simiglianza». L’abitazione, dunque, è coinvolta nel principio informatore della poetica dannunziana, secondo la quale è il sentimento di chi scrive a creare il mondo, come già si verificava per Dante Gabriel Rossetti e per il Des Esseintes di Huysmans. Fatto sta che la stesura del Piacere coincide per d’Annunzio con un periodo di arricchimento intellettuale, di avide letture, più o meno assimilate, di autori che denunciano la crisi del razionalismo scientista e affrontano la malattia morale del secolo. Inoltre, la costruzione del romanzo avviene anche attraverso una sorta di abile montaggio del materiale accumulato dal chroniqueur della vita romana, dall’osservatore di tipi e situazioni, di ricevimenti, di balli, di aste, di visioni incantate della città eterna. D’Annunzio matura ormai la convinzione che « Il romanzo naturalista è all’ agonia» – così scrive nel maggio 1888 – e che il circolo zoliano di Mèdan è disorientato, giacché non è più sufficiente credere che «le cose esteriori esistano fuori di noi» (L’ultimo romanzo). Appropriandosi di queste considerazioni (poco importa se derivate da Théodore de Wyzewa), d’Annunzio aveva in mente di negare l’oggettività del reale, sottolineando invece la necessità di porre in relazione luoghi e avvenimenti con «le speciali condizioni del “personaggio”», come se la realtà non vivesse di per sé, ma attraverso gli occhi e le sensazioni di chi la guarda. Il romanzo del 1889 riflette certo l’applicazione di queste idee e a poco vale la dichiarazione premessa nella lettera dedicatoria a Michetti, ove si parla con terminologia verghiana di studio della Vita. Quasi certamente l’espressione (la maiuscola ne è forse una spia) allude all’attenzione che l’autore deve rivolgere alle epifanie psicologiche e non al vaglio di dati esteriori. Sembra cosa di poco conto, ma tutto ciò implica quel modo nuovo di accostarsi ai fenomeni cogliendone le componenti irrazionalistiche ed estetiche che fanno dell’ opera la prima manifestazione, almeno in Italia, di letteratura decadente. E se Il piacere è un’operazione consapevole o spontanea poco importa. Certo è che d’Annunzio trova il modo di rinnovare contenuti e forme trasformandil genere romanzesco in poema moderno, dal quale non era esente un vago sapore di scandalo. Servendosi di un alter ego, egli rappresenta la propria avventura umana e intellettuale conciliando le ragioni di una rigorosa disciplina artistica con quelle del pubblico e dell’industria culturale.
7. La conoscenza del romanzo russo
Avviata la riflessione sulla propria evoluzione di narratore e insoddisfatto, nonostante tutto, dei risultati prodotti, d’Annunzio continua la sua ricerca attraverso un ulteriore sforzo di rinnovamento. I primi anni Novanta sono decisivi, anche perché ai modelli già collaudati si aggiunge la conoscenza dei russi ( di Tolstoj e di Dostoevskij in particolare) e la familiarità con Wagner e Nietzsche. Lo scrittore vive un momento di crisi profonda avvertendo i limiti della prima prova e si dichiara quasi nauseato delle «lucide forme verbali» in cui si era compiaciuto. La prefazione al Giovanni Episcopo, indirizzata a Matilde Serao, è un chiaro documento del tentativo di ripartire da zero («O rinnovarsi o morire»), non solo eliminando le ridondanze dello stile alla ricerca di una prosa più asciutta e concreta, ma anche tentando di caricare la narrazione di una valenza ideologica. D’Annunzio è attratto dalla moda del roman russe lanciata in Francia fin dal 1885-1886 dal marchese de Vogué, peraltro mediata in Italia dall’amico Angelo Conti, frequentatore dell’ aggiornata biblioteca del conte Primoli.
Egli è affascinato dal travaglio delirante e dalla psicologia criminale del personaggio di Marmeladov in Delitto e castigo, nonché dalla novella Kròtkaja, le cui analogie con l’Episcopo furono già sottolineate da un recensore illustre e perspicace come Luigi Capuana. Il «piccolo libro», comunque, fu un esperimento fallito in ogni direzione in quanto d’Annunzio non riuscì a scrollarsi di dosso l’esuberanza verbale di cui egli stesso si accusava, né a infondere al racconto la convincente forza morale che si prefiggeva. Indubbiamente però quell’ esperienza era servita se non altro a spianare il campo verso risultati meno labili, di cui L’Innocente, dal canto suo, è un passaggio non secondario. Ormai d’Annunzio si addentra nei meandri di una morbosa psicologia adoperando affilati strumenti di tipo analitico e affidando la narrazione al sorvegliato flusso della memoria. La suggestione dei russi è ancora forte, tanto che il modello di Tolstoj diventa preminente allorché il protagonista Tullio Hermill è dibattuto tra il suo esasperato egoismo e la volontà utopistica di rigenerazione. Il suo desiderio di purificarsi si scontra inevitabilmente con ragioni pretestuose, che finiscono per fargli ammettere l’infanticidio come atto necessario al suo «ritrovamento». I temi tolstoiani della bontà e dell’umanitarismo cristiano si dissolvono nelle anomalie comportamentali e nelle prime avvisaglie del superuomo. Tuttavia, mediando il coinvolgente descrittivismo del Piacere con la scheletrica fattura della prosa dell’Episcopo, d’Annunzio coniava nell’Innocente uno stile dalla sorprendente capacità simbolica ed evocativa, vitale per la sua forza musicale e per la parola sempre più evanescente e allusiva.
8. Un libro di prosa moderno: Il Trionfo della morte
Fatto sta che in quegli anni d’Annunzio osservava con grande interesse la metamorfosi in atto nella cultura europea, specialmente francese, e ne assorbiva con tempestività le opinioni riportandole negli articoli giornalistici che andava scrivendo. Tra il 1892 e il 1893 un manipolo di interventi dava conto delle sue posizioni sul futuro del romanzo, sull’esigenza di evadere dalla realtà, sulle tendenze più vistose di abbandono delle vecchie prospettive naturalistiche e di analisi psicologica. Inoltre, L’enquete sur l’évolution littéraire svolta da Jules Huret tra gli scrittori d’oltralpe offriva in tal senso un ventaglio di idee nuove da meditare. Ne scaturiva il progetto di una prosa densa di «elementi così varii e così efficaci da poter gareggiare con la grande orchestra wagneriana nel suggerire ciò che soltanto la Musica può suggerire all’anima moderna». Sono le parole fissate nella dedica a Michetti del Trionfo della morte, apparso nel ’94 sviluppando la linea dell’abortito tentativo dell’Invincibile ( 1889). La lunga prefazione è la chiave di lettura del nuovo Rinascimento auspicato nelle lettere moderne, di cui lo stesso d‘Annunzio si erge indirettamente a corifeo. L’anno seguente, infatti, intervistato da Ojetti, parlerà dei giovani aperti alle forme di un’arte universale e senza confini, che accoglie «in un vasto e lucido cerchio le più diffuse aspirazioni dell’anima umana ». L’obiettivo è quello di raggiungere, come aveva scritto nel proemio del Trionfo, «un ideal libro di prosa moderna che – essendo vario di suoni e ritmi come un poema; riunendo nel suo stile le più diverse virtù della parola scritta – armonizzasse tutte le varietà del conoscimento e tutte le varietà del mistero; alternasse le precisioni della scienza alle seduzioni del sogno; sembrasse non imitare ma continuare la natura; libero dai vincoli della favola, portasse alfine in sé creata con tutti i mezzi dell’arte letteraria la particolar vita -sensuale-sentimentale intellettuale – di un essere umano collocato nel centro della vita universa».
9. Da Giorgio Aurispa a Claudio Cantelmo
Sulla scia, dunque, di quanto già abbozzato con Il piacere, d’Annunzio tende ad accreditare un libro di prosa che non può più dirsi romanzo, avendone smarrito tutte le strutture e le impalcature per dare spazio a un flusso prosastico di impianto sinfonico. Protagonista dell’opera è una dramatis persona, eroe borghese che trae forza dal «gioco delle azioni e delle reazioni tra la sua sensibilità singola e le cose esteriori». E la nascita del superuomo («e prepariamo nell’arte con sicura fede l’avvento dell’ Uebermensch » ), incarnato ora dal cinico Giorgio Aurispa e in seguito dal dominatore Claudio Cantelmo nelle Vergini delle rocce, il poema metafisico e simbolico del 1895. Il primo, in realtà, avverte sì una imponderabile sete di dominio sulla gente comune, ma ha caratteri contraddittori, tant’è che più che la potenza, mostra tutta la debolezza del suo essere giungendo al suicidio nel tentativo non riuscito di liberarsi dalla schiavitù dei sensi. L’altro, invece, esalta i miti della forza e della razza ed è l’interprete di un’ «oligarchia nuova » nata per governare sui deboli; in lui si materializza l’aspirazione a una grandezza che a quel tempo coinvolgeva la borghesia italiana ed europea. Tutto ciò comporta sul piano della scrittura l’adozione di un dettato ridondante e declamatorio, fuori da ogni schema d’intreccio. Del resto, risulta alquanto improbabile e poco convincente, forse anche per lo stesso d‘Annunzio, la manìa razzistica e antidemocratica di Cantelmo , il suo bisogno di un figlio eccezionale, concepito con una donna altrettanto superlativa, destinato alla conquista della sovranità assoluta. Tant’è vero che il progetto della trilogia del “Giglio” naufragò miseramente lasciando in mente Dei La Grazia e L ‘Annunciazione. L’ideologia superomistica, comunque , si concretizza da questo momento nella creatività dannunziana, dopo essere stata annunciata nella Bestia elettiva del ’92 (“Il Mattino”, 25-26 settembre), l ‘articolo che rivela per la prima volta il contatto di d’Annunzio con Nietzsche: «Le plebi restano sempre schiave e condannate a soffrire tanto all’ombra delle torri feudali quanto all’ombra dei feudali fumaioli nelle officine moderne. Esse non avranno mai dentro di loro il sentimento della libertà (…) Su l’uguaglianza economica e politica, a cui aspira la democrazia socialista e non socialista , si andrà formando una oligarchia nuova, un nuovo reame della forza; e questo gruppo a poco a poco riuscirà a impadronirsi di tutte le redini per domare le masse a suo profitto, distruggendo qualunque vano sogno di uguaglianza e di giustizia ». Parole deliranti, che ritroveremo nel linguaggio di Cantelmo e nelle sue farneticanti elucubrazioni sull’alta dignità della stirpe aristocratica e sovrana.
10. La prosa suadente del Fuoco
Resta, comunque, nelle Vergini delle rocce, la prodigiosa prova dello stile che si cimenta nell’evocazione di una supernatura mitico-fantastica. Ed è ormai il sentiero che porta da un lato alla dimensione teatrale, dall’altro alla giustificazione estetica del superuomo nel Fuoco, il romanzo-saggio sulla Bellezza ove pure il congegno narrativo è pressoché inesistente dietro il flusso della prosa suadente. Avendo come protagonista un artista, è fin troppo evidente l’identificazione dell’autore con il suo personaggio, quello Stelio Effrena che è la proiezione dell’essere eccezionale nato per dar vita all ‘opera immortale, invasato dalla creazione , che accomuna indissolubilmente l ‘Arte con la Vita. L’ingranaggio narrativo è ormai un ricordo lontano e la poesia procede di pari passo con la prosa, mentre d’Annunzio sembra aver realizzato finalmente l‘aspirazione suprema del suo destino di scrittore sperimentale. Egli, tra l’altro, è divenuto a poco a poco l’emblema di una società estetizzante che si riconosce nelle sue idee e le fa proprie, dando vita a un nazionalismo di forte tempra che venera la patria e i diritti della razza latina, che finirà per sostenere la guerra come bagno di purificazione.
11. Il frammento e il diario intimo
Intanto il superomismo trovava ampia attuazione nella produzione lirica e teatrale dei primi del secolo e un ‘ulteriore amplificazione nelle situazioni labirintiche di un ultimo romanzo, il Forse che sì forse che no, meditato fin dal 1907 e apparso nel 1910. Qui la vera novità non sta tanto nella missione di Paolo Tarsis a volare per affermare il suo bisogno di dominio assoluto o nel suo conflitto vittorioso con la lussuria, altro leit-motiv già precedentemente affrontato, né in quell’alone di «modernità» che lambisce i programmi futuristi intorno all’ideologia della macchina; la nuova opera segna invece una vera e propria rivoluzione espressiva che non sarà senza conseguenze per il futuro del d’Annunzio prosatore.
L’artefice della parola, vincendo se stesso, trova incredibilmente la forza di rinunciare ai toni magniloquenti esibiti nelle Vergini e nel Fuoco per approdare a una dimensione più stringata e intima. Il fiume dell’enfasi oratoria perde vigore a beneficio di soluzioni più temperate, mentre persino il tessuto narrativo sembra recuperare una sua identità. Si attestano, insomma, motivi come quelli della confessione e della contemplazione , dello spazio della memoria, del senso di disfacimento delle cose e dell’angoscia che ne consegue, del mistero della morte; elementi che rappresentano una svolta dalla solarità all’ ombra e che conducono «sull’orlo della sintassi del Notturno » (Tropeano).
Si annuncia la grande stagione delle Faville che, a parte i dubbi legittimi sull’autenticità di quanto a esse affidato, rappresentano, nella loro apparente e immediata semplicità, un risultato diverso e sorprendente. D’Annunzio imbocca senza intermediari la strada dell’ autobiografismo, indugiando sulle malinconie dell’esistenza e sulla riflessione artistica, interiorizzando fino all’ estremo limite il fatto letterario, dando così un’ennesima prova della sua infinita capacità di metamorfosi. Attraversando questo tonificante laboratorio, che alterna timbri realistici e visionari, non sorprenderà, dunque, la nascita di opere come la Contemplazione della morte (1912), La Leda senza cigno (1913), fino a giungere ai cartigli dell’ orbo veggente nel Notturno e all’intimità dell’appunto segreto. Egli ormai è entrato nella «Zona d’ombra» dove le cose del mondo si distanziano nel dolce amaro sapore del dolore, attivate dai sogni e dalle allucinazioni dell’ essere immobile, in un’altalena di piani temporali. E laddove il primo d’Annunzio «solare» nominava le cose dando loro corpo in un ampio movimento visivo, quello «notturno» allude e sottintende atmosfere, quando non predilige il silenzio. Il tipo di scrittura «libera» tende all’ essenzialità del frammento, alla notazione rapida, spesso di stile nominale, tra scatti analogici e modulazioni leggere che sottolineano i trapassi subitanei della mente intorno al tema funebre o esitano nel ritmo puro. Scrivere nella «rigidità di uno scriba egizio scolpito nel basalto» acuisce i sensi portandoli a percezioni illimitate che si accordano con la sintassi spezzata, con le cadenze sincopate, attutite, riparate dal sordo fragore. Si sa quanto tutto questo abbia contribuito a individuare nel «commentario delle tenebre» l’antecedente di tanta prosa novecentesca.
Nel Libro segreto, infine, il processo di dissoluzione prosastica giunge al grado estremo mediante la vanificazione della stessa punteggiatura, il non rispetto delle maiuscole, in un assemblaggio solo apparentemente disordinato di materiali di varia estrazione. Nella «cartella di cordovano fulvo» è racchiusa invece tutta la scaltra esperienza dannunziana, dell’uomo afflitto dalla vecchiaia, che tende a vanificare nell’annientamento la persona e nella rarefazione la scrittura, fino quasi a nullificarla del tutto in un grido di morte e di disperata distruzione. Quel diario senza date è il culmine inevitabile di un processo ininterrotto avviato fin dagli anni della giovinezza e che aveva portato allora alla contestazione della solida architettura del romanzo naturalista e via via alla partitura musicale delle prove successive, fino alla distillazione suprema della parola. E d’Annunzio è ora come un artista del suo tempo giunto al segno astratto dopo la macerante insoddisfazione per la corposità della figura.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)