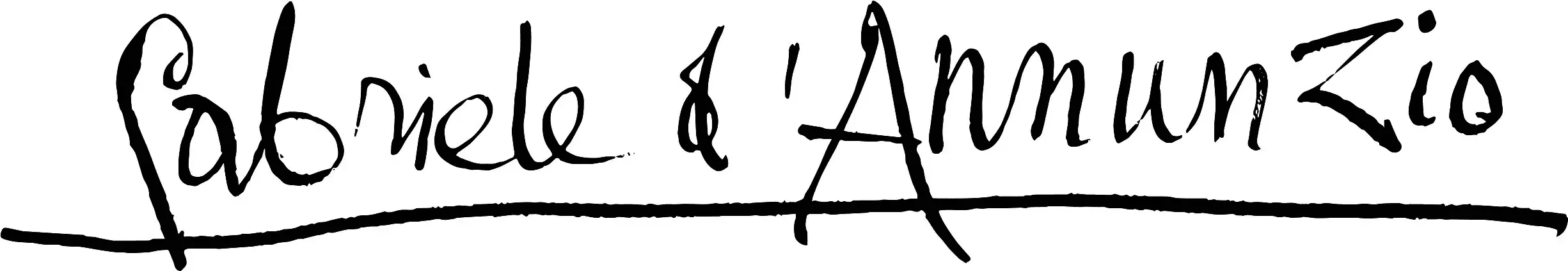di Sandro Gentili, Enciclopedia dannunziana
La fortuna di Angelo Conti
Scrittore, giornalista, critico d’arte e, seppur con minore continuità e con attitudine meno specialistica, di musica e di letteratura, Angelo Conti (Roma 1860 – Napoli 1930) fu oggetto ancora in vita e poi nel mezzo secolo successivo alla sua morte di un giudizio storiografico estremamente limitativo e, conseguente a tale giudizio, di un’attenzione occasionale e spesso pigramente ripetitiva da parte degli studiosi dell’età del Decadentismo, per usare la categoria al tempo onnicomprensiva dei fenomeni artistici della fin de siècle. A partire invece dalla seconda metà degli anni Settanta del Novecento e in sintonia con la meno ideologicamente pregiudicata valutazione di quell’età e in essa dell’opera di Gabriele d’Annunzio, si è registrata una ripresa di interesse per la funzione svolta da quella personalità solo in apparenza marginale e solo in apparenza vivente di luce riflessa. Personalità che infatti di lì a poco, precisamente negli anni Novanta, avrebbe potuto vantare ben tre monografie: di Ricciarda Ricorda, Laura Romani e Giorgio Zanetti; la riedizione di alcune delle opere maggiori, Giorgione, a cura di Ricorda, e La beata riva, a cura di Pietro Gibellini, ormai con la data 2000; e la pubblicazioni di inediti, favorita dal deposito delle carte dello scrittore presso l’Archivio contemporaneo del Gabinetto scientifico e letterario G. P. Vieusseux di Firenze, di cui sono un esempio le lettere date alle stampe da Gianni Oliva e il saggio sul Paradiso di Dante fatto conoscere più di recente da Mario Cimini. Sia nelle monografie e nei numerosi e più circoscritti studi critici in rivista o in volume, sia nelle riedizioni di libri e nelle pubblicazioni di inediti, il rapporto di amicizia e di collaborazione realizzatosi fra Conti e d’Annunzio è stato posto, e talvolta con vigore persino eccessivo, in primo piano; tanto che, per questo più circoscritto settore, sono da addizionare al catalogo appena prodotto gli articoli e le recensioni consacrati all’amico poeta, narratore e tragediografo, ancora grazie a Oliva, e il regesto delle opere dannunziane presenti nella biblioteca di Conti con relative dediche, ancora grazie a Gibellini, che sono andati ad aggiungersi alle lettere di Gabriele ad Angelo raccolte per le cure di Ermindo Campana già nel 1939. E infine giova ricordare il ricco apparato di note dell’edizione delle opere di d’Annunzio nei “Meridiani” Mondadori, in particolare Il fuoco (Niva Lorenzini) ed Elettra (Zanetti), che consente di disporre di un puntuale censimento dei prestiti contiani, o più esattamente, di mettere nel debito risalto l’inestricabile rapporto del dare e dell’avere intercorso fra i due sodali in particolare negli ultimissimi anni del secolo diciannovesimo.
Notizia bio-bibliografica
Il giovane d’Annunzio e Conti, di soli tre anni più anziano e che visse nella capitale dal 1880 al 1892, si erano conosciuti già dai primi anni Ottanta dell’Ottocento (1882) negli ambienti artistico-letterari della Roma bizantina, l’uno più incline alla frequentazione del contesto artistico-letterario riunitosi attorno ad Angelo Sommaruga, l’altro a partecipare alle accese discussioni sull’arte e sulla musica contemporanee del Caffè Greco e del cenacolo In Arte Libertas e progressivamente ad arricchirle con letture di carattere filosofico e più in particolare estetico, da Platone a Kant a Schopenhauer e poi (ma l’elenco dovrebbe essere ben altrimenti nutrito) a Pater, Ruskin, Schuré, Wagner e forse al Nietzsche della Nascita della tragedia; ed entrambi furono perciò largamente presenti nei periodici della capitale. Dopo il biennio fiorentino presso gli Uffizi (1892-1894), a cui si deve un’Introduzione ad uno studio su Francesco Petrarca (1892) orientata in chiave metodologica antipositivistica, Conti si trasferì a Venezia, alle Gallerie dell’Accademia (1894-1896), di cui redasse un Catalogo (1895); e dove riprese a frequentare d’Annunzio (e l’amica Eleonora Duse) dal 1894, anno della pubblicazione della sua maggiore monografia, Giorgione, recensita brillantemente dal poeta sul «Convito» (Note su Giorgione e la critica, 1895), a sua volta cultore d’arte veneziana rinascimentale. Ritornato a Firenze (1896-1901), ebbe un ruolo importante di critico e soprattutto di teorico nel dannunziano-pascoliano «Marzocco», intensificando i contatti con Gabriele allora residente alla Capponcina. L’episodio di maggior rilievo per documentare l’apice del sodalizio è costituito dalla pubblicazione contemporanea, il 1° marzo 1900, presso lo stesso editore, il Treves di Milano, del Fuoco di d’Annunzio, con Conti personaggio, e della Beata riva di Conti, con prefazione di d’Annunzio e con Gabriele interlocutore di Ariele-Conti nei due dialoghi platonici che vi sono compresi: «come se le due opere componessero un dittico» (Gibellini). Secondo che testimonia il pur incompleto epistolario, il rapporto di amicizia proseguì anche durante l’ultimo trentennio di vita di Conti, trascorso prima a Roma, presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti (1901-1904), e poi a Napoli, alla Pinacoteca del Museo nazionale e poi di Capodimonte (1904-1930); ma stancamente, venuti meno, non l’affetto reciproco, ma il diretto commercio intellettuale e la feconda concordia discors dell’ultimo decennio dell’Ottocento; e voltosi il «dottor mistico», dopo due belle raccolte di articoli ancora parzialmente ispirati al culto morale della Bellezza (Sul fiume del tempo, 1907 e Dopo il canto delle Sirene, 1911), a coltivare un’ispirazione e un’aspirazione più propriamente religiose (massima espressione San Francesco, postumo e con prefazione di Giovanni Papini, 1931; ma altrettanto, e anch’essi postumi, Virgilio dolcissimo padre, 1931, e Nel Paradiso di Dante, 2017), che non gli preclusero due ultimi tributi all’arte, la monografia Domenico Morelli (1927) e la prefazione al catalogo della mostra romana di Adolfo De Carolis (1929).
Le recensioni dannunziane di Conti
Gli articoli e le recensioni rappresentano il contributo più oggettivamente accertabile che Conti abbia fornito all’interpretazione dell’opera dannunziana: si susseguono infatti per oltre un quindicennio su varie riviste e quotidiani (1885-1901, con un’appendice negli anni Venti) e si misurano con tutti i generi letterari sperimentati in quell’arco di tempo dallo scrittore: la lirica, la narrazione breve e la narrazione lunga, le pièces teatrali, registrando pour cause un picco di impegno quantitativo e soprattutto qualitativo nel biennio a cavallo dei due secoli (1899-1900). Le prime prove (L’arte a Roma, 1885; Note bibliografiche. «San Pantaleone», 1886; «Isaotta Guttadauro». Le illustrazioni, 1887; A proposito della «Isaotta Guttadauro», 1887) servono al critico per riconoscere e annunciare in d’Annunzio, ed è riconoscimento in seguito indiscusso, «il solo poeta vivente» italiano, l’unico in ogni caso prodotto dalla Roma bizantina, e a giustificare volta a volta il giudizio sul fondamento parnassiano di una raffinatezza alla maniera di Théofile Gautier, sulla sintonia con il dilagante gusto preraffaellita, sul concorso di classico e moderno, garanzia di semplicità di stile e dunque di affinità con «i Greci del tempo antico», stante il carattere metatemporale dello stile stesso. La coppia di articoli del 1889 dedicati a Il piacere (Cronaca d’arte. «Il piacere» e Cose d’arte. Il poema moderno) contengono l’ambizione di redigere un primo consuntivo dell’opera dannunziana e una parallela riflessione sui generi letterari già tentati. Refrattario all’acceso colorismo naturalistico del Canto novo, Conti individua nella strenua ricerca formale dell’Isaotta, sulle tracce della tradizione italiana tre-quattrocentesca, il presupposto della rinascita dell’arte latina, ma non senza dubbi sull’efficacia dello strumento, se la lirica nel corso del secolo si è ammalata di aspirazione insoddisfatta all’ignoto e al mistero: oggi, infatti, «l’arte della parola accenna a concentrarsi tutta nella prosa», scoprendovi quella semplicità necessaria a esprimere il suo contenuto spirituale. Senonché il romanzo, o meglio «il poema moderno», è una forma tuttora in divenire e non sufficientemente determinata: vi è comunque debitamente segnalato l’elemento drammatico, che «tende ad acquisire una così grande importanza in mano alla semplice e nuda osservazione degli avvenimenti umani» e a garantire uno sguardo d’insieme sulla vita. Come appunto nel Piacere, dove l’autore contempla con «tristezza» il male che ha descritto, donde il pronostico e l’auspicio che altri personaggi, temi e generi segneranno in diversa direzione l’opera dannunziana degli anni a venire. Si realizza in questa modalità di lettura una inclinazione, ribadita per anni con crescente convinzione (e nonostante le smentite di fatto ricevute), verso un tipo di critica che vuol farsi collaborazione allo sviluppo in prima istanza morale dell’arte dannunziana. Dopo un lungo intervallo segue il blocco compatto dei tre scritti sulle tragedie e i Sogni teatrali: «La città morta» (1897), «La Gioconda» (1899), I drammi di Gabriele d’Annunzio (1899), blocco di cui fa parte integrante il saggio riservato al genere letterario, Il teatro futuro (1899). Già le recensioni delle due tragedie danno occasione a Conti di manifestare il proprio entusiastico consenso alla nuova scelta formale dell’amico, nella Città morta enfatizzando il processo di interiorizzazione e di umanizzazione dei modelli greci, in particolare del coro e del fato, ma nella fedeltà agli originari rigore stilistico e simmetria strutturale; nella Gioconda insistendo sulla funzione catartica del canto, precondizione della «Tragedia dei tempi rinnovellati». Il dittico saggistico rappresenta nella sua interdipendenza l’elaborazione più persuasa e lucida dell’acquisita convinzione del teatro come forma suprema della poesia e di d’Annunzio come suo rappresentante moderno; mentre il romanzo, «forma letteraria di transizione, nata dal disfacimento del poema epico, non può in alcun modo produrre le opere destinate a proclamare agli uomini le verità eterne». È il teatro, invece, per la sua essenza religiosa, a rivelarle, nel loro legame con la leggenda e il mito, perché esse vivono da sempre nel cuore di tutti e infatti: «L’effetto prodotto in noi dalla creazione estetica consiste sempre in un riconoscimento». Il mito è popolare perché, nato dal popolo, riconduce alla semplicità della natura, possiede la virtù consolatrice, guida verso la purificazione e verso l’innocenza delle cose, ristabilisce l’armonia con il creato. È dunque necessario elevare il teatro alla «solennità di spettacolo religioso» attraverso la ripresa della tragedia greca, come già intuito e realizzato da Wagner e secondo il progetto dannunziano del teatro di Albano (poesia, musica, danza), prima tappa del rinascimento dello spirito latino. In questa prospettiva, a inizio del secondo saggio, è compendiato quanto finora fatto da d’Annunzio e che era stato intuito e preconizzato nel Piacere: «L’idea che domina in tutta la recente opera drammatica di Gabriele d’Annunzio e si manifesta anche nei precedenti suoi libri di prosa e di poesia, è la salvazione e la purificazione dall’errore e dalla colpa, per mezzo del dolore e della bontà semplice e innocente della natura». Sul fondamento di questo concetto morale sono rilette le opere successive al primo e al secondo viaggio in Grecia, luogo nel quale, incontrando la stessa antica vergine natura, il poeta riconobbe come propri maestri i creatori del ditirambo e della tragedia. Così è letto il Sogno d’un mattino di primavera, dove l’immagine della primavera «è la prima apparizione della natura consolatrice del dolore umano, è il primo dono d’oblio che nel dramma d’annunziano la gran madre di tutti offre ai suoi figli sbigottiti e tremanti»; così La città morta, se con l’uccisione di Bianca Maria da parte di Leonardo è sancita «la sconfitta dell’antico destino», cantate «la libertà e la purificazione», pronunciata «la prima parola del dramma rinnovellato», sulla base della tradizione greca dominata dall’elemento epico-lirico, cioè dall’aspirazione al canto, dal ruolo protagonistico del coro, che «nel canto» esala il suo spirito; così il Sogno d’un tramonto d’autunno, in virtù del suo ritmo, correlativo del rapporto armonico con la natura; così la Gioconda, in cui la musica verbale conduce Silvia Settàla alla purificazione finale, tramite la Sirenetta (d’Annunzio meriterebbe perciò la qualifica di «idealista mistico»); così La gloria, dove è il Giovinetto a favorire la redenzione di Ruggero Flamma, ad avviarlo alla percezione della nobiltà della natura e alla visione della verità e della libertà nel momento della morte. D’Annunzio drammaturgo ha dunque ripudiato il teatro realista e romantico, ripristinando la centralità della favola, esaltando il valore dell’«invenzione», per la quale nei nuovi miti è possibile riconoscere la parte più intima della vita e, vedendo proiettato il dolore fuori di sé, godere della catarsi tragica. Un’operazione di rinnovamento che presuppone la devozione alla tradizione e alla natura che vi è rappresentata nella sua semplicità originaria; e «i Greci sono coloro che in tutte le forme artistiche hanno creato le opere più vicine alla natura, e sono perciò e saranno sempre i maestri di tutte le umane generazioni. L’amore e la religione dell’antichità classica è il carattere principale del nostro Rinascimento nei secoli decimoquarto e decimoquinto. Il culto rinnovato della Grecia sarà il principale fattore del rinascimento latino, iniziato da noi da Gabriele d’Annunzio». La riduzione a unità della multiforme opera dannunziana prosegue oltre la rassegna dell’attività teatrale e investe sia il poeta (Nota per le «Laudi», 1899; si tratta del gruppo di Laudi edito in quello stesso anno nella «Nuova Antologia»), caratterizzate in senso non eroico, ma religioso, perché liriche-preghiere la cui divinità è la natura, non la patria; anche se a due anni di distanza («La canzone di Garibaldi», 1901) l’autore è esaltato in chiave epico-lirica, come produttore di un mito moderno e dunque «poeta civile d’Italia». Lo stesso avviene per il nuovo romanzo («Il fuoco» di Gabriele d’Annunzio, 1900), «un’aspirazione e un canto alla speranza immortale», e dunque anch’esso religioso, perché la speranza è conseguita a seguito dell’esperienza del dolore e della colpa e in virtù del ritmo dell’ultimo capitolo, annunzio di una nuova vita rispetto a quella precedentemente narrata. Non per nulla la protagonista del Fuoco è felicemente identificata in Foscarina, ispiratrice di una più alta idea di vita rispetto a quella dell’orgoglioso e voluttuoso Stelio: a significare che l’autore non si identifica con il personaggio, che anzi il primo ha già idealmente percorso i tre stadi in cui avrebbe dovuto articolarsi la trilogia, celebrazione dell’«eternità della natura». D’Annunzio perciò si predispone in questo ultimo libro, come aveva fatto con il primo romanzo e con le tragedie, all’«avvento di un’arte nuova e rinnovellata, semplice e forte: ed io vorrei aggiungere rude e disadorna». Un auspicio costantemente replicato, perché costantemente insoddisfatto.
La recensione contiana di d’Annunzio
D’Annunzio a sua volta aveva recensito, in Note su Giorgione e la critica, la monografia di Conti sul pittore di Castelfranco, presentando uno scambio di ruoli, che replicherà nel Ragionamento premesso a La beata riva, rispetto a quelli già canonici e che poi si troveranno di nuovo assegnati nel Fuoco: è l’artista ad investirsi dell’ufficio di esegeta e a svolgerlo secondo convenzione istituzionale per i primi tre dei cinque paragrafi che compongono lo scritto. Nel primo esamina la dottrina estetica che percorre le pagine dell’amico e anzi, a suo dire, ne costituisce il carattere essenziale, relegato in secondo piano e reso in certo modo strumentale il discorso critico: l’opera d’arte va considerata in sé, come continuazione, non imitazione, della natura, fino a conseguirne la manifestazione dell’intima aspirazione ed essenza, l’idea, attraverso l’opera di selezione e concentrazione dello stile, che ne è il segno perenne e immutabile, dalla Grecia, che lo creò, al Quattrocento italiano, che, riscopertolo, lo assunse come proprio. Nel secondo contestualizza teoria e metodo di Conti, aderendo alla sua rivendicazione di una prospettiva interna e viceversa giudicando illegittime le analisi impostate sulla raccolta sistematica dei dati esterni, siano biografici (Sainte-Beuve) che ambientali (Taine, ma concessogli l’onore delle armi), estensione per analogia del modello scientifico già dominante e ormai in declino, come il corrispettivo artistico-letterario del naturalismo. Il cambio di paradigma autorizza il recensore alla formula congeniale della «critica artifex additus artifici», che, appunto perché opera d’arte richiede quel suggello dello stile, che invece ha fatto difetto al pur possente De Sanctis e lo ha condannato a un rapido declino nonostante la sua corretta disposizione di interprete. E parzialmente la censura stilistica è fatta valere per lo stesso Conti (paragrafo terzo), da cui è auspicata una maggiore limpidezza formale, che dia per presupposte le istanze teoriche e si concentri sull’arte della ricreazione del capolavoro della quale offre un saggio il recensore stesso e nientemeno che su Giorgione; perché a Giorgione non è possibile pensare se non da artifex additus artifici, «senza che ci si riapra nella memoria lo spettacolo d’un fiammeo pomeriggio dell’estate moritura nel silenzio della città dogale». Il quarto paragrafo svolge l’analogia, riuscendo però a un’immagine dell’artista esattamente antagonista a quella di Conti: vitalità, voluttà, insaziabilità, assenza di qualsiasi proposito di ascesi e di oblio; e in ciò «il più profondo rivelatore dell’Anima veneziana» (quinto brevissimo paragrafo, a mo’ di epilogo, sviluppato poi nel Fuoco). Una recensione, in sintesi, che da una parte offre un brillante compendio dell’estetica e del metodo dell’amico; dall’altro non esita a entrare in competizione con il suo scritto, secondo un intreccio di generosità e realistica consapevolezza delle gerarchie che ritroveremo, concretato in dramatis personae, nel romanzo veneziano.
Daniele Glàuro e Angelo Conti nel Fuoco
Nel Fuoco Conti figura come personaggio: e perciò l’opportunità di distinguere questa funzione testuale, gestita accortamente e tendenziosamente dal narratore, da quella di fonte, talvolta dichiarata talaltra dissimulata, di tante pagine del romanzo di carattere filosofico, estetico e storico-critico. Nel primo ruolo Daniele Glàuro, così è ribattezzato, fa la sua comparsa nel momento in cui Stelio Èffrena, il protagonista, si reca al Palazzo Ducale per tenervi la sua orazione; ed è presentato nella veste di «fervido e sterile asceta della Bellezza, con quella sua voce spiritale in cui pareva riflettersi l’ardore bianco e inestinguibile della sua anima che il maestro prediligeva come la più fedele». Religioso cultore dell’Arte, sostenuto dalla «stessa fede con cui il buon sacerdote officia dinanzi all’altare», Glàuro è inoltre apprezzato quale «sottile esegete», tanto che in lui Stelio spesso ritrova «una specie di conscienza rivelativa e nel comento di lui talvolta una illuminazione imprevedibile della sua propria opera», che si forma invece sotto la dettatura dell’ispirazione geniale. In negativo il “dottor mistico” è segnato dallo stigma dell’infecondità, come testimonia l’insistito particolare fisiognomico della «enorme fronte meditativa che pareva gonfia di un mondo non partorito»; e come è dato intendere, per citare un solo episodio, dalla sua incapacità di ascolto e immedesimazione nella melodia naturale di Venezia durante la memorabile passeggiata con l’amico attraverso la città e dopo il soccorso prestato a Wagner malato: «– Hai udito? / – A me non è dato udire quel che tu odi – rispose l’asceta sterile allo spirito geniale. – Aspetterò che tu possa ripetermi la parola che la Natura ti ha detto. / Ambedue tremavano nel loro intimo cuore: l’uno, lucidissimo; l’altro, inconsapevole»; di modo che Daniele è visto vivere di una sorta di ebbrezza riflessa, mediata dall’ispirazione dell’«animatore», da colui che trasforma in realtà i presentimenti dell’altro. A conferma: di fronte alle «invenzioni» della «tragedia nuova» di Stelio «Daniele Glàuro taceva, divinando il tormento dello spirito fraterno, egli che aveva sortito dalla natura il dono di gioire della bellezza ma non di crearla. Muto camminava al fianco del suo fratello, china l’enorme fronte meditativa che pareva gonfia di un mondo non partorito» (con replica del dato figurativo e più manifesta enfasi sul contrasto). Glàuro, dunque, vede attraverso gli occhi di Stelio e accanto a lui sente di «vivere una vita più rapida», perché Stelio insieme al pensiero e all’arte conserva il desiderio dell’azione, mentre Daniele è l’asceta che ha domato il desiderio. E se è vero, infine, che a Daniele è attribuito l’onore dell’annuncio della morte di Wagner e, insieme a Stelio e al gruppo di devoti, del trasporto della bara, è Stelio ad avere «il suo posto a capo», mentre Glàuro lo ha «a piede»», come quel giorno, in cui soccorsero il poeta malato. Per quanto riguarda la seconda e più significativa funzione esercitata da Conti, il contributo tematico e indirettamente stilistico recato al romanzo e in specie alla prima delle sue due parti, L’epifania del fuoco, essa appare paradossalmente molto ampia e al tempo stesso molto limitata. Molto ampia perché le idee di Conti investono tutte le questioni teoriche discusse nel testo, a cominciare dalla definizione di “stile”, soggiacente quella di “idea”, esposta da Stelio e Daniele a proposito delle medaglie del Pisanello e che sottende la comune convinzione dell’esemplarità dell’antico e della sua resurrezione nel secolo quindicesimo, già ben noti al recensore del Giorgione. Il concetto dell’arte come oblio del dolore e superamento della mediocrità e insoddisfazione della vita, su cui Èffrena riflette durante la sua orazione («In quell’ora egli non era se non il tramite pel quale la Bellezza porgeva agli uomini […] il dono divino dell’Oblio. […] Era il sommo beneficio della Bellezza rivelata; era la vittoria dell’Arte liberatrice su le miserie e su le inquietudini e su i tedii dei giorni comuni […]») dichiara a chiare lettere la propria collateralità al Trattato dell’oblìo appena allestito da Conti e a uno dei nuclei fondamentali della sua estetica; così come la capacità dell’arte di abolire l’inganno del tempo, di lacerare, seppur temporaneamente, il velo di Maia, pertiene alla mediazione schopenhaueriana di Angelo, attiva già dal periodo romano. La centralità della musica nel sistema delle arti, intesa come arte notturna e la sola che colga e penetri l’enigma ed esprima la volontà della natura, è anch’essa idea che appartiene al culto schopenhaueriano e wagneriano di Conti; così come le riflessioni sulla drammaturgia wagneriana e sulla tragedia greca e l’unione delle tre arti, poesia, musica, danza, che vi sarebbe essenziale; trattandosi in definitiva della possibilità di un effettivo rinnovamento come recupero dell’antico. Da un punto di vista stilistico, proprio l’accento posto sul valore della musica e del ritmo, della simmetria e della figura della ripetizione, in particolare nel teatro greco e nella strofa, ha indubbiamente contribuito a orientare la prosa di d’Annunzio verso il massiccio uso di questi elementi nella scrittura di romanzo, nel Fuoco in primo luogo, ma anche nelle Laudi giusto allora intraprese. Si dovrà però sottolineare come tutti i dati, che si sono appena forniti, consentono una lettura, se non opposta, diversa: l’idea di stile in Conti ha un sottofondo platonico che non ha in d’Annunzio; l’arte come oblio non è un fine per lo scrittore, ma non più che uno dei mezzi di fascinazione per ottenere il dominio della folla; il wagnerismo dannunziano comporta limitazioni nazionalistiche estranee alla prospettiva universalistica di Angelo; l’esaltazione della musica e della danza, che è di Conti, non è altrettanto di d’Annunzio, dove la preminenza continua a essere affidata alla parola. Nel complesso e volendo risalire alla motivazione di fondo, la si può riassumere confermando quando già detto, che cioè all’attitudine contemplativa dell’uno è addizionato, con tutto quel che comporta a tutti i livelli, un atteggiamento vitalistico e attivistico nell’altro: «Se infatti per d’Annunzio, ad esempio, l’esigenza di uscire dalla torre d’avorio in cui si era rinchiuso l’esteta sperelliano si coniuga immediatamente con un’intenzione propagandistica e con un uso della parola finalizzata alla sottomissione della moltitudine e cioè ad un progetto di potere politico, la via indicata da Conti è decisamente divergente. La bellezza […] è presentata da lui come valore da preservare, proprio per la sua alterità all’esistenza borghese, e da diffondere presso un pubblico il più ampio possibile» (Ricorda). Per concludere, uno sguardo sulle modalità meno canoniche del prestito. In qualche caso il debito è reso esplicito dall’autore, che è, si ricordi, «un io, per così dire, in terza persona» (Raimondi), il che implica anche per Glàuro un’oscillazione fra finzione e realtà biografica. Due esempi che rendono evidente questa moltiplicazione di identità e statuti e il suo significato per il caso specifico: la descrizione di una medaglia di Pisanello, che costituisce «l’esemplare della più esatta espressione», «l’impronta del più alto stile», dell’«anima più schiettamente ellenica di tutto il Rinascimento», che il d’Annunzio autore riserva a Daniele personaggio con destinatario Stelio personaggio, contiene la citazione dell’Angelo Conti autore del Giorgione, ma anche del Gabriele d’Annunzio suo recensore, con traslazione e rispetto dei ruoli della realtà nella finzione; la sequenza sulla diversità fra suono e voce delle cose e sull’essenza della musica individuata nel silenzio che precede e segue i suoni, cioè nel ritmo, derivano dal Conti del «Marzocco» e della Beata riva, ma sono abilmente riadattati (Lorenzini) a danno di Daniele-Angelo: «Quella legge di natura metafisica, enunciata dal contemplatore, confermò a Stelio la giustezza della sua propria intuizione». Da una parte un doveroso e generoso tributo: dall’altra un’assimilazione che tende a diventare un’appropriazione, di nuovo nella priorità conferita all’inconsapevolezza del genio rispetto alla lucidità dell’esegeta. Ma al di là di questa strategia autoriale e di quella di Conti (di cui fra poco), l’intrecciarsi delle citazioni e delle allusioni, in cui confluiscono reciproche letture, sia del già edito che dell’ancora inedito, e scambi di idee consegnati all’oralità e al privato delle discussioni amicali, consigliano di concedere un valore molto limitato agli accertamenti di priorità e alla denuncia dell’eventuale occultamento delle derivazioni.
Ariele e Gabriele nella Beata riva
Conti non volle riconoscersi nel personaggio di Glàuro, come rivela senza reticenze la citata recensione del Fuoco, dove non sono lesinate parole di disprezzo per la propria controfigura romanzesca e per il gruppo dei seguaci dell’Imaginifico, «quei mediocri che lo circondano», e in particolare per Daniele, ridotto a riflesso «della sua anima» e sdoppiamento «della sua coscienza». Rende chiara la rivendicazione del diritto all’autonomia intellettuale il primo dialogo con Gabriele della Beata riva, dove Ariele propone con orgoglio il valore del proprio attivo ufficio nel rapporto amicale, dilatando quello assegnatoli da d’Annunzio di «sottile esegete»: «Poiché tu sai che da parecchi anni io sono il compagno della tua vita, e che molte volte ho avuto la virtù di renderti chiaro ciò che in te si chiudeva nel mistero del sentimento, e che spesso molte imagini da te vedute e fissate col magistero dello stile, hanno dalle mie parole acquistato per te medesimo una più profonda significazione». Questa istanza interpretativa e rivelatrice è mandata a effetto proprio nei due immaginari dialoghi platonici della Beata riva, in cui però trascende il compito esplicito e tende a presentarsi come un’opera di integrazione e orientamento, a non dire di correzione, delle posizioni ufficialmente proprie dell’interlocutore (in ciò, e nell’accezione più estesa, di artifex additus artifici). Nel dialogo del secondo capitolo, a Venezia sulla Riva degli Schiavoni, Ariele conduce Gabriele a riflettere sull’intuizione quale sostanza immediata e reale del pensiero e a mutare l’oggetto dell’arte dalla Vita, dalla celebrazione della «vita intensa e ardente, ricca di piacere e di oblìo…», all’idea platonica, che si manifesta kantianamente nello spazio e nel tempo quando l’artista intuisce e ferma nello stile l’aspirazione, altrimenti frustrata, della natura. Sintetizza infatti il convertito Gabriele: «Lo stile d’una forma naturale non è niente altro che l’imagine fedele, il riflesso immediato della sua destinazione nella natura; e nello stile, che è l’imagine visibile dell’idea, si riflette la sua somma di vita»; e soprattutto aggiunge, a conferma del cambiamento di referente intellettuale: «Hai ragione. L’arte vera è quella che non aggiunge nulla alla natura, ma la rivela nella sua finalità e ne seconda e continua le ardenti aspirazioni di vita. Hai ragione, amico diletto. Anch’io mi sento oggi come te Platone platonior; e t’assicuro che se Claudio Cantelmo ha accolto con entusiasmo la invocazione nietzsciana, ciò è avvenuto unicamente perché la voce di chi scrisse la Natività della tragedia gli parve l’eco fedele della Grecia di Parmenide, d’Empedocle, d’Eschilo e di Platone, verso la quale la sua anima era tesa con impeto di desiderio e con ardore di preghiera, come verso una patria perduta» (con significativa estensione della Grecia di Nietzsche a comprendere Platone e con improbabile palinodia). Nel secondo dialogo, del capitolo quarto, a essere posto all’attenzione è il «fondamento psicologico individuale della più profonda, più limpida e più perfetta visione del mondo e della vita», che è identificato da Ariele nel dominio delle passioni e nella pregressa consapevolezza pessimistica della nullità della vita, storicamente accreditati ai filosofi e ai tragici greci, al buddismo e a Schopenhauer. A fronte dell’immagine (auto)vulgata del poeta della voluttà di vivere, dell’esaltazione dell’istinto e del desiderio e dell’arte prodotte dalla vitalità e dalla gioia, esito della lettura-assimilazione di Nietzsche, Gabriele replica confessando la sua «anima tragica», a cui però lo stesso Nietzsche l’avrebbe condotto, anima che, riversandovisi, si placa nell’opera: «I miei libri, amico mio, non sono, come crede il volgo, la glorificazione della gioia di vivere, ma servono a mostrare in qual modo l’esperienza del male possa essere feconda per l’artista, servono a mostrare che l’uomo non diventa buono e potente se non a condizione d’essere passato a traverso la debolezza e la colpa, e d’aver acquistato un sentimento tragico della vita». Ariele esalta questa prospettiva educativa dell’arte dannunziana, specificando che il saggio la realizza attraverso la consapevolezza filosofica dell’idealità del tempo e dello spazio, mentre l’artista, legato per mille fili al fenomenico, non può raggiungerla che attraverso il dolore, non la gioia e il piacere; donde la critica conclusiva a Claudio Cantelmo e alla sua morale aristocratica ed edonistica. In modo perfettamente speculare all’operazione condotta nel Fuoco da Stelio nei confronti di Daniele, Ariele ha infine convinto Gabriele a essere riflesso «della sua anima» e sdoppiamento «della sua coscienza».
Dopo La beata riva
Preparata dall’intensa collaborazione di fine secolo al «Marzocco», La beata riva realizza la sintesi a sua modo definitiva delle idee sull’arte di Angelo Conti: la sapiente disposizione delle parti, l’accresciuta attenzione alla qualità della scrittura, l’alternanza tonale, dal discorsivo al lirico al sublime, il confronto con tutti insieme i propri autori di riferimento, confronto ricco e mai dissimulato, la fedeltà ai nuclei tematici essenziali della propria riflessione, oggetto di uno scavo ininterrotto, rappresentano il blasone di nobiltà del trattato. Vi trovano la compiutezza compatibile con un pensiero che non vuole, forse non sa, essere rigidamente sistematico: il rapporto natura e arte, nei modi che si sono visti; i concetti della meraviglia, idealmente fanciullesca, come precondizione della conoscenza intuitiva, che è la vera conoscenza delle cose; della musica quale oggetto di tensione per tutte le forme artistiche; della tragedia, il genere che permette di fondere le arti che si svolgono nel tempo; della poesia, nel suo significato più estensivo, che produce il contatto diretto con la verità fuori del tempo e dello spazio e quindi l’oblio del contingente e il contatto, sia pur momentaneo, con l’eterno, e dunque corrispettivo della preghiera; in calce, inserita in extremis in un’appendice, la registrazione del progressivo fascino liberatorio esercitato dal dionisiaco rispetto al giovanile culto dell’apollineo. Sono sufficienti i giudizi che abbiamo letto su d’Annunzio a caratterizzare questa forma di estetismo in chiave morale: il culto della Bellezza non comporta in alcun modo finalità praticistiche, di fascinazione e di conseguente dominio; né presuppone un destinatario aristocratico e antidemocratico: pur sapendo che «il suo è un libro per happy few», Conti sa altrettanto bene che essi devono essere «selezionati non dalla raffinatezza del gusto o dalla spregiudicatezza, secondo moduli decadenti o superomistici, ma dall’affinità elettiva, dall’educazione sentimentale e soprattutto dalla laboriosa disposizione conoscitiva» (Gibellini). Dopo questo momento di massima concentrazione, l’attività del «dottor mistico» si fece meno intensa, ma in compenso più rispondente al nom de plume giovanile e alla sua vocazione forse più genuina: una volta riproposti gli articoli del periodo in particolare marzocchino, di cui sopra, essa si rivolse senza esitazioni verso la religione e fu una scelta radicale di purificazione e di rinuncia. In questa chiave andrà letto il trittico di libri postumi, con buona approssimazione concepiti e scritti tra il 1921 e l’anno della morte, Nel Paradiso di Dante, Virgilio dolcissimo padre e San Francesco, dove la critica, e sia pure di artifex, è deposta e la stessa poesia confinata a esperienza di un passato non rinnegato ma trasceso: «Ma qui ci sia concesso d’affermare che anche l’arte può essere superata. Diciamo dunque addio a questa nobile attività dello spirito, che ci ha rapiti per tanti anni, alla creatrice di tanti capolavori, alla divina consolatrice che vinse in noi il dolore tante volte nella nostra vita e ci liberò dalla illusione del tempo. Non trovo ancora le parole per esprimere i nuovi sentimenti che possono prendere il posto suo ed aiutarci nel cammino verso un’idea più alta, verso una vita più serena. Le troveremo, parlando di S. Francesco». E furono parole senza equivoci, sulla «felicità della non esistenza», sull’attrazione per «quella che i mistici chiamano la notte profonda, l’oscurità senza fine», sul paradiso da immaginare negativamente, come assenza, sull’io da annullare nel tutto. Ma se così effettivamente fu, non risulterà una mera curiosità notare che in nessuno dei volumi della trilogia della senilità difetta un riferimento a d’Annunzio, al suo d’Annunzio buono: in San Francesco la condizione spirituale per ricevere e godere il messaggio del Santo è quella suggerita dal poeta, che ha avuto il coraggio di sentirsi lebbroso, collocando a capo del suo letto il quadro «che rappresenta S. Francesco e il lebbroso, nel quale ha voluto che il volto fosse il suo ritratto»; in Virgilio dolcissimo padre è collocato il ricordo di una giornata trascorsa insieme all’amico Alla foce del Tevere, luogo che per l’incuria degli uomini ha perduto l’antico fascino, ma di cui la lettura dell’Eneide e il volo di un popolo di allodole che si perde nella luce e nel silenzio del cielo trasformano la tristezza in beatitudine; Nel Paradiso di Dante accoglie in appendice un articolo, La religione di Dante (1900), che riconosce nella lectura dannunziana dell’ottavo canto dell’Inferno (1900) «uno fra i primi atti e fra le prime parole del nuovo culto e della nuova religione di Dante», ben altrimenti significativi dell’ammirazione estetica. Nella configurazione ultima della sua riflessione sulla vita Ariele ha avuto cura di conservare e rendere pubblica l’impronta che vi aveva impresso il dialogo con Gabriele.
Bibliografia essenziale
Angelo Conti, Giorgione, Firenze, Fratelli Alinari editori, 1894 (a cura di Ricciarda Ricorda, Novi Ligure, Città del silenzio edizioni, 2007).
Angelo Conti, La Beata Riva. Trattato dell’oblìo preceduto da un Ragionamento di Gabriele d’Annunzio, Milano, Treves, 1900 (a cura di Pietro Gibellini, Venezia, Marsilio, 2000).
Angelo Conti, Virgilio dolcissimo padre, Napoli, Ricciardi, 1931. Angelo Conti, San Francesco, opera postuma preceduta da un saggio di Giovanni Papini e da una nota bio-bibliografica, Firenze, Vallecchi, 1931.
Angelo Conti, Nel Paradiso di Dante, a cura di Mario Cimini, Roma, Salerno, 2017. Gabriele d’Annunzio, Il fuoco, note di Niva Lorenzini, in Prose di romanzi, volume secondo, edizione diretta da Ezio Raimondi, a cura di Niva Lorenzini, introduzione di Ezio Raimondi, Milano, Mondadori, 1989, pp. 195-518, 1176-1314.
Gabriele d’Annunzio, Note su Giorgione e la critica, in «Il Convito», gennaio 1895, ora in Scritti giornalistici, volume secondo, a cura e con una introduzione di Annamaria Andreoli, testi raccolti da Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2003, pp. 287-311.
Gabriele d’Annunzio, Elettra, note di Giorgio Zanetti, in Versi d’amore e di gloria, edizione diretta da Luciano Anceschi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 1984, pp. 253-409, 995-1143.
Gabriele d’Annunzio, Carteggio con Angelo Conti, a cura di Ermindo Campana, in «Nuova Antologia», 1° gennaio 1939, ristampa: Roma, Tipografia Medaglie d’oro, 1985.
Sandro Gentili, Trionfo e crisi del modello dannunziano. «Il Marzocco» – Angelo Conti – Dino Campana, Firenze, Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 1981.
Sandro Gentili, Capitoli di storia della critica letteraria dell’Ottocento e del Novecento, Firenze, Cesati, 2023.
Gianni Oliva, I nobili spiriti. Pascoli, D’Annunzio e le riviste dell’estetismo fiorentino, Bergamo, Minerva Italica, 1979.
Gianni Oliva, D’Annunzio e la poetica dell’invenzione, Milano, Mursia, 1992.
Ricciarda Ricorda, Dalla parte di Ariele. Angelo Conti nella cultura di fine secolo, Roma, Bulzoni, 1993.
Laura Romani, Il tempo dell’anima. Angelo Conti nella cultura italiana tra Otto e Novecento, Roma, Studium, 1998.
Giorgio Zanetti, Estetismo e modernità. Saggio su Angelo Conti, Bologna, il Mulino, 1996.