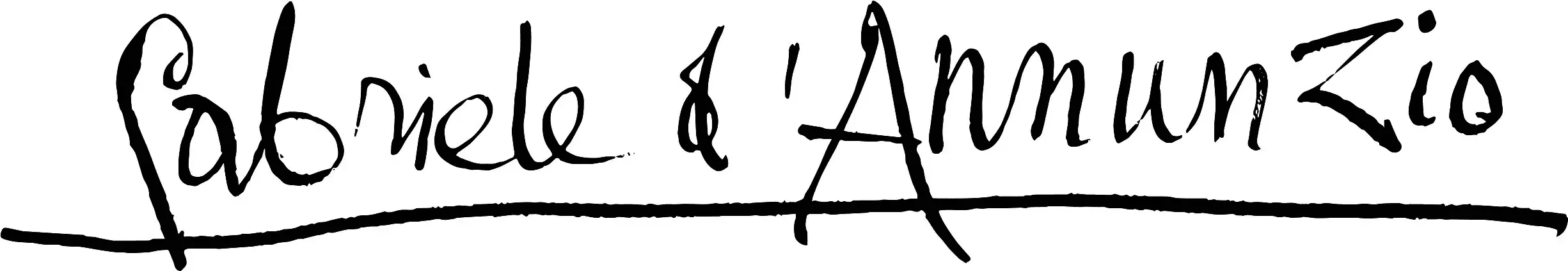di Simone Di Valerio, Enciclopedia dannunziana
Un profilo generale. La ricerca archivistica
Arnaldo Ferraguti (1862 ‒ 1925) fu un artista poliedrico a cavallo tra Otto e Novecento, ma viene spesso ricordato soprattutto per le sue doti di pittore, incisore e illustratore. In tali vesti collaborò anche con Gabriele d’Annunzio in più occasioni, tra le quali occorre sicuramente ricordare quella dell’allestimento scenico per la tragedia pastorale La Figlia di Iorio nel marzo 1904, chiamato su iniziativa e in soccorso di Francesco Paolo Michetti, che li aveva già fatti incontrare vent’anni prima, e del quale il pittore più giovane era stato seguace e rimase per sempre amico. D’altronde era stato lo stesso Michetti a introdurre Ferraguti presso la casa editrice Treves, per la quale era diventato in breve tempo l’illustratore di punta, lavorando per i numeri de «L’Illustrazione Italiana» e disegnando le immagini per i volumi degli autori più importanti. Così ebbe anche modo di conoscere e sposare Olga Treves, nipote dei fratelli editori Emilio e Giuseppe, figlia del loro fratello maggiore Enrico, con la quale diede alla luce Mario, Alessandro e Renata.
I rapporti tra Gabriele d’Annunzio e Arnaldo Ferraguti sono ben documentati dal carteggio tra loro intercorso, oggi conservato negli archivi della Fondazione del Vittoriale degli Italiani. La corrispondenza abbraccia un periodo di tempo che dal 1893 si protrae fino al 1918: le lettere di pugno del poeta appartengono alla cartella denominata «Ferraguti, Arnaldo», numero di inventario 23138 – 23146 dell’Archivio Personale; le missive inviate da Ferraguti sono nella cartella denominata «Ferraguti, Arnaldo – XXVIII» dell’Archivio Generale, e sono per la maggior parte telegrammi. Tuttavia, durante recenti ricerche d’archivio, grazie a un riferimento ritrovato proprio all’interno di questa busta, sono state rinvenute lettere fino ad allora inedite, dal contenuto dirompente, che sua moglie Olga indirizzò al Vate. Le lettere «occulte» rivelano che Olga Treves Ferraguti e d’Annunzio furono amanti, e questo legame, rimasto sconosciuto a lungo, ha permesso di fare luce su altri episodi della vita di entrambi, a cavallo tra 1903 e 1904. Da esse, per esempio, emergono il ruolo di un d’Annnunzio sensale matrimoniale per l’amico Annibale Tenneroni nel 1903, e dettagli sulla terza ed ultima maternità di Olga, quella di Renata Ferraguti nata nel 1904, ambiguamente omonima dell’unica e amatissima figlia riconosciuta dal poeta e avuta dalla relazione con Maria Gravina (Di Valerio 2023). Una passione che il Vate consumò dunque presumibilmente alle spalle di Arnaldo, a dispetto della complicità e della disponibilità mostrategli da quest’ultimo per il già citato allestimento della Figlia di Iorio in quello stesso 1904, quando, tempestivamente chiamato a far parte dell’impresa, il pittore prestò la sua opera di scenografo, contribuendo ad evitare una catastrofe finanziaria per le casse della produzione. Si è comunque portati a credere che il marito inconsapevole s’imbarcò in quell’impresa non tanto per riconoscenza e per devozione verso l’Imaginifico, o verso Michetti, quanto per l’irriducibilità del suo temperamento, per saziare quell’appetito di avventura e di sfida all’ignoto che sembra aver contraddistinto tutta la sua esperienza. Che fu appunto non solo di artista, con all’attivo esposizioni internazionali, o di disegnatore della più importante rivista illustrata italiana di quel periodo, ma anche di inventore prolifico e riconosciuto, e infine pure di capitano d’industria capace, se venne chiamato, negli anni Venti, a dirigere la fabbrica di un materiale (la cosiddetta pergamenoide) da lui sintetizzato in precedenza.
Gli esordi. Il debutto per la casa editrice Fratelli Treves (1862 ‒ 1893)
Arnaldo Ferraguti (1862 ‒ 1925) nacque a Marrara, frazione di Ferrara, ma presto si trasferì con la famiglia a Napoli dove, dopo studi tecnici, frequentò l’Accademia di Belle Arti dal 1879 al 1882. Prese così parte all’esposizione cittadina del 1880 con il quadro Alhambra. Funerali di un emiro, dal titolo e dal gusto chiaramente ispirati all’esotismo del maestro Domenico Morelli, allora insegnante proprio presso l’Accademia. L’esposizione decisiva per la sua vita e per la sua carriera fu però quella tenutasi a Roma nel 1883: partecipandovi, ebbe l’occasione di incontrare Francesco Paolo Michetti, Giulio Aristide Sartorio e Costantino Barbella, anch’essi in mostra, con i quali entrò subito in sintonia, subendo il fascino dell’ideale della fusione tra tutte le arti, da Michetti propugnato e praticato. Arrivò addirittura a trasferirsi per un periodo a Corfinio (AQ), in Abruzzo, alla metà degli anni Ottanta, per seguirne da vicino l’esempio. A questo periodo risalgono alcuni dipinti di scene di genere in cui è evidente l’influsso dell’arte del maestro. Si veda nello specifico il gruppo di sette studi di teste (1885 ‒ 1895) che riprende quanto il pittore abruzzese già da tempo andava ritraendo: volti, soprattutto di donna, tratti dal mondo contadino e resi sulla carta attraverso la tecnica del pastello, impiegata per ottenere contorni e sfondo non definiti in modo da evocare l’immediatezza della ripresa (Rebora 2006, p. 92). Ferraguti prese parte alle riunioni del cenacolo di intellettuali ed artisti nel convento di Santa Maria Maggiore a Francavilla al mare (CH), ed è qui che, con molta probabilità, incrociò per la prima volta Gabriele d’Annunzio.
La figura di Michetti rimase poi sempre centrale nel rapporto tra i due: il «Nostro», come lo indica l’artista ferrarese in una lettera del 1912 indirizzata al Vate, fu importante anche per le carriere artistiche di entrambi. Come infatti fece nel 1885 per d’Annunzio, quando, insieme a Matilde Serao, ne propiziò l’incontro con l’editore Emilio Treves, ugualmente, qualche anno più tardi, si spese in favore di Arnaldo Ferraguti. Questi, nello stesso 1885, era riuscito ad aprire un atelier personale nella natìa Ferrara, realizzando specialmente ritratti su commissione, ma continuava a fare la spola tra la città estense e la Roma bizantina di quel finire degli anni Ottanta, un effervescente centro culturale alle cui lusinghe, per un artista, era difficile sottrarsi. I ritratti realizzati presentavano l’utilizzo di uno sfondo neutro, privo di qualsiasi caratterizzazione ambientale, una tecnica tesa a mettere in primo piano la fisionomia e la psicologia del soggetto raffigurato, che agli esordi fu spesso un membro della sua famiglia: si vedano Ritratto di Emma Ferraguti Daneo (1885 circa), Ritratto di Gualtiero Ferraguti (1882), suo fratello, e Ritratto di Carlo Ferraguti (1880 ‒ 1885 circa), suo padre (Rebora 2006, p. 86). Sempre più calamitato dall’Urbe, ma soprattutto dall’ambiente delle campagne circostanti, all’epoca prese d’assalto da una schiera di impressionisti da tutta Europa, Ferraguti alla fine si trasferì in una comune di pittori insediatasi nel paese di Anticoli Corrado (RM), con i quali abitò anche Sartorio, sua vecchia conoscenza. Il paesaggio e la popolazione locali gli ispirarono l’imponente Alla vanga (1890), tela dal forte sapore verista per la quale viene maggiormente ricordato anche al giorno d’oggi. Esposta alla Prima Triennale di Brera del 1891, il soggetto della tela si rifà al tema del lavoro nei campi, importante nella pittura del realismo europeo del secondo Ottocento, diffusosi dalla Francia di Courbet in tutta Europa. Nel dipinto si nota come la distribuzione in diagonale delle figure dei contadini, tutte immortalate nell’atto di dissodare il terreno, favorisca «l’accentuazione enfatizzata del reiterarsi del gesto», ma, essendo «tutte estremamente caratterizzate e tipizzate», non vengono comunque pregiudicati «la loro perfetta leggibilità e […] il dato narrativo e descrittivo» (Rebora 2006, p. 110). Ciò a dispetto della «comune gamma cromatica che arrossa i volti e i corpi», nella tavolozza di Ferraguti che si componeva dei colori puri utilizzati da Michetti, dal quale mutuò inoltre la tecnica di accostare «ampie stesure» con «parti risolte con pennellate più frammentate […] e a pigmenti sovrapposti (Rebora 2006, p.111). In definitiva, in Alla vanga, queste figure di contadini risultano stagliarsi
tra la tersità del cielo, dalla pennellata più distesa e compatta, e i primi piani a colori più corposi, con ocre, bruni e tonalità rossastre, stesi a rendere quasi fisicamente la matericità e la tattilità della terra dissodata (Rebora 2006, p. 111).
A trarre d’impaccio l’artista dai contrafforti dell’Appennino centrale, per catapultarlo nell’ «atmosfera di Banche e di Imprese Industriali» meneghina, fu appunto Michetti che, come si era già speso per d’Annunzio, introdusse anche Ferraguti nella casa editrice Treves: nel 1889, così, uscirono alcuni suoi bozzetti sull’ «Illustrazione Italiana». Fu l’inizio di una collaborazione destinata a cambiare la carriera, e in primis la vita, del pittore, che comunque in quegli anni aveva partecipato ad esposizioni nelle più importanti città italiane, nonché a Monaco e a Vienna. In merito alla carriera, già nel 1890 ebbe l’incarico di illustrare Sull’Oceano di Edmondo De Amicis, imbarcandosi su un piroscafo di emigranti verso il Nuovo Mondo per realizzarne gli studii preparatori: 191 tavole, sapientemente pubblicizzate sulle riviste di casa Treves, che gli valsero il primato tra gli illustratori dell’intera scuderia. In merito alla vita privata, grazie al nuovo impiego, conobbe la sua futura moglie, Olga Treves (1873 ‒ 1945), nipote di Emilio e di Giuseppe, figlia dell’avvocato Enrico; la sposò il 16 aprile 1891, mentre la sua lanciata attività di illustratore per la tipografia «di famiglia» gli permise di collaborare all’ennesima riedizione del deamicisiano Cuore del 1892, di nuovo al fianco di Sartorio.
«Un libro d’ambientazione siciliana» (1893)
Sotto contratto con la casa editrice figurava anche Giovanni Verga: agganciato durante qualche ricevimento in casa dei potenti fratelli Treves, ai quali piaceva riunire attorno a loro il bel mondo culturale e gli scrittori più fedeli, Ferraguti, acceso d’ambizione e di fede nel credo verista, riuscì ad impetrare dallo schivo scrittore isolano il permesso di illustrare una nuova edizione della raccolta Vita dei campi, in vista della quale intraprese un avventuroso viaggio in Sicilia nell’autunno 1892, con lo scopo di trarne studii di assolate piazze metafisiche e polverosi fichi d’india (Pasquini 2021; sull’epistolario tra il pittore e Verga si veda anche Raya 1986). L’edizione uscì poi solo nel 1897, ma Ferraguti fu sul punto di ripetere la trasferta a Palermo e dintorni pochi mesi dopo il suo rientro. Su questo progetto vertono infatti le prime lettere pervenuteci del suo carteggio con d’Annunzio: agli inizi del 1893, i due si concertarono circa l’ideazione di un non meglio precisato «libro d’ambientazione siciliana», forse sull’onda del successo della Cavalleria rusticana di Mascagni, basata proprio su una novella presente in Vita dei campi. Trattarono con l’editore Giulio Ricordi, non con Treves, che all’epoca non intratteneva buoni rapporti né con d’Annunzio, già trasferitosi a Napoli, al quale aveva opposto un netto rifiuto per la pubblicazione dell’immorale L’Innocente, né con Ferraguti, forse per l’eccessiva intraprendenza con la quale questi aveva braccato persino Verga. D’Annunzio si prodigava per sapere «ciò che Ricordi vuol pagare la parte letteraria» (lettera del 13 gennaio 1893), ovvero la sua, col desiderio di visitare la Sicilia in aprile, insieme con Ferraguti e coinvolgendo magari anche Sartorio, quando «sarà tutta un giardino fiorito» (lettera del 21 febbraio 1893), visto che «il principio della primavera e poi lo scoppio quasi furioso di tutte le fioriture sono in Sicilia oltremirabili» (lettera del 19 gennaio 1893). Ma faccia attenzione Ferraguti: «in Sicilia la vita non è a buon mercato per i forestieri» (lettera del 21 febbraio 1893), lo ammoniva il poeta, e quindi era forse il caso di indurre Ricordi ad allargare i cordoni della borsa di più che per le sole mille lire proposte come risarcimento per la trasferta. E come ultima, ma non meno importante raccomandazione, il Vate incaricava il suo collaboratore che, nel caso di conferma da parte dell’editore, gli facesse «avere sollecitamente dal Ricordi l’anticipazione» (lettera del 21 febbraio 1893). Forse non la vide mai, e non a caso, lo stesso giorno in cui faceva questa richiesta a Ricordi tramite l’amico, iniziò a riallacciare i rapporti con Emilio Treves, inviandogli una lettera.
La svolta leonardesca: «L’artifiziosa pergamena» (1902 ‒ 1903)
Il primo tentativo di collaborazione tra d’Annunzio e Ferraguti dunque fallì, e le loro carriere, prima che si rincrociassero, li portarono a fare esperienze nei più disparati campi, confermando l’estro e la poliedricità di entrambi: d’Annunzio nell’ultimo decennio del secolo fagocitò ogni genere letterario, confermandosi nel romanzo, debuttando sul palcoscenico e proiettandosi verso la poesia degli anni futuri. Ferraguti, fallito il suo tentativo di emancipazione dalla ditta di famiglia, tornò ad illustrare per questa i volumi dei suoi autori di punta, le Novelle di De Amicis (1893), I Fiori di Pietro Gori (1894), I Naufraghi del Poplador (1895) di Emilio Salgari, i nuovi romanzi di Virginia Tedeschi Treves, moglie di Giuseppe, in arte Cordelia. Nello stesso periodo, non mancò di partecipare a nuove esposizioni, alle quali inviava soprattutto pastelli e dipinti a olio, in Italia ed in Europa, a Berlino e a Monaco (1897) dove espose i pastelli dell’illustrazione di Vita dei campi. Forte di questi successi, ritrovò lo slancio perduto e la voglia di indipendenza: a metà degli anni Novanta, emulo degli zii acquisiti, comprò un terreno e costruì una villa sulle rive del Lago Maggiore, in quel di Pallanza, sponda verbanese, dove pullulavano le case di villeggiatura dell’alta borghesia lombarda; la costruì nella stessa strada litoranea della collina della Castagnola, su cui si affacciava Villa Cordelia di Giuseppe Treves. I bei sogni in vista del lago durarono però poco: già nel 1900 Villa Olga, come era stata chiamata in onore della moglie, venne venduta ad altri proprietari per ripianare la situazione economica. Negli anni a cavallo tra i due secoli, infatti, Ferraguti ebbe una svolta leonardesca, o michettiana: accantonato il lavoro artistico, limitandosi a collaborare solo all’ «Illustrazione Italiana», si dedicò agli studi chimici e realizzò prima, nel 1894, un fissativo per pastelli, il cui brevetto fu comprato dalla Lefranc e commercializzato; poi, all’inizio del Novecento, sintetizzò un nuovo materiale, la «pergamenoide», un finto cuoio. Tale invenzione è al centro di altre lettere del carteggio con Gabriele d’Annunzio: nell’estate 1902, questi, sulle orme del Sommo Poeta, ospite del castello di Romena, si trovava nel pieno parto creativo del futuro libro di Alcyone, e scriveva anche parte di Elettra; così, «corso da continui ruscelletti più o meno danteschi di poesia» (lettera del 25 luglio 1902), rispose forse all’invio di un campione del nuovo materiale creato da Ferraguti, e la decisione fu presto presa. Il «libro sacro», e cioè, a scanso di equivoci, le stesse Laudi, sarebbe dovuto «escire alla luce» nelle fasce di quella «artifiziosa pergamena», che lo conquistò al punto che avrebbe voluto averla «per cute naturale per almeno sei mesi dell’anno» (lettera del 25 luglio 1902). Nella stessa lettera, si congratulò con l’amico pure per i suoi disegni della novella L’Eroe, definendoli «ottimi», sebbene «mal riprodotti». Il racconto ‒ un episodio di fanatismo religioso da parte di un contadino abruzzese, che sfocia in un atto di autolesionismo ‒ già apparso nella raccolta San Pantaleone (1886), venne infatti pubblicato nel luglio 1902 sul secondo numero della nuova rivista mensile di casa Treves, «Il Secolo XX», accompagnato da tre illustrazioni realizzate proprio da Arnaldo Ferraguti. Come informa la nota introduttiva alla novella, in quegli stessi giorni L’Eroe veniva inoltre pubblicato nel primo volume delle Novelle della Pescara, sempre per i tipi Treves: quindi la contestuale stampa illustrata su rivista era chiaramente un’anticipazione offerta ai lettori per promuovere l’intero volume. Il poeta tenne fede alla promessa, informò subito Pepi, alias Giuseppe Treves, della pergamenoide e questa volta la collaborazione con il pittore e inventore ferrarese dovette andare a buon fine: così in una lettera del 22 dicembre 1903 d’Annunzio lo ringraziò, salutandolo come «l’amico che ha messo in fasce il mio neonato» e augurandosi che il suo cervello continuasse con «molte scintille inventrici». E scrisse di aver mandato insieme alla missiva un regalo a donna Olga, «l’Acqua Nunzia che le promisi»: dovrebbe trattarsi del profumo che, secondo le più autorevoli biografie del poeta, il Vate avrebbe realizzato in omaggio a Giuseppina Mancini, amante degli anni 1907 – 1908 (Andreoli 2000, p. 422). Facendone però dono già nel 1902 ad Olga Treves, si intuisce che la creazione deve essere retrodatata e non può essere riferita al periodo della relazione con Amaranta – Mancini, quando decise di commercializzarla per trarne profitti.
L’Odissea di un allestimento scenico (1904)
Delle «scintille inventrici» dell’amico ferrarese d’Annunzio si servì ancora, dopo un nuovo parto creativo propiziato da un’altra estate feconda, quella subito successiva del 1903, quando, dimorando con la Duse e la figlia Renata nella villa Borghese di Nettuno, compose la tragedia pastorale La figlia di Iorio, dandone tempestiva notizia al Michetti, già autore del dipinto omonimo. Questi, come al solito, fece da tramite tra d’Annunzio e Ferraguti: incaricato dal poeta di curare l’allestimento dell’opera sul palcoscenico sin dall’autunno del 1903, in un colloquio avuto con lui a Roma nel gennaio 1904, gli fece espressa richiesta di coinvolgere anche il pittore ferrarese esperto dei costumi abruzzesi, per riuscire a completare il lavoro nel poco tempo rimasto a disposizione. La tragedia doveva necessariamente andare in scena entro il mese di marzo 1904, pena «una catastrofe finanziaria irrimediabile», così come precisò lo stesso d’Annunzio a Ferraguti nelle lettere e nei telegrammi concitati che gli inviò per proporgli la partecipazione all’allestimento. Il Vate si aspettava un «generoso consentimento» in nome della sua «amicizia e dell’«amore per il vecchio Abruzzo» (lettera del 19 gennaio 1904). E difatti Arnaldo partì subito per «raggiungere senza indugio Ciccillo a Francavilla» (telegramma del 19 gennaio 1904). Una volta ritrovatisi presso il convento della località costiera, Michetti e Ferraguti si diressero poi insieme al mercato di Chieti ed è facile immaginarseli mentre, intabarrati, interrogarono rabdomanticamente i manufatti esposti dagli ambulanti teatini, concertandosi tra loro se il materiale in rassegna fosse abbastanza etnico, simili a due europei del tempo in gita tra le bancarelle del suk di una qualsiasi meta esotica che avesse anche solo un vago odore di orientalismo. Così, recando molte casse stipate di oggetti, abiti, vasellame, tappeti e disegni per l’allestimento, all’inizio di febbraio i due pittori tornarono a Milano, in vista della prima della tragedia; ma Michetti vi giunse influenzato e stette con Ferraguti chiuso in albergo per quattro giorni in attesa di guarire. Sotto le pressioni di d’Annunzio, i due partirono comunque per Verona, dove li raggiunse da Roma lo stesso poeta, essendo il Teatro Drammatico della città scaligera il quartier generale della compagnia Talli: lì ebbe modo di incontrare Michetti ancora malato e così il giorno 7 febbraio il febbricitante fu pietosamente rispedito a casa su un convoglio diretto a Francavilla. Michetti però non si diede per vinto, continuò a collaborare all’allestimento da remoto, come testimonia una sua lettera del 21 febbraio proprio a Ferraguti, dove scrisse di avergli mandato un abito da donna e gli oggetti da fusaro, dovendo ancora inviare alcune ceste e diversi berretti (Di Tizio 2002) Il lavoro sul campo rimase tutto nelle mani di Ferraguti, che, nel linguaggio ellittico del telegramma, fece sapere a d’Annunzio di essere «incerto aratro forma antica», ma lo rassicurava: «però cerco scrivo» (telegramma del 12 febbraio 1904). Alla fine le cose andarono per il meglio: La figlia di Iorio debuttò al Teatro Manzoni di Milano il 2 marzo, portata in scena dalla compagnia di Talli, in prima fila si ritrovarono Ferraguti e Michetti, e l’opera fu un successo di pubblico e di critica. A maggio l’artista ferrarese pubblicò così sulla rivista di casa Treves «Il secolo XX» un resoconto dell’esperienza vissuta dal titolo proverbiale, L’Odissea di un allestimento scenico, dando saggio di una scrittura narrativa affabile e brillante, in cui rievocò le peripezie vissute non senza un velo di bonaria ironia (Ferraguti 1904).
L’ultima collaborazione e la fase imprenditoriale (1908 ‒ 1925)
Il 1904 fu un anno anche di notizie tristi, venendo a mancare (il 5 settembre) Giuseppe Treves: il lutto fu acuito, per la coppia Ferraguti, dal fatto che nel testamento del defunto non ci fosse neppure un saluto nei loro confronti, segno che forse il rapporto personale tra Arnaldo e i fratelli editori si era nel tempo deteriorato, proprio per la spiccata indipendenza e spregiudicatezza delle iniziative personali dell’artista. Che tentò di nuovo allora, all’indomani della scomparsa dell’influente Giuseppe, la via dell’affermazione individuale: nel 1905 entrò in società con una banca per dare vita ad una fabbrica di pergamenoide. Dedicandosi al sogno di diventare capitano d’industria, smise anche di dipingere, o quantomeno di esporre, partecipando per l’ultima volta ad una kermesse del genere nel 1908. Anno che si dimostrò fatale, se poi in quell’inverno fu costretto a dimettersi da direttore tecnico e chimico della fabbrica, per salvarsi dai debiti accumulati. E così mestamente tornò tra gli illustratori di casa Treves, e della circostanza ci dà appunto conto l’ultimo contatto documentato avuto con d’Annunzio. In una lettera datata 19 aprile 1908, porgendogli gli auguri di buona Pasqua, il poeta si disse «lietissimo della proposta» e di affrettare «coi voti il compimento», auspicando «alla […] mano una nuova potenza»: dovrebbe questo essere un riferimento alla nuova edizione delle Novelle della Pescara, uscita in quell’anno (1908) e illustrata da Ferraguti e da Gennaro Amato, un altro artista della scuderia Treves. Ma il pittore ferrarese non si era dato ancora per vinto: nel 1911 si svincolò definitivamente, fondando la ditta «A. Ferraguti (Telio)» per il commercio dell’«artifiziosa pergamena», cessando per sempre anche la sua attività di illustratore.
Nel 1916 morì Emilio Treves, e la casa editrice passò nelle mani di Guido, il fratello di Olga; frattanto Arnaldo continuava con le sue ricerche di laboratorio che, nel primo dopoguerra, si volsero a contrastare gli effetti delle armi chimiche sui reduci dalle trincee, tra i quali c’era anche il figlio secondogenito Alessandro (1896 ‒ 1971), che soffriva di «nevrastenia di guerra», come scrisse Olga a d’Annunzio (lettera del 2 agosto 1924).
Negli ultimi anni, Arnaldo Ferraguti si trasferì infine a Forlì per dirigere la ditta Giovanni Romanini e C., dedita anch’essa alla produzione di finto cuoio. Qui alla fine si spense il 4 dicembre 1925, e lì ancora riposa, nel locale cimitero dove fu sepolto. La sua vena inventrice sembra influenzasse le attitudini del figlio primogenito Mario (1892 ‒ 1976), professore di scienze agrarie, uomo di fiducia di Mussolini nella politica di autarchia alimentare degli anni Trenta, nonché prolifico inventore, di un nuovo sistema di coltivazione per ottimizzare il rendimento della superficie di semina, e di una macchina con motore a scoppio alimentata a carbone, detta a «gasogeno», della quale si mise futuristicamente alla guida in alcune edizioni della gara Mille Miglia, nella seconda metà degli anni Trenta.
Bibliografia
Annamaria Andreoli, Il vivere inimitabile, Milano, Mondadori, 2000.
Gabriele d’Annunzio, Lettere ai Treves, a cura di Gianni Oliva, Milano, Garzanti, 1999.
Arnaldo Ferraguti, L’Odissea di un allestimento scenico. La figlia di Iorio, «Il Secolo XX», n. 5, maggio 1904, pp. 354 ‒ 376.
Arnaldo Ferraguti 1862 ‒ 1925. Tra pittura e letteratura alla fine di un secolo, a cura di Sergio Rebora, con la collaborazione di Maria Cristina Brunati, Massimiliano Cremona, Mariella Milan, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2006.
Franco Di Tizio, D’Annunzio e Michetti: la verità sui loro rapporti, Pescara, Ianieri Edizioni, 2002.
Simone Di Valerio, «Vorrei essere l’Unica!». Lettere inedite di Olga Treves Ferraguti a Gabriele d’Annunzio, «Archivio d’Annunzio», vol. 10, ottobre 2023, pp. 139 ‒ 153.
Luciana Pasquini, Gli espedienti dell’industria culturale e l’illustrazione di Vita dei Campi, «Misure Critiche», a. XX, n. 1 ‒ 2, 2021.
Gino Raya, Verga e i Treves, Roma, Herder editore, 1986.