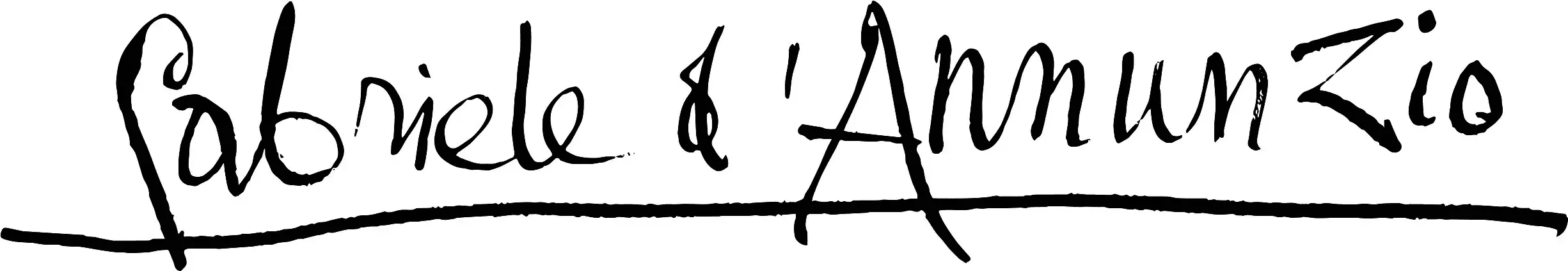di Gioele Cristofari, Enciclopedia dannunziana
D’Annunzio in Pavese, classicità e politica
Delle molte possibili memorie dannunziane nell’opera di Cesare Pavese, la più evidente e macroscopica è senz’altro il titolo, già alcyonio, Feria d’agosto, scelto per il volume di prose pubblicato da Einaudi nel 1946. Si trattava forse allora di alludere all’attesa contemplativa dell’«ospite» nel testo di d’Annunzio (v. 54), qui certo da identificare in Fernanda Pivano, che Pavese tentò di sposare tra i due estremi cronologici esibiti in epigrafe («In memoria | † | 26 luglio ’40 – 10 luglio ’45»); il cenno è però anche all’otium genericamente alcyonio, quasi una tregua, che lo scrittore sfollato si era concesso nel periodo dell’occupazione, durante il quale aveva scritto buona parte di quelle prose. In larga maggioranza narrative, tra di esse c’è però spazio anche per cinque brevi saggi di poetica (Del mito, del simbolo e d’altro, Stato di grazia, L’adolescenza, La vigna, Mal di mestiere) che costituiscono la prima e più ampia testimonianza di una riflessione sul mito tesa fin da subito a organizzarsi in teoria gnoseologica ed estetica.
Dei cinque saggi, il più antico e decisivo è senza dubbio Del mito, del simbolo e d’altro. La curatrice della prestigiosa edizione di Tutti i racconti, condotta sugli autografi pavesiani, non ne conosce testimoni d’autore (Pavese 2002, p. 949). L’archivio delle carte pavesiane, attualmente presso il Centro studi «Guido Gozzano – Cesare Pavese» dell’Università degli studi di Torino, conserva però una minuta (siglata Fondo Einaudi 17.50) aperta e chiusa dalle datazioni «22 sett.» e «24 sett.». L’anno è con ogni probabilità il 1943: non solo perché, a distanza di un paio di mesi, Pavese scriverà sul diario a proposito del «sett. ’43» come del momento di «scoperta del mito-unicità» (Pavese 1990, p. 269), ma anche a partire dall’avantesto di Del mito, del simbolo e d’altro, che addensa al suo interno materiali provenienti in larga misura dalle pagine del Mestiere di vivere compilate tra l’inizio del 1942 e quella data, e in particolare da due ampie note dell’11 e del 17 settembre (Pavese 1990, pp. 232-258; un regesto parziale delle corrispondenze è in de las Nieves Muñiz Muñiz 1992b, p. 318). Il mero dato cronologico e filologico non è inutile alla valutazione dell’eredità dannunziana in Pavese. Ciò che non filtra nel saggio di settembre è infatti una serie di tre note estive, immediatamente precedenti alla composizione, in cui il nome di d’Annunzio gioca un ruolo chiave:
La tua classicità: le Georgiche, d’Annunzio, la collina del Pino. Qui si è innestata l’America come linguaggio rustico-universale (Anderson, An ohio pagan), e la barriera (il Campo di grano) che è riscontro di città e campagna. […] Recentemente hai aggiunto la scoperta dell’infanzia (campagna = forma mentale), valorizzando gli studi di etnografia (il Dio caprone, la teoria dell’immagine-racconto). […]
Alle radici componenti della tua classicità aggiungi la mania astronomica delle stelle, ch’era mania dei bei nomi. Essa si legò subito meravigliosamente alle prime letture classiche (Georgiche): Ante tibi Eoae Atlantides abscondatur… e anche a D’Ann. (Maja). […]
Insomma, il tuo stupore dei 16-19 anni era che la realtà (la cavedagna di Reaglie sotto le stelle, i boschi di forti frassini a far lance ecc.) fosse la stessa che Omero e d’Annunzio sottacevano. Prima c’era stata la commozione ispirata dai segni delle cose (poesie, favole, miti); di qui hai riconosciuto la bellezza e l’interesse del mondo delle cose.
Benché fuori ancora dalla letteratura, ti sei interessato di astronomia ecc. perché commosso da segni (Flammarion, film su Dante, ecc.) che ti hanno tratto a battezzare questa realtà e quindi interessartene. (Pavese 1990, pp. 254-257)
D’Annunzio, insomma, «alle radici» del classicismo pavesiano, di lì a pochi anni ampiamente sviluppato nel capolavoro dei Dialoghi con Leucò (per cui l’opera dell’Imaginifico potrebbe aver funzionato da serbatoio tematico: ma certo in concorso con altre fonti), e d’Annunzio quale medium nella conoscenza del reale di Pavese ragazzo; in piena coerenza, del resto, con la costituenda teoria di Del mito, del simbolo e d’altro, per la quale «il mondo s’impara a conoscerlo non […] con immediato e originario contatto alle cose, ma attraverso i segni di queste» (Pavese 2002, p. 129). Se il tentativo di sistematizzare le riflessioni nel saggio impone di abbandonare i riferimenti a d’Annunzio, cui è preferito un Charles Baudelaire meno sospetto sul piano politico («Hai descritto così quella che Baudelaire chiama “l’extase”»; ibidem), è vero che, nel descrivere i rapporti del mito e del simbolo individuale con il fatto artistico, riemergono gli accenti di una vulgata tipicamente dannunziana e simbolista (già Furio Jesi scriveva per il Pavese di Feria d’agosto di uno stile analogo a quello «della parte più superficiale dell’esoterismo», e proponeva, accanto a quello del Vate, i nomi di Stefan George e Rainer Maria Rilke; 1968, p. 132): l’opera d’arte sarebbe infatti il risultato unico di «tempre straordinarie di creatori» il cui prodotto «ha un carattere di rivelazione inaudita come per il credente una festa rituale» (ibidem). Ancora più naturale, allora, che il sigillo del titolo apposto alla raccolta di quelle prose sia dannunziano.
L’assenza di riferimenti a d’Annunzio può essere motivata anche da ragioni di opportunità. È nota la stroncatura postuma di Pavese da parte di Alberto Moravia, che scrisse di un’improvvisa «conversione» dello scrittore al comunismo, paragonandola esplicitamente al posizionamento politico del Poeta-soldato: «dal decadentismo trasmutato in patriottismo (d’Annunzio) si giunge al decadentismo trasmutato in comunismo (Pavese)» (1963, p. 190). Moravia poteva esser mosso anche da risentimento personale, dal momento che in una pagina del Mestiere di vivere, da poco edito, trovava il suo nome inventariato in una «scuola romana» di «giornalisti, avventurieri, scrittori, pittori ecc.» che per l’autore costituivano «in sostanza l’arte fascista» (Pavese 1990, pp. 347-348). Pur piegato forzatamente sul piano politico, l’accostamento di Pavese a d’Annunzio coglieva però nel segno, e riprendeva antiche accuse, l’ultima delle quali era venuta allo scrittore nel gennaio 1950 da Augusto Monti, suo professore al liceo Massimo d’Azeglio di Torino e poi costante punto di riferimento intellettuale: «dannunziano» era per Monti il Pavese della Bella estate, il cui narrato sarebbe intessuto di inutili «ciarpe» rese leggibili solo dal virtuosismo dell’autore (Pavese 1966b, p. 461). La risposta di Pavese non si era fatta attendere, ed era al limite dell’aggressione verbale: «È diventato fesso, e basta» (ivi, p. 460). Contiguità con d’Annunzio quale accusa di inconsistenza politica o letteraria, da un lato, anti-dannunzianesimo pubblico e di prammatica dall’altro: e non stupisce che, già nel 1929, in una lettera a Leone Ginzburg, il Vate fosse qualificato con un appellativo inequivocabile («stronzo»; Pavese 1966a, pp. 140-141). Nel pugno di occorrenze del nome d’Annunzio tra le scritture pubbliche (due volte nei Saggi letterari, quattro in tutto l’epistolario), lo scrittore è quasi sempre citato come esempio negativo; si può anzi ben dire che il Vate agisca quale anti-modello persino nell’organizzazione interna delle poesie nella princeps di Lavorare stanca. Nell’autocommento alla raccolta (Il mestiere di poeta), sviluppando il ragionamento sull’impossibilità di costruire un «canzoniere» saldamente strutturato, Pavese non manca infatti di esaminare l’Alcyone: per il giovane scrittore il terzo delle Laudi è privo di un «passaggio fantastico» o «concettuale» di poesia in poesia, tale da renderlo un organismo internamente compiuto; al limite, vi si può ritrovare «un legame temporale, fantasie da giugno a settembre» (1998, pp. 105-106). A profondi debiti, riconosciuti a posteriori nell’intimo delle pagine di diario, si accompagnavano insomma in pubblico la svalutazione e il disconoscimento di d’Annunzio.
D’Annunzio nelle carte e nella biblioteca di Pavese
Fin qui sul piano dell’eredità macroscopica o teorica, e delle dichiarazioni pubbliche. Prima di valutare nel dettaglio il precipitato intertestuale dell’opera di d’Annunzio nella scrittura di Pavese, e di quella in versi in particolare, converrà soffermarsi sulla documentazione d’archivio che possa documentare l’interesse del secondo nei confronti del primo, a partire dai volumi attualmente conservati nella biblioteca. Si tratta di sei opere in tutto, sempre con segni di lettura: La Leda senza cigno, il Giovanni Episcopo, Terra vergine, il Canto novo e l’Alcyone sono attualmente nel Fondo Sini dell’archivio Pavese del Centro studi (siglati rispettivamente FS 09, 53, 54, 55 e 62); la sola Maia è invece nel Fondo Einaudi (FE 264). Assenti i grandi romanzi, dunque, e presenti ben tre volumi di versi, due dei quali appartenenti al ciclo delle Laudi, al quale Pavese dava «un’occhiatina» già nell’autunno 1926, secondo un fittissimo programma di lettura inviato all’amico Tullio Pinelli (Pavese 1966a, p. 39). Se la giovane matricola universitaria sfogliò allora anche le pagine dell’Alcyone, non si trattò certo del volume oggi conservato, che è del 1931 (Per L’Oleandro); quanto agli altri, Giovanni Episcopo, Terra vergine e Canto novo sono tutti editi da Sonzogno e privi di data, La Leda senza cigno è quella dell’Edizione Nazionale, del 1939, mentre Maia è un prezioso in ottavo Treves con illustrazioni di Adolfo de Carolis, del 1920.
Il documento più interessante riguarda proprio il primo volume delle Laudi, che Pavese citava nelle note dell’estate 1943 come uno dei testi «alle radici della sua classicità», insieme alle Georgiche e ai nomi di Omero, Dante (per un «film» non meglio precisato) e a quello dell’astronomo francese Nicolas Camille Flammarion. L’opera a cui si riferisce Pavese in quest’ultimo caso è con buona certezza Le Monde avant la création de l’homme (1886), di cui scrisse nel 1946 alla collega Bianca Garufi come del «primo vero libro» che lesse, quindicenne, «alla Biblioteca Civica», togliendone «lunghi estratti» (Pavese 1966b, p. 58). Alla segnatura AP X.70, l’archivio del Centro studi conserva un quaderno, oggi parzialmente edito, databile grazie a indizi interni al periodo tra il settembre 1923 e lo stesso mese dell’anno successivo (Cristofari 2022): vi sono distribuiti alcuni passi riconducibili al quinto libro del volume di Flammarion (certo parte dei «lunghi estratti» del 1946), abbozzi di racconti, prose critiche sulla Vita Nuova e l’Odissea, considerazioni sul progresso e sulla poesia, note bibliografiche, orari scolastici, appunti di matematica, fisica e scienze e, soprattutto, una nutrita serie di appunti relative ai canti III–V, VII–X e XII di Maia. Fatta eccezione per le Georgiche, le quaranta carte del quaderno sembrano insomma dare concretezza documentaria ai tre luoghi del diario che nell’estate 1943 preludono alla sistematizzazione teorica delle riflessioni sul mito in Feria d’agosto. Le note su Maia si possono distinguere, a livello tipologico, in tre gruppi: citazioni dirette, spesso inesatte (III, vv. 379-399; IV, vv. 829-832; V, vv. 1026-1041), brevi prose critiche ed elenchi lessicali, anch’essi con qualche errore (dai canti IV–V, VIIIX–X e XII). Testimoni di un precoce interesse per il d’Annunzio poeta, gli appunti di Pavese hanno ben poco valore critico; oltre a commenti dei passi citati, si tratta per lo più di conclusioni scolastiche sulla figura dell’Imaginifico e sullo «spirito moderno», che si risolvono nell’opposizione, già crociana (forse mediata dall’insegnamento di Monti), con l’opera di Giosuè Carducci:
La poesia del d’Annunzio è una zitella che ha passati i 40, nervosa, imbellettata, come una cantante da varietà, piena di desideri sfioriti e tanto più spasmodici, adulatrice e insolente come una qualunque cortigiana, mentre quella del Card. è una giovine nel fiore del suo rigoglio desiderata da tutti e posseduta da nessuno[.]
La svalutazione critica si affianca insomma, già negli anni liceali, all’attento studio dell’opera, qui al limite dell’assorbimento, come documentano in particolare gli elenchi lessicali. Proprio questi ultimi riservano le maggiori sorprese, dal momento che molti lessemi registrati sono quelli, di ambito marinaresco, che d’Annunzio prelevava dal Vocabolario marino e militare di Alberto Guglielmotti (un approfondimento in Praz 1986, pp. 411-421). Nel 1932, riemergeranno nella traduzione pavesiana del Moby Dick (Melville 1959): così «drizze» (pp. 222, 310, 874), «ghindata» (ma nella forma verbale imperativa «Ghindate», p. 873), «paranco» (pp. 275, 506, 507 due volte, poi alle pp. 560, 563, 704, 712, 887), «randa» (pp. 653, 810), «ralinga» (pp. 857, due volte), «scotta» (pp. 135, 385, 410, 797, 860, 770) e «bompresso» (pp. 55, 112, 134, 431, 466, 783 due volte, poi alle pp. 814, 896). Possibile, ovviamente, che si tratti di casi fortuiti, imputabili alla contiguità tematica; è comunque indubbio che il gusto del Pavese traduttore per il tecnicismo, parallelo magari alla «mania dei bei nomi» confessata nelle note del 1943, si sia nutrito alla fonte della poesia dannunziana.
Memorie dannunziane nei versi e nelle prose di Pavese
Prevedibilmente, Maia agisce in più di un caso nel discorso in versi del periodo liceale e universitario, che si conclude con la laurea in Lettere il 20 giugno 1930 (Mondo 2006, p. 47), lo stesso anno dei Mari del Sud, il testo che apre Lavorare stanca e, insieme, la stagione della maturità poetica di Pavese. Nel 1925 di «Per la gran notte sol rompe il silenzio», per esempio, è evidente il prelievo in incipit dal v. 398 della Laus vitae, copiato sul quaderno del 1923-1924 («Così viveva la gran notte»), mentre la pàtina linguistica dannunziana ricopre la memoria di Ugo Foscolo nella coeva «O colli dov’io nacqui, sempre v’avrò nel cuore», ricordo lirico del «fanciullo ignaro» (v. 4) nel «meriggio d’estate» (v. 2), ancora forse in qualche rapporto coi passi commentati in AP X.70 (magari «s’io torni ove nacqui», v. 949). Anche certe preziose tessere lessicali della poesia degli anni Venti sono riconducibili a Maia: così i «vùlturi» di Sull’arida pianura sabbiosa (v. 9), tolti dal v. 1813, o gli «eptacordi» e «l’anima ellena» di Ti ho amata come li Arii (vv. 6 e 8), già ai vv. 4030 e 1539; altri materiali dannunziani sono poi in All’alta rupe sul mare, dalla «medusa morta» del v. 44 (tra le Città terribili, v.5804) al «canto / dell’ultima oceanina» (vv. 18‑19 e 39‑40), che è probabile replica delle «Oceanine» di Maia (v. 3973), magari ibridate con le «vergini / oceanine» nel primo libro del Canto novo del 1882 (II, vv. 4‑5) o con il «canto delle Oceanine» in Per la morte di un capolavoro (v. 156). Se il volume di Alcyone oggi conservato nell’archivio di Pavese è del 1931, non mancano poi nella poesia giovanile echi scoperti dal terzo libro delle Laudi. Su tutti, l’«Odo» o il «chi sa dove» in D’estate (vv. 17 e 48) e i «fusti» e «le rame spoglie» di O, nella vita sono tanto giovine (vv. 6‑7), che denunciano le memorie, certo convenzionali, della Pioggia nel pineto (per il verbo «udire» i vv. 2, 4, 33 e 80-81; «chi sa dove» iterato al v. 94) e della Sera fiesolana (le «rame spoglie» al v. 14, i «fusti» al v. 18).
A partire dal 1930, l’impiego dell’anapesto e la parallela virata narrativa dei versi pavesiani, che segnano il passaggio alla maturità e il duro rifiuto del «lirismo» giovanile (Pavese 1998, p. 107), comportano anche il parziale abbandono dei modelli precedenti, tra i quali in particolare d’Annunzio, e un complessivo abbassamento del tasso di intertestualità di una versificazione che fa dell’ostinata «opposizione al gusto dominante» (Fortini 1977, p. 120) la sua principale caratteristica. La lirica di d’Annunzio, quella dell’Alcyone in particolare, continua però ad agire nascostamente anche nelle pagine di Lavorare stanca, a partire dai titoli delle poesie (Notturno e Un ricordo, mentre una Luna d’agosto è già al v. 95 di Undulna), fino a una nutritissima serie di echi più o meno precisi. Ci si può limitare ai più esposti: La pioggia nel pineto fornisce ancora prodromi al v. 11 di Estate («Ascolti») e al v. 25 di Terre bruciate («Lo ascolto»), entrambi isolati dalla successiva spezzatura tipografica («Ascolta» ai vv. 40, 65 e 88 del capolavoro dannunziano); Innanzi l’alba è forse all’origine del letterario «anzi l’alba» nel contesto domestico della Cena triste (v. 15); le «mammelle premute» nel Carrettiere (v. 7) discendono più probabilmente dai Tributarii («mammella non premuta», v. 47) che dal Poema paradisiaco («mamma premuta», O rus!, v. 58). Per Giorgio Bàrberi Squarotti, La morte del cervo è poi modello per Il dio-caprone (1982, pp. 47-48), certo in più ampio rapporto con le molte apparizioni fin de siècle di Pan o di semidei metamorfici; così, Pio Fontana ritiene genericamente alcyonio l’«incanto sottile della stagione»in Grappa a settembre (1958, p. 472), mentre al «gusto figurativo decadente» appartiene per Anco Marzio Mutterle l’«amaro sorriso» al v. 21 del Figlio della vedova (1966, p. 266). Più precise le memorie dannunziane segnalate da Giovanni Bàrberi Squarotti nel suo commento ai versi di Pavese (2021), tra le quali vanno segnalate almeno l’«ambiguo lume» del Novilunio (v. 35) per «le stelle ambigue» di Incontro (v. 5), le «ombre estuose» di Bocca di Serchio (v. 140) per il v. 30 dell’esclusa Tradimento («Ora l’ombra è estuosa») o, in Mito, i rapporti del «gran sole» al v. 14 con Primo vere (Lucertole, v. 39), con Canto novo (Canto del Sole, I, v. 8) e con La figlia di Iorio (I, 3), così come quelli del v. 6 («è morta l’estate») con le varie attestazioni della stagione declinante nei capolavori dannunziani, in particolare nei Madrigali alcyonii. Fuori dalla produzione in versi, conta in proposito soprattutto l’«Estate defunta» del Fuoco (L’Epifania del Fuoco, [I]), che fornisce anche, al v. 6 di Tolleranza, un sintagma come «paese sommerso» (L’Impero del Silenzio, [XV]), allargando così le memorie dannunziane in Pavese al piano interdiscorsivo.
I due lavori esplicitamente dedicati all’eredità di d’Annunzio in Pavese, quello di Simona Costa (1989) e ancor più quello di Roberto Gigliucci (2003), si concentrano però soprattutto sull’ultima stagione della scrittura in versi dell’autore piemontese, quella amorosa, aperta nel 1945 con La terra e la morte, proseguita l’anno successivo con le Due poesie a T. e chiusa a pochi mesi dal suicidio dai dieci testi di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. L’abbandono del metro narrativo di Lavorare stanca e la riemersione di modelli apertamente lirici erano del resto già sottolineati dallo stesso Pavese che, proponendo le nove poesie della Terra e la morte per la pubblicazione, le descriveva come «diversissime da Lavorare stanca (in settenari) e quasi dannunziane» (1966b, p. 42). Non a caso, oltre agli Inni a Venere-Afrodite di Lucrezio e Omero, gli antecedenti tematici proposti per il «poemetto» (Pavese 1990, p. 381) sono «l’Hymne à la beauté di Baudelaire, e soprattutto l’Inno alla Delfica dannunziano» (de las Nieves Muñiz Muñiz 1992a, p. 107); quanto al ritorno al metro tradizionale, l’accenno di Pavese a d’Annunzio è dovuto per Stefano Giovannuzzi al ricordo delle Stirpi canore, del Meriggio e della Pioggia nel pineto (2012, p. 25), mentre Lorenzo Mondo ne individua prodromi soprattutto nel Novilunio (2011, p. 266), che in effetti echeggia almeno nell’explicit di «Tu sei come una terra» («Tu tremi nell’estate», prossimo a «tu hai tremato» al v. 130 del testo dannunziano). Alcyonia è poi soprattutto «Di salmastro e di terra», sia per l’aggettivo dell’incipit, già nella celebre Pioggia nel pineto (v. 11) ma pure nell’Ippocampo (v. 67), in Feria d’agosto (v. 11), nel Tritone (v. 8) e nel quarto Ditirambo (v. 326), che per la «Bava di vento» del v. 11, per cui vale soprattutto il Meriggio («Non bava / di vento», vv. 6-7); in «Sempre vieni dal mare», il v. 13 «Noi sempre combattemmo» è poi un’ulteriore, evidentissima ripresa dall’incipitdella Tregua («Despota, andammo e combattemmo, sempre / fedeli al tuo comandamento», vv. 1-2). A riemergere è ora persino la lontana memoria di Maia, in «Hai viso di pietra scolpita»: «Tutto accogli e scruti / e respingi da te / come il mare» (vv. 4-6), potrebbe infatti riprenderne i vv. 2920-291, «Così tutto attrassi e composi / in me, tutto abbracciai». Per le memorie dannunziane in Verrà la morte, e in particolare in Passerò per Piazza di Spagna, varrà il rimando al saggio di Gigliucci (che ha trovato antecedenti soprattutto nella coppia Romanza–Rondò della Chimera); altre possibili sono nel celebre explicit del testo eponimo, «Scenderemo nel gorgo muti» (dal Ditirambo II: «Precipite / caddi nel gorgo», vv. 104-105, e in chiusura «Nel gorgo mi precipito») e in You, wind of March, che importa soprattutto per le varie occorrenze di un «passo leggero» (vv. 7, 10, 35 e 50) contiguo a vari luoghi dannunziani, dalla generica «levità del tuo passo» in Maia (v. 2847), al «passo leggero» nell’Onda (v. 80), fino alle molte occorrenze nel Notturno, tra le quali è decisiva quella nella Seconda offerta («il suo passo è leggero»), già segnalata da Anco Marzio Mutterle (1966, p. 311). Qualche interesse è infine al v. 8 di «I mattini passano chiari», «non pena non febbre non ombra», che riprende una volta di più il primo libro delle Laudi, «Non templi non are non tombe», tanto dal punto di vista sintattico che metrico (v. 1681).
Se la rapida carrellata di alcuni luoghi prossimi a del discorso in versi pavesiano potrebbe essere notevolmente estesa, rintracciare più che vaghe ascendenze del romanzo o delle prose del Vate nella narrativa dell’autore piemontese è ben più arduo. Piuttosto, come ha dimostrato Simona Costa a proposito di rapporti tra la prostituta del Carcere e la «meretrice di Pirgo» della Laus vitae (1989, p. 155), i prelievi del secondo sembrano ignorare i tradizionaliconfini tra i generi, e rimandare ancora alla lirica dannunziana. Decisivo, in questo senso, l’insistito simbolo sessualizzante della «collinaccia che sembrava una mammella» in Paesi tuoi, «tutta rotonda sulle coste e col ciuffo di piante che la chiazzava in punta» (Pavese 2000, pp. 16 e 17-18), evidente trasfigurazione narrativa della collina «enorme e ubertosa come una grande mammella» di cui Pavese scriverà a Fernanda Pivano nel 1942 (1966a, p. 637), in una lettera anch’essa certamente prodromica alle riflessioni sui luoghi mitici in Del mito, del simbolo e d’altro. Sulle fantasie infantili, come teorizzato nei saggi di Feria d’agosto, si è però a quel punto innestata una memoria letteraria tanto scoperta da apparire quasi paradigmatica, se proprio in Maia la Maiella è un «monte nevoso / che ha forma d’ubero pieno» (vv. 877‑878). Attraverso d’Annunzio, la nuda realtà della collina langarola si è fatta, in termini propriamente pavesiani, simbolo scoperto. La sovrimpressione della poesia del Vate sulla classicità greco-latina è evidente, infine, anche nei Dialoghi con Leucò: basti, in questo caso, l’esempio della nota dell’autore al primo di quei pezzi, La nube, in cui il protagonista Issione è caratterizzato dalla sua «audacia» (Pavese 2017, p. 4). Se quel personaggio era già «audaci» nelle Metamorfosi di Ovidio (XII, v. 210), lo scrittore piemontese potrebbe qui essersi rifatto anche alla Morte del cervo, in cui si legge appunto di un’«audacia d’Issione» certamente debitrice del poeta degli Amores (v. 156). Ricondurre con certezza la nota dei Dialoghi a uno dei due antefatti, oltre che impossibile, è probabilmente sbagliato: come apertamente dichiarato nel Mestiere di vivere dell’estate 1943, del resto, l’attualizzazione del classico data dall’opera di d’Annunzio finisce per essere indistinguibile dai suoi precedenti, e costituire così la precondizione ideale per il recupero del mito portato avanti da Pavese stesso da Feria d’agosto in poi.
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria:
Gabriele d’Annunzio, Maia, edizione critica a cura di Cristina Montagnani, Gardone Riviera, Il Vittoriale degli Italiani, 2006.
Gabriele d’Annunzio, Alcyone, edizione critica a cura di Pietro Gibellini, commento di Giulia Belletti, Sara Campardo, Erica Gambin, scheda metrica di Gianfranca Lavezzi, Venezia, Marsilio, 2018.
Camille Flammarion, Le Monde avant la création de l’homme, Parigi, C. Marpon et E. Flammarion, 1886.
Herman Melville, Moby Dick o la balena, traduzione di Cesare Pavese, Torino, Frassinelli, 1959.
Cesare Pavese, Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 1946.
Cesare Pavese, Lettere 1924-1944, a cura di Lorenzo Mondo, Torino, Einaudi, 1966a.
Cesare Pavese, Lettere 1945-1950, a cura di Italo Calvino, Torino, Einaudi, 1966b.
Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, a cura di Marziano Guglielminetti e Laura Nay, Torino, Einaudi, 1990.
Cesare Pavese, Le poesie, a cura di Mariarosa Masoero, introduzione di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 1998.
Cesare Pavese, Tutti i romanzi, a cura di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 2000.
Cesare Pavese, Tutti i racconti, a cura di Mariarosa Masoero, introduzione di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 2002.
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, Torino, Einaudi, 2017.
Cesare Pavese, Poesie, a cura di Giovanni Bàrberi Squarotti, Milano, Rizzoli, 2021.
Bibliografia secondaria:
Giorgio Bàrberi Squarotti, Lettura di «Lavorare stanca», in Il mestiere di scrivere. Cesare Pavese trent’anni dopo. Atti del convegno, 13 dicembre 1980, Santo Stefano Belbo, Quaderni del Centro Studi Cesare Pavese, 1982, pp. 37-62.
Simona Costa, Pavese e d’Annunzio, in Cesare Pavese oggi. Atti del convegno internazionale di studi: San Salvatore Monferrato, 25-26-27 settembre 1987, a cura di Giovanna Ioli, Torino, Celid, 1989, pp. 147-158.
Gioele Cristofari, «Alle radici»: Pavese, l’Alcyone, le note su Maia, «Archivio d’Annunzio», 9, 2022, pp. 141-153.
Pio Fontana, Il primo Pavese. Da «Lavorare stanca» a «La spiaggia», «Aevum», 32, 5-6, 1958, pp. 462-503.
Franco Fortini, L’antifascismo e Cesare Pavese, in Idem, I poeti del Novecento, Roma-Napoli, Laterza, 1977, pp. 119-122.
Roberto Gigliucci, Pavese (e D’Annunzio) a Piazza di Spagna, in Spazi, geografie, testi, a cura di Siriana Sgavicchia, Roma, Bulzoni, 2003, pp. 141-147.
Stefano Giovannuzzi, Pavese, prosa e poesia, in Idem, La persistenza della lirica. La poesia italiana nel secondo Novecento da Pavese a Pasolini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2012, pp. 3-28.
Saverio Ieva, Moravia contro Pavese: un esempio di critica «parodica»?, «Italies», 4, 2000, pp. 425-446.
Furio Jesi, Cesare Pavese, il mito e la scienza del mito, in Letteratura e mito, Torino, Einaudi, 1968, pp. 129-160.
Lorenzo Mondo, Quell’antico ragazzo. Vita di Cesare Pavese, Milano, Rizzoli, 2006.
Lorenzo Mondo, Cesare Pavese: Il mestiere di poeta, in Cesare Pavese: un classico del XX secolo (1908-2008), a cura di Elisa Martinez Garrido, Salud Marìa Jarilla Bravo, Madrid, Cuadernos de Filologìa Italiana, Volumen Extraordinario, 2011, pp. 257-267.
Alberto Moravia, Pavese decadente, in L’uomo come fine e altri saggi, Milano, Bompiani, 1963, pp. 187-191.
Anco Marzio Mutterle, Appunti sulla lingua di Pavese lirico, «Quaderni del Circolo filologico linguistico padovano», 1, 1966, pp. 263-313.
María de las Nieves Muñiz Muñiz, Introduzione a Pavese, Roma, Laterza, 1992a.
María de las Nieves Muñiz Muñiz, Un Pavese einaudito, «Belfagor», 47, 3, 1992b, pp. 313-327.
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, introduzione di Paola Colaiacomo, Firenze, Sansoni, 1986.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)