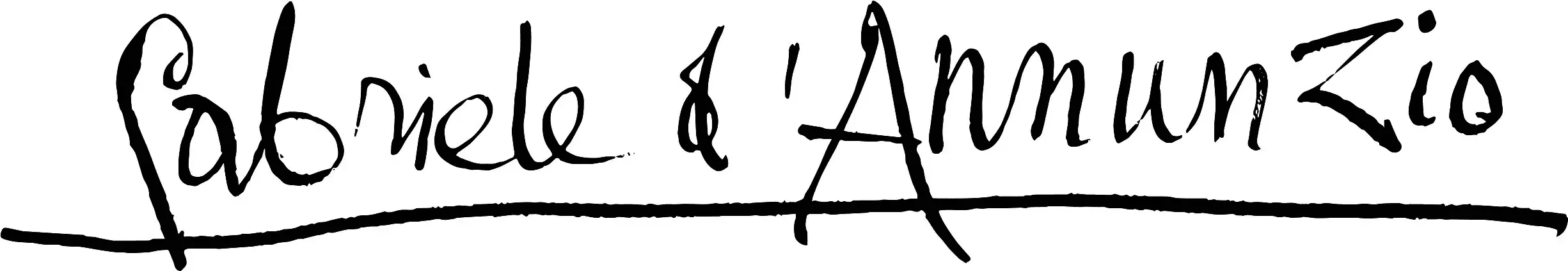di Anton Giulio Mancino, Enciclopedia dannunziana
La mano di Luchino
Luchino Visconti, tra i romanzi del Ciclo della Rosa, ha davvero optato per L’innocente come seconda o terza scelta? L’imperativo dannunziano per l’ultimo capolavoro viscontiano, algido e testamentario a un tempo, trovandosi ormai l’autore cinematografico costretto sulla sedia a rotelle e paralizzato per metà, con l’ictus aggravato da una recente caduta con conseguente frattura, assume carattere quasi di risarcimento; e, pur con intransigenti e severi distinguo, suggerisce una provocazione culturale, tra le righe sottilmente politica: «Era ora – dichiara Visconti – di tornare a Gabriele D’Annunzio, dopo cinquant’anni di abbandono, anzi di dileggio. Sono state scritte su di lui delle cose atroci, specialmente da [Alberto] Moravia e da [Pier Paolo] Pasolini, quella gente lì… Fossero capaci loro di scrivere le cose che ha scritto D’Annunzio. Gabriele D’Annunzio è un grande poeta. Il Notturno e l’Alcione sono tra le sue cose più belle. Le tragedie sono dei disastri. La città morta è un disastro. Molti anni addietro la [Lilla] Brignone, la [Anna] Proclemer e [Giorgio] Albertazzi mi proposero di metterla in scena. Ne facemmo una lettura, ma finimmo tutti sotto i tavoli dal ridere. Non so come se la sia cavata [Franco] Zeffirelli. Mi dicono piuttosto Male. Soltanto La figlia di Iorio si salva, le altre sono orribili».
Per comprendere quanto relativa diventi a queste condizioni di partenza, nelle mani del diretto interessato dietro la macchina da presa, la matrice dannunziana, occorre tenerne d’occhio soltanto una: la destra. In dettaglio, assai riconoscibile nella scena dei titoli di testa del film, la mano destra si fa carico anche della sinistra, inservibile. Segnata dalle macchie sulla pelle e dall’età avanzata, quest’unica mano attiva e indiziaria rimanda alla persona di Visconti, il cui resto del corpo, ugualmente inservibile, viene relegato fuori campo. Non rimane che la mano, mentre sfoglia le prime venticinque pagine del peculiare romanzo, deciso e decisivo nel breve termine e a futura memoria.
Mettere “mano” a D’annunzio comporta per Visconti, fuor di metafora, l’utilizzo della sola a disposizione capace ancora di affermare con residua potenza la completa autorialità rispetto al testo originale: una mano che reca il segno inconfondibile dell’intera e ossimorica «libera riduzione»; dove cioè la dicitura corrente di “riduzione” cinematografica dell’opera letteraria, contraddetta dall’istanza di “libertà” ad essa combinata, esprime un’irriducibile volontà di far proprio il testo posto al centro dell’inquadratura.
L’ausilio di una mano non anonima quale la sua, che ne scorre le pagine iniziali, soffermandosi su alcune per niente casuali, è insostituibile. Questi passi salienti, individuati dalla mano che indugia quasi assorta in una rapida rilettura e rielaborazione mentale, brillano le ragioni più ermeneutiche che ermetiche del dubbio sostanziale sulla priorità assoluta di concentrarsi su L’innocente, contemperando fattori autobiografici e testuali convogliati sul medesimo asse spettatoriale. Il secondo dei romanzi del Ciclo dannunziano viene opportunamente interiorizzato e perciò con speciale vigore dis-adattato anziché semplicemente adattato, a differenza del terzo, Il trionfo della morte, o tantomeno del primo, Il piacere, addirittura strappato in due e gettato via in Anni difficili (1948) di Luigi Zampa dallo sventurato protagonista, irritato oltre misura dalla sciocca figlia che avidamente e in gran segreto legge «questo libraccio maledetto».
L’aiuto regista Giorgio Treves ha raccontato che il produttore, sceneggiatore e regista Marco Vicario, detenesse allora i diritti di sfruttamento cinematografico de Il piacere. Ma tutto ciò non basta a comprendere perché Visconti abbia preferito, risultati alla mano, quella mano, concentrarsi su L’innocente.
Disadattare D’Annunzio
La prassi del disadattamento, concetto di gran lunga preferibile a quello più comune, equivoco e fuorviante di adattamento, dopo la pionieristica trasposizione de L’innocente ad opera di Edoardo Bencivenga (1911), trova una coerente applicazione nel ben più significativo “tradimento” messo a punto da Visconti nel 1976. E sgombra il campo da qualsivoglia ridimensionamento nel rapporto libro-film; compreso il campo inteso nell’accezione audiovisiva, perimetrato e sviluppato molto in orizzontale dall’obiettivo anamorfico. Non si tratta quindi di prestare occasionalmente la propria mano ancora attiva alla pellicola, fissandola sull’incipit, ma di estenderne la portata all’intero asse narrativo; fino alla fine, dove non si salva l’antieroe narrante dannunziano, nel senso che Visconti non intende salvarlo, ma farlo soccombere, mediante suicidio. Il gesto teatrale di togliersi la vita con le sue mani, con un colpo di pistola, distanziato in campo medio/lungo del Tullio Hermil interpretato da Giancarlo Giannini, permette a Visconti di prendersi una rivincita d’autore radicale sul piano politico, culturale e drammaturgico.
Di suo pugno, per restare in metafora, l’autore del film impedisce all’ex personaggio del romanzo di eludere la giustizia degli uomini e persino di sopravvivergli, sotto il peso della colpa, delle insostenibili pose da superuomo e dalla fatuità dell’arbitrio classista, sessista e in ultima istanza criminale. Non è un caso che «Mi dispiace davvero, ma ormai è tardi» sia la prima vera battuta messa in bocca all’aristocratico romano di fine secolo, il quale compare, bardato e mascherato da schermitore, solo nella seconda sequenza; a rimorchio di quella dei titoli di testa segnati dalla polisemica mano e dal nome espresso dall’ultimo dei titoli, entrambi sigilli autoreferenziali di Visconti. Non si può insomma mostrare un Hermil, in quanto rinnovata creatura cinematografica, che duri più a lungo del suo creatore.
Ecco perché, nel mettere mano alla rivoltella e proferire l’ultima, fatale battuta, rivolta tanto alla contessa sferzante Teresa Raffo quanto allo spettatore: «Non dormire, ti prego. Voglio farti vedere come so concludere», anche il protagonista deve sottostare all’egida e al decreto mortale del regista. Visconti, condannato a sua volta a non durare più del suo L’innocente, dimidiato tra due mondi e a disagio nell’uno e nell’altro come il suo ex principe di Salina ereditato dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, intende “far vedere come sa concludere”: la vita, il film, il personaggio rielaborato a propria immagine e dissomiglianza. In pratica, con allusiva, straniata confidenza, Luchino ha messo Tullio nella condizione di chi non può più rinunciare ad autoinfliggersi la giusta punizione. Già dai titoli di testa su cui è indispensabile tornare ripetutamente, accade che con un eccentrico colpo di mano, fisico e traslato, l’autore numero due, Visconti, subentrando a D’Annunzio, ipotechi al termine della rievocazione del misfatto dispensata dal protagonista all’amante, una speciale pena di morte. La distanza morale mimata dall’obiettivo di una delle cineprese in azione investe il pubblico in sala: si consuma così, tragicamente e sotto gli occhi di tutti, la sorte scenica di quest’esemplare osceno, disumano e inammissibile di infanticida.
La morte punitiva riservata ad Hermil, saldandosi a quella storica e fisiologica viscontiana, prefigurata dalle morti dei protagonisti non più letterari ma cinematografici e pertanto speculari e criticamente omogenei de Il Gattopardo (1963), Ludwig (1973) e Gruppo di famiglia in un interno (1974), completa il quadro funebre del romanzo L’innocente che si chiude con il funerale del neonato e “beato immacolato”. La misura già colma in D’annunzio trova in Visconti una sepolcrale aggiunta: anziché un giro di vite, un ultimo giro di vita e di manovella; come quella che nel cinema delle origini, per mano dell’operatore, consentiva prima le riprese e poi la proiezione; e ora si dedica a remote e indicate poiché indicative pagine letterarie, “girate” a scopo filmico.
I decessi sistematici di Visconti, che investono questo finale di partita a decorrere dallo speciale esergo del film, non possono prescindere nemmeno dalla figura dello scrittore e amante occasionale di Giuliana, giocando sul cognome: il Filippo Arborio de L’innocente numero uno viene innanzitutto trasformato in Filippo D’Arborio in L’innocente numero due da parte di Visconti e dei suoi stretti cosceneggiatori, Suso Cecchi D’Amico ed Enrico Medioli. Ma la conquista di una “D” apostrofata davanti al semplice cognome “Arborio” dell’opera cartacea non basta da sola ad assimilarla al cognome “D’Annunzio”; e a chiudere il cerchio è il titolo dell’immaginario romanzo attribuito a questo personaggio opportunamente riscritto in termini audiovisivi: La fiamma, che rimanda palesemente al dannunziano Il fuoco (1900).
Il decreto di morte che tra le righe colpisce D’Arborio, ergo D’Annunzio, accorciando le distanze tra i due, è frutto del giudizio complessivo, fatto di apprezzamento e disprezzo, che Visconti rivolge all’autore letterario la cui fama è inseparabile dall’uomo, in esibizionistica accezione nazionalistica e virile, ugualmente senza soluzione di continuità: «Io Gabriele D’Annunzio non l’ho mai visto di persona, ma ne ero anch’io affascinato. In seguito l’abbandonai per altri scrittori che consideravo più interessanti di lui, ma forse mi sbagliavo. L’uomo dell’impresa di Fiume mi faceva schifo, mi urtava i nervi. Ma neppure io so spiegarmi il suo successo con le donne. Forse era dovuto al suo modo di parlare, per quanto avesse una voce acuta e antipatica. La calvizie gli era venuta dopo il duello con Edoardo Scarfoglio, il quale non aveva esitato a scrivere che la moglie gli faceva le corna. Scarfoglio gli aveva dato una sciabolata in testa ed i medici gli avevano applicato un medicamento troppo forte. Ma anche da calvo riusciva a sedurre moltissime donne. La Duse, la Rudinì, la Mancini. Forse aveva una portentosa abilità a letto, o forse era particolarmente dotato. Non so… Ho sentito dire che Mauro Bolognini vorrebbe fare un film sulla sua vita. Ma la biografia di D’Annunzio non mi sembra interessante. In caso bisognerebbe fare un film da II fuoco, sul rapporto con la Duse. Ma II fuoco è molto noioso. D’altro canto, la Duse messa in piazza così, poveretta…».
Impossibile separare l’eccellenza artistica dalle vicende biografiche, in D’annunzio come in Visconti, specialmente quando una morte tira l’altra, avanti e indietro continuamente, dalla pagina allo schermo.
La pagina sullo schermo
Il singolare sbocco viscontiano de L’innocente dimostra immediatamente quanto insostenibile sia l’idea di poter riprodurre la pagina sullo schermo così com’è o adattare l’una alle esigenze linguistiche dell’altro. La prima scena, perno semantico all’operazione D’Annunzio che Visconti conduce in totale autonomia creativa, puntualmente autobiografica, rende infatti palese l’unica maniera concepibile di rendere cinematografico un libro: filmarlo esternamente come oggetto materiale per consentire allo spettatore di leggerlo, pagina dopo pagina, ingigantito nel buio della sala; magari con l’aiuto sibillino di Visconti, il quale con la propria mano non esita alla venticinquesima per lasciare alla dissolvenza in nero la transizione dalla copia conforme dell’impaginato più remoto all’impaginazione audiovisiva della trama dannunziana rivista e corretta: «Dei tre romanzi L’innocente – spiega ancora – è il più cinematografico. In esso c’è un fatto preciso: l’uccisione di un bambino. Anche il rapporto tra Tullio Hermil e la moglie, Giuliana, è molto interessante. Il piacere è difficile a farsi. È tutto ambientato a Roma. Come si potrebbe ambientare oggi a Roma? Al Pincio, a Trinità dei Monti, sulla Nomentana? Macchine che si incalzano, fili del telefono, hippies. Neppure il Trionfo della morte si potrebbe fare, anzi meno che mai. Non ci andrebbe nessuno al cinema, o ci andrebbero tenendo in mano le chiavi di casa per fare gli scongiuri, o magari facendo le corna. Gabriele D’Annunzio si era prefisso di scrivere un capolavoro prima dei trent’anni. L’innocente non è un capolavoro, ma è un bel romanzo. È vero che Tullio Hermil è un superuomo più verbale che reale, ma noi lo abbiamo modificato. Oggi nessuno più tollera un superuomo nietzschiano, come nessuno più tollera un uomo che uccide un bambino. Così noi nel film lo presentiamo diversamente. Dopo aver ucciso il bambino che Giuliana aveva avuto dall’amante, si uccide a sua volta. Si autopunisce. Il personaggio è così più giusto. Era giusto che si autopunisse. E può essere più agevolmente accettato dal pubblico».
Avendo dapprincipio sottomano, per l’appunto, un testo per lui insostituibile come L’innocente, e scartata ogni altra affinità con l’ingombrante scrittore, a Visconti non resta che attuare il travestimento. E il suo D’Arborio, non più Arborio, rilancia l’assonanza onomastica diretta con D’Annunzio, arricchita di un richiamo proustiano integrativo: due vetrine di libreria d’epoca che ospitano una prima pagina di giornale commemorativa, un ritratto e i suoi libri chiusi o aperti, rendono D’Arborio una sorta di Bergotte, lo scrittore di Alla ricerca del tempo perduto (1913-1927); donde il riferimento alla sceneggiatura dell’omonimo film mai realizzato che Visconti aveva scritto con D’Amico nel 1970, prima di tuffarsi fino a debilitarsi irrimediabilmente nell’imponente impresa di Ludwig.
La nuda verità
È un bene che almeno questa scena, tutt’altro che didascalica o di raccordo, non sia stata eliminata durante il montaggio finale, come richiesto dalla sceneggiatrice D’Amico più volte, sia prima che dopo la morte di Visconti. Renata Franceschi, la fidata segretaria di produzione, ha dichiarato di contro di aver insistito per mantenerla, riuscendoci, come si apprende dal documentario The Innocent at Work (2017) di Roberta Licurgo incluso nel blu-ray inglese Cultsfilms: qui la testimonianza di Franceschi è assai più franca di quella resa precedentemente, per ragioni abbastanza comprensibili, in A proposito di… L’innocente (presumibilmente del 2013, anno del dvd italiano Medusa nei cui contenuti speciali è stato inserito) di Silvia D’Amico Bendicò, Gioia Magrini, Roberto Meddi. Si apprende così come, attenendosi scrupolosamente alla ferma volontà del regista ancora vivo di conservare a tutti i costi la scena delle vetrine dedicate a D’Arborio, Franceschi si sia caparbiamente rifiutata di recepire l’indicazione reiterata di D’Amico di tagliarla alla moviola. Il che rimette in discussione la versione fornita da D’Amico che parla di un Visconti insoddisfatto del montaggio: «Quanto al montaggio Visconti morì pochi giorni dopo la proiezione del primo montaggio che ci lasciò tutti (Visconti per primo) assai scontenti. Quando accorsi a casa di Luchino chiamata dalla sorella che mi dette l’annuncio della morte, vidi sul tavolino la lunga lettera che gli avevo scritto dopo la proiezione. (Avevamo con Visconti l’abitudine di scambiarci per iscritto impressioni sul lavoro). Apportammo in seguito alcune modifiche al primo montaggio sulla base dei pochissimi commenti scambiati dopo la proiezione. Pochissimi davvero perché Visconti era molto stanco e nervoso quella sera e andò via subito dopo la proiezione. Anche per questo gli scrissi subito».
Su questo resoconto dei fatti cui conviene far luce poiché contrasta con il racconto di Franceschi, la quale ha sostenuto fino all’ultimo che D’Amico aveva visto il cosiddetto “primo” montaggio separatamente, e non con Visconti. Le parole di D’Amico sopra trascritte hanno pesato molto sul giudizio relativo all’edizione del film ad oggi disponibile, corrispondente per Franceschi ai desiderata di Visconti, salvo che per un’inquadratura che D’Amico è riuscita infine a far eliminare. Scampato il primo taglio alle forbici, un secondo taglio in un altro punto del viene comunque apportato in sede di montaggio. E stavolta Franceschi non riesce a spuntarla su D’Amico. Si tratta della seconda panoramica verticale in senso inverso che ripercorre dall’alto verso il basso il nudo integrale di D’Arborio, mostrandone esplicitamente il sesso. Nella precedente panoramica, dal basso verso l’alto, risulta infatti coperto dal ginocchio piegato dell’uomo, spiato sotto la doccia della palestra dall’accigliato Hermil il quale si sta concentrando sul corpo e quindi sugli attributi virili del rivale in amore. La doppia panoramica verticale voluta da Visconti per rappresentare in soggettiva lo sguardo insistito, reiterato e morboso di Hermil su D’Arborio, coglieva infine il dettaglio anatomico tutt’altro che gratuito o lascivo nell’economia intransigente del film; rimandando nella sua schiacciante evidenza alla frustrazione del sentimento maschilista del protagonista.
Non per niente Hermil, colpito nel vivo del suo autoritarismo sessista dalla vista dell’attributo erotico di D’Arborio, matura un malessere appena dissimulato dal sovrappensiero che sfocia nella scena successiva, a casa della contessa Teresa, con la presenza marcata di un paralume palesemente fallico a brevissima distanza dal volto, ripreso da ogni angolazione assunta dalle differenti inquadrature.
Senza quel pregresso e rivelatore ritorno di panoramica, che inchioda il protagonista al bisogno di competere con altri soggetti maschili e assoggettare col suo fascino prepotente le donne, la moglie come l’amante, non si comprende con altrettanta, crudele precisione, il tormento mentale che lo assilla, complice l’ossessivo contenuto “genitale” che sta consumando anche in veste di circostante suppellettile dell’arredamento, quindi di correlativo oggettivo, il suo animo profondamente pulsionale ed egoista. E sentirsi ripetere all’unisono dalla moglie, dall’amante e persino dal fratello, di cui si intuisce una celata inclinazione omosessuale, che tutte le donne sono attratte dalla persona e dalla scrittura di D’Arborio non fa che aumentare in lui un inesorabile senso di inferiorità. Perciò la perduta panoramica numero due, immediatamente consequenziale alla precedente, recante l’evidenza fisica dello scrittore nudo di cui sopra, sacrificata al montaggio per disposizione di D’Amico, nonostante la resistenza di Franceschi, resta l’unico dato lacunoso del film che Visconti aveva intanto approvato. L’ipotesi più verosimile è che la sceneggiatrice, ottenendo in definitiva soltanto uno dei due tagli, abbia trasferito su Visconti un motivo di “scontento” che in realtà l’ha riguardata personalmente.
Non sfugga, in una simile cornice di riferimento, che L’innocente di Visconti, possibilmente completo della panoramica “proibita”, cancellata per ingiustificate preoccupazioni di “decoro”, contemperando anche la gelosia infanticida di Hermil verso la creatura concepita dalla moglie con D’Arborio, si sarebbe meglio agganciato non tanto al romanzo di D’Annunzio, bensì a due altri film radicali sempre del 1976: L’ultima donna di Marco Ferreri ed Ecco L’impero dei sensi di Nagisa Ōshima, dove coerente e scandaloso è il comune gesto simbolico dei rispettivi protagonisti di evirarsi a vista. L’autonomia femminile, tale nel film di Ferreri da condurre “l’ultimo uomo” al tremendo esito poiché contempera anche un’insofferenza verso il legame stretto ed indipendente della donna con il bambino, diventa fatale anche per l’Hermil viscontiano.
Costui è ormai così consapevole del fallimento a stento rievocato come trionfo, da togliersi/tagliarsi sullo schermo la vita con un irremovibile, allusivo colpo di pistola.
La quarta edizione
Non può che attingere dalla materia offerta da L’innocente questo irreversibile “trionfo della morte” che assilla il Visconti terminale, deciso tuttavia a non far sconti al personaggio centrale, assimilando le rivendicazioni in atto dei movimenti femministi; e per giunta inserendosi con una personale provocazione nel clima ancora acceso che la legge e il referendum sull’aborto avevano innescato.
Forte di uno statuto autoriale indiscutibile, il regista ha sentito di poter puntare su questo romanzo di D’Annunzio che oggettiva e per molti versi reifica, cioè inquadrandolo come prima immagine da consegnare allo spettatore, per poi impadronirsene con la mano, docilmente ma senza desistere. Questo procedimento gli permette di confrontarsi in extremis con fantasmi di lungo corso e turbamenti contingenti, individuali e collettivi. Il riflesso privato del suo malinconico e malandato sé viene da un lato marcato, grazie all’immediato darsi a vedere corporeo nel film, e dall’altro distanziato, con lo stravolgimento di situazioni, scelte narrative e capisaldi della trama presa in prestito. Sostituendo alla prima persona del protagonista letterario la propria, manuale, fa sì che il colpo di “mano”, la destra sulla quale esercita ancora il controllo, mette in guardia chi guarda e nel contempo ascolta per predisporlo al finale alternativo, critico e dissenziente verso la mappa mentale coltivata dal tradizionale lettore dannunziano.
Il film, presentato al festival di Cannes e in sala cinema inevitabilmente dopo la morte di Visconti, avvenuta nella sua casa romana di via Fleming il 17 marzo 1976, reca dunque in dote un finale di partita non eterodiretto. Tutto si consuma, in famiglia: la prima persona cinematografica dell’autore gioca d’anticipo la sua ultima “mano” accompagnata dall’Adagio del maestro Franco Mannino, marito della cara sorella Uberta Visconti.
Innanzitutto viene esposta al centro dell’inquadratura, in diagonale e su uno sfondo di velluto rosso dall’effetto “mosso”, la pregiata quarta edizione di questo libro basilare, conforme alla prima del 1892: quella in sedicesimo, con copertina in brossura, edita dal napoletano Ferdinando Bideri.
Il volume che nella metà superiore reca il nome e cognome dell’autore e il numero dell’edizione al centro viene circoscritto da un rapido restringimento dell’inquadratura ottenuto con lo zoom. Sono i primi due elementi indiziari ai quali Visconti riserva un supplemento di attenzione. Sul piatto anteriore ingiallito una decorazione in rosso sulla sinistra impedisce al cognome a caratteri neri dello scrittore di restare allineato per intero in alto: perciò «Gabriele d’Annun-» termina a destra con un curioso a capo, lasciando sul rigo seguente l’ultima sillaba «zio» e, di dimensioni maggiori, il titolo «L’Innocente». Sotto, la didascalia: «con disegno di G.[iulio] A.[ristide] Sartorio», anticipa il dipinto interno a doppia pagina e in bianco e nero.
L’autore letterario, il cui nome appare spezzato, finisce per contare meno del romanzo, e soprattutto di quell’edizione che, per un cultore della precisione assoluta qual è Visconti, dovrebbe essere la prima e non la quarta. In più l’accento che la copertina suggerisce cade sulla componente iconografica che, superato il frontespizio, di fatto precede il testo scritto all’interno. Come dire che il regista, prendendo le mosse da D’Annunzio, debitamente ridimensionato poiché già infranto dall’intestazione cartacea, sta altresì puntando da par suo sugli aspetti prettamente visivi e perciò cinematografici dell’opera così esautorata.
Il primo dei titoli di testa che compare sigla contestualmente il primato del cineasta: «Un film di LUCHINO VISCONTI», con caratteri bianchi cubitali che coprono per esteso quelli suddetti del parcellizzato «Gabriele d’Annun-zio».
Una nuova zoomata a ritroso, che dimostra la coerenza della successiva panoramica del nudo dimezzato, quasi un “Visconti dimezzato” nelle sue fondamentali scelte di regia, torna qui ad allargare l’inquadratura, offrendo così la possibilità al diretto interessato, Visconti stesso, collocato sulla destra e riassunto mediante una sineddoche audiovisiva dalla sola mano funzionante, di voltare la copertina: la mano anch’essa destra ora in campo è indicativa e inequivocabile anche per via dell’elegante polsino della camicia nera con rombi bianchi disegnati che sbuca dalla manica della giacca. I rombi riprendono il motivo del libro inclinato, quindi non direttamente adattato, bensì disadattato; mentre le macchie sulla pelle della mano rimano gli equivalenti segni del tempo, tra fioriture e bruniture, sulla copertina e sulle pagine “girate” da Visconti. Il suo ingresso autorevole e autoriale, rafforzato dalla comparsa in sovrimpressione del titolo bianco del film «L’INNOCENTE», prevalente sul titolo nero del romanzo «L’Innocente», serve ad acclarare dal principio, come una privata ceralacca filmica apposta su una missiva di rango, il decorso del racconto linguisticamente rinnovato e rimeditato. Quel che segue va quasi a configurarsi come obbligatoria conseguenza di questo speciale sigillo, alla stregua di un ideale flashback; non foss’altro perché tutte le altre riprese del film sono state realizzate cronologicamente prima di quest’ultima scena, sistemata in esergo quale stralcio/reliquia di corpo sofferente. Il regista, filmato in limine mortis, esige uno spazio privilegiato in apertura, anche dell’ex libro, che spetta al montaggio post-mortem oramai esaudire.
Ma resta in piedi il quesito della quarta edizione, poiché unicamente per mano di Visconti in quanto autore cinematografico, concluso l’incipit della rassegna cartacea alla venticinquesima pagina con una dissolvenza in nero, possono prendere forma gli avvenimenti della narrazione ufficiale; ossia a decorrere dall’allenamento in palestra del competitivo e conflittuale Hermil, abile nella scherma ma forse non altrettanto desto o dominante nelle schermaglie amorose.
Nulla infatti può sfuggire al calcolo indiziario in quest’ordine del discorso viscontiano che si dà a vedere come commiato, davvero struggente e codificato poiché interpretato dall’unica mano in auge. La mossa della mano sul libro è teneramente teatrale, poiché arriva sul set inaspettata dopo la sua morte, con la post-produzione a un passo dalla conclusione, in fase di mixaggio, e rinnova il nuovo cordoglio dei collaboratori stretti; ma va oltre il memorandum interno per intercettare un sottotesto familiare e storico.
La valenza imprescindibile di questo marchio, a capo di innumerevoli tracce del sottotesto e di connessi significati riposti, crea un raggio ermeneutico d’azione che si estende su tutto film. Ecco perché è lecito insistervi, ovvero chiedersi se effettivamente un autore tanto puntiglioso, profondamente realista e filologico come Visconti, abbia rinunciato a una prima edizione del libro apparecchiata in piena evidenza, se fin lì si è dimostrato ferreo nelle decisioni; al punto da contestare la maggiore fotogenia del colore grigio scelto dal fedelissimo costumista Piero Tosi, anziché attenersi al più verosimile marrone cammello per il tessuto vigogna dell’abito indossato da Laura Antonelli nei panni di Giuliana. Difficile credere che il puntiglioso Visconti si sia quindi accontentato della quarta edizione Bideri del romanzo di D’Annunzio e non di una prima edizione, possibilmente quella di pregio in quarto, a tiratura molto limitata, con il medesimo testo impaginato ma decentrato nel riquadro in alto a destra; o al massimo, rinunciando a questo speciale esemplare di dimensioni più consistenti, oramai appannaggio di rari collezionisti, ripiegare almeno sull’altra prima edizione in sedicesimo, peraltro identica alla quarta.
Quale sottile circostanza ha indotto Visconti a esibire invece quest’ultima, appositamente?
La dedica
Sin dal nastro o rullo di partenza L’innocente viscontiano va a intercettare pulsioni intime, pensieri trasversali e preoccupazioni a largo spettro, che solo da un disadattamento sui generis di questo specifico romanzo dannunziano possono trarre linfa vitale o mortale, combinate. Ragion per cui, al netto del commisurato stile filmico o dei temi cari all’autore che trovano la loro ultima e compiuta espressione, l’unica spiegazione pertinente nel ricorso alla quarta edizione Bideri è la diretta provenienza della copia dalla biblioteca personale o di famiglia. Non è un’ipotesi semplice ma legittima, dal momento che nella scena esaminata la conferma arriva a stretto giro (di pagine), quando la mano di Visconti oltrepassa sia il frontespizio che il successivo dipinto di Sartorio (non a caso poi anche cineasta in proprio, a buon intenditore) con il Cristo in croce sovrastato dalla scritta «L’innocente», quindi realizzato dall’artista ad hoc per le sole edizioni Bideri in sedicesimo, dalla prima alla quarta; e scopre finalmente la dedica datata 11 marzo 1892: «Alla contessa Maria Anguissola-Gravina Cruyllas di Rammacca». Ecco svelato l’arcano, per niente riservato all’esigua di schiera di intenditori. Ancora una volta, lo zoom non resta indifferente alla circostanza e in chiave allusiva restringe daccapo il campo visivo a questa dedica evidenziata perciò a chiare e cubitali lettere a tutto schermo. Si noti quanto indicativa sia nella scena in questione la prassi di concentrarsi, tramite l’utilizzo dello zoom, via via sulle pagine che più interessano Visconti, tralasciando le altre.
Nell’ultima stagione della sua filmografia l’effetto ottenuto dalle zoomate consiste nell’evidenziare aspetti già recepiti dal dettagliato quadro largo: ricevendo una chiosa dal lento ingrandimento determinato dall’obiettivo della macchina da presa, tali aspetti vengono sottoposti allo sguardo come segni indelebili di un destino a quel punto incontrovertibile. In questa categoria strettamente indiziaria rientrano tanto le pagine su cui la mano di Visconti si sofferma, senza lo zoom ancillare, quanto il casato degli Anguissola che, con l’effetto rimarchevole dello zoom, trova invece la sua strenua chiave di rilettura filmica.
Il riferimento, per gli studiosi dannunziani, è alla nobile siciliana, figlia di Francesco Gravina, principe di Ramacca, e consorte di Guido Ferdinando Anguissola, figlio di Amilcare. Con la dedicataria contessa Maria Gravina Cruyllas, madre di quattro figli, lo scrittore a Napoli ebbe ai tempi della stesura e pubblicazione de L’innocente una relazione che gli costò una denuncia per adulterio da parte del conte Anguissola. Se si considera la circostanza nella prospettiva biografica di D’Annunzio, interessa relativamente meno sapere che gli Anguissola napoletani sono stati gli unici rappresentanti del ramo di San Giorgio e San Damiano, staccatosi nel 1300 dalla storica famiglia aristocratica ghibellina di Piacenza. Ma se la prospettiva si restringe, come con lo zoom, e diventa quella dell’autore del film, non è di poco conto completare il quadro genealogico con gli Anguissola piacentini. Nel 1884, con la morte all’età di ottant’anni di Francesca (Fanny) Visconti Anguissola, la tenuta di Grazzano passa in eredità al nipote Guido Visconti di Modrone. Alla sua morte questi beni un tempo degli Anguissola e ora dei Visconti, passano al milanese Giuseppe, che sposa Carla Erba, figlia del farmacista Carlo. Giuseppe e Carla sono i genitori di Luchino Visconti di Modrone, le cui origini nobiliari quindi risalgono anche agli Anguissola di Piacenza, tanto che Grazzano è oggi nota come Grazzano Visconti.
La dedica dunque, su una copia privata di Visconti, indica l’ennesimo richiamo autoreferenziale che trascende il dato dannunziano iniziale. E oltre a rendere il fattore cinematografico prevalente su quello letterario, attraverso un sibillino richiamo familiare che soltanto un Visconti di Modrone è in grado di vantare, immette nel tessuto simbolico generale anche quello dello stemma familiare, il biscione azzurro che ingoia nelle sue fauci spalancate un bambino.
I Visconti insomma di «Beati immaculati» come quelli cui è rivolta l’invocazione dannunziana che apre L’innocente, prima della pagina iniziale, se ne intendono, per remoto retaggio, secolare e araldica effige. L’incubo dell’infanticidio, ad opera della serpe dentata che Luchino vede ovunque sin da bambino, da Grazzano a Milano, è un contrassegno di famiglia. Per questa lontana ragione che lo assilla da sempre può far suo un romanzo come L’innocente che si accinge nel film a passare in rassegna, pagina dopo pagina, fino alla pagina numero venticinque, cercando all’occorrenza l’aggancio personale.
Girare L’innocente è in definitiva per lui come girare, alla lettera, le pagine di un libro caro, dove disegni, dediche e invocazioni sono parte di un affare di famiglia, dal lessico alla drammaturgia, dall’iconografia alla sfera affettiva. Tanto che la mirata e meticolosa corrispondenza ricercata specialmente negli abiti e nel portamento tra la madre Carla e la Giuliana del film ne è la prova lampante.
Pagine girate
La prima pausa del regista arriva con le pagine 6 e 7:
Ambedue avevamo creduto al nostro sogno e avevamo proferito più d’una volta, nell’ebbrezza, le due grandi parole illusorie: sempre! Mai Avevamo perfino creduto all’affinità della nostra carne, a quell’affinità rarissima e misteriosa che lega due creature umane col tremendo legame del desiderio insaziabile […]. L’illusione era caduta; ogni fiamma era spenta. La mia anima (lo giuro) aveva pianto sinceramente su la ruina. Ma come opporsi a un fenomeno necessario? Come evitare l’inevitabile? […] In realtà, la nuova vita, non più coniugale ma fraterna, si basava tutta su un presupposto: sull’assoluta abnegazione della sorella. […] La mia gratitudine talvolta diveniva così calda che si espandeva in un’infinità di delicatezze, di premure affettuose. Io sapevo di essere il migliore dei fratelli. Quando ero assente, scrivevo a Giuliana lunghe lettere malinconiche e tènere che spesso partivano insieme con quelle dirette alla mia amante; e la mia amante non avrebbe potuto esserne gelosa […]. Perché Giuliana persistesse in quella meravigliosa forza di sacrificio, bisognava ch’ella mi amasse d’un sovrano amore; e, amandomi e non potendo essere se non la mia sorella, doveva portar chiusa in sé una disperazione mortale.
È il primo segnale di una riappropriazione meditata, cui ha forse concorso la lettura proposta da Carlo Salinari sul rapporto incestuoso che si manifesta tramite l’idea della sorellanza con la consorte Giuliana: «Nell’Innocente l’amore di Tullio per Giuliana è incestuoso perché si riaccende dopo un lungo periodo in cui i loro rapporti erano stati semplicemente fraterni e di qui trae un nuovo sapore». E non è di poco conto che questa interpretazione fraterna, rimodulando una tenerezza tale da rispecchiare il grande affetto che lega Luchino alla sorella Uberta, provenga proprio da Salinari, il quale subentra a Emilio Sereni come guida culturale del Pci. Il rapporto leale ma perennemente conflittuale di Visconti con il Partito comunista italiano trova nella ferma decisione di attingere a D’Annunzio, che non era esattamente tra gli scrittori più graditi alla politica culturale dell’area marxista, per il congedo definitivo dalla vita e dall’arte
La seconda e la terza pausa di queste “pagine girate”, rispettivamente sull’undicesima e la tredicesima, è un richiamo all’appuntamento con il dolore e la morte che Visconti non ha più bisogno di delegare al principe de Il Gattopardo o al professore di Gruppo di famiglia in un interno. Il sentimento della fine imminente lo percepisce dentro, crescente, e sembra fargli balenare un’intenzione funesta e impronunciabile, mutuata dal gesto di Giuliana, poi viene trasferita con probabile enfasi catartica sul personaggio effettivamente negletto e indifendibile di Hermil. A pagina 11, con l’ausilio di Visconti, si legge:
Una domanda mi salì alle labbra: «Hai tu mai avuta la tentazione?» E poi un’altra: «Potrebbe essere che tu cedessi alla tentazione?» Né l’una né l’altra proferii; eppure mi parve ch’ella intendesse. Ambedue oramai eravamo dominati da quel pensiero di morte, da quell’immagine di morte; ambedue eravamo entrati in una specie di esaltazione tragica, dimenticando l’equivoco che l’aveva generata, smarrendo la coscienza della realtà.
A pagina 13 il libro restituisce per intero al regista, per interposto personaggio, il peso insostenibile della malattia che reclama una degenza inaccettabile, contraddetta dall’intimo bisogno di morire, sì, ma senza privarsi del set o restandovi troppo lontano:
Poiché le sofferenze fisiche di lei aumentavano, io e mia madre potemmo con molta fatica ottenere che ella si sottoponesse all’operazione richiesta dal suo stato. L’operazione portava per séguito trenta o quaranta giorni di assoluto riposo nel letto e una convalescenza prudente. Già la povera malata aveva i nervi estremamente indeboliti e irritabili. I preparativi lunghi e fastidiosi la estenuarono e la esasperarono al punto che ella più d’una volta tentò di gittarsi dal letto, di ribellarsi, di sottrarsi a quel supplizio brutale che la violava, che l’umiliava, che l’avviliva.
– Di’, – mi chiese un giorno, con la bocca amara – se tu ci pensi, non hai ribrezzo di me? Ah, che brutta cosa!
E fece un atto di disgusto su sé medesima; e s’accigliò, e si ammutolì.
Il giro di vite, ma non della vita che cede il passo alla tetra e scolpita coscienza della morte, raggiunge l’apice a pagina 25, l’ultima condivisa con lo spettatore:
Tutti i fantasmi delle illusioni e delle commozioni recenti abbandonarono a un tratto il mio spirito, come i fiori d’un albero scosso da una folata gagliarda. E come i fiori caduti sono per l’albero irrecuperabili, così furono per me quelle cose dell’anima: mi divennero estranee. Feci uno sforzo, tentai di raccogliermi; non riuscì a nulla. […]
Scendeva il crepuscolo.
Sopravvivere, giorno per giorno, a condizioni insopportabili, significa sposare il contenuto di quest’estrema assimilazione dannunziana, prima di lasciare che il film faccia narrativamente il suo corso:
Oddio, prima ero libero. Usavo il mio corpo come fosse il fatto più naturale del mondo… Eppoi, di colpo… Be’: lo schiaffo. La revisione. L’improvvisa scoperta che certe cose non avrei potuto farle più… Che la libertà se n’era andata per sempre… Io odio la mia malattia per questo: perché mi ha privato della libertà. Perché mi ha umiliato e mi sta umiliando continuamente. Perché devo imparare a camminare di nuovo, a muovere di nuovo le mani, ad adoperarle di nuovo… Eppoi il bisogno di essere accudito, il bisogno che ci sia sempre qualcuno lì pronto a vestirti, metterti le scarpe, farti la barba, pettinarti… È talmente avvilente, signora mia. Ti ferisce in modo così orribile… E dunque ti ribelli, sicuro. Ma dentro di te, con gli altri non servirebbe, non sarebbe giusto… Certi giorni davvero fatico a sopportarmi, sa. E allora per non pensare, per non “sentire”, mi applico ancora di più, mi sforzo ancora di più… Non che in genere sia molto disciplinato, questo no: fumo ancora, sul lavoro tiro più di quanto dovrei, se prima davo cento adesso cerco di dare almeno novanta. Ho perso un po’ di vivacità, è naturale.
Rigor mortis
Raramente un film ha immagazzinato tanta sofferenza e rilanciato una tenace energia creativa direttamente proporzionale. Lo stato fisico di Visconti si fa stile, e il rigore prepara il terreno dell’irrigidimento del corpo che così coincide con la scelta di campo: un campo immobile al servizio delle immagini in movimento, dove a muoversi sono gli attori all’interno delle sole inquadrature ammesse: quelle fisse o seguite da contemplative ed esauste panoramiche, in cui il principio rotatorio non implica uno spostamento del punto di applicazione della macchina da presa. L’infermità del regista demiurgo esige ora la totale fermezza nel descrivere ambienti, tresche e personaggi, rappresentare dialoghi e azioni altrui, tra crudeltà e auto-persuasione di un’impotenza che in Hermil si sfoga sotto specie di potere infelice, capace appena di togliere la gioia della potenza a chi ce l’ha e ha davanti una vita intera, fino a macchiarsi del peggiore dei delitti.
In The Innocent at Work l’inseparabile Franceschi racconta così il definitivo metodo Visconti: «Era tutta una direzione statica, da un uomo immobilizzato su una sedia a rotelle e che di conseguenza vedeva anche il mondo in una forma sotto un occhio, se posso dire, immobile. La scelta però del film L’innocente in questo senso non fu casuale. Era un film che si prestava ad essere girato concentrandosi soltanto sui personaggi. Non era un film che aveva bisogno di grandi movimenti di azione. Ed era un film che si prestava ad essere diretto da un uomo che non era più padrone dei suoi movimenti. […] La macchina da presa, contrariamente agli altri suoi film precedenti, è una macchina presa statica, immobile. Le varie macchine da presa, perché noi abbiamo girato quasi sempre con due, e in certe circostanze con tre macchine da presa. Ma le macchine da presa erano sempre usate, come Visconti le usava fin da Rocco e i suoi fratelli, in funzione del montaggio, per avere una continuità di recitazione degli attori, una continuità della luce, una continuità di racconto, però erano ferme. I carrelli e gli zoom che lui amava non c’erano più».
E se il direttore della fotografia Pasqualino De Santis solo si permette in fase di riprese di suggerire al maestro una carrellata una tantum, gli arriva addosso un’occhiata fulminante che equivale ad un diniego categorico. Poi un’affermazione lapidaria, in ogni senso: «In questo film la macchina da presa non si muove».
Perché tutto finisca e con cognizione di causa è indispensabile valorizzare qualsiasi tassello del mosaico semantico. Visconti sa di non poter contare sulla coppia di innamorati ambiziosi e spregiudicati dell’Italia unita, Tancredi ed Angelica, poiché il rifiuto congiunto di Alain Delon e Claudia Cardinale gli impedisce di rendere palese la parabola de L’innocente come terribile conseguenza de Il Gattopardo. Ma quella che l’autore giudica una duplice e imperdonabile ingratitudine di due attori che gli devono molto si trasforma in risorsa per l’ultimo film: la bellezza muliebre di Laura Antonelli erotizzata dai film di Salvatore Samperi e la vena da commediante che Lina Wertmüller ha coltivato in Giancarlo Giannini fanno al caso suo.
Antonelli, come ha raccontato il costumista Tosi, è imparagonabile svestita, rispetto a qualsiasi mise aristocratica. Cosicché si consacra con generosa e resistente nudità al desiderio che la sua Giuliana riaccende in Tullio, costretto di conseguenza, con le sembianze pertinenti di Giannini, a tradire l’amante per la moglie, seguendo un copione da commedia involontaria. La partita vincente, nella logica che il film acutamente “veste” e “svela”, premia entrambe: Teresa, da figura protofemminista, seduce senza il corpo ma con l’abito mentale e il rosso che regna addosso e nel suo appartamento ispirandole passione, franchezza e spregiudicata lucidità; Giuliana si concede fisicamente per tentare di proteggere un inconfessabile vero amore e la conseguente creatura che ha in seno, rendendo la sottomissione nell’amplesso con il marito-padrone una maschera necessaria, tale e quale alla veletta stretta sul viso ispirata a una scultura di Medardo Rosso: per vie più traverse il suo è un sintomo d’opposizione, pronta com’è alla “dissimulazione onesta”, alla ribellione covata in gran segreto e, dopo il tragico epilogo natalizio distrutto dall’Erode domestico, all’odio perpetuo.
Controllando qualsiasi strumento a disposizione, umano e materiale, estetico e narrativo, verbale e visivo, tecnico e artistico, Visconti con L’innocente “tradisce” D’Annunzio, ma abbandonandosi allo spirito di chi rimette in discussione principalmente sé stesso, mentre si riflette a mano libera nello specchio dello schermo. Il tradimento è sintomo di liberazione, maturata con la crisi e il declino inesorabile del corpo e la rinuncia coatta al movimento. Respinge pertanto al mittente, quindi al personaggio di Hermil, se non direttamente allo scrittore, la deriva narcisistica intravista anche sulla pagina letteraria; e dai cui limiti lui, intellettuale autocritico versato tanto nella regia teatrale quanto in quella cinematografica, ha intanto preso le debite, risolutive distanze; come del resto dalla vita, suo malgrado, al culmine di una sconsolata razionalità temperata appena da ritratti mariani e cristologici, di madri e bambini stretti in cornici sparse in ogni angolo senziente del film.
Bibliografia essenziale
Nello Ajello, Intellettuali e Pci 1944/1958, Roma-Bari, Laterza, 1979.
Pio Baldelli, Luchino Visconti, Milano, Gabriele Mazzotta, 1982.
Alessandro Bencivenni, Luchino Visconti, Il Castoro cinema, n. 98, Firenze, La Nuova Italia, 1983.
Aldo Carotenuto, Amare tradire. Quasi un’apologia del tradimento, Bompiani, 1991.
Gabriele D’Annunzio, L’innocente, Napoli, Ferdinando Bideri, 1892.
Suso Cecchi D’Amico, Luchino Visconti, Alla ricerca del tempo perduto. Sceneggiatura dall’opera di Marcel Proust, Milano, Arnoldo Mondadori, 1986.
Costanzo Costantini, L’ultimo Visconti, Milano, SugarCo, 1976.
Luciano De Giusti, I film di Luchino Visconti, Roma, Gremese, 1985.
Luciano De Giusti, «L’innocente»: trascrizione e negazione, in David Bruni, Veronica Pravadelli (a cura di), Studi viscontiani, Venezia, Marsilio, 1997.
Giorgio De Vincenti, L’innocente. Da D’Annunzio contro il dannunzianesimo, in Veronica Pravadelli (a cura di), Il cinema di Luchino Visconti, Biblioteca di Bianco & Nero, Quaderni, n. 2, Roma, Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, 2000.
Sigmund Freud, Introduzione al narcisismo (1914), in Id., Psicologia e metapsicologia, Roma, Newton Compton, 1992.
Mauro Giori, Scandalo e banalità. Rappresentazioni dell’eros in Luchino Visconti (1963-1976), Milano, Università degli Studi di Milano/LED – Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2012.
Mauro Giori, Intorno a Luchino Visconti. Dieci sguardi eccentrici, Torino, UTET, 2021.
Anton Giulio Mancino, Pagine girate. Nuovo cinema Pirandello, Torino, Kaplan, 2023.
Ferruccio Pizzamiglio, Renato passerini, Oreste Grana, Giuseppe Visconti di Modrone e il suo borgo medievale, Piacenza, Quaderni del museo della vite e del vino “Fernando Pizzamiglio”, 2020.
Carlo Salinari, Miti e coscienza del decadentismo italiano, Milano, Giangiacomo Feltrinelli, 1960.
Renzo Renzi, Visconti segreto, Roma-Bari, Laterza, 1994.
Gianni Rondolino, Visconti, Torino, UTET, 1981.
Laurence Schifano, I fuochi della passione. La vita di Luchino Visconti, Milano, Longanesi & C., 1988.
Gaia Servadio, Luchino Visconti, Milano, Arnoldo Mondadori, 1980.