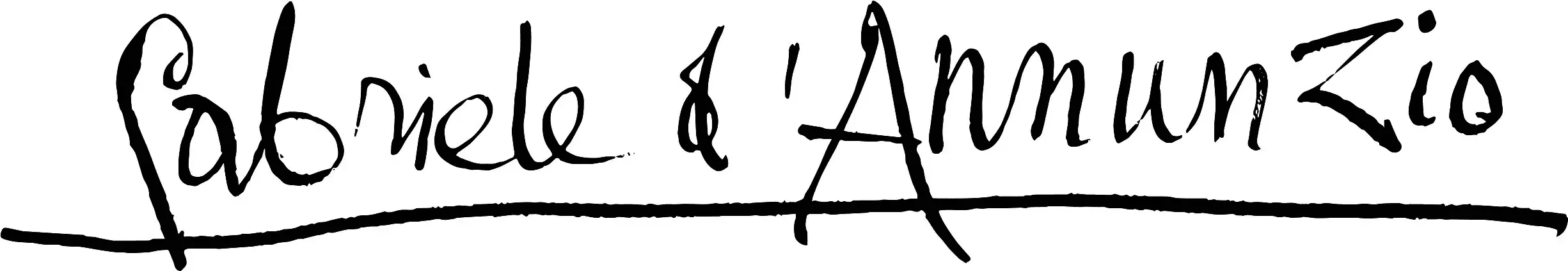di Camilla Ziglia, Enciclopedia dannunziana
Genesi e vicenda editoriale
Il corpus delle poesie “disperse” o “estravaganti” di Gabriele d’Annunzio è costituito da circa duecento testi che non hanno trovato collocazione nel progetto della monumentale Edizione Nazionale delle sue opere diretta dallo stesso autore, in particolare nella sezione dei Versi d’amore e di gloria. Non si tratta solo di inediti privi dell’imprimatur del poeta, ma anche di stampati in periodici non inclusi successivamente nelle raccolte canoniche o presenti nelle prime edizioni delle stesse e rimossi nelle successive. Le fonti dei versi inediti in vita dell’autore sono disparate, talvolta sorprendenti: si muovono fra carteggi e note su taccuini o a margine di libro, supporti scrittori occasionali, qualche braccio di miniera archivistica inesplorato (oltre ai principali, il mercato antiquario annovera ancora molti collezionisti privati); per quanto riguarda le più fitte, ossia gli accoglimenti di singoli componimenti o esigue plaquettes su quotidiani, riviste e periodici, si considerino due fattori alla radice della dispersione: d’Annunzio inviò occasionalmente materiale anche sotto svariati pseudonimi, soprattutto nel periodo giovanile di maggior collaborazione con testate letterarie e politiche, quasi a non voler saturare quotidianamente il pubblico e certo per distinguere con la firma i pezzi di maggiore peso. Il secondo fattore riguarda la natura stessa della destinazione giornalistica: ampia diffusione in contesto di rapido consumo, una vita breve. Esempi di alcune fonti notevoli si daranno in seguito, nella trattazione di singoli testi.
Gli intenti del poeta sono però il primo motivo di questa dispersione. Nel 1926, la costituzione di un Istituto Nazionale per l’edizione di tutte le opere di Gabriele d’Annunzio, sollecitata dall’autore e dall’editore Mondadori, sotto il patrocinio di Vittorio Emanuele III e la presidenza onoraria di Benito Mussolini, diede avvio alla stampa dell’Opera omnia, inaugurata con l’Alcyone (1927): primo onore accordato dallo Stato a un poeta vivente. L’edizione, la cui veste elegante fu curata dallo stesso autore assieme all’editore e al maestro stampatore Hans Mardersteig, offrì a d’Annunzio l’occasione di selezionare la sua vasta produzione sistemandola in base al genere letterario cui le singole opere erano ascritte; poesia (Versi d’amore e di gloria), teatro (Tragedie, sogni, misteri), narrativa (Prose di romanzi) e prose varie (Prose di ricerca). All’interno delle sezioni le opere erano disposte secondo l’ordine cronologico di composizione e/o edizione – categorie non sempre coincidenti – contrassegnato da una semplice data fra parentesi quadre posta sotto il titolo nel frontespizio. L’impresa editoriale obbediva essenzialmente a fini estetici e celebrativi. Alla ricostruzione filologica quindi d’Annunzio riservò un’attenzione e una precisione minori, intervenendo addirittura su qualche data di composizione purché il tracciato fosse netto, e ignorando o ripudiando alcuni testi: accolse, come detto, poesie, romanzi e novelle, testi teatrali, messaggi e scritti critici o saggistici, ma non progettò una raccolta completa degli articoli giornalistici di cronaca o costume. Non progettò neppure una scelta dell’enorme epistolario, anche se ebbe cura di recuperare alcune corrispondenze particolarmente importanti per la sua vicenda sentimentale ed artistica, specialmente con donne.
Seguirono l’editio minor dell’Oleandro (1931-1937) presso la Libreria dello Stato e la pubblicazione postuma (1939-1942) della Fondazione del Vittoriale, che pure rispettarono la volontà del poeta, omissioni comprese.
Furono rinvenimenti successivi di poesie “estravaganti” o manipolate a suggerire a studiosi e ricercatori la curatela di ulteriori apposite raccolte in saggi o articoli. Prima del rimando alla sezione bibliografica, è utile citare i lavori filologici di restituzione, selezione, datazione e commento di Guy Tosi 1946 e 1966; Mario Vecchioni 1964 e 1976; Pietro Gibellini 1976 e 1985; Raffaele Tiboni 1992.
Le poesie disperse e le ripudiate sono state aggiunte a completamento dell’intero corpus dannunziano per la prima volta nelle appendici al primo dei due volumi Versi d’amore e di gloria, in Gabriele d’Annunzio, Tutte le opere, a cura di Egidio Bianchetti per Mondadori (collezione I classici contemporanei italiani, diretta da Giansiro Ferrata), sotto gli auspici della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”. Avviata nel 1939 e pubblicata in prima edizione nel 1950, la raccolta si è in seguito arricchita. L’Appendice I, Dalle prime edizioni (pp. 761-888) contiene testi delle prime uscite di Primo vere e Canto novo in seguito non ristampati, esclusi o non rielaborati. L’Appendice II, Poesie sparse (pp. 891-1031) contiene le estravaganti, mai raccolte in volume unico. L’Appendice III estrapola testi poetici da prose pubblicate. L’Appendice II ebbe travagliata gestazione: già predisposta, andò distrutta a causa di eventi bellici e i curatori si trovarono a recuperare e riunire materiale di reperibilità difficile o impossibile. L’Aggiunta all’Appendice II (due soli sonetti, pp. 1111-1112) è la più recente. La quinta e ultima edizione dell’opera è del 1968.
Ad oggi il volume più completo e aggiornato delle disperse in seno all’opera omnia porta la firma di curatela di Vito Moretti ed è il terzo di Tutte le poesie (direzione di Gianni Oliva per Newton Compton, 1995): Poesie in dialetto, per canzoni e disperse (pp. 226). Il materiale è suddiviso in sei capitoli: Poesie in dialetto (sette rime e due brevissime prose), Testi per canzoni (diciassette testi), Poesie ripudiate (una d’occasione e una silloge di ventuno), Rime disperse e stravaganti (circa centocinquanta), Versi dalle opere in prosa e teatrali (una cinquantina di testi), Motti del «Vittoriale» e altre massime (circa centosessanta); a questa edizione fanno riferimento i numeri di pagina a corredo dei testi riportati, laddove non compaia indicazione di diversa fonte.
Si esaminano ora le poesie raggruppandole nei seguenti paragrafi, all’interno dei quali si considerano in ordine cronologico: Poesie disperse, Poesie ripudiate, Testi per canzoni, Poesie in dialetto.
Poesie disperse
Sono sufficienti le quattro composizioni più antiche, risalenti al periodo liceale, ad abbozzare in nuce quanto sarà e a restituire il peso delle disperse quali tracce biografiche, stilistiche, tematiche o genetiche di tanti editi. Anteriore a tutte, risalente al quindicesimo anno di vita del poeta, è Allegoria (prova di versificazione italiana), che recupera la terzina dantesca per un ricalco del primo canto dell’Inferno, dove al Gabriele-pellegrino in ascesa sul colle si oppongono tre fiere in tutto abruzzesi («uno scheltro di lupo», un mostro «simile a un bove truculento» e un caprone); in ritirata il giovane trova però modo di contrastarle e conclude «Ond’io ripieno di nuovo valore / mi volsi e stetti di offensione in atto». Esercizio giovanile sì, ma è già cosa sua: un confronto stretto con il modello, marchiato del suo noto ardimento. All’8 maggio 1879 risale l’omaggio a un altro suo maestro, Giosue Carducci: le tre strofe asclepiadee di Neèra senza modifica alcuna (se non il nome oraziano mutato in Lilia) confluiranno nella più ampia Suavia (Fantasia) di Primo vere, con il loro metro barbaro. Terza, la romanza Quando siam soli!…, è un ritmo di settenari erotico di ambientazione naturale, eros e natura evolveranno le basi filosofiche ma resteranno sottesi a tanta parte della poetica dannunziana. L’ultima, Sciarada, un madrigale in calce a un’epistola alla madre in forma di dedica e complimento, testimonia un motivo autobiografico, altro elemento mai disgiunto dalla produzione di un poeta tanto in vista quanto il Nostro. Alcuni snodi di attenzione della critica successiva sono dunque già in luce.
Durante l’anno 1880, di intense letture e attività alla revisione «con penna e fuoco» di Primo vere, il sedicenne lascia cinque componimenti estivi pescaresi, uno delle quali (Le litanie di Frate Pippo) si fa notare per il supporto scrittorio: il retro della porta di un camerino dello stabilimento balneare Nettuno a Castellamare Adriatico. L’amena litania, con tanto di formula «ora pro nobis» a chiusa di ogni strofa, invoca l’amore femminile e una «mystica rosa» che non allude certo a Maria Vergine. Fu l’amico dedicatario Filippo De Titta a trascriverla e il musicista Vittorio Pepe compose le note (lo riporta Verlengia 1948, p. 16; torna in Tiboni 1992, p. 41). Le ambientazioni fanno tutte capo alla costa, alla veduta marina, alla percezione delle suggestioni foniche e luminose, alla brama giovanile di vita e, in procinto di ripartire, il Cicognino saluta il suo Abruzzo con tre quartine asclepiadee; ancora ambiente naturale, ossequio carducciano, dato biografico (p. 73):
Al mio Abruzzo
Da questa balza che s’eleva ardita
ti guardo, o Sannio mio;
e in cor mi sento rifiorir la vita
con ardente disìo…
Ah sì, le calme del tuo ciel divine
mi fecero poeta.
I sorrisi di un mar senza confine
là, tra la mia pineta…
E ti mando un saluto, o Sannio fiero,
senza nube d’affanni,
con tutto il foco prepotente e altero
dei miei diciassett’anni.
Con «Ah sì, le calme del tuo ciel divine / mi fecero poeta» parrebbe a una svolta il percorso di travagliata costruzione del sé-poeta, coraggiosamente confessato nel carteggio con l’anima affine dell’esteta e sodale Cesare Fontana: nell’epistola del 20 maggio 1879 lo ammonisce a non cercare la «scintilla del genio» tra i suoi versi che sarebbero «poca cosa!» (Ledda 2004); in questi versi pare invece archiviata ogni insicurezza.
Le poesie disperse mantengono un rapporto di proporzionalità inversa tra la frequenza delle loro stesure e l’impegno contemporaneamente profuso in attività legate alle grandi opere. Nella primavera dell’80, d’Annunzio invia al Chiarini una lettera, annunciandogli il proposito di seguirne i consigli e dedicarsi alle traduzioni: «Ho deciso di non scrivere più versi per un anno, tranne qualche cosuccia che potrà sfuggirmi per un caso qualunque» (Andreoli – Lorenzini 2013). Ebbene, parecchio si è diramato tra le disperse nel 1881: se ne annoverano ben diciannove. È il principio del periodo romano, del resto, di collaborazione con riviste di tiratura non solo locale, ma anche nazionale. Tra i componimenti rinvenuti, Pietro Gibellini segnala Dai “Thalassica” e Thalassica, indicati da nota autografa alla prima come preparatori per un «volume di liriche di prossima pubblicazione» che non è mai stato compiuto: gli sforzi miravano altri bersagli. Nelle due quartine alcaiche Dai “Thalassica” e tra le Marine [Marine I («Preludio», Ancona, 30 marzo 1881), Oliva 1995, p. 77] compare la figura di Lalla, Griselda Zucconi, l’amore più profondo e duraturo dei tempi del liceo, primogenita di Tito, docente di lingua straniera al Cicognini, destinata a diventare «adoratissima ispiratrice» e dedicataria del Canto novo.
Dai «Thalassica»
Appar su ’l lembo de ’1 mare un candido
stormo di vele, candido, e naviga
lontan ne ’l crepuscolo verde
su’ flutti colore di vïola.
Io sogno, o Lalla: noi siam due nàutili
cui la conchiglia sfavilla d’iridi,
lontan ne ’1 silenzio infinito
o Lalla, portati dall’amore.
Il medesimo rapporto di proporzionalità inversa si ripresenta in tutta evidenza all’apertura del nuovo secolo: del primo lustro restano solo uno scritto d’occasione e una dedica allo scultore Leonardo Bistolfi. Del resto, è la composizione delle Laudi a impegnare l’alba del Novecento.
Come accennato, tra le disperse si possono percorrere rami genetici ciechi di opere maggiori in gestazione: il 1882 vede la stampa di Canto novo a maggio e già nei tre sonetti di Rifioritura a fine ’81 si affaccia il tema decadente amore-morte con un approccio rinnovato, meno sognante; a questo fanno seguito, sulla medesima scia evolutiva della nuova raccolta, composizioni nelle quali, pur con metro barbaro spesso ancora e input visivi paesaggistici, scorrono nuovi timbri sensuali («Ecco, io mi sento dentro l’acqua audaci / i muscoli così, validi e fieri, / che tutte v’amerei, brune procaci!», Nell’acqua, sulla «Cronaca bizantina» di gennaio) e in alcune anche dettagli macabri o raccapriccianti (cfr. l’ultima quartina dell’asclepiadeo Dal Canto novo, rinvenuto da Gianni Oliva sul numero unico di «Lucifero», 5 febbraio 1882: «Via via s’incontrano cumuli d’alighe / riarsa, fracidi rottami, sugheri, / carogne brulicanti / di mosconi e di vermini»). In Turf d’Annunzio ambienta in spiaggia le cronache mondane, con asclepiadei a forte riduzione della similitudine per un effetto di maggior condensazione e concretezza. Lo stesso può dirsi per gli esiti del viaggio in Sardegna al seguito di Edoardo Scarfoglio (allora redattore del «Capitan Fracassa») e Cesare Pascarella, esperienza che consegnò alla rivista poesie nate dalle atmosfere della macchia mediterranea, con balenii di sentore nordafricano, sensuali dettagli fisici e rarefazioni evocative miranti alla coincidenza tra ambiente, psiche e linguaggio: Su Campidanu (I La Spéndula, II Sale, III Sotto la lolla, pp. 93-94) e Ella si ferma (I e II, pp. 95-96). Già in autunno però il «Fanfulla della Domenica» propone nel numero del 22 ottobre tre testi che incominciano a indagare le possibilità espressive degli Intermezzi di rime (1883). Un esempio (p. 97):
Penetrale
Ella dritta, ne l’abito d’estate
in casimiro bianco a gale ondanti,
piega su per le braccia incipriate
la pelle di camoscio ampia de’ guanti:
ne ’l cerchio de le pigre iridi ambrate
l’impazïenza brilla. E il sol davanti
riflesso ne lispecchi entra ad occhiate
gaio tra le cortine fluttuanti.
Ella piega il camoscio: i braccialetti,
d’oro, di smalto, d’argento brunito
scendono con sottil tintinnamento…
Ma che scoppii di risa agili e schietti
quand’io mi pungo appena appena il dito
chiudendole un fermaglio sotto a ’l mento!
La forma del sonetto indica un progressivo riavvicinamento al metro tradizionale della lirica italiana, ma la novità sta nella coloritura della scenetta mobile e allegra della chiusa, sonora nei tintinnii dei braccialetti e delle risate, che dà l’addio alla stagione impressionistica. Anche l’apertura allontana i consueti stimoli sensoriali paesaggistici per far ergere la donna («Ella dritta…», v. 1) come primo elemento e relega l’unico dato di natura ai vv. 6-8, in cui il sole appare riflesso e filtrato, contenuto, dominato. Pur in attesa lasciva, la protagonista sfodera la mossa provocante del guanto con una grazia superiore a quella di Rita Hayworth in Gilda, riuscendo così a raggiungere quel tono sofisticato che sarà proprio di Intermezzo di rime.
Parte cospicua tra le disperse trovano gli scritti d’occasione: un’ode per le nozze Belmonte-Torlonia del giugno 1885, due sonetti per le nozze del Duca Leopoldo di Torlonia l’anno successivo; per quelle del poeta Carmelo Errico fu vergato il Trittico delle Sibille nel 1889.
Di vena saldamente patriottica l’ode in terzine di ottonari cadenzati Per gli italiani morti in Africa, pubblicata su «Capitan Fracassa» qualche settimana dopo la disfatta di Dogali e il suo tragico massacro. Sul supplemento de «Il Mattino di Napoli» dell’8 luglio 1894 compaiono tre sonetti celebrativi in cui risuonano su note wagneriane i temi dannunzianamente nietzschiani de Le vergini delle rocce, al tempo in dirittura di stampa. Mancando indicazione del personaggio dedicatario, Pietro Gibellini (1985, pp. 221-222) ipotizza si tratti di Alfred Tennyson, sulla scorta dell’articolo celebrativo, a firma del poeta, Tennyson del 9-10 ottobre 1890 su «Il Mattino», che chiude con le medesime espressioni dei versi: «gli antichi, ne’ sepolcri marmorei, ai piedi della statua giacente solevano porre un veltro. Su la tomba che la nazione inglese darà a Alfredo Tennyson nell’abbazia di Westminster, lo statuario ponga ai piedi del poeta un globo simbolico, a significare che un mondo è finito con lui».
Per un sepolcro
Il più puro dei marmi, o statuario,
nel fianco de la tua grande alpe austera
eleggi, dove solitaria impera
l’aquila sotto il cielo solitario.
E scolpisci su ’l letto funerario,
con ogni tua virtù, l’effigie altera
di Lui composta ne la pace vera
in cui l’addusse il Fato necessario.
Ma non il veltro ai piedi del giacente
porrai, raccolto il lungo dorso in tondo
come solea col dolce suo signore;
sì bene un globo tu porrai, presente
simbolo in terra a figurar che un Mondo
è scomparso col suo Rivelatore.
(p. 138)
La Grande Guerra e l’impresa di Fiume presterebbero eventi ed occasioni per poesie di questo genere, ma poco si tramanda tra le disperse. Due sonetti del 1916 abbracciano il nazionalismo interventista che investe vita, pensiero e azione al rientro in Patria da Arcachon: Dio segnò i confini dell’Italia (vergato nel periodo della convalescenza veneziana e della stesura del Notturno) e A Ugo Ojetti, giornalista. Si fa risalire con ogni probabilità al 1919 La canzone di Fiume liberata, che inneggia ai «fratelli», all’Italia e alla cacciata dei «barbari». Non emerge alcun altro testo databile tra il 1919 e il 1924.
Di seguito una carrellata di protagoniste femminili e qualche occhiata a muse ispiratrici, vicende biografiche sentimentali e frequentazioni sociali.
Segnalo la grazia del sonetto All’inclita duchessa di Bisenti / il poeta Giovanni Casteldieri: la bella donna viene ritratta in atto di prepararsi per la notte e osservata con desiderio dall’esterno. Il poeta le rivolge la preghiera «sceglier vi piaccia l’uno o l’altro corno: / o chiudere i balconi, o aprir le porte!»; deve aver scelto la prima opzione quella sera, perché la composizione successiva parla di un bacio all’ancella della nobildonna, che certo non sarebbe scoccato non solo in caso di apertura delle porte, ma anche solo del balcone. Ancora al 1886 si ascrive il Commiato alla Tiranna di Policoro (p. 125), che anticipa concetti estetici de Il piacere di pubblicazione non distante:
L’avventura è divina. E con lavoro
lento io la volli d’eleganze ornare,
dotta amica, però che a te sien care
in ogni trama vaghe fila d’oro
ed in ogni vivanda spezie rare.
Ma poi che la Bellezza a dir sue lodi
rime sonanti e strofe agili vuole,
pensieri alati e lucide parole,
io comporrò con arte un inno: «M’odi,
alma Apollonia, iddia, d’Elena prole…».
Or tu leggi il racconto. Alta è la notte:
s’affaccia a’ vetri tuoi l’umida Luna
e, lenta, ne la stanza i sogni aduna
che su ’l noto origlier calano a frotte.
Tu le pagine volgi ad una ad una.
E, mentre con un languido sorriso,
ripensi ad Ebe e par ne la solinga
ombra de ’l letto che un timor ti stringa,
tu guardi se non sorga d’improvviso
a le soglie la bionda camarlinga,
àlacre Galatea da ’1 piè silente
cui qual zaffiro l’occhio disfavilla,
e non t’offra con grazïa tranquilla
un canestro di rose, oscuramente
ridendo da la bocca di sibilla.
Nell’aprile 1887 d’Annunzio conobbe ad un concerto Elvira Natalia Fraternali in Leoni, destinata a un amore quadriennale con lui; è la Barbara Leoni, vivificatrice di forze creative (non certo solo per il corpus di circa 1500 epistole), cui alludono atmosfere ne Il piacere e nel Trionfo della Morte. A lei il Nostro spedì nel 1888 Villa d’Este e Rondò dell’attesa e forse è dedicataria anche di Rondò del “Loukoumi” per via della ripetizione di uno stilema (tuttavia, qui il sentimento non è corrisposto e il dato non risulta certo).
La passionalità di Ad lunae sororem, di destinataria sconosciuta, tornò utile in anni successivi, con varianti, per la celebrazione dell’amante Elena Sangro (nome d’arte dell’attrice Maria Antonietta Bartoli Avveduti, la “Ornella” del Vittoriale) nel Carmen votivum (Alla piacente) del 1927, che confluì nel Libro segreto. Fac simile di autografo del 1883 fu pubblicato da Mario Vecchioni (Ad lunae sororem, Pescara, 1956):
Forma che così dolce t’arrotondi
dove si inserta larco delle reni
e, vincendo in tua copia tutti i seni,
ne la mia man che ti ricerca abbondi,
e ti parti, anche duplice, in due mondi
ove il Peccato i suoi più rari beni
chiuder volle per me, come in terreni
paradisi, e i misteri più profondi;
o tu, candida mole che sul vivo
perno ondeggi levata in alti ciel
ove la voluttà i suoi nembi aduna,
risplendi or qui come nel marmo argivo
s’io t’invoco presente, fuor de’ veli,
o carnale sorella de la Luna!
31 luglio 1893
(p. 137).
Alcuni sonetti giungono dal febbraio 1898, poco prima del trasferimento a Settignano. Amori et dolori sacra e La notte apollinea (I e II) trasfigurano la più nota delle amanti dannunziane, Eleonora Duse, in modelli stilnovistici lasciati sullo sfondo di un paesaggio grandioso e vitalistico. Vorticano dolori passionali, estro creativo, tratti medievali della donna e del sacro con contaminazioni superomistiche e baudelairiane («Arde una pia virtù ne gli occhi suoi. / Pel suo cammino ogni albero è un altare / cui pregando in silenzio ella si prostra», La notte apollinea II, vv. 12-14):
Amori et dolori sacra
O tu che su le cose fuggitive
piangi l’unico amor che ti fu santo
e ascolti nel profondo cuore il canto
che consolò le tue sorelle argive,
nell’onda delle tue lacrime vive
il tuo volto sarà pallido e affranto
come l’alga che sola erra nel pianto
dei mari eterni e delle antiche rive;
le tue mani saranno come i fiori
che uccide il vento del deserto atroce;
i tuoi piedi faran vermiglie impronte;
ma io verrò chiamando i tuoi dolori
nella mia gioia, e alla novella voce
tu d’improvviso volgerai la fronte.
«Illustrazione Abruzzese», 1898
(p. 146)
Rimase esclusa dall’opera omnia anche la plaquette di dodici poesie in francese, Sonnets cisalpins (1896), che mai arrivò oltre l’indirizzo del suo traduttore Georges Hérelle. Proprio nel carteggio fra i due fu recuperata dal Tosi (D’Annunzio à Georges Hérelle, correspondance présentée par Guy Tosi, 1946 e inserita in Egidio Bianchetti. App. II, pp. 1004-1015; per il carteggio completo: Cimini 2004).
Gli anni conclusivi della vita trascorsero nel ritiro alla villa Cargnacco di Gardone Riviera sul Garda, dove d’Annunzio attese a diverse occupazioni letterarie, dunque rare risultano le disperse. Alcune note di interesse autobiografico emergono in uno scritto del 1929, che dall’Archivio del Vittoriale ci viene riconsegnato da Pietro Gibellini (1985, pp. 264-265). Il cantor d’Alcyone eroe dell’aria, autoritratto di raro tenore sarcastico, non risparmia il poeta dalla constatazione amara della propria nullità, quasi un Napoleone a Sant’Elena nello scorrere delle imprese lontane e tanto più grandi, quanto più rimarchevoli della piccolezza presente, schiaffeggianti. La via dell’annullamento del gigantesco “sé dannunziano” è ormai intrapresa: il senso della morte come sbriciolamento, lascito e abbandono accomuna le ultime estravaganti, su questa linea Chien couchant, Homme couchant del 1934, Epigramma e Qui giacciono gli inutili miei cani del 1935 (Gibellini 1984, rispettivamente pp. 263, 261, 265-266). Pietro Gibellini rinviene la poesia Qui giacciono gli inutili miei cani e la consegna alle stampe, chiosando:
Sospeso tra una assurda illusione di eterna giovinezza («Sarò di nuovo giovane, sii giovane!») e il brivido di una decrepita vecchiezza, egli non ci lascia, di sé, che un estremo ritratto senza volto: un ritratto del nulla! Gli accade passeggiando nel giardino, in una delle estreme giornate di sua vita, passando accanto al cimitero dei suoi cani. Gli pare di sentire una sorda litania, un triturar d’ossi, una imago mortis fatta del suono segreto della decomposizione. E la registra a lapis sul libro che stava leggendo, chiudendola con una lapidaria quartina, con uno smarrito non-sense […]
Qui giacciono gli inutili miei cani
Qui giacciono gli inutili miei cani,
stupidi ed impudichi,
novi sempre et antichi,
fedeli et infedeli
all’Ozio lor signore,
non a me uom da nulla.
Rosicchiano sotterra
nel buio senza fine
rodon gli ossi i lor ossi,
non cessano di rodere i lor ossi
vuotati di medulla
et io potrei farne la fistola di Pan
come di sette canne
i’ potrei senza cera e senza lino
farne il flauto di Pan
se Pan è il tutto e
se la morte è il tutto.
Ogni uomo nella culla
succia e sbava il suo dito
ogni uomo seppellito
è il cane del suo nulla.
31 ottobre 1935
Il volume in lettura era un diario avventuroso di marina, dal potere certo evocativo per lui: Jurien De La Gravière, Voyage de la corvette. La Bayonnaise dans les mers de la Chine par le vice-amiral, troisième ed. t. I. Paris, Plon, 1872, oggi conservato nell’«Officina» del Vittoriale. Insieme all’Epigramma del febbraio ’35, al rinvenimento il testo fu passato alle rotative del «Corriere della Sera» per un articolo datato 15 novembre 1975 dal titolo D’Annunzio. Versi inediti che parlano di morte; fu poi inserito nella plaquette (illustrata da Luciano Cottini) D’Annunzio, i cani, il nulla, Milano, Sciardelli, 1979; per l’eccezionalità del caso e per il suo pregio artistico che proietta il tardo d’Annunzio in un nichilismo e in modi simbolici nuovi (nonostante il riferimento classico che resta sua cifra), Gibellini incluse il testo nell’antologia scolastica Lo spazio letterario, III, Brescia, La Scuola, 1991, p. 1092 (poi in Tiboni 1992, p. 138).
Sembra soccorrerci la cronologia delle apparizioni per un ritratto più autentico: d’Annunzio potrebbe congedarsi così? Come un petardo nell’atmosfera meditativa esplode Chiosa dantesca (giugno 1936), terzine incatenate erotiche per un mancato atto, «Per la tentata e non penetrata / e non penetrabile Tormentilla», veraci e di immaginazione esplicita. A seguire una quartina celebrativa di ottonari a ritmo di marcia, Sul monumento ai bersaglieri in Roma a Porta Pia, ci restituisce il Capitano, il patriota dal gesto eroico intessuto di arte e gloria. L’ultima, e unica datata proprio l’anno del decesso (1938), è la nota Pasquinata ai danni di Adolf Hitler, rancorosa e sprezzante.
Poesie ripudiate
G. A. Borgese apre così il suo Gabriele d’Annunzio per R. Ricciardi (1909): «Nel marzo del 1879 si pubblicava a Prato un opuscolo, ove i “giovani Vittorio Garbaglia e Gabriele d’Annunzio” facevano “augurii e voti” “all’augusto Sovrano d’Italia Umberto I di Savoia nel… suo giorno natalizio” e vedeva la luce il primo endecasillabo del nuovo poeta: “Lungo i declivi del romuleo Tebro”». D’Annunzio però nell’epistola all’amico Annibale Carrera («Dal Collegio di Prato, il 24 di marzo 1879», Tiboni 1992, pp. 5-6) ne prese le distanze:
Non so capire […] come ti possa piacere quella mia ode saffica, che in verità è tutto ciò che ci può essere di miserabile e di stonato in una poesia; e non accetto quelle lodi che non merito punto punto. Io non avrei voluto stamparla; ma il mio amico Garbaglia mi pregò tanto che alla fine acconsentii. Del resto non ne parliamo più.
Useremo il garbo di passare in sordina quest’ode A Umberto di Savoia, che non conobbe ristampe autorizzate da d’Annunzio e solo nel 1968 fu inserita da Egidio Bianchetti in Appendice I (pp. 763-765). La questione non era di natura politica: la riluttanza dell’autore verteva su questioni formali, anche se risulta ben sorvegliata (considerando anche una mano sedicenne) la strofe saffica carducciana nella gestione dei tre endecasillabi e del quinario in adonio. Vito Moretti, inoltre, nella Nota introduttiva al capitolo delle ripudiate, mette in luce «la chiusa, in cui si fa cenno – premonitoriamente – ai “sogni del vate”, destinati a ben altri sviluppi e accezioni» (Moretti 1995, p. 39).
Maggior rilevanza per la lettura del giovane autore di Primo vere assumono i venti componimenti (in larga parte sonetti) e il Congedo di In memoriam, perché si collocano fra la prima e la seconda edizione della raccolta, nel periodo della revisione «con penna e fuoco» e rispondono proprio all’intenso lavoro di affrancamento dal «maestro avverso» che tanto improntò la prima stesura, «da quel mago del Carducci che mi schiacciava» (epistola del maggio 1881 a Guido Biagi) e giustificano alcuni tagli e motivi nel Primo vere lancianese; a questo si aggiungano letture extrascolastiche di indirizzo europeo (Tennyson, Milton) e di affondo nella poesia classica. Le note prevalenti svelano il compianto per la perdita della cara nonna (Rita Lolli in Rapagnetta, deceduta il 26 gennaio 1879), il dolore con qualche cedimento al macabro, ma anche la tenerezza delicata e affettuosa, il rimpianto dei gesti e dei luoghi del cuore. Sono mantenute corte e tese le redini formali, pur senza perdita di terreno sull’animo di un lettore sensibile al primo grave lutto del poeta ragazzo.
VI.
Era una festa di peschi fiorenti,
di rose, di geranî e di viole
a i canti de le rondini fuggenti,
e gli aurei baci d’un giovine sole.
Io ’nseguivo a gran corsa le splendenti
farfalle via per le stellate aiuole;
nonna seduta dormicchiava, e i venti
le bisbigliavan chi sa quante fole…
Io me n’avvidi, e colsi molte rose,
le sfogliai tutte, gliele sparsi avanti,
ma il cor diceami tante strane cose
mentre pensavo a ’l monte di Flunire
dove cresce guardato da i giganti
quel bianco fior che fa ringiovanire.
XX.
Il dubbio atroce mi rifascia l’anima
e m’abbuia la mente:
o nonna, vieni: ne le veglie squallide
co ’l tuo sorriso d’angelo,
vieni a baciarmi questa fronte ardente.
I miei fantasmi d’òr via si dileguano
come uno stuol lucente
di colibrì ne gli splendor d’un vespero…
O mie strofe rachitiche!
O mia d’arte e d’amor febbre furente!
Un böa immane mi ravvolge e lacera
come gazella a ’l fonte;
tra le spire tenaci invano io m’agito
novo Laocoonte.
Nonna, riporta e sole e verde e cantici
a la mia anima oscura!
Scaccia da me questi feroci lémuri
che mi fanno paura!…
Perché ripudiare la raccolta ed escluderla dall’Edizione Nazionale? Stampata nel maggio 1880 dal tipografo Niccolai di Pistoia, In memoriam procurò non pochi fastidi al poeta. In primo luogo, piombò inaspettata la stroncatura a firma anonima sul «Fanfulla della Domenica» del 24 ottobre, verosimilmente del carducciano Giuseppe Chiarini, che sulla medesima rivista aveva recensito invece l’esordio di Primo vere in termini entusiastici (A proposito di un nuovo poeta, 2 maggio 1880). In secondo luogo, Raffaele Tiboni ricondurrebbe l’avversione dell’autore a dicerie sul cognome, illazioni di detrattori che lo mossero a una tale stizza da voler ritirare e eliminare tutte le copie residue (Tiboni 1992, p. 116).
Testi per canzoni
La sezione raccoglie testi musicati esclusi dai rondò e dalle romanze dell’Intermezzo melico de La Chimera e da tutto il corpus dell’Edizione Nazionale. Si tratta di diciassette componimenti di metro vario, volutamente destinati alla diffusione attraverso la musica e il canto ed entrati a pieno titolo fra le romanze della fiorente stagione del “salotto musicale italiano”. L’ambiente romano favorì la partecipazione del giovane d’Annunzio non solo a circoli letterari e eventi mondani, ma anche a concerti e incontri musicali, in risposta a una passione per questa forma d’arte che sempre accompagnò la sua vita e la sua poetica e maturò fino alle tragedie musicate da autori di fama internazionale di cui si farà menzione.
Assai proficua si rivelò l’amicizia con l’ortonese Francesco Paolo Tosti (1846-1916), tenore affermato, dal particolare profilo riservato alle romanze, che contribuì con d’Annunzio allo sviluppo del genere e alla sua evoluzione sulla linea più impegnata della lirica da camera. Tosti musicò una trentina di testi dannunziani in due periodi: dal 1880 al 1882 diciassette, a tema prevalentemente amoroso, in cui la musica aveva ruolo portante e la parola a servizio (tra le nostre Buon Capodanno, ‘A Vucchella, Malinconia, Visione!, Ninna Nanna, Arcano!, Vorrei); dal 1907 in poi si ampliarono le tematiche e fu protagonista la parola (le Quattro canzoni d’Amaranta, Due piccoli notturni, i due poemetti Consolazione e La sera); si è pensato ai Lieder di Franz Schubert su Goethe. Le romanze del Tosti su versi dannunziani si trovano raccolte in edizione Ricordi 1990.
La prima composizione volutamente per musica fu Visione!, melodia per archi (violino o violoncello) dedicata in stampa alla Signora Ricordi, moglie dell’editore, sotto pseudonimo Mario de’ Fiori; terminus ante quem di stesura è il principio del 1881, stando alle date di due epistole in cui vi si fa riferimento (una a Paolo De Cecco e l’altra a Giselda Zucconi di gennaio e maggio 1881).
Anche fra le romanze da salotto compaiono testi d’occasione (Buon Capo d’Anno, su «Capitan Fracassa» del primo gennaio 1882, una Ninna nanna) e qualche facezia (Vuol note o banconote? su «Cronaca bizantina» del febbraio 1882, al suo direttore dedicata, offrendogli i «fumi» di belle note invece degli «arrosti» di un contributo economico per la rivista).
Sempre al 1882 risale In amaca, diffusa anche in francese e in diverse versioni (a tempo di walzer e per soprano e mezzo-soprano); prosegue l’atmosfera notturna naturalistico-sensoriale appassionata e struggente che sfocia l’anno successivo in Arcano! La vitalità della natura è immersione e condivisione esperienziale, da cogliere come occasione irripetibile. Per un confronto con la produzione maggiore, il 1883 è anche l’anno d’uscita dell’Intermezzo di rime, in cui il «giovane forte e vigoroso del Canto novo si abbandona alla crisi della sazietà e voluttuosamente si immerge nell’erotismo raffinato, nelle torbide eleganze della psicologia salottiera» (Oliva 1995, p. XVII):
Arcano!…
Io credo udir tra li alberi un susurro,
mi giunge in volto un’acre onda di odore;
ma vento non aleggia ne l’azzurro,
tutte dormon le cime entro il chiarore.
Come un velo di sogni, ecco, discende
a raggiar la mia veglia;
un languor dolce le vene mi prende…
È il mio cor che si sveglia!
Io credo udir ne l’aria bisbigliare
de l’acque a riva fulgidi segreti;
ma vento non aleggia sopra il mare,
tacciono le mandole de i poeti.
Come un velo di sogni, ecco, discende
a raggiar la mia veglia;
un languor dolce le vene mi prende…
il mio cor che si sveglia!
Dopo più di tre anni di silenzio e intenso lavoro alla stesura di Isaotta Guttadàuro, Giovanni Episcopo, Poema paradisiaco, L’innocente e Elegie romane, furono vicende personali a riconsegnare d’Annunzio alla romanza. La chiusura del rapporto con Barbara Leoni ispirò Per morire (1892), dedicata all’amico e famoso tenore napoletano Fernando De Lucia; un altro legame porta a un’altra canzone: il volto di ‘A vucchella (la boccuccia) potrebbe appartenere verosimilmente a Maria Gravina Cruyllas di Ramacca, la scandalosa amante del periodo napoletano e oltre.
Sì, comm’a nu sciorillo
tu tieni na vucchella
nu poco pocorillo
appassuliatella.
Meh, dammillo, dammillo
– è comm’a na rusella –
dammillo nu vasillo,
dammillo, Cannetella!
Dammillo e pigliatillo,
nu vaso piccerillo
comm’a chesta vucchella,
che pare na rusella
nu poco pocorillo
appassuliatella…
(p. 28)
Traduz.: Sei come un fiorellino, / tu hai una boccuccia / appena un pochettino / appassitella. // Dai, dammelo, dammelo, / – è come una rosellina –, / dammelo un bacetto / dammelo, Cannetella. // Dammelo e prendilo / un bacio piccolino / come questa boccuccia, // che pare una rosellina / appena un pochettino / appassitella…
Versioni differenti si contendono l’occasione e il luogo della stesura di questa romanza di successo: porrei l’attenzione sul contributo del musicologo Federico Vacalebre comparso su «Il Mattino» del 22/3/2008, che conferma la tesi di Pietro Gargano sulla scorta di un articolo di Oreste Giordano (scrittore, giornalista e biografo di Ferdinando Russo per l’editore Eugenio De Simone, 1927) datato 8/9/1954, ancora su «Il Mattino», intitolato In margine a Piedigrotta, in occhiello Come D’Annunzio scrisse ’A vucchella musicata da F. P. Tosti:
L’articolo di Giordano inizia subito con una rivelazione, mai entrata, neppure per essere smentita, nella storiografia di cantaNapoli:
«Il titolo di “Vucchella” era in origine “Sunettiello”, con dedica a Ferdinando Russo». Poi conferma la datazione del brano al 1892, dopo la fondazione del quotidiano di Scarfoglio e della Serao. «Ecco, testualmente, quello che mi raccontò Ferdinando Russo», scrive Giordano (…): «Mi pare di vederlo nella nostra redazione, al Mattino… Una notte, seduto accanto a me che lo ascoltavo parlare… mi disse sorridendo: “Voglio provare a scrivere in napoletano”. Mi tolse la penna, tirò a sé davanti una cartella e dopo poco di domandò: ‘Dimmi: come si dice in dialetto pochino, pochino?” “Pucurillo pucurillo”. “E come si dice appassita, vizza?” “Appassuliata, appassiulatella”. “Sorrise e cominciò a scrivere, mentre io lo guardavo attento: “Sunettiello, a Ferd. Russo”».
Russo vorrebbe contendere a d’Annunzio il conio del neologismo «appassiulatella»? Del resto una lezione simile, ma si badi non coincidente, riporta un testo anteriore (1889), Ammore abbasato di Salvatore Di Giacomo («Vuie comm’a ll’uva ’e contratiempo site, / nu poco poco appassuliatella»). Anche se per il poeta fu quasi un gioco, non solo della fortuna musicale parla il suo successo in seno alla canzone napoletana (pur con qualche cadenza abruzzese), ma anche della levità dei diminutivi, dei vezzeggiativi che fanno un garbato verso alle sonorità partenopee più spiccate, come pure lo scherzoso «dammillo e pigliatillo». Pare fosse restìo alla divulgazione l’autore: ʼA vucchella comparve infatti solo nel 1903 sul «Mattino»; una volta musicata, fu interpretata e lanciata da voci di spicco (Caruso, Gigli, Schipa, Di Stefano, Tagliavini, Murolo, Bruni, Lanza, Tebaldi, Bruson, Ricciarelli, La Scola, Carreras, Pavarotti, Rondinella e altri).
Le Romanze del Tosti riportano per il 1893 due composizioni di ampio respiro: Consolazione e La sera (diciassette quartine di endecasillabi a schema rimico incrociato raggruppate in otto sezioni la prima e dieci in tre sezioni la seconda): una consolatio ad matrem e un pastiche tra Mendés e Moréas di apertura simbolista, confluiti nel Poema paradisiaco. I due poemetti manifestano i segni della svolta in ambito superomistico e nietzschiano che allontanò il poeta dalla romanza da salotto italiana, per avvicinarlo alla scena operistica internazionale attraverso la collaborazione di Alberto Franchetti (musicò La figlia di Iorio per la prima alla Scala del 1906) o di Ildebrando Pizzetti La nave stesso anno, Pietro Mascagni (Parisina), Claude Debussy (Le Martyre de Saint Sebastien) e altri.
Tosti emigrò in Inghilterra, i musicisti attingevano ormai al repertorio dannunziano pubblicato senza più accordi con il poeta e la partecipazione di d’Annunzio alla scena musicale per romanze e liriche da camera si esaurì non senza aver «contributo in varia misura al superamento del melodramma, che è fatto rimarchevole nell’Ottocento musicale italiano» e aver «dato alla produzione melodica un impulso fuori del comune» (Moretti 1995, p. 20).
Poesie in dialetto
Alberto Asor Rosa conferisce a Gabriele d’Annunzio l’attributo che egli riserva al protagonista de L’innocente, “multanime”, per la sua capacità di porsi in apertura su svariate esperienze di vita e di scrittura. Non stupisce quindi che, fra le varie esplorazioni, il poeta abbia soggiornato anche fra i dialetti, e più d’uno, li abbia frequentati e vi abbia reperito materiale fruibile. Oltre al pescarese e a idiomi abruzzesi (intrusioni nelle Novelle della Pescara, Trionfo della morte, La figlia di Iorio), oltre a schegge venete ne Il fuoco e sarde in Più che l’amore, napoletana è ‘A vucchella; esistono pure prove di romanesco (tentativi e calchi con minime varianti alla raccolta dei Sonetti romaneschi del Belli in suo possesso) e milanese (Ho sagiàa del Paradis e Ah, Gabriell de la mala fortuna).
Le lingue locali assorbite volutamente non solo nei luoghi d’origine, ma in diverse regioni italiane, sono uno degli aspetti della sua insaziabile ricerca di ritmi, sonorità, potenzialità significative arcaiche o effetti mimetici; eppure «il plurilinguismo di D’Annunzio (…) diviene elemento di un assiduo e costante monostilismo» (Gibellini 1979) e i vernacoli sopportano in d’Annunzio lo scotto di una comune percezione gerarchica della dignità letteraria che li subordina alla lingua nazionale: Dante Isella, del resto, nella Prefazione alle Poesie di Carlo Porta (autore presente al Vittoriale) per Garzanti (1975), conferma con decisione «l’assurda qualifica di “minore”» riservata alla letteratura dialettale, non certo solo dal pescarese. E con coerenza, infatti, d’Annunzio tratta la propria produzione, a partire dal fatto che non esista nel progetto del 1927 una sezione riservata.
Compaiono sì nell’Edizione Nazionale testi in prosa o in poesia dialettale, ma restano funzionali alla poetica in lingua italiana, all’interno di opere già diversamente connotate. Non è il caso in questa sede di ripercorrere l’ampia considerazione critica della funzione dei dialetti o del rapporto con il Verismo (rimando solo ai numerosi atti del I Convegno internazionale di studi dannunziani, D’Annunzio giovane e il Verismo, Pescara, Centro Naz. Di Studi Dannunziani, 1980 e agli studi di Ernesto Giammarco, Vito Moretti e Mario Vecchioni in bibliografia), ma l’approccio al vernacolo non va sottovalutato: è sempre stato in fondo “lettura attenta, e di poeta” come notano Eurialo De Micheli (De Michelis 1976, pp. 100-109) e Pietro Gibellini (Gibellini 1979, p. 155) a proposito dell’attenzione non esclusivamente bozzettistica o comica riservata al verso romanesco di Giuseppe Gioachino Belli, al ritmo dei suoi sonetti e al sostrato culturale delle espressioni, nonché alla sorprendente conservazione delle sue opere al Vittoriale nella stanza della Leda come livre de chevet (Gibellini 1979, De Michelis 1976). Stessa attenzione viene riservata al milanese di Carlo Porta, da cui ricava la lingua di alcune prove e un centone (Fondo Baccara, BXV, c. 1, a penna; ms. apografo):
Ah, Gabriell de la mala fortuna
dov’eel ch’el t’ha redutt el tò destin!
Gabriell e Canaja l’è tuttuna.
Apoll desbirolaa dalla veggiaia
Apoll scommunicaa dal Vatican
Apoll intapponii su’n pocch de paja
e riscommunicaa da Ca’ Marin
el dichiara e el protesta a tutt Milan
el protesta e el dichiara, Ernest, a tì:
«Ohi, ohi, mi creppi! Ma no stèl a dì»
9 III 1928
Gabriel el poetta ambrosian
Se i primi affioramenti del dialetto abruzzese nelle prose giovanili ricalcano materiale folkloristico preesistente (le Tradizioni popolari abruzzesi di Gennaro Finamore o gli Usi e costumi abruzzesi di Antonio De Nino) e alludono forse più agli studi di Ernesto Monaci che a strette frequentazioni di popolani abruzzesi, d’Annunzio si appropria del mezzo linguistico e delle tradizioni con sempre maggiore spontaneità e autonomia. Ricordiamo del resto che al Cicognini si sentiva preso in giro per l’accento e che il padre gli impedì per un certo periodo il rientro a casa per indurlo a respirare toscano e non doversi inginocchiare un domani a risciacquare cenci in Arno. Tuttavia nelle Novelle della Pescara, ad esempio, d’Annunzio connota alcuni personaggi alla maniera verista e successivamente matura l’idea di una pentalogia tragica di stretta ambientazione abruzzese con un ruolo più sostanziale e archetipico del vernacolo, oggetto di ricerca della sua «archeologia linguistica»; elabora solo I figli della terra (alle stampe in lingua più toscaneggiante che pescarese con il titolo La figlia di Iorio) e La fiaccola sotto il moggio.
Sono nove (sette poesie e due prose di poche righe) i testi di autonoma produzione dialettale abruzzese, tutti indirizzati a parenti o amici lontani che il vernacolo avvicina nell’occasione, nel gioco scherzoso, nella nostalgia, nella solitudine; non costituiscono sistema né raccolta nel repertorio dannunziano, la lingua mantiene veste letteraria nella metrica, nel ritmo, ma tende una mano alla vita estranea al mondo intellettuale, come a smarcarsi dalla pretenziosità dei toni affettati, dalla sacralità del segno straordinario per recuperare con un poetico confidenziale le persone familiari, i racconti e le geografie, assorbire lo spazio-tempo, assottigliarlo nelle onde della sonorità domestica, a partire dal potere di evocazione proustiana di un dolce o di un’essenza in ampolla di vetro inviatigli in dono perché vi trovasse un nome di successo. Di toccante elegiaca malinconia la visione della madre alla finestra durante una festa paesana (A Giacumìne Acèrbe); viva di efficacia popolare l’immagine della suzione vorace dal seno («sise») d’Abruzzo nella degustazione di un «parrozze nove»:
A Luiggìne D’Amiche
È ttante bbone ’stu parrozze nóve
che pare na pazzie de San Ciatté
ch’avesse messe a ’su Gran Forne té
la terre lavurate da lu bbove,
la terre grasse e lustre che se coce,
chiù tonne de ’na pròvole, a su foche
gientile, e che duvente a poche a poche
chiù doce de qualunque cosa ddoce.
Benedette D’Amiche e San Ciatté!
O Ddie, quanne m’attacche a lu parrozze,
ogne matine, pe lu cannaròzze
passe la sise de l’Abbruzze mé.
9 nov. 1926
Gabriele
(pp. 10-11)
Questo madrigale risale agli anni del Vittoriale, si pensi al peso pubblicitario della sua comparsa a dicembre su Il Secolo! «Luiggìne» è Luigi D’Amico, l’imprenditore dolciario che nomina anche la quartina I biscotti D’Amico (rinvenuta da Pietro Gibellini e pubblicata in Quaderni del Vittoriale nel 1977) e la prosa breve Care Luiggìne. Sempre in lode ad una torta, ma questa volta in milanese, un testo emerso dall’Archivio Personale (lemma 783) è reso noto dall’Antongini (D’Annunzio milanese, in «La Martinella di Milano», gennaio-febbraio 1965, p. 2730).
La più antica composizione rinvenuta è un sonetto del 1885 alla sorella maggiore Anna Maria Filomena in attesa (la prima delle sue tredici gravidanze). Con il tono divertito di un blando body shaming tipicamente fraterno, d’Annunzio nota che il bustino stringe e chiede l’intercessione di Sant’Anna protettrice delle «panzette» affinché il parto sia indolore e, in linea con la concezione dei generi dell’epoca, il figlio decisamente maschio «c’a da tené na belle piccarelle / sopra nu belle pare de fasciulone».
I motteggi salaci con gli amici paiono ricondurli al suo desco o a scorribande giovanili, grevi di trivialità vernacolare come si usa fra ragazzi e anche qui l’intento del cuore è l’azzeramento spazio-temporale. Durante la stesura delle Canzoni delle gesta d’Oltremare, dalla Francia così scrive all’amico abruzzese Ettore Janni (curatore a Milano della rubrica di recensioni letterarie del «Corriere della sera») in risposta a un telegramma inviatogli dallo stesso con altri sodali:
A l’Abbruzzise de Melane
J’ v’arrengrazie, amice sciampagnune.
Bïate a vu ca stete ’n cumbagnie,
’nnanze a lu foche, a fa’ na passatelle!
J’ cqua me more de malingunie.
Cqua me s’abbotte proprie li cujjune.
Cante e ccante, mannaggia la Majelle,
j’ nen ne pozze cchiù nghi sti canzune.
La sacce ca lu laure è bbone e belle.
Ma ’n ganne e ’n core tenghe na vulìe
de laure cotte nghi li capitune.
Me so’ stufate a ostreche e sardelle.
Me putesse magnà la Mezzalune
sane sane, nghi quattre pipintune
di li nuostre, mannaggia la Majelle!
1912 Don Gabbriele d’Annunzie
Al di là di notazioni antropologiche e linguistiche, anche composizioni in sé trascurabili nel tracciato artistico restituiscono un d’Annunzio inedito, colto in una personale “storia dell’anima” che può collocarsi accanto al materiale epistolare. Così la solitudine malinconica dell’autore in fase di concentrazione creativa perde i connotati melensi o austeri della tradizione e si colora in questo agile sonetto di fresca autoironia nel doppio senso di «laure», alloro poetico e ingrediente culinario. Quasi i panni di un personaggio plautino, di una maschera di crapulone, travestono di comicità stanchezza e nostalgia.
Bibliografia essenziale
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, I, Appendice I (Dalle prime edizioni), Appendice II (Poesie sparse), Aggiunta all’Appendice II, in Id., Versi d’amore e di gloria, a c. di Egidio Bianchetti, Milano, Mondadori, 1968.
Gabriele d’Annunzio, Poesie in dialetto, per canzoni e disperse, III, a c. di Vito Moretti, in Tutte le poesie, a c. di Gianni Oliva, Roma, Newton Compton, 1995 (a questa edizione fanno riferimento i numeri di pagina a corredo dei testi riportati, laddove non compaia indicazione di diversa fonte).
Rime disperse e stravaganti.
Pubblicazioni parziali di componimenti autonomi:
Giuseppe Fatini, Le prime esperienze di un grande poeta (1879-1881). Pagine sconosciute di G. D’Annunzio sulle Odi di Orazio, «Il Resto del Carlino», 1 dicembre 1927, poi in: Giuseppe Fatini, Il cigno e la cicogna, Firenze, La Nuova Italia, 1935, pp. 318-327.
Ferdinando Pasini, La quartina della riconoscenza, «L’Italia letteraria», 6 ottobre 1929.
Tomaso Fracassini, Gabriele D’Annunzio convittore, Roma, Casa del Libro, 1935, pp. 3-15, e anche in «Nuova Antologia», 1 aprile 1939, pp. 354-356.
Mario Guabello, Catalogo ragionato della collezione di libri e autografi di G. D’Annunzio, Biella, 1938, poi: Raccolta dannunziana Mario Guabello. Catalogo ragionato, ediz. definitiva, Biella, 1948.
Giuseppe Fatini, Nascita del Canto novo di D’Annunzio con versi e lettere inedite, «Nuova Antologia», 1 luglio 1942, pp. 24-35.
Guy Tosi, “Sonnets cisalpins” de D’Annunzio, in D’Annunzio à Georges Hérelle, correspondance présentée par Guy Tosi, Paris, Editions Denoël, 1946, pp. 308-315; sempre in lingua francese anche in Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, I, Appendice II, a c. di Egidio Bianchetti, Milano, Mondadori, 1968, pp. 1004-1015.
Francesco Verlengia, I primi componimenti scolastici di G. D’Annunzio, «Rivista Abruzzese», 1, gennaio-marzo 1948, pp. 11 e 16.
Emilio Mariano, II patto d’alleanza fra Eleonora Duse e G. D’Annunzio, «Nuova Antologia», gennaio (pp. 3-16) e febbraio 1951 (pp. 144-153).
Guy Tosi, Poesie dimenticate di G. D’Annunzio, «Quaderni dannunziani», XXXIV-XXXV, 1966, pp. 469-472.
Luigi Martellini, Il mare, il mito. D’Annunzio a Porto San Giorgio (1882-1883), Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1975, p. 23.
Mario Vecchioni, Tre dimenticate poesie di G. D’Annunzio, «L’Osservatore politico letterario», XXI, 9, settembre 1975, pp. 72-80.
Mario Vecchioni, Poesie sconosciute di G. D’Annunzio, riesumate e commentate da Mario Vecchioni, Pescara, Aternine, 1976, p. 50.
Pietro Gibellini, Liriche estravaganti di G. D’Annunzio, «Strumenti critici», 29, 1976, pp. 87-103.
Pietro Gibellini, D’Annunzio, i cani, il nulla, Milano, Sciardelli, 1979, poi in op. cit., pp. 261-266.
Eurialo De Michelis, Briciole dannunziane, «Rassegna di cultura e vita scolastica», XXXIII, 1-2, gennaio-febbraio 1979, pp. 1-2.
Raffaele Tiboni, Rime inedite e stravaganti di G. D’Annunzio, «Oggi e Domani», IX, 4, aprile 1981, pp. 5-24.
Pietro Gibellini, Logos e Mythos. Studi su Gabriele d’Annunzio, Firenze, Olschki («Saggi di Lettere italiane»), 1985, pp. 213-219.
Raffaele Tiboni, Rime inedite e stravaganti di G. D’Annunzio, in Scritti dannunziani, Pescara, Ediasr-Oggi e Domani, 1992, pp. 109-148.
Bibliografia di riferimento
Alighiero Castelli, Pagine disperse. Cronache mondane-letteratura-arte. Di Gabriele D’Annunzio, Roma, B. Lux, 1913.
D’Annunzio e Filippo De Titta: carteggio, 1880-1922 e altri documenti dannunziani, a cura di Enrico Di Carlo, Lanciano, Rocco Carabba, 2007.
Roberto Forcella, D’Annunzio, I e II, Roma, Fondazione Leonardo per la Cultura italiana, 1926 e 1928.
Angelo Sodini, Ariel armato. Gabriele d’Annunzio, Milano, A. Mondadori Editore 1931.
Mario Vecchioni, Ad lunae sororem, Pescara, Arte della Stampa («Piccole monografie dell’Archivio dannunziano»),1956.
Vincenzo Vicoli, Versi inediti di G. D’Annunzio. Per la grotta del Cavallone, «Il Giornale d’Italia», anno IX, n. 209, 28 luglio 1909, p. 3.
Gabriele d’Annunzio. Primo vere, A. Andreoli – N. Lorenzini (a c. di), ed. digitale Mondadori, 2013, p. 258.
Mario Cimini, Carteggio D’Annunzio-Hérelle (1891-1931), Lanciano, Carabba, 2004.
Gabriele d’Annunzio, Il fiore delle lettere. Epistolario, a cura di Elena Ledda, intr. di Marziano Guglielminetti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, pp. 52-53.
Poesie ripudiate
Gabriele d’Annunzio, In memoriam, Pistoia, Niccolai, 1880; poi in: Tommaso Fracassini, G. D’Annunzio convittore, Roma, Casa del Libro, 1935, pp. 3-15.
Gabriele d’Annunzio, All’Augusto Sovrano d’Italia Umberto I di Savoia, opuscolo scolastico Real Convitto «Cicognini di Prato», 1879; poi in Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, I, Appendice I, a c. di Egidio Bianchetti, Milano, Mondadori, 1968, pp. 763-765.
Bibliografia di riferimento
Giuseppe Antonio Borgese, Gabriele d’Annunzio. Con bibliografia, ritratto e autografo, Napoli, Ricciardi, 1909.
Raffaele Tiboni, G. D’Annunzio e l’ode a Re Umberto, in Scritti dannunziani, Pescara, Ediasr-Oggi e Domani, 1992, pp. 5-6.
Luigi Chiarini, Gli esordi di D’Annunzio nelle critiche del Chiarini, «Il Giornale d’Italia», 4 aprile 1934, p. 3.
Raffaele Tiboni, G. D’Annunzio e l’ode a Re Umberto, In Id., Scritti dannunziani, Pescara, Ediars-Oggi e Domani, 1992, pp. 5-6.
Testi per canzoni
Francesco Paolo Tosti, Romanze su testi di G. D’Annunzio, Milano, Ricordi, 1990 (parziale).
Bibliografia di riferimento
Gabriele d’Annunzio, Lettere a Giselda Zucconi, a cura di Ivanos Ciani, Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani, 1985.
Franco Di Tizio, F.P. Tosti, Pescara, Brandolini, 1984.
Oreste Giordano, Ferdinando Russo, L’uomo-il poeta, Napoli, Eugenio De Simone, 1927.
Vito Moretti, La problematica musicale nell’estetica di D’Annunzio e le collaborazioni dal Tosti al Debussy, in Idem, Gabriele D’Annunzio, Firenze, La nuova Italia, 1989, pp. 10-17.
«Rassegna dannunziana», a. VI, n. 14, dicembre 1988, pp. X-XVII.
Federico Vacalebre, «A’ vucchella» al Gambrinus? No, al Mattino, «Il Mattino», 22 marzo 2008, p. 45.
Poesie in dialetto
Componimenti autonomi in dialetto sono stati restituiti in pubblicazione parziale:
AA.VV., Gloria alla terra! Gabriele D’Annunzio e l’Abruzzo, Pescara, Ed. Dannunziana Abruzzese, 1963, p. 123.
Mario Vecchioni, Abruzzo dannunziano. Versi e prose dialettali di G. D’Annunzio, Roma, Aternine, 1964, p. 44.
Pietro Gibellini, Liriche estravaganti di Gabriele D’Annunzio, «Strumenti critici», 1976, 29, pp. 87-103.
Emilio Cecchi, Pagine disperse di Gabriele D’Annunzio, «La Tribuna», 27 maggio 1913, p. 3.
Mario Vecchioni, Poesie sconosciute di G. D’Annunzio, «L’Osservatore politico-letterario», novembre 1976, 31, pp 41-56.
Pietro Gibellini, D’Annunzio dialettale: versi inediti, «Quaderni del Vittoriale», giugno 1977, 3, pp. 10-16.
Pietro Gibellini, Il coltello e la corona. La poesia del Belli tra filologia e critica, Roma, Bulzoni, 1979, («Pyramidion», 6), pp. 160-161.
Raffaele Tiboni, Rime inedite e stravaganti di G. D’Annunzio, Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani, 1981, pp. 21-22.
Mario Vecchioni, L’Abruzzo di G. D’Annunzio, Pescara, Italica, 1983, pp. 118-124.
Pietro Gibellini, Logos e Mythos. Studi su Gabriele d’Annunzio. La biblioteca dialettale, Firenze, Olschki («Saggi di Lettere italiane»), 1985, p. 231.
Gianni Oliva, Carlo De Matteis, Abruzzo, Brescia, La Scuola, 1986, p. 226.
Vittoriano Esposito, Per un altro D’Annunzio, Roma, Dell’Urbe, 1988, pp. 77-80.
Bibliografia di riferimento
Antonio De Nino, Usi e costumi abruzzesi, Firenze, Barbèra, 1881, vi.
Gennaro Finamore, Tradizioni popolari abruzzesi, Lanciano, R. Carabba, 1882-1886, iii.
Credenze, usi e costumi abruzzesi raccolti da G. Finamore, Palermo, Libreria internazionale Pedone Lauriel, 1890.
Mario Vecchioni, Lettere inedite di G. D’Annunzio ai genitori, alla sorella Anna e al fratello, Pescara, Aternine, 1953.
Ernesto Giammarco, Il vernacolo abruzzese nella narrativa e nella drammaturgia dannunziana, «Abruzzo», I, 3, settembre-dicembre 1963, pp. 271-291.
Eurialo De Michelis, Sincero amante del Belli, in Roma senza lupa. Nuovi studi sul D’Annunzio, Roma, Bonacci editore, 1976, pp. 100-109.
Pietro Gibellini, Il coltello e la corona. La poesia del Belli tra filologia e critica, Roma, Bulzoni, 1979, («Pyramidion», 6), p. 150.
AA.VV., D’Annunzio giovane e il Verismo, Atti del I Convegno internazionale di Studi Dannunziani, (Pescara, 21-23 settembre 1979), Pescara, Centro nazionale di Studi Dannunziani, 1980.
Gabriele d’Annunzio, Lettere inedite di D’Annunzio alla famiglia d’origine, a cura di Raffaele Tiboni, Pescara, Centro Nazionale di Studi dannunziani, 1984.
Vito Moretti, Il volo di Icaro. Temi e modelli della scrittura dannunziana, Bomba, Troilo, 1994, pp. 120-134.