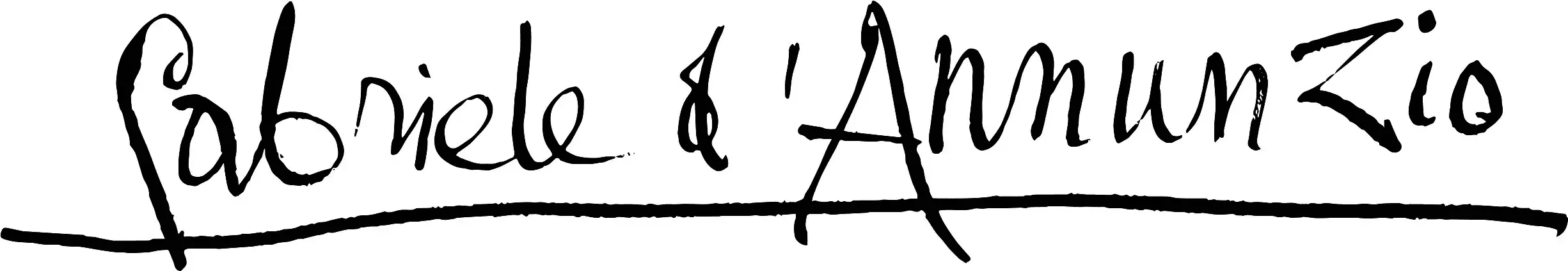di Andrea Lombardinilo, Enciclopedia dannunziana
Genesi, elaborazione, vicenda editoriale
Scritto per l’impresario Adolfo Re Riccardi, Più che l’amore va in scena al Teatro Costanzi di Roma il 29 ottobre 1906, affidato alle cure della Compagnia di Ermete Zacconi. L’impresario riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’attività drammaturgica dannunziana: «Re Riccardi acquisì i diritti d’autore sulla prima rappresentazione del Più che l’Amore (1906) e del Ferro (1913-1914), investì infruttuosamente su uno dei più notevoli incompiuti dannunziani, la commedia Amaranta, e fu il tramite del poeta con l’impresaria Andrews per l’acquisizione dei diritti sulla rappresentazione americana dello stesso Più che l’Amore» (Salvatore 2014, p. 142). L’edizione a stampa, diffusa da Emilio Treves, apparve in libreria il 10 gennaio 1907, per rispettare la clausola di non diffondere il testo a stampa a distanza di due mesi dalla prima rappresentazione. Una vicenda redazionale e editoriale complessa, considerata tale anche da d’Annunzio, che così scriveva al suo editore il 19 marzo 1906:
Non ti parlai del nuovo dramma perché, in verità, quando ti vidi, non ci pensavo neppure. Volevo terminare il romanzo; ma, non potendo ottenere una dilazione dell’impegno assunto verso il R. R., fui costretto a comporre il dramma promesso. Ora, non avendo dato finora alcun volume alla Libreria editrice, come avrei potuto onestamente sottrargli questo? Non puoi non riconoscere la dura necessità. Ad ogni modo, un’altra necessità di disegna: quella di trovare una via d’uscita.
Oggetto del contendere, l’ipotesi di abbandonare la casa editrice Treves per sfruttare le migliori condizioni proposte dalla Libreria Editrice Lombarda che sarà fondata di lì a breve da Tom Antongini e Arnaldo De Mohr. Dopo il primo avvio dell’agosto 1895 a Forte dei Marmi, la stesura del dramma avviene nella villa La Versiliana del conte Digerini Nuti tra febbraio e metà ottobre 1906, a ridosso della prima del 29 ottobre. Proprio quel giorno d’Annunzio scrive nuovamente all’editore, in ambasce per il braccio di ferro con Re Riccardi: «il Comm. R. R. persiste a credere che si debba attendere ancòra qualche settimana – per la pubblicazione del libro. Ma io rimanderò le bozze corrette, appena sarà tornato alla Versiliana (giovedì o venerdì); e potrai ordinare la tiratura. All’ultimo momento otterrò – spero bene – la rinuncia all’attesa inutile». Contrariamente a quanto comunicato, l’attesa sarà ottenuta da Re Riccardi, con il quale d’Annunzio stringe rapporti operativi proprio dal febbraio 1906, come dimostra la fitta corrispondenza curata da Eugenio Salvatore. Paradigmatica la lettera del 14 ottobre 1906:
= Ecco, in fine, un argomento grave.
Io ti promisi di non pubblicare la tragedia se non un paio di mesi dopo la prima. Io stesso penso che questo indugio sia utile. Ma il Comm. Emilio Treves tempesta per metter fuori il volume il giorno dopo la prima. Per frenarlo, ho dovuto confermare l’impegno preso con te.
Ora tu devi farmi il piacere di scrivergli (via Palermo, 12. Milano) dicendoti dolente di non poter consentire alla pubblicazione e deliberato di valerti dell’impegno da me formalmente assunto nel concludere il contratto. Aggiungerai che − regolandoti sull’esito della rappresentazione − potrai abbreviare i termini, lieto di usargli cortesia.
Grazie.
Interrottasi pochi mesi del rientro in Italia, la collaborazione con Re Riccardi si rivela proficua, come confermano le stesse informazioni relative al Più che l’amore: dall’iniziale struttura in quattro atti, da concludersi entro la fine di marzo, d’Annunzio passa a tre atti, da concludersi entro la fine di maggio, fino alla struttura definitiva in due atti, con la protagonista che assume il nome definitivo di Maria Vesta al posto del precedente Maria Grisi. Non meno complesse si rivelano le trattative per la rappresentazione, che d’Annunzio avrebbe voluto affidare alle professionalità congiunte delle compagnie di Ermete Zacconi e Virginio Talli. Le attese imposte dalla compagnia Stabile di quest’ultimo spingono l’autore, a malincuore, ad affidarsi a Ermete Zacconi e Cristina Ines, con i quali Re Riccardi era in trattativa da tempo per mettere in scena la tragedia. Dalle lettere si scopre inoltre che d’Annunzio riteneva che ottobre non fosse il mese migliore dal punto di vista del coinvolgimento del pubblico. Ne scrive il 13 agosto 1906 da Marina di Pietrasanta:
Mio caro amico, da più parti ricevo lettere di rammarico per l’intempestiva rappresentazione del Più che l’Amore a Roma in ottobre. Anche Vincenzo Morello mi scrisse ieri dal Rigi dimostrandomi «l’abominazione della desolazione» di Roma a mezzo ottobre! D’altronde tutti riconoscono che la ‘prima’ della tragedia romana dev’esser data nell’Urbe, non a Bologna dove l’avvenimento sarebbe menomato. E anch’io sono di questo parere. Intanto io vorrei mettermi in comunicazione con Ermete Zacconi, anche per dargli le indicazioni utili all’allestimento scenico. Dove posso dirigergli una lettera?
Che l’allestimento del dramma sia avvenuto in tempi strettissimi, imposti dalla conclusione in extremis della stesura, è confermato anche dalla lettera 20 ottobre 1906, in cui l’autore esprime la sua rassegnazione a proposito della scelta della compagnia di Zacconi e Cristina Ines: «Per l’interpretazione non c’è nulla da fare. Bisogna affidarsi a ciò che potrà ottenere il Commendatore. Ho scritto anche alla Cristina per rinfocolarla». L’insuccesso della prima rappresentazione del Costanzi, rievocata nel Discorso introduttivo posto in apertura del dramma nell’edizione trevesiana, è in parte lenito dall’accoglienza favorevole incassata nelle rappresentazioni successive, il 7 gennaio 1907 a Torino, con la compagnia di Ruggero Ruggeri, Emma Gramatica e Ugo Piperno, e dell’11 gennaio a Milano, ancora con la compagnia di Ermete Zacconi, Ines Cristina e Ciro Galvani. In primo piano, il personaggio discusso e controverso di Corrado, «il colpevole Ulisside» moderno che infrange la ritualità della vita borghese per riscattare l’anelito vitalistico del suo spirito di conquista, alle prese con la conflittualità tra istinto e sentimento. Ne scrive a Re Riccardi proprio a ridosso della prima rappresentazione al Costanzi: «Non faccio raccomandazioni a Corrado, perché non ne ha bisogno. Ma credo più necessarie le sue cure nella fine del primo atto, nelle scene tra il fratello e la sorella; dove vorrei che alcune note di angosciosa tenerezza non fossero soppresse».
Contenuto e struttura
Ispirato ad una citazione da Edgar Allan Poe trascritta su un taccuino del gennaio 1896 («But we loved with a love that was more than love. I and my Annibal Lee»), ripresa sia letteralmente («più che l’amore»), sia in perifrasi ne Il fuoco («Questa cosa io posso più che l’amore non può») con la mediazione di Swinburne, il dramma si compone di due episodi, preceduti da un lungo discorso programmatico ed accresciuto da un preludio, da un intermezzo e da un esodio. La fitta rete di citazioni dalla Laus vitae, unitamente alla costante conversazione con Euripide, Sofocle ed Eschilo, sono i segnali più evidenti delle finalità programmatiche che la vicenda di Corrado Brando, reduce dalle imprese di conquista in terra africana, rappresenta in riferimento alla complessità dei tempi moderni, segnati dal legame clandestino con Maria Vesta e dall’amicizia con il fratello di lei, Virginio. Nel primo atto ha la ventura di apprendere da Corrado che si è macchiato dell’omicidio di un baro/usuraio, e che è ancora a piede libero; nel secondo atto la sorella gli confida di attendere una gravidanza, e che il padre di suo figlio è proprio Corrado, clandestinamente legato alla sorella. La decisione di ripartire per l’Africa e di sfuggire così sia alla legge, sia alla paternità, non impedisce al protagonista di sfidare i gendarmi che chiedono di entrare in casa di Virginio, dove i due amici si trovano, in un ultimo disperato, folle atto vitalistico che prelude ad un finale aperto.
L’interpretazione vitalistica delle gesta delittuose di Corrado Brando provocò le proteste e le riserve del pubblico, che l’autore accusa di non aver compreso la cifra nicciana e prometeica della vicenda. La difesa d’ufficio è svolta nel lungo Discorso introduttivo, dedicato a Vincenzo Morello:
Questo libro non è offerto al difensore del colpevole Ulisside, allo scrittore che primo di sopra la vil canizza gazzettante levò una parola d’uomo pensoso e animoso. Questo poema di libertà, dove la più bella speranza canta la più alta melodia, è offerto al buon compagno che nella notte del mio pubblico vituperio, quando ancóra s’udiva dietro a noi la via del Teatro sonare maravigliosamente di urla implacabili, partecipò della mia allegrezza e rise del mio riso. Qual più virile testimonianza di fede avrebbe egli potuto dare in quel punto alla mia forza paziente? Eccogli dunque il segno del mio grato animo, nel suo nome.
Il lungo testo che d’Annunzio elabora come dichiarazione programmatica all’edizione a stampa di Più che l’amore, intitolato Dell’ultima terra lontana e della pietra bianca di Pallade. A Vincenzo Morello, è molto più di un omaggio a Rastignac, il fedele amico giornalista autore della celebre monografia del 1910, intitolata non a caso Gabriele d’Annunzio (Società libraria editrice nazionale). Il Discorso è concepito come una sorta di rivendicazione orgogliosa del proprio operato di artista e drammaturgo, alle prese con un processo di rinnovamento della scena teatrale che alterna grandi successi, come nel caso de La città morta e La Figlia di Iorio, a battute d’arresto dolorose e inaspettate, come nel caso di Più che l’amore, dramma moderno in prosa rappresentato per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 29 ottobre dello stesso anno. Negativa l’accoglienza sia dei critici che degli spettatori, impreparati «ad affrontare il significato dell’opera. Attento più all’azione scenica, molto povera, e alla crosta delle parole, credette di ravvisare soltanto l’apologia di un volgare omicidio a scopo di rapina. Non vide, o non si vedevano, i significati della tragedia e fece giustizia sommaria» (Longo 1979, p. 75).
In effetti, dietro l’apparente semplicità di una trama scarna e lineare, si cela un reticolato di significati profondi, alcuni dei quali molto dannunziani, come l’eroismo, la passione sentimentale, la fiducia tradita, la fame di conquista, il colonialismo, la modernità urbana, il progresso tecnologico. Ma soprattutto vi è l’ulissismo, incarnato dal protagonista, Corrado Brando, viaggiatore ed esploratore dei tempi moderni, costretto a vivere in una Roma che risplende del suo glorioso passato e, allo stesso tempo, è proiettata verso una nuova modernità, scandita da rivoluzioni urbanistiche, rinnovamenti edilizi e innovazioni ingegneristiche. Interlocutore di Corrado è l’amico fraterno Virginio Vesta, ingegnere idraulico vocato alla missione della scienza, che Corrado va a trovare nella sua casa/studio «che sta lungo il Tevere, alla Marmorata, tra l’Aventino e il Testaccio». Da un lato l’immagine dell’impavido esploratore, Corrado, ingabbiato nella stasi borghese della terza Roma, oggetto di un processo di rinnovamento infrastrutturale ed edilizio che la rende comunque mito inadeguata per chi coltiva aspirazioni di conquista ed è disposto ad uccidere un baro (usuraio e pure rivale) pur di finanziare l’agognata partenza. Dall’altro Virginio, uomo di scienza e conoscenza, attorniato dai suoi utensili, dalle carte raffiguranti i corsi dei fiumi, i canali, le cisterne, attorniato dai suoi fogli e dalle sue righe, necessari per svolgere il suo lavoro di «ingegnere d’acque».
Tra i due si svolge un dialogo fitto e ininterrotto, che assume una direzione impreveduta nel momento in cui Maria rivela al fratello di avere una relazione con Corrado e di attendere un bambino. Il corso degli eventi è segnato. Corrado decide di partire per l’Africa, sperando di sfuggire alla giustizia, che gli è ormai alle costole. Così Valentina Allia (2014, pp. 160-161):
Assalito, per un attimo, dal dubbio se sia meglio restare, verso la fine dell’ultimo episodio ordina perentoriamente al servo sardo Rudu di preparare le armi e di perseguire con coraggio il più volte vagheggiato progetto eroico. Sennonché la tragedia termina con l’arrivo improvviso di tre uomini, tre agenti della forza pubblica, che Corrado si accinge ad affrontare «con quel suo piglio leonino»: nessuna conclusione definitiva, quasi un finale aperto, non chiaro ed equivocabile, il dubbio che l’eroe omicida sia adesso assicurato alla giustizia calpestata oppure che si tratti dell’estrema celebrazione del coraggio di colui che, pur di non piegarsi, preferisce darsi la morte.
Una vicenda altamente drammatica, che denota la straordinaria capacità di d’Annunzio nel creare personaggi psicopatologicamente significativi, come messo in rilievo da Scipio Sighele in numerosi dei suoi saggi dannunziani. Come rilevato opportunamente da Mario Cimini (2019), è lo stesso d’Annunzio ad esprimere a Ugo Ojetti, nella nota intervista del 1895, le ragioni del suo interesse per gli aspetti psicopatologici degli individui:
La malattia concorre ad allargare il campo della conoscenza. Lo studio dei degenerati, degli idioti, dei pazzi è per la psicologia contemporanea uno dei più efficaci modelli di speculazione, perché la malattia aiuta l’opera dell’analisi decomponendo lo spirito»; ragion per cui sarebbe stato «un puerile errore il credere che le facoltà dell’artista e quello dello scienziato sieno opposte e inconciliabili (Ojetti 1895, p. 326).
La vicenda rappresentata in Più che l’amore non fa eccezione. L’ulissismo cinico di Corrado Brando si contrappone alla stabilità esistenziale di Virginio e Maria Vesta, alle prese con la nicciana «volontà di potenza» di Corrado, a sua volta invischiato nella trasformazione del delitto in un atto vitalistico e di ribellione, non alla portata del pubblico insolentito della prima rappresentazione. A d’Annunzio spetta la difesa d’ufficio del suo protagonista, indirizzata a Vincenzo Morello: «In Corrado Brando non è glorificato il delitto, come pretendono i grossi e i sottili Beoti, ma son manifestate – con i segni proprii dell’arte tragica – l’efficacia e la dignità del delitto concepito come virtù prometeica». La forza del mito antico e l’aspirazione al progresso tecnologico sono di per sé sufficienti a trasfigurare il presente e a imprimere uno scarto netto rispetto alle interpretazioni corrive e alle strumentalizzazioni della critica e della pubblicistica militante. Sfugge a molti la controversa forza demiurgica della tragedia incarnata da Corrado e Maria: «Tale, o amico, è la parola della tragedia abominevole che i catoncelli stercorarii – sia detto con sopportazione – consegnano ogni giorno alla vendetta popolare». Di qui la rivendicazione della «dura disciplina» che genera «l’eternità della poesia che abolisce l’errore del tempo»:
Anche riconosco la verità e la purità della mia arte moderna; che cammina col suo passo inimitabile, con la movenza che è propria di lei sola, ma sempre su la vasta via diritta segnata dai monumenti dei poeti ladri. Per ciò io mi considero maestro legittimo; e voglio essere e sono il maestro che per gli Italiani riassume nella sua dottrina le tradizioni e le aspirazioni del gran sangue ond’è nato; non un seduttore né un corruttore, sì bene un infaticabile animatore che èccita gli spiriti non soltanto con le opere scritte ma con i giorni trascorsi leggermente nell’esercizio della più dura disciplina.
Stile e interpretazioni
«È una bella sera» dice l’Ulisside allorché, avendo preso commiato dal fratello generoso e dalla vita terribile con l’ultima strofe del suo fùnebre canto, si accosta alla finestra aperta ed alza al cielo primaverile di Roma gli occhi che fra poco saranno spenti. Si racconta che, come l’attore ebbe pronunziata quella parola tranquilla, un potentissimo scroscio di risa rintronò tutto il teatro e fece lungamente sussultare il ventre innumerevole.
La lunga apologia del dramma posta ad introduzione dell’edizione a stampa, intitolata Dell’ultima terra lontana e della pietra bianca di Pallade, si configura ancora come un testo esplicativo e allo stesso tempo creativo, funzionale alla necessità di denunciare l’inadeguatezza del pubblico al cospetto di un’opera di poesia assoluta, sospesa tra modernità e mito. Un testo difficile, colto, raffinato, giocato sulla contiguità temperamentale tra il protagonista, Corrado Brando, e alcune figure mitiche che si macchiano di omicidio per compiere l’inesorabilità della vendetta. Costanti i richiami all’Orestea di Eschilo, all’Alcesti di Euripide e all’Aiace di Sofocle, in cui il tema dell’assassinio si lega alla dimensione atavica della passione e della vendetta.
Concluso il 30 novembre 1906, il Discorso proemiale è un saggio di poetica drammaturgica, giocato tanto sulla celebrazione del vitalismo dell’eroe che si macchia del delitto pur di infrangere la mediocrità del tempo presente. Da un lato la celebrazione del mito dell’eroe, che d’Annunzio sviluppa sulla scorta della sua passione per Friedrich Nietzsche e Thomas Carlyle, dall’altro la rivendicazione del rinnovamento della scena teatrale avviata con Eleonora Duse e proseguita sulla scorta del «nuovo teatro» di Gordon Craig, frequentato a Firenze proprio a partire dal 1906, anno della pubblicazione del dramma di Corrado Brando. Questi pochi ma essenziali riferimenti sono necessari per comprendere l’origine e la complessità delle vicende che vedono protagonista l’Ulisside moderno, Corrado, e i due fratelli che gli sono vicini, Virginio e Maria, alle prese con l’inesorabile dipanarsi di un fato ancipite, che l’azione dell’uomo può indirizzare e influenzare. I continui riferimenti alle Erinni, al tempio di Pallade, ad Apollo e alle altre figure forgiate da Eschilo per rappresentare il dramma di Oreste, che uccide la madre Clitennestra per vendicarsi del delitto del padre Agamennone, costituiscono i poli dialettici della requisitoria dannunziana rivolta al «ventre innumerevole» del pubblico e dei critici, inconsapevoli del sostrato mitografico alla base delle vicende di Corrado Brando. Soltanto un esempio, tra i tanti enucleabili, così da evidenziare la straordinaria capacità di d’Annunzio di eternare la vicenda contemporanea attraverso la rivisitazione del mito antico:
Ci piacque d’imaginar rinnovato per l’Ulisside il giudizio di Oreste, il dibàttito presieduto da Pallade nell’Areopago venerando dinanzi al popolo convocato dalla tomba tirrenica. «Sarà il colpevole assolto dal bianco lapillo di Atena?» L’Occhichiara, alzata nel suo corto chitone dorico dalle pieghe simili alle scanalature della colonna, si degnò di ascoltare l’accusa e la difesa con sopracciglio sereno, come Colei che – nata dal Cervello – converte del continuo l’ambiguo evento in specie di puro pensiero. Ma, prima dello scrutinio, ahimè, subitamente si dileguò. E ci accorgemmo ch’ella era stata offesa dall’aspetto e dall’odore di uno fra i tanti miei patroni e clièntoli sopraggiunto; il quale, premendo la casta mano sul cuor purulento, prese a lamentare la mia gloria abbattuta per sempre contro le lastre del Viminale. Tuttavia, per buono stomaco, da quei costanti bevitori d’acqua che noi siamo, potemmo essere a cena.
A differenza di Oreste, perdonato a graziato da Pallade nell’Areopago, Brando è costretto ad affrontare le maglie della giustizia, incarnata dai gendarmi che lo devono prelevare, sul finire del dramma, in casa dell’amico Virginio. Lui lo vorrebbe salvare, nonostante abbia tradito la sua fiducia, non avendolo informato della relazione con la sorella Maria, da cui adesso attende quel figlio che solo potrebbe trattenerlo. L’iniziativa di brandire un’arma prima dell’ingresso dei gendarmi è un’altra di quelle soluzioni ad effetto che consentono al drammaturgo di tenere alta l’attenzione dello spettatore, posto dinanzi ad un finale aperto, che attesta quello spirito di ribellione che conduce Brando alla perdizione e alla sconfitta. Lo spiega d’Annunzio: «Destinato a scomparire, l’eroe diffonde e perpetua intorno a sé la sua volontà eroica, che la colpa non può distruggere né menomare. In Corrado Brando non è glorificato il delitto, come pretendono i grossi e i sottili Beoti, ma son manifestate – con i segni proprii dell’arte tragica – l’efficacia e la dignità del delitto concepito come virtù prometèa».
Personaggio controverso, divisivo e calamitante allo stesso tempo, Brando è soltanto l’ultima creazione del genio letterario di d’Annunzio, cui Scipio Sighele riconosce una particolare predisposizione per la creazione di figure psicopatologicamente connotate, tanto nei romanzi quanto nei drammi, come lo stesso Sighele enfatizza nella conferenza Gabriele d’Annunzio dinanzi alla psichiatria (1899). Tra «i tipi di degenerati felicemente intuiti da Gabriele d’Annunzio» vi sono Isabella, protagonista del Sogno d’un mattino di primavera, la dogaressa Gradeniga del Sogno d’un mattino d’autunno, lo scultore Lucio ne La Gioconda, senza tralasciare le vicende drammatiche che coinvolgono Leonardo e sua sorella Bianca Maria ne La città morta. L’omicidio è sempre una possibilità incombente nei drammi quanto nei romanzi dannunziani, come ben sanno Giovanni Episcopo, Tullio Hermil e Giorgio Aurispa, afflitti da manie omicide e suicide che lo rendono possibili oggetti di studio sul piano scientifico. Tutti loro, ivi compresi Andrea Sperelli e Claudio Cantelmo, scontano «una conseguenza egoisticamente volgare d’una filosofia epicurea», a sua volta innestata sulla degenerazione nicciana della volontà di potenza denunciata da Sighele:
Forse – ed io esprimo qui più che un mio fermo pensiero un mio dubbio – forse l’artista si è lasciato, a poco a poco, suggestionare dall’idea anormale che studiava. In principio avrà soltanto voluto analizzare il fenomeno, non certo comune ma pur vero, del superuomo: in seguito la malattia ch’egli osservava si sarà comunicata a lui per contagio, ed egli sarà rimasto vittima del veleno psicologico che – nella febbre della ricerca – aveva assoggettato al suo esame. (Sighele 1899, p. 73)
Il caso vuole che Più che l’amore si situi cronologicamente tra Francesca da Rimini e La nave, i due drammi analizzati da Sighele con l’obiettivo di rafforzare l’interpretazione di d’Annunzio come artefice di figure patologicamente connotate: «il temperamento artistico di Gabriele d’Annunzio è tale che raggiunge le più alte vette dell’arte quando vuol rappresentare individui eccezionali o stati d’anima patologici, ma rimane inferiore a sé stesso quando ci dipinge uomini moralmente sani e stati d’anima normali» (Sighele 1902, p. 312). Se tutto questo è valido per Maltestino e altri personaggi dannunziani, lo è altrettanto per Corrado Brando e la sua vicenda di aspirante eroe gravato dalla condizione di omicida, costretto a partire per l’Africa nonostante l’amore di Maria e la paternità incombente. Ma d’Annunzio lo dipinge sotto le mentite spoglie dell’eroe, chiamato a compiere atti irrituali e all’apparenza ignominiosi, ma che denotano la forza vitalistica del riscatto dall’infida mediocritas cui il presente condanna gli spiriti audaci.
Il dialogo continuo con l’Alceste di Sofocle e l’Alcesti di Euripide è uno degli accorgimenti dialettici che il drammaturgo utilizza nella prosa introduttiva per spiegare le ragioni del suo protagonista e per ribattere alle accuse di apologia dell’omicidio che il pubblico gli ha sferrato dopo la prima rappresentazione. Il paragone con l’Oreste eschileo, «il perduto Ulisside», è del resto una sorta di transfert mitografico teso a giustificare il delitto della madre. L’immagine di Oreste nell’Areopago che sta per essere assolto dalla corte composta dagli dei è il correlativo oggettivo della condizione di Corrado Brando, che rivendica il diritto di aver ucciso il baro anche per la sua condizione di reietto: «Ed ecco un altro argomento, fornito dal colpevole: Là, alla tavola del giuoco, nello scompiglio delle sorti, era una carne di goditore o una volontà di asceta, una bassa cupidigia o una fatalità eroica? Ed eccone un altro ancòra: “Non per me, non per me! Basta a me un pugno d’orzo abbrustolito, la carne degli avvoltoi, l’acqua della cisterna o del pantano, e per sale la necessità di superarmi ogni giorno” ».
Il delirio vitalistico che ispira le gesta dell’Ulisside dannunziano ha fondamenta mitiche illustri e vive nel canto lirico della Laus vitae, «il solo poema di vita totale che sia apparso in Italia dopo la Comedia» (1093). Pubblicato nel 1903, il poema è onnipresente nel dramma con numerose citazioni testuali, quasi a formare un dialogo a distanza tra l’Ulisside/poeta in viaggio verso l’Ellade e l’Ulisside/omicida invischiato nelle trame della terza Roma. Un sistema citazionale complesso, teso a rafforzare e a legittimare gli aneliti di gloria del protagonista:
L’eroe, votato all’errore e al dolore, soffre non per purificarsi d’una passione criminosa, non per espiare il suo peccato e per riacquistare la sua innocenza ma per essere – di là dal terrore e dalla pietà – «l’eterna gioia del divenire». Mentre appare paziente, egli raggiunge il grado massimo della sua attività; la quale, dopo di lui, continua a operare. La legge umana, l’ordine naturale, l’uso, il costume possono essere sovvertiti dal suo atto; ma il suo atto genera un cerchio di potenze più alte, una inaspettata sovrabbondanza di vita superna. Destinato a scomparire, l’eroe diffonde e perpetua intorno a sé la sua volontà eroica, che la colpa non può distruggere né menomare.
L’eroismo del protagonista eguaglia quello di Maria, sorella nubile dell’amico fraterno Virginio, entrambi disposti ad accettare il fato che Corrado si impone di assecondare «più che l’amore», la prima sacrificando la prospettiva di una stabilità sentimentale e filiale, il secondo disposto a perdonare l’amico per avergli taciuto la relazione con la sorella. Discendente del Raskòlnikov di Delitto e castigo, Corrado è disposto a trasformare quel «più che l’amore» nel «più oltre» che il callido esploratore ha sposato come filosofia di vita, nel segno di quell’ulissismo in terra d’Africa che conferisce al dramma un’aura di sinistro esotismo e di straniante profetismo: «Ho il mio pensiero, anzi ho il mio impero, una parola romana da rendere italica: Teneo te, Africa». A distanza di dieci anni dalla battaglia di Adua, che arrestò per molti anni le mire colonialistiche italiane, d’Annunzio sembra presagire l’imminente deflagrazione della guerra di Libia (1911-1912) e, soprattutto, la guerra di Etiopia del 19136, celebrata dal Vate con i discorsi del Teneo te Africa.
Proprio nella cifra ideologica del personaggio si possono intravedere le ragioni delle contestazioni di cui d’Annunzio è fatto oggetto sia dal pubblico che dalla critica, se solo si pensa che nel Tutto d’Annunzio, Eurialo De Michelis stroncava non solo l’iniziativa del Discorso iniziale, in cui i riferimenti a Eschilo, Sofocle, Euripide, a Dante e alla Laus vitae sono «avvicinamenti postumi, non come quelli che contestuali nella Fiaccola sotto il moggio poterono in qualche modo facilitarne la traduzione in pantomima»; più in generale, criticabile è la stessa matrice vitalistica del personaggio disposto ad andare «più oltre» della realtà quotidiana, soprattutto quando ad avere la meglio è il momento in cui i fasti del passato impongono di tornare in battaglia:
che è il momento quando la nostalgia del personaggio diventa, come spiega il Discorso premesso al volume, audace e moderna interpretazione del mito di Prometeo. E ciò guasta senza rimedio l’opera, in ragione della logica con cui vi si attiene: infatti anche gli antagonisti soavi: Maria, la donna abbandonata, Virginio, il fratello di lei, si svolgono essi pure su un disegno altrettanto eroico (De Michelis 1960, p. 330).
Nel ridimensionare il giudizio negativo di De Michelis, è opportuno sottolineare che la ragione del dramma, e anche il suo fascino, risiedono proprio nella divergenza tra gli aneliti di grandezza del protagonista e l’inesorabilità delle conseguenze derivanti dai propri gesti, soprattutto quando questi infrangono la legge e obliterano qualunque aspettativa di grandezza, ivi compresa quella derivante dall’amore e dall’amicizia. Non apparirebbe altrettanto eroica la condizione dei due «antagonisti soavi», Maria e il fratello Virginio, se non nella misura in cui essi sottostanno coraggiosamente (ma passivamente) al piano esistenziale di Corrado, per cui conta più l’eroismo dell’esplorazione e della conquista rispetto alla salvaguardia degli affetti. La gravidanza di Maria è «più che un dono; un Segno», come lo stesso d’Annunzio esplicita nel Discorso introduttivo, descrivendo con slancio lirico la complessità scenica di Corrado e Maria, uniti e separati dalla stessa ineluttabile esistenza data dall’insopprimibile mutabilità del destino:
Quando la voce feminile ascende sino alle note del canto, il suo potere riesce a superare il fascino d’ogni altra bellezza e d’ogni altra armonia; poiché, per divenir musicale, è necessario che quella voce s’accordi col ritmo del nostro cuore, lo rinforzi, si perda in noi, diventi la nostra essenza stessa, si trasformi in qualche cosa che prima ignoravamo e che d’improvviso ci appare come un nuovo tesoro di sangue e d’anima. «Sento che le radici della mia vita non sono più in me e che l’infinito è là dove tu ti volgi» dice l’inebriato quando sta per ricevere l’annunzio della maternità. Egli medesimo ascende alle più alte note del canto nel celebrare la vita della sua vita.
L’epifania della vita ancora in nuce sembra far da contrasto alla sospensione esistenziale di Corrado, gravato dal sentimento della fine che incombe su di lui. Maria è soltanto un’alternativa, non desiderata, al soddisfacimento dell’ansia vitalistica che lo affligge. Così Giorgio Zanetti a tal proposito:
per Maria vivere è attendere, per Corrado vivere è vincere. Il suo tentativo di sovrapporre l’attualità alla memoria, la consapevolezza di poter realizzare le proprie ambizioni di azione e di vittoria soltanto in un altrove fantastico e non in una società senza eroi, che non concede alternative se non nella follia, suscitano la rievocazione degli atti di coraggio e di valore guerresco compiuti in un’Africa sospesa tra mito e realtà (Zanetti 2013, pp. 1542-1543).
La dicotomia tra sanità e insanità mentale si innesta sulla dialettica tra interno ed esterno, città e natura, stasi e azione, sentimento e ragione. Dicotomie tutte racchiuse nella conflittualità tra eroismo e rinuncia, sospesa tra il Superuomo di Nietzsche e l’eroe di Carlyle, che d’Annunzio sfrutta per portare sulla scena una personalissima interpretazione del mito moderno dell’eroe che sconta l’inadeguatezza del presente, consapevole del destino tragico che attende l’ulisside pronto a sfidare le barriere del tempo e dello spazio. E l’eroismo di Maria risiede nella sua capacità di accettare la sorte di chi sa che è possibile amare «più che l’amore», come ben sanno Eschilo, Sofocle, Euripide, cui il drammaturgo guarda ogni qual volta la forza del destino si compie nel segno di eroine che sfidano la fallibilità della condizione umana, complice anche la mediazione elegiaca delle Heroides ovidiane. Così d’Annunzio, sempre nel Discorso introduttivo, in cui il richiamo del passato si innesta sulla lettura della modernità e del progresso:
Mi tornano nella memoria le parole dell’Antico mentre mi accomiato dalla creatura nuova che porta la costellazione di ferro nell’iride. Ella va a porsi tra Silvia Settala e Mila di Codra, non mutilata come l’una, non incenerita come l’altra, ma compiuta da un sacramento della Natura; non un vincolo ma un dono; più che un dono; un Segno. «Or teco pensa, che bellezza dovea essere in lei, alla quale parea si convenisse lo suo dolore!».
Maria ha certamente un destino migliore rispetto a quello di molti altri personaggi femminili dannunziani, analizzati da Scipio Sighele sul piano psicopatologico: un destino migliore della protagonista della Gioconda, Silvia Settala, mutilata di una mano in seguito ad una colluttazione scaturita dalla necessità di salvare il suo matrimonio con lo scultore Lucio Settala, invaghitosi della modella Gioconda; un destino nettamente migliore della protagonista de La figlia di Iorio, Mila di Codra, disposta a sacrificarsi e di essere arsa viva pur di riscattare l’amore per Aligi, macchiatosi di parricidio. Per non parlare della fine tragica di Francesca da Polenta e di Basiliola ne La Nave, fino all’omicidio/suicidio compiuto da Mortella nel Ferro, che segna la conclusione della parabola drammaturgica dannunziana e, sottolinea Pietro Gibellini (1995), «la fine del superuomo» Ma non meno lancinante è il suo destino sul piano emotivo ed esistenziale, considerata l’ansia di evasione e di infrazione delle regole cui è condannato il suo amante e padre della sua prole. Forme diverse e complementari di sacrificio, che né il gioco, né lo spirito di impresa, né la forza del sentimento, né il progresso tecnologico possono mutare: «Scomparsa la donna dalla scena, il ritmo fùnebre interrotto ricomincia; ma or sembra condurre l’eroe non più verso il sacrificio e verso il sepolcro, sì bene oltre l’amore e oltre la morte, là dove egli non possa “né soffrire né morire” ».
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Gabriele d’Annunzio, Più che l’amore, in Tragedie, sogni e misteri, vol. II, a cura di Annamaria Andreoli, con la collaborazione di Giorgio Zanetti, Mondadori, Milano, 2013, pp. 3-166.
Gabriele d’Annunzio, Lettere ai Treves, a cura di Gianni Oliva, Milano, Treves, 1999.
Eugenio Salvatore, Le lettere di d’Annunzio a Re Riccardi, «Archivio d’Annunzio», vol. 1, 2014, pp. 141-204.
Bibliografia secondaria
Valentina Allia, Appunti sulla lingua del ‘Più che l’amore’ di d’Annunzio, HUMANITIES – Anno III, Numero 5, gennaio 2014.
Annamaria Andreoli, Più che l’amore. Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio, Venezia, Marsilio, 2017.
Raffaella Castagnola, D’Annunzio e l’Africa: riferimenti esotici per ‘Più che l’amore’, in La lingua del teatro fra D’Annunzio e Pirandello, a cura di Diego Poli e Laura Melosi, Atti del convegno di studi, Macerata, 19-20 ottobre 2004, pp. 29-48.
Mario Cimini, Letteratura e psichiatria, da Gabriele D’Annunzio ad Alda Merini. Nota introduttiva, in Letteratura e Scienze, Atti delle sessioni parallele del XXIII Congresso dell’ADI (Associazione degli Italianisti), Pisa, 12-14 settembre 2019 a cura di A. Casadei, F. Fedi, A. Nacinovich, A. Torre, Roma, Adi editore 2021, pp. 1-2. Consultato il 20 agosto 2024: https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/letteratura-e-scienze/Cimini-Nota-introduttiva.pdf.
Eurialo De Michelis, Tutto d’Annunzio, Milano, Feltrinelli, 1960.
Pietro Gibellini, Fine del superuomo: per l’autografo del «Ferro», in Id., D’Annunzio dal gesto al testo, Milano, Mursia, 1995, pp. 89-101.
Laura Granatella, «Arrestate l’autore!». D’Annunzio in scena. Cronache, testimonianze, illustrazioni, documenti inediti e rari del primo grande spettacolo del ‘900, Roma, Bulzoni, 1993.
Giuseppe Longo, Una chiave di lettura per ‘Più che l’amore’, «Quaderni del Vittoriale», n. 14, 1979, pp. 75-78.
Mario Martelli, La nave, Più che l’amore, in D’Annunzio a cinquant’anni dalla morte, Atti dell’XI Convegno internazionale di studi dannunziani, Pescara, 9-14 maggio 1988, vol. II, Ediars, Pescara 1988, pp. 545-557.
Ugo Ojetti, Alla scoperta dei letterati, Milano, Bocca, 1895.
Scipio Sighele, Gabriele d’Annunzio dinanzi alla psichiatria. Conferenza, «Rivista politica e letteraria», aprile 1899, pp. 58-74, poi in Id., Letteratura tragica, Milano, Treves, 1906, pp. 1-94.
Giorgio Zanetti, Più che l’amore, in G. d’Annunzio, Tragedie, sogni e misteri, vol. II, Milano, Mondadori, 2013, pp. 1537-1556.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)