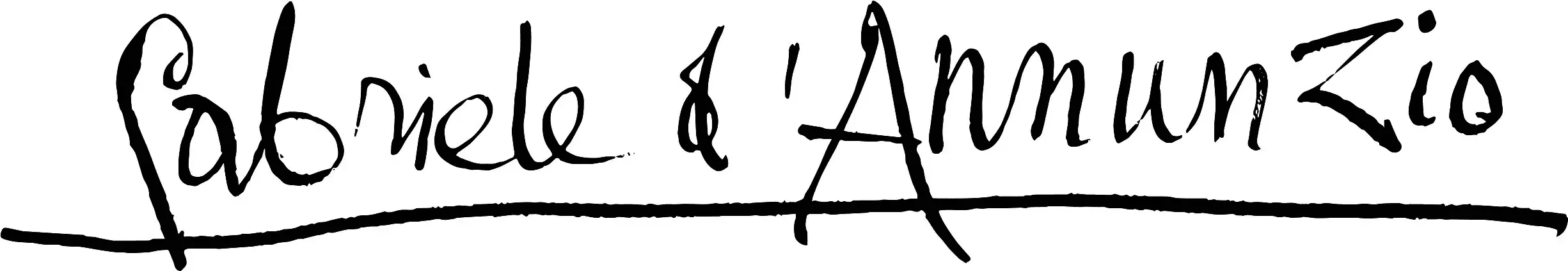di Simona Costa, Enciclopedia dannunziana
Un paesaggio edenico, tra Bocca d’Arno e il Magra
Il 7 luglio 1899 d’Annunzio scriveva a Giuseppe (Pepi) Treves dalla Marina di Pisa: «Ho passato questi giorni in una quiete profonda, disteso in una barca al sole. Tu non conosci questi luoghi: sono divini. La foce dell’Arno ha una soavità così pura che non so paragonarle nessuna bocca di donna amata». Sempre tra le righe di questa lettera, il cui corrispettivo è nei versi di Bocca d’Arno (stesa, come testimonia Palmerio, il 6 luglio 1899), si registra, in contrasto con l’affaticato asservimento «alla mole della prosa» (Il fuoco), l’avvio alla felicità del canto, con versi che nascono spontanei dall’anima «come le schiume dalle onde» e la creazione di alcune Laudi che paiono «figlie delle acque e dei raggi, tutte penetrate di aria e di salsedine».
L’abbandono a questo «fiume di poesia» cui aveva finora resistito lo induce, come si legge nella successiva lettera del 7 agosto da Settignano al «caro Pepi», a rimettersi sì al compimento della «sciagurata avventura» del Fuoco, ma rimaneggiandolo. Sarà così infine accantonato il progetto, di cui pur scriveva ancora al suo traduttore francese Georges Hérelle il 18 dicembre 1899, di un libro «nazionale» dai multipli scenari, anche toscani. L’esplosione lirica delle Laudi si intreccerà in avvio del nuovo secolo con il teatro in versi: la Francesca da Rimini, stesa nell’estate del 1901 e La figlia di Iorio, composta nell’estate 1903. Il 1903, data dei quarant’anni dannunziani, suggella dunque una straordinaria stagione di felicità creativa: a maggio esce Maia, programmaticamente primo libro delle Laudi, mentre il secondo, Elettra, esce insieme ad Alcyone nel dicembre 1903, seppur con data 1904.
La frequentazione dannunziana del litorale toscano gravita essenzialmente tra Pisa, la sua marina e, salendo a nord, la Versilia, in una fusione che, come ha notato Cesare Garboli, fa di questa terra tra Bocca d’Arno e il Magra un unico paesaggio edenico, destinato a soppiantare i bagni di Livorno con Forte dei Marmi. Anche se è da registrare una primitiva conoscenza dannunziana di Livorno, in una per lui indimenticabile visita del Natale 1880 al critico che lo aveva lanciato nell’agone letterario, Giuseppe Chiarini, che tuttavia dai festeggiamenti sarebbe trascorso al ripudio nell’accesa polemica del 1884 sulla “verecondia”. Le promesse di tornare a trovarlo e restarvi a lungo non saranno mantenute; nelle lettere abruzzesi del 6 e 12 agosto 1881 alla fiorentina Giselda Zucconi (la Lalla dedicataria di Canto novo), le chiedeva di andare per lui ad ammirare Livorno e di salutargli l’Ardenza e la Torre del Marzocco.
Se i ritorni livornesi, come annota Ivanos Ciani, furono sporadici (tre volte sicuramente tra il 1905 e il 1908) mentre di maggior peso furono alcuni amici livornesi, a cominciare da Costanzo Ciano, suo compagno nella Beffa di Buccari, fu certo una Pisa «argentea e primaverile» a catturarlo in un incantesimo lirico. Ce lo dice la lettera a Hérelle dall’Hôtel Victoria di Pisa del 16 gennaio 1896, dove narra di stare «lunghe ore al sole, sul prato del Duomo, sotto le mura merlate o contro una porta di bronzo mentre i simboli parlano a la sua anima silenziosa» e di andare a San Rossore «a contemplare le file di cammelli carichi di frasca; e poi al Gombo, su la riva del Tirreno sparsa d’alghe morte, dove erra lo spirito giovenile di Percy Shelley». E conclude: «Sboccano nella mia anima – da alcune settimane – fiumi di poesia».
Le descrizioni epistolari trovano riscontro anche nella scrittura di taccuino, dove, sotto la data «Pisa – San Rossore. 15 genn. ’96», troviamo notazioni sulla pineta del Gombo e la spiaggia «sparsa di alghe morte», il tutto di «una solitudine immensa, quasi terrificante»; sul «passaggio dei camelli tardi e gravi, carichi di fascine»; sulla lontana visione delle montagne di Carrara, con la cima di Monte Pellegrino, e il repentino approdo del cadavere di Percy Shelley (Taccuino VI). Appunti di cui è stata notata qualche approssimazione geografica: come il cadavere di Shelley fatto giungere non a Viareggio ma sulla spiaggia del Gombo, particolare tuttavia rivisitato – anticipando la connessione Shelley-Orfeo di Anniversario orfico – nel Taccuino 10 del 1899 (in Altri Taccuini), sotto la fatidica data 8 luglio («Non so se quivi [al Gombo] approdò veramente il cadavere di Shelley, ma certo questa riva è degna che vi approdi il capo di Orfeo su la sua lira»); o come l’Alpe di San Pellegrino, alta cima non delle Apuane (cui si affaccia) ma dell’Appennino tosco-emiliano.
Siamo, con queste note del gennaio 1896, alla messa a fuoco di luoghi e figure topici dell’immaginario dannunziano, rifruiti nell’ambientazione del quarto atto della Gioconda, ma soprattutto nell’Alcyone di Il Gombo, di Anniversario orfico e de I Camelli. E l’onirica visione del cadavere di Shelley, nella sua metamorfosi «into something rich and strange», rimanda alla dannunziana Commemorazione di Percy Bysshe Shelley pubblicata sul «Mattino» di Napoli il 4-5 agosto 1892 e riedita in prima pagina il 21 agosto dal lucchese «Figurinaio» di Carlo Paladini. Si apre così il pieno inserimento nel viareggino culto di Shelley di un d’Annunzio che fin dagli anni romani, grazie anche all’amico Adolfo De Bosis, era stato appassionato frequentatore del poeta inglese, ben presente al giornalista come al narratore del Piacere e del Trionfo della morte.
A Pisa era anche Eleonora Duse, di ritorno ai primi di gennaio da una tournée con ultima tappa Copenaghen: giorni determinanti per sancire la loro relazione, come suggerisce una lettera di Eleonora senza data (e forse non spedita) in risposta a una lettera di lui del 17 luglio 1904, dove si parla della «promessa di Pisa» dopo la quale non ebbe «che una forza: Lavorare per voi», ovvero per Gabriele e la figlia Renata/Cicciuzza, avuta da Maria Gravina. Anche se, partita la Duse per Parigi (da dove gli scrive, datando dal 18 al 19 gennaio) e poi per Londra in attesa di imbarcarsi da Liverpool per gli Stati Uniti, d’Annunzio in procinto di tornare a Francavilla si fermerà a Firenze «trattenuto da un incantesimo solare», come dice in una lettera a Emilio Treves del 26 gennaio 1896; incantesimo, dunque, da non collegare all’immagine della Duse, ma probabilmente, come hanno suggerito più biografi, a quella di Giulietta Gordigiani, la Donatella Arvale del Fuoco.
Altre notazioni affiorano da un taccuino del 1898 (Taccuino 9 di Altri taccuini), che trascorre da Portofino (20 febbraio) a Pisa (21 febbraio). Dopo aver raggiunto Eleonora a Santa Margherita Ligure, nella sosta a Pisa, alle soglie ormai del trasferimento alla Capponcina, sul taccuino si appuntano immagini della città che ritroveremo nei versi delle Città del silenzio e in Forse che sì, sogguardate da Paolo e Isabella nel loro catartico volo sull’Ardea. Eleonora, che nell’aprile 1899 aveva portato in scena con la Compagnia Duse-Zacconi La Gioconda, ambientata tra le colline fiorentine, la Firenze urbana e la marina pisana, nell’estate 1899 a Marina di Pisa, località da lei già frequentata, affittò il casone della Dogana vecchia (soprannominata «la casa delle rondini») dove Gabriele, di stanza alla Capponcina come dicono i suoi contatti epistolari, la visitò, non continuativamente, a luglio. In agosto le lettere di Eleonora, partita per lavoro, sono indirizzate alla Capponcina; ai primi di settembre Gabriele fu con lei alcuni giorni a Zurigo.
Tra il 2 e l’8 luglio 1899 (anniversario della morte di Shelley) il già citato Taccuino 10 è fitto di notazioni che, in parte riprese in Forse che sì, rimandano a più luoghi di Alcyone, mentre altri taccuini (Taccuino XXVIII e XXIX di Taccuini) alle date del 20 e 21 luglio ci portano al castello dei Malaspina a Fosdinovo e, dettagliatamente, alle cave di Carrara, e il 23 e 24 luglio a Marina di Pisa. All’amico Angelo Conti, prima di partire da Settignano per Carrara, Gabriele scriveva il suo rammarico di non poterlo avere accanto «tra i bianchi marmi» per leggergli le Laudi da poco composte e scendere poi con lui a Bocca d’Arno «per salutare l’amica nella Casa delle Rondini».
Nel luglio 1900 (quindi dopo la sconfitta elettorale del 30 giugno) Gabriele ed Eleonora furono vicino a Viareggio, al Secco, come annunciano i giornali locali che collocano il poeta in una villetta tra i pini, accanto al mare, identificata in una proprietà di Armanda Consigli. In una lettera al fedele veterinario e factotum Benigno Palmerio del 4 luglio si legge: «Portami le carte topografiche della Lunigiana, delle Alpi Apuane, e del paese che va dall’Arno a Pietrasanta (Migliarino, Massacciuccoli, Viareggio, Torre del Lago)», mentre nella Biblioteca del Vittoriale troviamo, con segni di lettura, una Guida alle Alpi Apuane di Cesare Zolfanelli e Vincenzo Santini (Firenze, Tip. di G. Barbera, 1874). Eleonora partì il 20 agosto per una tournée, continuando a scrivergli a Villa Consigli; si incontreranno nella prima metà d’ottobre in Germania, come dicono anche gli appunti del Taccuino 13 di Altri taccuini. Scriveva d’Annunzio ad Annibale Tenneroni, sotto la data «Motrone 1900»: «Io abito il Secco Motrone, a 5 chilometri dall’abitato, su un lido deserto; e in questi due mesi ho appena veduto – e ben di rado – qualche pescatore di telline!».
Anche l’estate del 1901 trascorse al Secco, mentre nell’estate del 1902 Gabriele ed Eleonora furono in Casentino, a Romena, però con qualche nostalgia per il Secco Motrone, dove Eleonora avrebbe voluto tornare per qualche settimana. In una lettera del 2 agosto a Benigno Palmerio d’Annunzio gli chiedeva infatti di informarsi se e a quali condizioni, accettabili o meno, fosse ancora possibile ottenere la villa del Secco dal 20 agosto al 20 settembre, progettando anche un poi inattuato trasferimento.
Se l’estate del 1903 fu trascorsa, insieme a Eleonora e alla piccola Renata, nella villa del Bell’Aspetto dei principi Borghese a Nettuno, luogo di stesura fra il 18 luglio e il 29 agosto della Figlia di Iorio, nell’estate 1904 d’Annunzio si mise in cerca di una residenza estiva che accogliesse non più Eleonora bensì Alessandra di Rudinì: la compagna sana e forte che univa cultura e gusto per la vita selvaggia, come si legge in una lettera a Hérelle da Marina di Pisa datata Ognissanti 1904. La scelta cadde infatti su Marina di Pisa, ma solo dopo aver tentato di affittare a Marina di Pietrasanta una villa «veramente ampia, fresca e comodissima», come scriveva a Palmerio il 1º giugno: ovvero la Versiliana, il cui unico difetto era una scuderia troppo piccola, adatta solo a cinque cavalli, ma ampliabile con la cessione di una stalla da cui sfrattare due mucche. Il negoziato non andò in porto: la proprietaria ne aveva già chiesto al salottiero cosmopolita Carlo Placci (cfr. D’Annunzio e Firenze) duemila lire al mese e d’Annunzio ne offriva quattromila per tre mesi e mezzo.
A Marina di Pisa, dopo tante vane ricerche, ecco infine quello che lui descriverà ad Alessandra come il loro «asilo d’amore» (pur carente anch’esso di una adeguata scuderia): Villa Peratoner, la casa rossa o delle tempeste, già un tempo desiderata e non ottenuta, e ora affittata, dopo un primitivo diniego, grazie a un locale postino/mediatore, nel periodo tra luglio e novembre su una richiesta di duemila lire. Qui, vicino alla foce dell’Arno e con dietro la pineta, d’Annunzio si stabilì con Alessandra e ancora la figlia Renata. Palmerio ed Angelo Bruschi, direttore della fiorentina Biblioteca Marucelliana, furono i destinatari delle sue numerose richieste di libri, utili all’avviata composizione della tragedia La Nave.
Dopo l’accidentata estate 1905, segnata dalla grave malattia e dalle operazioni di Alessandra (cfr. D’Annunzio e Firenze), tra giugno e novembre 1906 d’Annunzio, con sporadici viaggi a Firenze, Milano, Bologna e Roma, riuscì finalmente ad affittare la Versiliana, la villa fatta costruire a Marina di Pietrasanta nel 1886 dalla nobile fiorentina Marianna Ginori Lisci moglie del conte Digerini Nuti e dove finì di stendere il Più che l’amore. «Io sono nel più bel luogo dell’Universo; e medito una cosa bella», scriveva il 5 luglio 1906 a Emilio Treves. Una stagione rimasta favolosa nei ricordi locali, tra servitori, cavalli e innumeri cani, ampiamente nutriti da carretti di carne del macellaio di Pietrasanta e sguinzagliati sulla spiaggia, al galoppo in mitiche cavalcate.
Con lui furono per parte del tempo Alessandra e i tre figli, Mario, Gabriellino e Veniero: fu Gabriellino a condurre dal padre un suo amico che come lui abitava allora a Firenze, Umberto Poli che, giovanilmente infatuato di d’Annunzio, si firmava Umberto da Montereale. È il racconto che Umberto Saba fa di una sua visita a Il bianco immacolato signore (in «Corriere della Sera», 24 novembre 1946), in quel settembre versiliese in cui d’Annunzio stava scrivendo per «La Lettura» la commemorazione del suo direttore, Giuseppe Giacosa. Ma, nonostante le promesse di aiuto del «Grande Smemorato», non rimase a Saba di quell’incontro che il ricordo di una sontuosa pasta al pomodoro.
La nuova relazione con Giuseppina Giorgi Mancini, corteggiata epistolarmente nell’estate alla Versiliana, non vide successivi soggiorni estivi tra Pisa e la Versilia. Il paesaggio alcionico non sarà tuttavia mai obliato, come dicono le presenze di d’Annunzio alla foce del Motrone il giorno dopo la morte di Carducci e all’esplosione di una mina a Carrara nel luglio 1907. O ancora, nel Solus ad solam, la fuga catartica verso Viareggio e la Versilia, passando per Prato e ritornando per la via di Pisa, in data 15 settembre 1908, nei tormentosi giorni della follia di Giuseppina/Giusini.
A Marina di Pisa d’Annunzio fece ritorno nell’estate 1909 con un nuovo amore, Nathalie de Goloubeff, in fuga dai creditori che premevano alla Capponcina, impedendogli di lavorare al Forse che sì. I due trovarono separato rifugio: lui a Villa Alba della contessa Flora Douglas Fenzi, capace di «vivere con venticinque lire al mese!» come scriveva a Emilio Treves il 4 agosto l’incredulo Gabriele, che aveva segnato alla data del 13 maggio su un taccuino (Taccuino 17 di Altri taccuini) l’esborso (1000 lire) della pigione e della locale e usuale mediazione di Felice Castelli. Nathalie, con i due figli, si sistemò a Villa Garzella, di proprietà dell’economo dell’ospedale di Pisa.
Un periodo quanto mai travagliato che le lettere a Emilio Treves ripercorrono, tra continue richieste di soccorso economico; sequestri, oltre che alla Capponcina, dei cavalli a Marina di Pisa; pressato lavoro per il compimento del romanzo, che richiese anche, nel settembre, i viaggi documentari a Mantova e al circuito aereo di Montichiari presso Brescia e, nell’ottobre, a Volterra. Nathalie partì in novembre per Parigi, mentre Gabriele ad inizio novembre lasciava la sua «casa palustre», divenuta permeabile a vento e pioggia, per spostarsi alla già abitata Villa Peratoner fino, dopo alcuni abboccamenti finanziari con l’impresario Pilade Frattini e l’abruzzese/argentino Giovanni Del Guzzo, alla partenza francese di fine marzo 1910. Qui, oltre che da Nathalie, fu accolto dal Tout Paris col viatico di quel Forse che sì i cui diritti erano stato acquistati da Jacques Rouché, direttore della «Grande Revue» e alle cui pagine aveva affidato, nel volo di Paolo e Isabella sull’Ardea, le ultime sue immagini innamorate di Pisa, della sua Piazza, del suo Camposanto e della sua marina.
La Versilia, oltre il paesaggio
Il paesaggio della costa toscana, al pari delle colline fiorentine, domina certo l’immaginario del poeta, legandosi alla scoperta edenica di luoghi primordiali, in grado di far rivivere nella contemporaneità i miti classici e di far avvertire la nostalgia della loro perdita, nella dissoluzione della «favola» e nel cedere della gioia ellenica alla dea moderna della Malinconia, come ha ben visto Pietro Gibellini nella sua lettura alcionica. Viareggio, già in fase di strutturazione turistica, non può quindi trovare spazio nei suoi versi, ma questo non esime d’Annunzio dai rapporti con il contesto locale e dal riconoscersi nel culto di Shelley, il «poeta del liberato mondo» secondo la definizione carducciana, venerato dagli incendiari frequentatori della taverna del Prometeo di via di Mezzo, tra cui Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e Lorenzo Viani. L’idea dell’erezione di un monumento al poeta del Prometeo liberato, nel luogo dove si era consumato il rogo, venne nell’estate 1890 a due amici: Pericle Pieri, giornalista lucchese, e Cesare Riccioni, studente all’Università di Pisa, in contatto con Pietro Gori e Felice Cavallotti, attivissimo sia politicamente nella sinistra radicale sia sul versante culturale.
Tra polemiche e contrasti, specie col mondo clericale, il monumento, opera di Urbano Lucchesi, fu inaugurato il 30 settembre 1894 con un discorso di Riccioni che riprendeva anche la Commemorazione dannunziana del 1892, dove Shelley era accostato a Gesù e avvertito quale paladino del Bene. Per l’orazione inaugurale Riccioni aveva in realtà cercato d’Annunzio, che rispose tuttavia il 2 ottobre da Francavilla, di ritorno da Venezia, dicendosi sinceramente rammaricato del ritardo con cui aveva ricevuto l’invito, causa l’errore di indirizzo documentato dall’acclusa busta (Sereni 2003, pp. 138-139).
Di qui l’amicizia nata tra Riccioni, agli inizi Novecento per due volte sindaco di Viareggio, e il d’Annunzio dei soggiorni estivi versiliesi, come testimoniano i loro contatti epistolari, fra cui la lettera che il poeta gli inviò dopo aver concluso la sera prima, «fra lampi e tuoni», la stesura della Francesca da Rimini, e in cui esprimeva tutta la sua riconoscenza alla bella e per lui materna Versilia, dove si sentiva rinato. È interessante poi ricordare che l’avvocato Riccioni, oltre ad essere in grande amicizia con Puccini, sposerà, nel 1910, la celebre cantante lirica ucraina Salomea Kruceniskij, che nel 1904 aveva portato al trionfo a Brescia Madame Butterfly, dopo il fiasco della prima scaligera, e che nel 1915 sarà interprete alla Scala della Fedra dannunziana musicata da Ildebrando Pizzetti.
Di D’Annunzio in Versilia ci ha lasciato un vivido ritratto, anche se con imprecisioni di luoghi, eventi e date, Lorenzo Viani, classe 1882, i cui genitori furono in servizio nella Tenuta di don Carlos di Borbone. Ne nasce un improbabile e fantasioso racconto di un giovane Viani inviato dal barbiere Fortunato Primo Puccini, di cui era apprendista, a radere barba e baffi di d’Annunzio alla Versiliana (dove, poi disse, aveva invece recato un telegramma). Ne segue il codicillo di uno stupefatto Fortunato Puccini cui, nella sua qualità non di «barbitonsore» bensì di Segretario della Camera del Lavoro di Viareggio, capitò di ricevere un telegramma così concepito: «Ha terminato la sua grande fatica l’operaio della parola. Gabriele d’Annunzio». La fatica terminata era, anche stavolta, la tragedia Francesca da Rimini, compiuta però non alla Versiliana ma al Secco alla data del 4 settembre 1901.
Viani, insieme a una folla di notabili, artisti, giornalisti, eleganti signore, era invece davvero presente e persino vicino al poeta, secondo la testimonianza fotografica di Mario Nunes Vais, a Carrara nel luglio 1907 per l’esplosione di una mina di grande potenza prodotta dalla società Prométhée.
Ulteriori e più tarde furono le occasioni per Viani di incrociare un d’Annunzio ormai non più versiliese, anche se non di parlargli: ai tempi del discorso di Quarto; poi nel pieno della guerra; fino all’invito fattogli da Alceste De Ambris, altro fedele di Shelley, di illustrare con sue xilografie la lettera, inviatagli dal Garda, in data 11 maggio 1921 e divulgata sui fogli dei legionari fiumani, in cui d’Annunzio lo incitava e sosteneva a presentarsi a Parma come candidato indipendente nelle elezioni politiche, in chiara contrapposizione a Mussolini e ai “blocchi nazionali”. Le xilografie di Viani, che accompagnarono la limitatissima (100 esemplari) edizione presso la Tipografia Benedetti e Nicolai di Pescia del messaggio titolato Vogliamo vivere, furono viste e ammirate da d’Annunzio, che gli scrisse: «Il legno è vulnerato con mistica forza e potentemente vive ed esprime e significa».
Ma la Versilia è anche terra di incroci coi luoghi legati ai nomi di Carducci, Pascoli e Puccini. Il Taccuino XLIV, alla data del 21 settembre 1902, annota una visita alla casa natale di Carducci a Valdicastello: appunti sottesi a più testi dannunziani, come il Saluto al Maestro di Maia e il Commiato di Alcyone. Nel segno del pellegrinaggio, il Taccuino XLVIII, sotto la data del «17 febbraio 1907, il giorno dopo la morte di Enotrio», ferma alla foce del Motrone impressioni rielaborate nell’avvio di una favilla edita sul «Corriere della Sera» il 30 luglio 1911, Di un maestro avverso, poi nel Compagno dagli occhi senza cigli. Se d’Annunzio non andò ai funerali bolognesi, cercando piuttosto il dialogo con il Maestro nel suo paesaggio natale, non si sottrasse, oltre che dal comporre per la sua morte un’ode ben pagata, pubblicata sul «Corriere della Sera» del 21 febbraio, dal commemorarlo a Milano il 24 marzo al Teatro Lirico, dove ancora una volta strettamente legava il poeta alla «figura di luoghi» della sua nascita e dunque a un sacrale imprinting (Orazione al popolo di Milano in morte di Giosue Carducci, in L’allegoria dell’Autunno).
Un legame con le forme della terra da cui si è forgiati che d’Annunzio doveva sentire proiettato da Carducci a sé stesso: secondo quel movimento simpatetico tra noi e le cose, quelle misteriose corrispondenze tra interno ed esterno, tra anima e natura che aprono anche a un magico recupero di mitologici mondi perduti. Il che permette di leggere il nostro d’Annunzio come scrittore europeo, inserito a pieno nelle problematiche in cui si giocavano il destino della letteratura e persino la sua funzione antropologica (Raimondi 2003).
Su rapporti altalenanti e contraddittori, i due “fratelli” – maggiori o minori che siano – Pascoli e d’Annunzio saranno separati e uniti da quel monte sulla cui cima si ritroveranno ascendendo «per l’opposta balza». Su eco della pascoliana ascesa fissata nei versi di La piccozza (in Odi e inni), così infatti recita Il commiato di Alcyone: «Altro è il Monte invisibile ch’ei sale / e che tu sali per l’opposta balza. / Soli e discosti, entrambi una immortale / ansia v’incalza. // Or dove i cuori prodi hanno promesso / di rincontrarsi un dì, se non in cima? / Quel dì voi canterete un inno istesso / di su la cima». Versi che, come è stato notato, attingono alle righe epistolari in cui Pascoli rispondeva a una progettata visita autunnale promessa, o forse meglio minacciata (ma non attuata), nel luglio 1903 da un d’Annunzio di stanza, però, a Nettuno: «Oh! Che bel giorno sarà quello in cospetto della Pania sublime che per un pezzo abbiamo contemplato tutti e due, sebbene tu da una parte e io dall’altra, ma nel medesimo tempo, con lo stesso cuore!» (20 luglio 1903).
Metamorfosata nel monte della Gloria, la Pania, che divideva i due nei loro soggiorni estivi a Castelvecchio e in Versilia, separava anche due costumi di vita divergenti, contrassegnati dallo stesso d’Annunzio. Se infatti in Alcyone i versi del Novilunio davano malinconicamente l’addio alla panica figura di Ermione/Eleonora Duse, nel successivo Commiato, omaggio particolarmente ricco di riprese e citazioni pascoliane, appare un’altra, ben diversa figura femminile: Mariù, «la suora dalle chiome lisce», colta mentre a sera abbandona i ferri e chiude «nel forziere il lin che aulisce / di spicanardi». E nella Contemplazione della morte leggiamo: «Spesso, alla buona stagione, eravamo vicini; e vedevamo entrambi, al levarci, la Pania e il Monte forato. Ma non avemmo agio né forse voglia di visitarci, perché ci sembrava pur sempre che qualcosa delle nostre persone facesse ingombro alla familiarità dei nostri spiriti» (d’Annunzio 2005, II, p. 2124). Anche se l’ingombro delle persone non aveva impedito al dialogo di stabilizzarsi sulla pagina, come testimoniano le reciproche e assodate influenze.
Quanto a Puccini, la collaborazione a più riprese perseguita sin dal 1894, quando d’Annunzio avanzò pretese economiche troppo elevate, non approdò ad alcun esito, tanto da dettare allo scrittore del Libro segreto il ben noto: «Ecco il Lago di Massaciùccoli tanto ricco di cacciagione quanto misero d’ispirazione» (d’Annunzio 2005, I, p. 1709). Eppure un taccuino del 1900 (Taccuino XXXIX) registra la minuta di un discorso in onore di Lucca e del suo figlio Puccini, preparato da d’Annunzio, che il 3 settembre 1900 assisteva, appunto a Lucca, alla rappresentazione di Tosca, mentre la corrispondenza tra i due reca, insieme a reciproci strali, anche affettuose espressioni di stima.
Così al tempo del soggiorno dannunziano alla Versiliana nel 1906, i giornali locali parlavano di un raggiunto accordo sulla Figlia di Iorio, già tuttavia musicata da Alberto Franchetti e la cui prima scaligera era stata il 29 marzo 1906. Un progetto c’era sì, ma riguardava altra opera da comporre, La Rosa di Cipro, di cui d’Annunzio liricamente parlava scrivendo dalla Versiliana a un Puccini in più fresca vacanza a Boscolungo (lettera del 7 agosto 1906). L’abbozzo della Rosa di Cipro (nell’Allegoria dell’Autunno) darà poi vita a quella Pisanelle musicata da Pizzetti nel 1913. Non meglio andrà anni dopo, ai tempi del soggiorno dannunziano ad Arcachon, un rinnovato tentativo di collaborazione con Puccini che portò all’incompiuta stesura della Crociata degli innocenti, destinata a un approdo filmico.
Un lungo addio
Il litorale toscano resterà fino all’ultimo nella memoria e nell’immaginario dannunziano. Al di là dell’aneddoto localmente tramandato, della donna velata inviata in macchina a prendere per lui, poco prima della sua morte, una zolla di terra dal parco della Versiliana, sono le sue pagine a darne testimonianza. Il Taccuino CIX, avviato sulla partenza del 24 settembre 1917 da Taliedo con la sua squadriglia per l’impresa di Cattaro, registra, passato l’Appennino, l’emozionato avvistamento della costa tirrenica e l’insorgere dei ricordi nel passaggio su Forte dei Marmi, Viareggio, la pineta di Migliarino, la Fossa Burlamacca, il Lago di Massaciuccoli, il Serchio, l’Arno, Pisa, Bocca d’Arno, San Rossore, l’isola di Progne, la selva del Tombolo, Calambrone, Livorno. «Passo veloce sopra la mia stessa vita!», annota d’Annunzio, votato a un’impresa per cui è partito lasciando lettere di addio.
Quanto mai significativo appare che questi appunti trovino la loro rielaborata collocazione nel testamentario Libro segreto in cui si chiede: «Non dileguo su la mia stessa dileguata vita?» (d’Annunzio 2005, I, pp. 1709-1710). E torna qui una notazione di autobiografia spirituale legata ad un’immagine da lui sempre avvertita, con i suoi affreschi, come d’elezione, quella del Camposanto di Pisa che tanto spazio aveva preso già sulle pagine del Taccuino VI del 1896 e che aveva ispirato nella Pisa delle Città del silenzio i versi finali di calco petrarchesco: «Forse avverrà che quivi un giorno io rechi / il mio spirito, fuor della tempesta, / a mutar d’ale».
Se infatti nella Contemplazione della morte (d’Annunzio 2005, II, p. 2155) il Camposanto pisano (di cui si tramanda la nascita su terra santa proveniente dal Golgota) era visto quale luogo per l’avvio di una «vita nuova», sul monito al «mutar d’ale» inviatogli nel tempo e nelle lontananze da un’eletta figura femminile (Eleonora), nel Segreto ci si rivolge direttamente a lei, che di sé tanto impregna queste pagine, dicendo: «‘Mutar d’ale’. o Ghisola sempre rimota, sempre attesa, sempre disparita, io le ho pur mutate; e le rimuto. non fuor della tempesta ma sì ancor più addentro» (d’Annunzio 2005, I, p. 1710).
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Gabriele d’Annunzio, Taccuini, a cura di Enrica Bianchetti e Roberto Forcella, Milano, Mondadori, 1965.
Gabriele d’Annunzio, Altri taccuini, a cura di Enrica Bianchetti, Milano, Mondadori, 1976.
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, I e II, ed. diretta da Luciano Anceschi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 1982-1984.
Gabriele d’Annunzio, Prose di ricerca, I e II, a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2005.
Gabriele d’Annunzio, Alcyone, ed. critica a cura di Pietro Gibellini, Venezia, Marsilio, 2018.
Gabriele d’Annunzio, Carteggio col «dottor Mistico» [Angelo Conti], con una notizia di Ermindo Campana, «Nuova Antologia», 1° gennaio 1939, fasc. 1603, pp. 10-32.
Giorgio Luti, D’Annunzio in Marucelliana, in Id., Narrativa italiana dell’Otto e Novecento, Firenze, Sansoni, 1964, pp. 427-447 (con le lettere dannunziane ad Angelo Bruschi).
Gabriele d’Annunzio, Lettere a Giselda Zucconi, a cura di Ivanos Ciani, Pescara, Centro Nazionale di studi dannunziani, 1985.
Gabriele d’Annunzio, Lettere ai Treves, a cura di Gianni Oliva, con la collab. di Katia Berardi e Barbara Di Serio, Milano, Garzanti, 1999.
Gabriele d’Annunzio, Carteggio con Benigno Palmerio, Torino, Aragno, 2003.
Carteggio D’Annunzio-Hérelle (1891-1931), a cura di Mario Cimini, Lanciano, Carabba, 2004.
Al “candido fratello”. Carteggio Gabriele d’Annunzio-Annibale Tenneroni (1895-1928), a cura di Mirko Menna, Lanciano, Carabba, 2007.
Carteggio Pascoli-D’Annunzio, a cura di Emilio Torchio, Bologna, Pàtron, 2008.
Gabriele d’Annunzio, Giacomo Puccini, Il carteggio recuperato (1894-1922), a cura di Aldo Simeone, Lanciano, Carabba, 2009.
Gabriele d’Annunzio e Alessandra di Rudinì. Carteggio, a cura di Cristiana Dobner, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana, 2013.
Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio. Come il mare io ti parlo. Lettere 1894-1923, a cura di Franca Minnucci, ed. diretta da Annamaria Andreoli, Milano, Bompiani, 2014.
Bibliografia secondaria
Lorenzo Viani, Il cipresso e la vite, scritti inediti scelti e ordinati da C. Cordiè, Firenze, Vallecchi, 1943.
Lucy Napoli Prario, Tre abiti bianchi per Alessandra. La marchesa Carlotti nata Di Rudinì, Milano, Mondadori, 1954.
Guglielmo Gatti, Vita di Gabriele d’Annunzio, Firenze, Sansoni, 1956.
Umberto Saba, Prose, a cura di Linuccia Saba, Milano, Mondadori, 1964.
Paolo Alatri, Gabriele d’Annunzio, Torino, UTET, 1983.
Pietro Gibellini, Introduzione a Gabriele d’Annunzio, Alcyone, Torino, Einaudi, 1995.
Federico Roncoroni, Introduzione a Gabriele d’Annunzio, Alcyone, Milano, Mondadori, 1995.
D’Annunzio e la scoperta della Versilia, Catalogo della mostra Marina di Pietrasanta 27 maggio-5 settembre 1999, a cura di Annamaria Andreoli, Firenze, Maschietto e Musolino, 1999 (con interventi di Cesare Garboli, Annamaria Andreoli, Carlo Cresti, Rossana Bossaglia, Umberto Sereni).
Terre, città e paesi nella vita e nell’arte di Gabriele d’Annunzio, II-III, La Toscana, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e la Francia, a cura di Silvia Capecchi, XXIV Convegno internazionale Firenze-Pisa, 7-10 maggio 1997, Pescara, Ediars, 1999 (con, in particolare, gli interventi di Ivanos Ciani su Pisa e la Versilia; di Floriano Romboli, Pietro Gibellini, Antonio Zollino e Francesca Nassi sui luoghi di Alcyone).
L’Alcyone e la scoperta della Versilia, Atti del Convegno Pietrasanta 27-29 maggio 1999, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 2003 (con interventi di Ezio Raimondi, Marco Santagata, Cristina Benussi, Mario Bortolotto, Rossana Bossaglia, Giorgio Zanetti, Annamaria Andreoli, Carlo Cresti, Umberto Sereni, Alberto Bertoni, Cesare Garboli, Pietro Gibellini, Carlo da Pozzo).
Pietro Gibellini, Un’idea di d’Annunzio. Trent’anni di studi, Lanciano, Carabba, 2023.
Lorenzo Viani, Gabriele d’Annunzio. Eterna inquietudine, a cura di Paolo Riani e Andrea Lancellotti, Reggio Emilia, Corsieri, 2023 (catalogo di due mostre tenute a Gardone Riviera e Viareggio nel 2023).