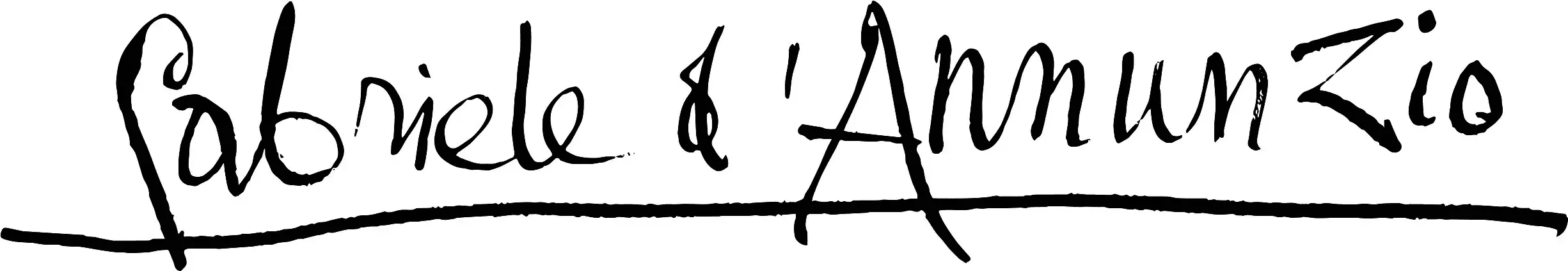di Elisa Sala, Enciclopedia dannunziana
La nascita del progetto: dai desiderata dannunziani al 1930
Il Teatro all’aperto del Vittoriale degli Italiani si colloca nel complesso monumentale di Gardone Riviera (BS), residenza benacense di Gabriele d’Annunzio dal 1921. La struttura per lo spettacolo si lega saldamente al disegno architettonico complessivo del Vittoriale, venendo racchiusa tra suoi viali d’accesso (Terraroli 2001, pp. 248-249). Ripercorrendo il tracciato originario studiato da Gian Carlo Maroni, l’architetto della Santa Fabbrica dannunziana (Irace 1993), superato il doppio portale e lasciandosi alle spalle l’iconica iscrizione «Io ho quel che ho donato», si viene immessi nel percorso di risalita verso la Prioria (Guerri 2025). All’altezza del Giardino delle Vittorie, volgendo lo sguardo a sud-est, la vista abbraccia l’intero emiciclo del Teatro spaziando sul lago di Garda, con la possibilità di ammirare l’isola del Garda, la rocca di Manerba, il monte Baldo e il promontorio di Sirmione. Una scenografia naturale e suggestiva, parte integrante del complesso architettonico dannunziano. Il secondo percorso, oggi utile alla gestione dell’accesso dei visitatori, si imposta più a sud e, sfruttando il declivio del terreno, giunge in quota alla platea, incuneandosi tra cavea e palcoscenico.
L’idea progettuale del Teatro all’aperto del Vittoriale degli Italiani, Il Parlaggio, come lo battezzò Gabriele d’Annunzio ancora prima della sua costruzione, è frutto di una vicenda composita che affonda le sue radici in diverse esperienze vissute di persona dal Vate. Questo complesso bagaglio emotivo e teorico orienta le scelte compositive di Gian Carlo Maroni, indirizzate alla creazione di un teatro moderno e innovativo il cui progetto è riconducibile al 1930 (Giustina Sala 2021, pp. 17-40).
L’esperienza del Festspielhaus di Richard Wagner a Bayreuth e del festival Les Chorégies d’Orange che si teneva, come oggi, nell’antico teatro romano «costruito contro il fianco petroso d’un colle, a simiglianza del Teatro di Dionisio contro il fianco dell’Acropoli ateniese» (D’Annunzio 1897), segnano il Poeta nella maturazione della sua idea di architettura teatrale ancor prima della fine dell’Ottocento (Isgrò 2024; Idem 2009, pp. 17-57).
Ne nasce il sogno di un teatro ad Albano, ai piedi dell’antica Albalonga, desiderio condiviso con l’amata Eleonora Duse (Caterina Del Vivo 2025; Orvieto 1897). Un teatro di festa (Oliva 2022) ispirato a quello di Orange ma al contempo differente, non un semplice recupero archeologico: un’interpretazione in chiave moderna della lezione dell’antico. L’eccessivo onere economico del progetto fa naufragare la sua realizzazione lasciandone traccia solo nel romanzo Il fuoco (1900) e, forse, in un illusorio «secondo sogno», come lo definisce Tom Antongini, da idearsi sulle vestigia del teatro romano di Fiesole (Antongini 1938, p. 634).
Il trasferimento a Parigi del 1910 porta il Poeta a confrontarsi con prospettive progettuali e operative totalmente nuove (Isgrò 2025, pp. 41-44). L’amicizia con Mariano Fortuny conduce alla creazione di un impianto mobile coperto da una ardita cupola di ferro e tela e articolato secondo l’ispirazione classica, fondendo elementi dell’anfiteatro romano con quelli del teatro greco in un binomio che tornerà poi nel progetto per il Vittoriale (Isgrò 2016). Anche questa nuova occasione sfuma però nel 1912.
Si giunge quindi all’esperienza fiumana e agli articoli della Carta del Carnaro declamati dal Comandante la sera del 30 agosto 1920, quando al Collegio degli Edili commissiona «l’edificazione di una Rotonda capace di almeno diecimila uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e d’una vasta fossa per l’orchestra e il coro» (La reggenza del Carnaro… 1920). Ancora un teatro all’aperto.
Nel 1921, con alle spalle di Natale di Sangue, il Poeta giunge a Gardone e si stabilisce a villa Thode (Mazza 1985), il nucleo originario dell’attuale Prioria del Vittoriale degli Italiani (Raimondi 2021, pp. 21-47; Terraroli 2001, pp. 99-225). L’iniziativa dannunziana, dalla sponda benacense, si spinge ben presto fino alla città di Brescia, travalicando le mura del Castello, posto nel cuore dell’urbe, e concretizzandosi nella costruzione di un vero e proprio teatro all’aperto, sempre in forma emiciclica, il cui cantiere si avvia con il febbraio del 1923 (Gatta 2022). L’opera, oggi non più esistente, viene a collocarsi a est della Torre Coltrina, nello spazio erboso noto come Fossa dei Martiri.
Conclusa l’esperienza in Castello, d’Annunzio matura l’intenzione di tramutare gli spazi verdi del Vittoriale degli Italiani, ancora scevri di molte delle architetture che poi andranno a caratterizzarli nei decenni successivi, in un luogo idoneo a mettere in scena La figlia di Iorio, la prima rappresentazione teatrale ospitata nel complesso (Isgrò 2017; Pirlo 2007). La tragedia rustica, ambientata in Abruzzo, trova dunque spazio, nell’agosto del 1927, nei giardini del Vittoriale; per l’occasione Maroni progetta e costruisce architetture di scena effimere. Da questo momento il tema del Teatro diviene oggetto anche di alcuni scambi epistolari tra il Vate e il suo architetto (Di Tizio 2009).
Il disegno di una struttura stabile destinata al Vittoriale degli Italiani è, invece, databile al 1930 grazie ad alcuni schizzi preparatori e tre tavole di progetto firmate dall’architetto e conservate negli Archivi della Fondazione (Giustina Sala 2021, pp. 18-40). Gli schizzi maroniani, attentamente studiati e discussi da Irene Giustina, mostrano il vaglio delle scelte architettoniche mirate a emulare, e al contempo perfezionare, le innovazioni della rappresentazione e della struttura teatrale adottate nel Festspielhaus di Bayreuth. La cavea assume uno sviluppo semicircolare, ancorandosi alla scena mediante corpi laterali in progressivo aggetto sulla gradinata; la scenafronte viene modellata anch’essa secondo un profilo semicircolare ad arcate, lasciando intravedere l’ampio spazio retrostante, di analoga geometria; il proscenio si protende al centro dell’orchestra, celando il golfo mistico destinato agli orchestrali. Diverse ipotesi vengono invece sperimentate per la sommità della cavea. Le idee formulate per il teatro lasciano intendere una prima fase di approccio al tema progettuale, che esplora la possibilità di trasferire e adattare agli spazi del Vittoriale, in una declinazione en plein air, le principali soluzioni proprie del teatro di Bayreuth, struttura che, del resto, d’Annunzio riteneva esemplare: «Teatro ideale […] edificio sacro alla festa suprema dell’Arte» (D’Annunzio 1894, p. 522).
Nelle tavole, si conferma l’adozione del modello antico a emiciclo con cavea gradonata conclusa in sommità da un motivo trabeato, che richiama la romana columnatio, e ai lati da ampie curve divergenti a memoria dell’idea tardocinquecentesca di Vincenzo Scamozzi per il teatro di Sabbioneta. Alla cavea si collega la «platea alta», sviluppata sopra un particolare e innovativo foyer interrato. Il palcoscenico, di cui Maroni sfrutta abilmente anche il sottopalco, è anch’esso ricurvo e incorniciato da torri di scena capaci di inquadrare la bellezza del lago di Garda. Il Teatro così ideato diviene il fulcro ideale dell’intero complesso, come sottolinea Marcello Piacentini nel 1930 osservandone i disegni: «Il Teatro, con lo sfondo del Lago, è il fuoco di tutta la composizione architettonica del Vittoriale: tutte le vie vi convergono» (Piacentini 1930, p. 166).
Per comprovare la bontà del suo progetto e per convalidare gli studi affrontati per delinearlo, testimoniati anche dall’acquisto di una copia dell’opera Pompei di Arturo Jahn Rusconi, edita nel 1929 (Arnaudi 2025, p. 92), l’architetto, in compagnia dell’artista e amico Renato Brozzi, si reca in terra partenopea nel 1931. Rincuorato delle sue scelte, stende il progetto definitivo arrivando al dettaglio strutturale, sfruttando i materiali della modernità (cemento armato e solai in latero-cemento) senza rinunciare alla monumentalità di un rivestimento in lastre di marmo rosso di Verona. Sebbene tutto sia pronto, difficoltà nell’ottenere i finanziamenti e altre urgenze edilizie nel Vittoriale ritardano l’avvio del cantiere del Teatro.
L’avvio dei lavori e il ruolo di Gian Carlo Maroni (1935-1951)
Più di cento disegni conservati presso gli Archivi del Vittoriale dettagliano le fasi salienti del cantiere del Teatro i cui lavori vengono affidati alla ditta Butturini e Rusinenti di Salò (BS), mentre la Angelo Castellani & Figli di Caprino Veronese (VR) è la principale fornitrice di materiali lapidei (Giustina Sala 2021, pp. 43-60).
Il primo lotto di lavori al Teatro, avviato nel 1935, riguarda le attività di sbancamento e l’esecuzione delle prime fondazioni per la realizzazione della cavea, in particolare della parte più alta, in diretta connessione con i percorsi d’accesso al Vittoriale. Le opere edili si protraggono fino all’agosto del 1936, giungendo a completare le quattro arcate in affaccio sui viali d’accesso rivestite in marmo rosso di Verona lavorato a martellina.
Tra il marzo 1935 e il febbraio 1936 Gian Carlo Maroni si dedica alla redazione di tavole specifiche per la posa dei rivestimenti del nucleo ingressi, comprese le scale gemelle a servizio del pulvinare e degli interrati; la medesima cura nella lavorazione delle fronti viene garantita al prospetto opposto al Teatro che, lungo i viali d’ingresso, specchia la soluzione a quattro arcate. Ogni singolo elemento lapideo è definito nelle sue dimensioni, si stabilisce lo spessore dei giunti di malta e il metodo di aggancio alla struttura muraria in cemento armato. Con il 1936 le attività vengono sospese.
Nel maggio del 1937 nasce la Fondazione del Vittoriale degli Italiani, che diviene operante dopo la scomparsa di Gabriele d’Annunzio (1° marzo 1938). Da questo momento Maroni assume ufficialmente la nomina di Sovrintendente del Vittoriale degli Italiani. Il cantiere del Teatro è riaperto nell’aprile del 1938 con la costruzione degli arconi strutturali reggenti la cavea; ciò implica che dell’intera struttura del Teatro le uniche parti effettivamente apprezzate da d’Annunzio in opera siano le quattro arcate di ingresso.
Dal giugno del 1939 l’attenzione viene rivolta alla costruzione del “solettone” in latero-cemento, ossia la porzione di copertura della gradonata più alta e della pavimentazione del nucleo ingressi. Le attività edili, anche in questo caso, e secondo una logica estremamente ricorrente all’interno del cantiere del Vittoriale degli Italiani, sono nuovamente sospese per mancanza di fondi. Incuriosisce il fatto che, nello stesso periodo (1940), la stampa nazionale informi dell’avviamento di un progetto architettonico indirizzato ad omaggiare la figura del Vate nella sua città natale, Pescara, attraverso la costruzione di un altro teatro (Fiadino 2019). Maroni, già nel 1936, aveva liquidato la possibilità di seguire in prima persona la commessa; l’opera pare trovare attuazione solo nel 1943 senza però concretizzarsi prima degli anni Sessanta (Verazzo 2020).
Numerose fotografie conservate presso gli Archivi della Fondazione permettono, invece, di cogliere appieno lo stato di avanzamento dei lavori del Teatro del Vittoriale al 1939: l’ingresso al Teatro è segnato da quattro arcate ai lati delle quali si innestano i corpi-scala, mentre manca completamente la muratura del prospetto interno; sono stati realizzati gli arconi più elevati a sostegno della porzione superiore della cavea. Pochi interventi di sbancamento hanno interessato l’area della platea e niente è stato fatto per il palcoscenico.
Nonostante lunghe ed estenuanti trattative per ottenere nuovi finanziamenti, l’inizio della Seconda guerra mondiale e il successivo dopoguerra decretarono una inevitabile sospensione di tutte le attività edili e, di fatto, sanciscono alcune sensibili variazioni al progetto iniziale applicate in parte dallo stesso Maroni nella speranza di contenere al massimo i costi e quindi facilitare le sovvenzioni statali. Le dimensioni del teatro rimangono invariate: si conferma un diametro massimo di 50 metri della struttura, capace di accogliere ben 2500 persone, implementabili fino a 3000 con l’aggiunta di adattamenti provvisori. Spicca inoltre la volontà dell’architetto di sfruttare le nuove tecnologie: ambisce a poter allestire un sistema di rotaie raso pavimento per la gestione di carrelli su cui posizionare le scene modellate nelle tre dimensioni e strutturate per non essere fisse. L’arcense rimane alla direzione del cantiere fino a pochi mesi prima della sua morte (2 gennaio 1952).
Il cantiere e i professionisti coinvolti nella seconda metà del Novecento
Venuto a mancare Gian Carlo Maroni, la guida tecnico-amministrativa viene assunta dal fratello Italo con la collaborazione consultiva dell’ingegnere Mario Moretti di Brescia. La volontà del Presidente della Fondazione, in quegli anni Eucardio Momigliano (Raimondo 2021, pp. 132-143), è di aprire il Teatro al pubblico nell’agosto del 1953 in occasione delle Manifestazioni dannunziane prima, però, è necessario portarlo a compimento nelle sue forme e funzionalità essenziali (Giustina Sala 2021, pp. 63-83).
Il cantiere è quindi riavviato nel novembre del 1952 con attività finanziate dalla Fondazione e grazie a offerte e forniture di materiali edili garantite da alcuni sostenitori privati, in gran parte bresciani. Si procede con la definizione delle sottostrutture ad arco della cavea, viene completato il getto della soletta e si avvia la messa in opera delle fondazioni del palcoscenico oltre agli scavi per la fossa dell’orchestra e allo spianamento dell’area della platea. Ristrettezze economiche portano a rinunciare alla «platea alta» progettata da Gian Carlo Maroni, quindi, si perde il volume dell’ampia sala destinata ad attività espositive, ma soprattutto viene a mancare la continuità di quota tra la base della cavea, la platea e il palcoscenico; la soluzione finale viene, infatti, definita a «platea bassa».
Le attività edili proseguono senza sosta e, con un secondo lotto di lavori, si provvede all’esecuzione del nucleo ingressi e del pulvinare, semplificando notevolmente l’idea maroniana del 1930. In base alle tavole dell’architetto il prospetto esterno avrebbe dovuto prevedere un secondo livello caratterizzato da tozze lesene in continuità con quelle inferiori e racchiuso, agli estremi, da archi a doppia ghiera di conci. La fronte rivolta verso la cavea, invece, oltre a essere caratterizzata da un fondale architettonico creato appunto dal secondo registro appena descritto, avrebbe dovuto articolarsi in un prospetto più complesso basato sul ritmo di due arcate in estremità con tratto trabeato a doppia luce centrale. Con i lavori del 1953 non solo si evita la realizzazione del secondo ordine della facciata esterna, ma si semplifica notevolmente quella interna privandola del sistema a doppio arco e portando a vista le pareti racchiudenti i vani scale, inizialmente occultati da un sistema murario più complesso e armonioso. Ristrettezza di tempi e di fondi non consentono infine la messa in opera del rivestimento lapideo.
Si procede inoltre con la realizzazione della soletta del palcoscenico e l’inserimento dei servizi igienici sotto la cavea. Il sopralluogo di Paolo Grassi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, evidenzia ancora la necessità di ulteriori lavori per accogliere attori e pubblico in sicurezza e decoro (6 aprile 1953). Alle attività già in atto se ne affiancano quindi altre indirizzate al compimento di alcuni camerini nell’area sotto al palcoscenico e all’inserimento di gradinate esterne a suo servizio; si lavora inoltre alla creazione della buca del suggeritore e alla sistemazione di quella dell’orchestra.
L’8 agosto del 1953, nell’ambito delle Manifestazioni dannunziane, viene finalmente inaugurato il Teatro con il concerto sinfonico dell’orchestra del Teatro alla Scala diretta dal maestro Carlo Maria Giulini, con musiche di Vivaldi, Pizzetti, Wagner e Beethoven; un palinsesto ben diverso da quello inizialmente sperato, che avrebbe dovuto prevedere la rappresentazione de La figlia di Iorio per riconnettersi idealmente all’evento tenutosi nei giardini del Vittoriale nel 1927 (Rosso 1953).
Il Parlaggio, concluso almeno nelle sue linee essenziali, stupisce pubblico e stampa. Scrive Orio Vergani in quei giorni: «Aspettando di poter fare “tutto”, il Teatro non avrebbe potuto forse diventare mai una realtà. Era, invece necessario cominciare da una realtà che dovrà poi perfezionarsi: ultimare le gradinate, gli accessi, le tribune, la piattaforma del palcoscenico con la vasta gradinata che lo conclude verso il panorama del lago. […] un Teatro ancora senza marmi, ma “agibile” […] Il Teatro c’è; la sua decorazione verrà più tardi» (Vergani 1953).
Pochi anni dopo è progettato e realizzato il motivo trabeato (1957) a chiusura superiore della cavea. L’idea di creare un elemento architettonico che definisse geometricamente l’ingombro del teatro alla quota massima era, come anticipato, parte del progetto maroniano del 1930 dove si proponevano semplici pilastrini, parzialmente rivestiti a bugnato, disposti in pianta secondo un disegno semicircolare. Il coronamento trabeato è concretamente realizzato sotto la supervisione di Moretti prima del luglio del 1957, poiché appare nelle fotografie scattate in occasione della messinscena de La figlia di Iorio. Il disegno, evidentemente semplificato rispetto alla proposta originaria, prevede la creazione di snelli pilastrini in calcestruzzo armato da lasciarsi a vista, quindi senza rivestimento lapideo, collocandoli lungo il profilo alto della cavea e mantenendo un interasse di poco inferiore ai 4 metri; su di essi viene impostato un architrave modanato, molto sottile, anch’esso in calcestruzzo armato. Solo ipotizzato rimane, invece, il disegno del sistema di rivestimento in marmo rosso di Verona del pulvinare (1955), ancora ostacolato dalle ristrettezze economiche.
Con il 1957 si giunge a realizzare la struttura generale e funzionale del Teatro, ma già nel 1965 cominciano a comparire evidenti segni di usura nelle murature e nei solai, rimasti senza finitura o protezione diversa ormai da alcuni anni. Si devono attendere gli anni Settanta per la presentazione di un piano-lavori a firma dell’architetto Carlo Casati di Milano e dell’ingegnere Pietro Trivella di Montichiari (Giustina Sala 2021, pp. 76-79). La lettura dello stato di fatto è arricchita da preziose fotografie di scorci del Teatro che aggiungono il necessario chiarimento alle linee progettuali e al contempo risultano un efficace documento per la valutazione delle condizioni della struttura.
Il progetto, ben più vasto di una semplice messa in sicurezza, punta all’eliminazione di quelle che vengono definite ‘sovrastrutture’ capaci solo di interrompere la visione unitaria tra architettura e ambiente naturale. Si suggerisce la totale demolizione del nucleo ingressi e la creazione di nuove scale per l’accesso all’area sotto la cavea oltre a demolire le quinte laterali, poste in opera dopo il 1953. Ambendo forse a rivitalizzare quella connessione inizialmente prospettata da Maroni tra palcoscenico e cavea, Casati propone, inoltre, di mettere in opera due terrazze; mentre, nell’area sotto il palco, oltre ai camerini disposti a raggera lungo la circonferenza maggiore, in linea con l’idea maroniana, prospetta l’aggiunta di un ambiente per mostre o riunioni. Le indicazioni progettuali contemplano, infine, una revisione completa del tracciamento viario a servizio del Teatro.
Poco viene realizzato del progetto Casati: si interviene sull’area del palco risanandone la soletta e allestendo nell’interrato i camerini e l’area multifunzionale, la stessa che, nel 2010, ha accolto le sale del museo D’Annunzio segreto; nel medesimo anno si è posizionata la scultura Cavallo blu di Mimmo Palatino e nel 2016 gli Angeli di Ugo Riva (Raimondo 2021, p. 202). Tutti questi interventi hanno avuto luogo sotto la presidenza di Giordano Bruno Guerri (Raimondo 2021, pp. 200-211).
Il teatro, dal 2011, ospita la regolare stagione degli spettacoli del Festival Tener-a-mente. Nel 2015 è inoltre nata la sezione della rivista Sinestesieonline intitolata Il Parlaggio e aperta a contributi sul teatro e le arti performative in tutte le epoche storiche, forme e varianti.
Il completamento del Teatro (2018-2020)
L’incompiutezza dell’opera, soprattutto in relazione alla mancanza delle fodere lapidee previste già nel 1930, unitamente all’usura causata dal tempo, aggravata dall’azione degli agenti atmosferici e da uno sfruttamento intensivo del bene, hanno determinato negli anni l’insorgere di numerosi problemi architettonici e strutturali (Giustina Sala 2021, 79-80).
Il Progetto di riqualificazione e completamento dell’anfiteatro del Vittoriale, ideato da MI10 srl grazie all’iniziativa del Presidente della Fondazione Giordano Bruno Guerri (Raimondo 2021, p. 202-203), ha previsto interventi di miglioramento conservativo delle strutture murarie e lo studio di un nuovo impianto illuminotecnico.
I lavori eseguiti nel biennio 2019-2020 hanno riguardato il trattamento, la pulizia e la protezione delle superfici del Teatro usurate dal tempo garantendo una riqualificazione architettonica dell’intera struttura. Si è quindi provveduto alla posa del rivestimento lapideo, in marmo rosso di Verona, come da indicazione di Gian Carlo Maroni. Proprio ad alcuni dettagli disegnati dall’architetto si è ispirata la soluzione adottata per tutta l’area della gradinata e poi estesa alla pavimentazione alta del coronamento, alla platea e alla porzione più bassa dei pilastri.
Le pareti colorate che delimitano la platea e l’area del pulvinare sono state pulite e, dove necessario, si è rimosso e poi ripristinato lo strato di intonaco deteriorato. Gli interventi si sono conclusi con la posa di nuove lattonerie e la sostituzione dei parapetti a delimitazione delle gradinate con protezioni idonee alla messa in sicurezza degli spettatori. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo dell’Assessorato all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia.
Nel luglio del 2020 il teatro del Vittoriale, nella sua nuova e vera veste di conca marmorea, viene inaugurato. L’occasione, ricordata anche da un’esposizione permanente intitolata Il Teatro del Vittoriale degli italiani. Idee, progetto e cantiere a cura di Irene Giustina e Elisa Sala, oltre a mostrare l’esito dei lavori, segna anche il punto di chiusura della lunga vicenda progettuale e costruttiva dell’opera.
*Lo studio del progetto e del cantiere del Teatro all’aperto del Vittoriale degli Italiani è stato condotto nell’ambito della Convenzione triennale di ricerca, I luoghi di Gabriele d’Annunzio e Gian Carlo Maroni tra storia e progetto. Conoscenza e valorizzazione del complesso architettonico, museale e ambientale del Vittoriale degli Italiani, stipulata tra la Fondazione del Vittoriale degli Italiani e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica – DICATAM dell’Università degli Studi di Brescia con il coordinamento scientifico della prof.ssa Irene Giustina e la partecipazione dell’ing. Elisa Sala.
La voce qui presentata riassume e aggiorna la vicenda del Teatro pubblicata nel volume Irene Giustina, Elisa Sala, “Videro in sogno il teatro di marmo”. Storia, architettura e cantiere del ‘Parlaggio’ nel Vittoriale degli Italiani, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2021 e anticipata nella breve guida alla mostra permanente Irene Giustina, Elisa Sala, Il teatro del Vittoriale degli Italiani. Idee, progetto e cantiere, Breno (BS), Il Leggio (in coedizione con Il Vittoriale degli Italiani), 2020.
Bibliografia essenziale
Irene Giustina, Elisa Sala, «Videro in sogno il teatro di marmo». Storia, architettura e cantiere del ‘Parlaggio’ nel Vittoriale degli Italiani, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2021.
D’Annunzio e il teatro all’aperto. Estetica, luoghi, protagonisti, a cura di Maria Pia Pagani, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2025.
Giovanni Isgrò, Il paesaggio scenico di Gabriele D’Annunzio, Roma, Bulzoni Editore, 2024.
Ho fatto di tutto me la mia casa. Antologia di scritti illustri sulla Prioria del Vittoriale degli Italiani, a cura di Giordano Bruno Guerri, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2025.
Teatri all’aperto in Italia: lo stato degli studi, Atti del Workshop per il progetto PRIN PNRR 2022 Open Air Theatres in Italy (OATI) (30 aprile 2025), a cura di Maria Pia Pagani, Paolo Quazzolo, Anna Sica, in «Sinestesieonline», rubrica Il Parlaggio, 46, XIV, settembre 2025, online all’indirizzo <https://sinestesieonline.it/il-parlaggio/>.
Chiara Arnaudi, «Qui si farà il teatro che il Comandante chiama già il Parlaggio». Gabriele d’Annunzio, Gian Carlo Maroni e il teatro del Vittoriale, in D’Annunzio e il teatro all’aperto. Estetica, luoghi, protagonisti, a cura di Maria Pia Pagani, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2025, pp. 83-97.
Giovanni Isgrò, L’idea del teatro en plein air da d’Annunzio a Fortuny, in D’Annunzio e il teatro all’aperto. Estetica, luoghi, protagonisti, a cura di Maria Pia Pagani, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2025, pp. 35-45.
Caterina Del Vivo, Angiolo e Laura Orvieto e il Teatro Romano di Fiesole, in D’Annunzio e il teatro all’aperto. Estetica, luoghi, protagonisti, a cura di Maria Pia Pagani, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2025, pp. 69-81.
Costanzo Gatta, Nel 1923 a Brescia il teatro all’aperto sognato da d’Annunzio, «Sinestesie», 2022, 24: D’Annunzio e l’innovazione drammaturgica. Numero speciale, pp. 323-342.
Gianni Oliva, Il teatro di festa. Progettualità e messinscena nella drammaturgia dannunziana, «Sinestesie», 2022, 24: D’Annunzio e l’innovazione drammaturgica. Numero speciale, pp. 95-108.
Valentina Raimondo, Cento anni di storia del Vittoriale degli Italiani. L’incantevole sogno, Cinisello Balsamo (MI), SilvanaEditoriale, 2021.
Clara Verazzo, Una iniziativa nata morta. Il teatro “rudere” dedicato a Gabriele d’Annunzio dalla realizzazione alla conservazione, «Conversaciones… con Nicholas Stanley-Price», 2020, 9, pp. 201-2020.
Adele Fiadino, Il monumento nazionale a Gabriele D’Annunzio e il teatro all’aperto nella pineta di Pescara, in La tutela difficile. Patrimonio architettonico e conservazione a Pescara, a cura di Claudio Varagnoli, Corfinio, MAC Edizioni, 2019, pp. 97-104.
Giovanni Isgrò, D’Annunzio e il teatro fuori dal teatro. La messinscena della Figlia di Iorio al Vittoriale (1927) e della Nave a Venezia (1938), «Archivio d’Annunzio», 2017, 4, pp. 39-48.
Giovanni Isgrò, La mancata collaborazione D’Annunzio/Fortuny, in La scena di Mariano Fortuny, a cura di Maria Ida Biggi, Claudio Franzini, Cristina Grazioli, Marzia Maino, atti del convegno (Padova-Venezia, 22-23 novembre 2013), Roma, Bulzoni Editore, 2016, pp. 179-196.
Giovanni Isgrò, Sviluppi delle risorse sceniche in Italia. Da d’Annunzio agli anni Trenta, Roma, Bulzoni Editore, 2009.
La Santa Fabbrica del Vittoriale nel carteggio inedito d’Annunzio-Maroni, a cura di Franco Di Tizio, Pescara, Ianieri Editore, 2009.
Vittorio Pirlo, Con la mazza del pastore e la camicia bianca. Dalla ‘platea erbosa’ al ‘parlaggio’, in «Quaderni de Il Garda», 2007, 3, pp. 27-34.
Valerio Terraroli, Il Vittoriale. Percorsi simbolici e collezioni d’arte di Gabriele d’Annunzio, Genève-Milano, Skira, 2001.
L’architetto del lago. Giancarlo Maroni e il Garda, a cura di Fulvio Irace, catalogo della mostra (Riviera del Garda e Gardone Riviera, 11 luglio – 21 novembre 1993), Milano, Electa, 1993.
Attilio Mazza, Cargnacco prima di d’Annunzio, Brescia, Ecoedizioni, 1985.
Orio Vergani, Si inaugura al Vittoriale il teatro che D’Annunzio sognò, «Corriere della Sera», Milano, 7 agosto 1953.
Francesco Rosso, Il nuovo teatro del Vittoriale aspetta «La figlia di Jorio», «Il Dramma», 1° settembre 1953, 187-188, pp. 69-71.
Tom Antongini, Vita segreta di d’Annunzio, Verona, Mondadori, 1938.
Marcello Piacentini, Gian Carlo Maroni architetto del Vittoriale, «Architettura e Arti decorative», 1930, 10, pp. 145-168.
La reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello stato libero di Fiume. Quis contra nos? In Fiume d’Italia. XXVII agosto MCMXX, Tipografia “Miriam”, [Fiume 1920].
Gabriele d’Annunzio, Trionfo della morte, Milano (1894) 1900, Treves, pp. 522.
Gabriele d’Annunzio, La Rinascenza della Tragedia, «La Tribuna», 2 agosto 1897, pubblicato in Gabriele d’Annunzio, Scritti giornalistici, 2 voll., a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 2003, II, pp. 262-265.
Angiolo Orvieto, Il teatro di festa. Colloquio con Gabriele D’Annunzio, «Il Marzocco», 12 dicembre 1897.