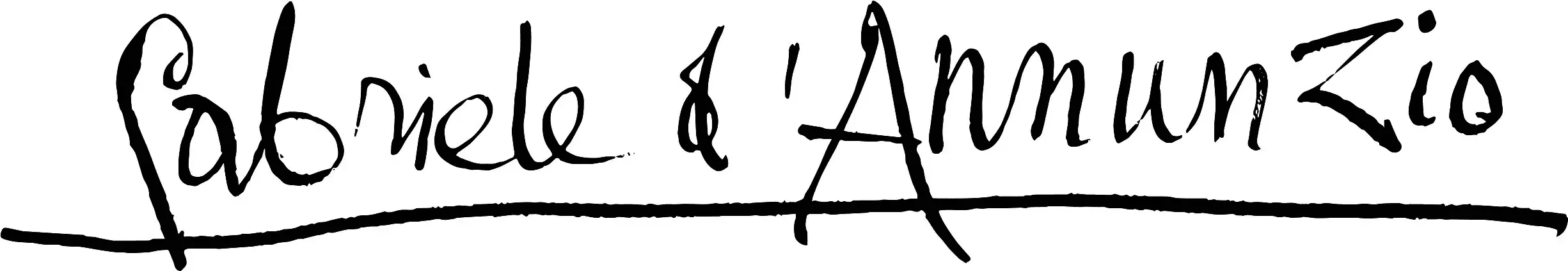di Manuela Ricci, Enciclopedia dannunziana
Il rapporto di Marino Moretti con Gabriele d’Annunzio si configura primariamente come un confronto con il modello culturale dominante del primo Novecento, si trattò infatti di un incontro avvenuto anzitutto sul piano letterario, che solo in seguito assunse il dato di una conoscenza personale. Come accaduto per gli altri giovani poeti della sua generazione, infatti, la sua formazione si era compiuta sotto il segno del Maestro a partire dalla lezione del dannunzianesimo, propiziata, oltre che dalle letture, da un gusto diffuso e pervasivo che segnò la cultura del tempo e penetrò anche la primissima produzione del giovane romagnolo. L’incontro col Vate avvenne in seguito e gli scarni eventi arricchirono di nuovi accenti l’opera morettiana che quindi si infittì di occorrenze della presenza del “personaggio d’Annunzio”, sia in poesia che in prosa.
Per quanto riguarda gli anni della formazione e dell’esordio morettiano, il racconto è ampiamente registrato nei capitoli di Via Laura, libro di memorie giovanili del 1931, in parte anticipati nei Ricordi dannunziani apparsi sulle pagine di «Pegaso» nel 1929. Tutto avveniva infatti a Firenze dove il giovane romagnolo si era trasferito, fatalmente attratto da una ipotesi di carriera teatrale che ben presto tuttavia si era trasformata in pura vocazione letteraria proprio all’interno della Regia Scuola di Recitazione di Luigi Rasi.
Nella capitale dell’intellettualismo italiano egli tuttavia avrebbe conosciuto e amato «il giovinetto, angelico e ricciutello, tutto però illusorio o presunto, del Primo Vere» ch’era Gabriellino e non Gabriele, avrebbe cioè goduto dell’amicizia trepida del figlio, anch’egli frequentante la scuola del Rasi, e «non il favore o l’incitamento del padre». Il legame con Gabriellino è testimoniato dalle affettuose pagine di Via Laura dedicate a Simonetto (1931, pp. 36-48), che – come anche i documenti epistolari attestano (Benfante 1993) – si riferiscono ad un breve, seppure intenso, capitolo dell’esperienza fiorentina: nel 1905, infatti, la scrittura de La fiaccola sotto il moggio, che Gabriele padre realizzò apposta per il figlio, ne sancì il debuttò teatrale che divise la sua strada da quella dei sodali: «Triste, quando una specie di fiele della coscienza e dell’intelletto avvelena la nostra infanzia letteraria togliendoci la felicità e la freschezza e quasi la fede, e non si può più amare ciecamente un poeta. Felici coloro che non fecero mai distinzioni: questo è bello, questo un po’ meno. Grande poeta, ripreparaci il filtro della giovinezza perché possiamo ritrovare il senso della tua infallibilità» (1931, pp. 48)
Malgrado la presenza di Gabriellino, la città che ospitava sulla collina «l’autore del Piacere e del Fuoco, dell’Isotteo e del Poema Paradisiaco», non fece mai da scenario a un incontro personale di Moretti col d’Annunzio. Nella città d’elezione, che a quel tempo l’Italia colta e raffinata guardava trepidante perché vi si compiva il destino di una intera generazione di giovani entusiasti decisi a farsi un nome, la chiesa promulgatrice di quella nuova religione di Bellezza ˗ scriveva appunto Moretti ˗ aveva il nome “lievemente ridicolo” di Capponcina, la villa di Settignano, occultata da cieche muraglie a protegger la “clausura” dov’egli, al tempo, non ebbe modo di entrare potendo solo immaginare la splendida dimora attraverso il racconto di altri più fortunati frequentatori:
chi poteva dire come fosse l’interno della straordinaria catapecchia e di che fossero ricoperti i suoi vani, di qual materia fossero i tappeti, i cuscini, le stoffe? Strane dovevano essere le suppellettili in quella penombra quasi di cripta ove s’alzavano disordinatamente qua e là bizzarre forme di leggii, candelabri, torcieri, e da per tutto, dicevasi, oggetti da chiesa in effluvî densi d’incenso, statue greche, interi pezzi di Partenone, il mezzo busto di Niccolò da Uzzano che ci aveva fatto quasi paura al Bargello, ed ecco la camera del poeta che pareva una camera mortuaria, con un lettuccio simile a una bara. Fuor della casa, oltre il muretto a secco, si udivano strane voci: latravan cani, nitrivan cavalli. Proseguendo la strada sonora, tutta di pietra, incassata fra i muriccioli dei poderi, io recitavo fra me nel mio cervello l’invettiva di Ostasio o tubavo l’ingenua pena di Samaritana, piccola sorella, finché giungemmo al termine del muretto là dove si apriva la porticina rustica con sopra una madonnina robbiesca sbocconcellata, pochissimo dannunziana, che aveva sul capo le due prime parole della salutazione angelica, ma del più smorto blù di terracotta. Povertà, misticismo umilissimo dopo lo sfarzo del misticismo quasi sacrilego. C’era in quel punto anche uno scandaloso odor di basilico o di pepolino. Ora mi pare che nel podere di là della Capponcina, un uccellino pascoliano pigolasse quasi a rifare il verso, per contrasto, al serafico antagonista del padron di casa, fratello maggiore e minore. Dirimpetto alla porticina rustica c’era l’ingresso d’una bicocca tanto più piccola, più in vista questa, con un portale quasi di chiesa, ermetica, disabitata e col nome suo di Porziuncola. Non era la Porziuncola di San Francesco: era la Porziuncola della Duse. (1931, pp. 24-25)
In quella Firenze dunque che «furiosamente dannunzianeggiava», pur preda di una giovanile immedesimazione col maestro e nell’ambiguità di quell’attrazione, anche Moretti parve subito ossessionato dall’urgenza del superamento del modello dannunziano e al contempo dell’influsso «di simbolisti, di decadenti, di parnassiani, di mistici, di magi». La sua affermazione sarebbe partita dalle letture più varie e audaci, di italiani e stranieri, soprattutto francesi o in lingua francese («Qui ho letto i grandi poeti, i grandi e i piccoli, i piccoli e i minimi, i minimi e i microscopici»), e avrebbe voluto in un’avventura libera e inebriante approdare subito ad una scrittura con scelte stilistiche distinte, originali, uniche. Complice l’amicizia di Aldo Giurlani, non ancora Palazzeschi, che con lui si trovò ben presto a fare i conti con la poesia prima ancora che con i testi teatrali, nel breve arco di una stagione Moretti arrivò a diventare poeta in proprio, sedotto in primis, per sua ammissione, «con la lussuria e con la suprema eleganza di d’Annunzio, come Pascoli seduceva con l’umiltà e domesticità».
Sarà impossibile, perciò, per lui come per gli altri poeti novissimi, impostare qualunque analisi in termini di netta contrapposizione tra la sua visione del modo e quella imaginifica del d’Annunzio che egli non potè non metabolizzare profondamente nell’ampio arco dell’intera sua vicenda umana e letteraria, in una disposizione verso il Maestro fatta di dissimulata ammirazione, disconoscimenti e lontananze, e infine di ritorni e aperti apprezzamenti, che a tratti si presenterà piuttosto come una malcelata e costante devozione, pur trattandosi di una «fedeltà a contraggenio» (Zollino 2008, p. 99).
Benchè in seguito Moretti avesse fissato il proprio esordio ufficiale al 1905 e a Fraternità, libro di segno invece tutto pascoliano, in realtà il processo creativo era partito da una serie di prove, al limite dell’esercizio manieristico – il cosiddetto ur-moretti che l’autore tentò di disconoscere –, in cui, più che altrove, si avvertirà quell’impegno definito dalla critica come l’«attraversamento» (anche nel suo caso, piuttosto che montalianamente il «superamento») dell’influenza del Vate (Boggione 2022).
L’impronta della poetica dannunziana sulle acerbe, quanto esili, prove morettiane uscite agli albori del secolo e riportate alla luce da Piero Bigongiari solo nel 1975, era ancora così pervasiva da conferire loro un carattere mimetico che di lì a breve avrebbe probabilmente determinato il loro fermo ripudio, violato, appunto, solo a distanza di oltre un settantennio. Durante l’importante Convegno di Studi dedicato a Moretti, emersero quindi le novelle de Le primavere edite dall’Elzeviriana nel 1902 che, oltre alle implicazioni dannunziane del titolo, esibivano in epigrafe, sia in copertina che nel frontespizio, la prima quartina del secondo sonetto sperelliano dell’Erma («L’anima ride li amor suoi lontani / mentre fiso rimiro il Mal già vinto / che in quei di fuoco intrichi aveami spinto / come in boschi nudriti da vulcani»), mentre a fronte dell’eponima novella d’apertura riprendeva, sempre in forma di epigrafe e quasi con funzione apotropaica, i versi prelevati anch’essi da Il Re di Cipro, l’apocrifo poema di Andrea Sperelli, ugualmente citato nel Piacere, già proposti ne La chimera: «Vuoi tu far vivere un marmo? Ergere un tempio? Comporre un immortale inno? Vuoi (m’odi, giovine, m’odi) vuoi divinamente amare?».
Bigongiari segnalava inoltre la trilogia di plaquettes uscita nel 1903, sempre a Firenze per i tipi di Ducci, con tre poemetti che benché usciti separatamente ricomponevano un unicum dove l’imitazione dannunziana appariva anche più scoperta e vistosa, perché rimandava ben più di qualche eco tematica e formale dell’Isotteo, de La Chimera, del Poema paradisiaco e delle Laudi.
Il poema di un’Armonia, opera con la quale il giovane Moretti avrebbe voluto fissare le impressioni un po’ estenuate, dettate dalla natura nelle sue varie fasi «dalla primula al bucaneve», si apriva con la lunga dedica «A Irma Gramatica», sentita particolarmente vicina come anima triste. Anche La Sorgente della Pace era dedicata ad una figura femminile di riferimento, il volumetto nelle prime pagine infatti, insieme alla data, recava l’offerta «Per la Signora Teresa Sormanni Rasi e per tutte le anime vigili e malinconiche», ma anche il corpo centrale dei componimenti aveva ogni singolo testo rivolto, tra gli altri, alle donne forti, alla giovinezza, alla madre, alla città addormentata… Completava la trilogia L’Autunno della Vergine, opera meno esposta programmaticamente sul versante dannunziano (anche più criptica la dedica «Alle tue incertezze e alle mie speranze»), dove tuttavia il personaggio della Sposa mistica tenderà alla consacrazione di “poeta” per il personaggio di Goffredo: «Voi siete soprattutto poeta… / Sien rese grazie a tutte le cose che vi fanno / poeta, e sieno grazie, pur nel soave inganno, / a tutte le concordi dolcezze delle rime» (1903, p. 29). Contestualmente Moretti vi annunziava altre pubblicazioni d’imminente uscita che verosimilmente non videro mai la luce, ma che ancora echeggiavano lavori dannunziani: «una commedia, I Revere, una raccolta di novelle, Le tre vie, ed altre opere di genere non meglio precisato: Armonie della Vita: immagini della morte (ma è evidente, nel titolo, l’eco delle Imagini dell’Amore e della Morte che costituiscono la prima sezione de La chimera), Il cammin faticoso e Di Leonardo da Vinci e della sua opera civile, con Laude al Maestro (il tema di quest’ultima sarà però ripreso, di lì a poco, nel poema drammatico Leonardo da Vinci, scritto a quattro mani con Francesco Cazzamini Mussi e pubblicato a Milano nel 1909). Fra gli altri progetti mai o solo in parte realizzati, il poema Hortus animae (titolo che ricalca anch’esso una sezione del Poema paradisiaco), alla stampa del quale avrebbe dovuto cooperare Alfonso De Carolis, una raccolta di Canti di giovinezze perdute, ed una commedia in tre atti, La gabbia» (Cremante 2011, p. 579).
Secondo Bigongiari, il tentativo di Moretti sarebbe stato quello di «disinnescare il dannunzianesimo all’interno dello stesso dannunzianesimo», camminando «nel campo minato dell’estetismo senza mettere il piede sulle mine». In quelle prime prove il tentativo sembrò fallire, ma proprio in quell’omocromia adolescenziale e sperimentale, si attuava il momento necessario per gli sviluppi futuri della parola morettiana che si sarebbe avviata ad affrontare la sua «discesa semantica fino a raggiungere il grado zero del linguaggio crepuscolare». Attraversando il dannunzianesimo, come anche il «pascolismo, pronubo di simbolici strumenti scrittorî più familiari», la poesia di Moretti sarebbe arrivata quindi alla tonalità del “lapis”, in una forma che già mostrava «di voler prediligere, del panismo meridiano dell’Art nouveau, il lato meno sanguinario e sacrificale, o comunque meno statico e “offerto”, e piuttosto quello più adolescente e segreto, con una sorte di descensus borghese al livello del canto “autunnale”, racchiuso nel mistero di una grazia che reclina in se stessa» (Cremante 2011, p. 579).
Ma se nel cesenaticense il processo di assimilazione del magistero pascoliano potrà sembrare meglio metabolizzato anche per la comune matrice territoriale, l’affronto di d’Annunzio costituirà, di fatto, quello stimolo indispensabile e il naturale punto di partenza dell’intero itinerario poetico morettiano: «lievito» per le nuove generazioni, d’Annunzio è anche protagonista dentro un contesto storico-letterario comune che agisce dentro la stessa «temporalità del gusto» in cui si avviano i giovani, cosiddetti crepuscolari, e dunque, almeno inizialmente, parteciperà ad una sorta di ideale dialogo e attenzione reciproca con i poeti della nuova generazione, prima che essi dichiarino la loro presa di distanza.
Di lì a qualche anno, quasi in concomitanza dell’uscita dei libri crepuscolari più “innovativi” delle Poesie scritte col lapis e delle Poesie di tutti i giorni, Moretti infatti tornerà a fare ancora i conti con le suggestioni dannunziane, insieme ad un altro giovane amico, Francesco Cazzamini Mussi, col quale firmerà tra il 1909 e il 1912 un progetto editoriale, poetico e teatrale, che prevedeva una tetralogia di poemi drammatici «lumeggianti le figure dei grandi italiani che vissero ed ebbero luce e potere dal Duecento al Rinascimento», ovvero quei grandi miti d’inizio secolo che vanno sotto il nome di Leonardo, Dante, San Francesco e Giorgione. Anche qui s’intuiva la volontà di riferirsi al teatro dannunziano: non erano infatti così remote le date de La Gioconda (1898) ma soprattutto della Francesca da Rimini (1902) perché questi poemi non venissero ricondotti a quei topoi con i quali si comparavano sin nella veste grafica, e qui i riferimenti erano le edizioni illustrate dal De Carolis della Fiaccola sotto il moggio e della Figlia di Iorio del 1904 e 1905. Altra figura cruciale di richiamo dannunziano per Moretti in questo periodo è, appunto, Adolfo De Carolis, la cui amicizia si dovrà proprio alla mediazione di Gabriellino. Frutto dell’influenza delle poetiche europee di matrice simbolista di fine Ottocento, il gusto che aveva pervaso la letteratura aveva contaminato soprattutto l’arte, in particolare quella dello xilografo marchigiano, illustratore delle migliori edizioni della trimurti tra Otto e Novecento. Magister Adolfus, che poi per Moretti realizzò la copertina di Fraternità (1905) e le xilografie de La serenata delle zanzare (1908), rappresentava per i giovani poeti l’obiettivo più ambito per impreziosire ogni pubblicazione:
Ora i miei idoli erano due. A sommo dell’altissima scala restava pur sempre il D’Annunzio, e un po’ più sotto, Adolfo de Carolis. Quando, sfogliando quei fascicoli così ben ornati ed impressi m’accorsi che il De Carolis scriveva anche lui bellamente, allora l’ammirazione aumentò e lo Xilografo salì un altro scalino e quasi raggiunse il Poeta. (1931, pp. 222-238)
Moretti e Cazzamini Mussi nei poemi avevano spento però quegli accenti più tragici e passionali, sostituendo «alla celebrazione del sangue e della lussuria», a loro del tutto alieni, «l’invito alla pace, alla preghiera, alla rinuncia e il culto dell’arte», presentando quel misticismo in una tonalità, insomma, in grigio et in silenzio che improntava i poemi nati dall’idea che il teatro doveva essere soprattutto poesia: un’operazione di reductio che non portò agli strepitosi risultati sperati.
Ispirato tra l’altro dalle celebri biografie vinciane di Gustavo Uzielli, Dmitri Mereshkowsky e Edmondo Solmi, anticipato con enfasi in più sedi col titolo provvisorio di Leonardo da Vinci e della sua opera civile con laude al Maestro, ne L’autunno della vergine, e poi ancora, col titolo definitivo, ne La serenata delle zanzare, finalmente nel 1909 per i tipi milanesi di Baldini e Castoldi era uscito Leonardo Da Vinci, illustrato da Carlo Felice Zanelli (Bologna, 1887-1966), di fatto il “terzo autore” come lo definì Moretti, tutto nutrito di scuola pittorica bolognese ma nei fatti anch’egli intriso delle intonazioni liberty dei volumi dannunziani.
Gli autori spiegavano nella nota conclusiva che l’intento era quello di comprendere e di sentire l’anima del grande artista di Vinci, e insieme di cogliere lo spirito profondo dell’epoca nella quale il suo genio ebbe luce e potere, focalizzando quattro momenti salienti della sua vita. Ma il volume non incontrò i favori della critica proprio per quella retorica decadente di ascendenza dannunziana, diffusa nella linea che va dall’Ode per la morte di un capolavoro del 1901 all’Anima con le labbra del 1911 (Pedretti 2002), per cui vennero le stroncature di Maffio Maffi e di Goffredo Bellonci, solo per citarne alcuni che avevano parlato della forma di un “cattivo d’Annunzio”, cui si sarebbe aggiunta la voce di Cesare Levi che, nel 1919, in occasione delle celebrazioni del IV Centenario della morte di Leonardo, sulle pagine del «Marzocco» avrebbe scritto: «Questo Leonardo del Cazzamini Mussi e del Moretti, monologheggiante in versi non troppo alati, è un personaggio di cartapesta, non un uomo». Più mitigato era stato il giudizio, in concomitanza dell’uscita del volume, di Angelo De Gubernatis: «Evidente che i due autori amano il simbolismo dannunziano e la forma d’arte del maestro; ma conviene rallegrarsi con essi, perché non abbiano lasciato passare nel loro dramma nulla d’impuro, nulla di strambo, nulla di grottesco…».
L’anno successivo, quel cruciale 1910 che lo vide consacrato poeta “crepuscolare”, Moretti diede alle stampe col medesimo schema il secondo poema dedicato a Dante, dal titolo Gli Allighieri. Diviso in quattro parti, l’opera recava una dedica a stampa a Ravenna: «ai sarcofaghi del quadriportico di Braccioforte, ai pini della foresta millenaria, al silenzio della città morta» e, fin dal titolo “plurale”, confermava un disegno condiviso da una coralità di personaggi: non solo Dante, quindi, ma anche i figli, Jacopo e Piero, e, infine, Beatrice. Anche in questo caso l’edizione usciva in duplice formato: una illustrata in ottavo (di cui trenta copie numerate in carta pregiata) e una in formato più piccolo senza illustrazioni. E, pure in questo caso, l’accoglienza fu tiepida ma non scoraggiò gli autori a proseguire nel progetto delle uscite annuali previste. Venne però riconsiderata la veste dell’opera successiva, Frate Sole, che vide la luce in formato più piccolo sebbene con ricchezza di tavole (oltre cinquanta illustrazioni per i cinque atti dedicati figura di San Francesco); mentre con Giuditta, pubblicato presso la «Rivista di Roma», si opterà per un più esiguo numero di pagine e un corredo iconografico con le sole testatine dei tre atti.
Pur nell’impegno profuso, i lavori erano stati criticati per certo estetismo di maniera; personaggi e ambientazioni erano rivissuti e, per così dire, “di seconda mano”, proposti attraverso quella coscienza contemplativa degli autori che conferiva all’elemento storico emozioni e sentimenti personali. L’occhio e la sensibilità dei due giovani autori nelle intenzioni infatti avevano cercato di mostrare il lato più semplice e di pura umanità dei cosiddetti “miti”, spogliandoli dell’idealizzazione convenzionale di cui erano stati rivestiti da una secolare ammirazione, ma questa riduzione non ne fece un’operazione in favore della verità. È la nota finale degli Allighieri a chiarirlo, quasi una excusatio non petita a difesa dello stesso genere del poema drammatico: «il quale se esprime qualcosa, e in forma artistica, à diritto – e nessuno glielo può togliere – di cittadinanza nella cosiddetta repubblica delle lettere». In questo caso, il poema che rappresentava chiaramente la risposta implicita alla Francesca da Rimini cui era accomunato dall’ambientazione romagnola, avrebbe secondo le intenzioni di Moretti negato o quanto meno ridimensionato il più possibile, ogni suggestione drammaturgica riferibile alle tragedie dannunziane che egli aveva letto con estrema attenzione mista a invidia, rivendicando invece una ascendenza tutta pascoliana alla sua poesia. Tale valutazione non sarà stemperabile nella considerazione dell’apporto intellettuale del secondo autore se non fosse stata svelata dallo stesso Moretti una curiosità: i poemi drammatici usciti con la doppia firma, in realtà potrebbero avere avuto una paternità letteraria unica, prevalentemente attribuibile al Nostro, con una più spiccata inclinazione “teatrale”, mentre Cazzamini Mussi aveva, sì, sperimentato la poesia scoprendosi tuttavia «più portato per la saggistica», oltre che economicamente in grado di sostenere un’operazione editoriale così fastosa. In una nota autografa, datata 29 aprile 1972, apposta nel piatto di Frate Sole, Moretti specificava infatti che la paternità del poema era
bisogna pur dirlo, d’un autore solo. Fu scritto quando egli aveva sì e no ventitré anni, cioè fra il 1908 e 9, subito dopo la lettura degli incantevoli Fioretti e di qualche opera sulla vita e l’apostolato del Poverello. Pubblicare il libro in una veste decorosa, come allora si sognava, era cosa più che mai assurda a quei tempi, se non che, questa volta, non mancò l’intervento di un poeta finalmente non povero mentre povero era l’autore di questo “Frate Sole”. L’ottimo amico e quasi coetaneo, poeta egli stesso, ma più portato per la saggistica, si addossava in fine le spese di stampa, non indifferenti, dell’intero volume. E per questo, e per avere egli scritto i versi ottonari della “Tentazione” al quarto atto (che a me in verità non piacevano, tanto meno oggi) gli venne offerto di “firmare” il così detto “poema drammatico”. All’autore vero la cosa pareva allora doverosa, tanto più che l’amico finiva con l’accettare senza troppa riluttanza. Ed era lui a chiamarsi Francesco: Francesco Cazzamini Mussi.
Cazzamini Mussi (1931, p. 18), dal canto suo, aveva recisamente negato che l’amico avesse subito la seduzione del Vate: «Alieno dal subire il fascino del D’Annunzio, checché ne abbia detto Renato Serra nelle sue Lettere, il Moretti doveva sentirsi attratto nell’orbita pascoliana per quel senso di bontà, di pietà, d’umanità che da essa emanava», assecondando quel fastidio dell’amico per il non troppo lusinghiero giudizio serriano (Serra 1914, p. 78):
Moretti ha fatto dei versi “col lapis” e delle “poesie di tutti i giorni”, come l’anno prima aveva scritto dei versi dannunziani; con un’abilità incontestabile. Egli è riuscito, meglio di ogni altro, a dare una espressione e quasi un corpo a quella semplicissima sensazione letteraria da cui si muove; ma era solo una sensazione, non un’anima o una personalità, era l’effetto nascente alla lettura, del contrasto fra certe cose e un certo tono della voce. Egli ha riprodotto e moltiplicato questo effetto con una varietà ammirabile, ma così monotona e così vuota in fondo! […] E badiamo che Moretti ha delle qualità non comuni per realizzare le sue impressioni in parole fluide e sicure; e possiede anche un certo sentimento felice della rima. Ma tutto questo è adoperato invano, a non dir nulla.
Nella poesia più matura della prima stagione, si potrebbero anche rilevare alcuni debiti tematici pur tuttavia non così determinanti: su tutte la pioggia di A Cesena che richiamava, sì, il d’Annunzio nel Pineto, ma che non portava alcuna speranza o possibilità di riscatto ed era semmai utile a scandire il grigiore e la crudele monotonia dell’esistenza quale “corrispettivo musicale della malinconia”. Era un richiamo formalmente tenue, come sottolineato da Pietro Gibellini, ma tanto più rilevante forse nel rinvio contrastivo alla lirica dannunziana esibito fin dall’attacco:
il poeta visita la sorella sposata da poco tempo, sufficiente però a sciogliere ogni residuo sogno romantico nella prosa del quotidiano (più che la sorella, la disillusione tocca il cuore del poeta, il vero infelice); e la costanza della pioggia è il corrispettivo musicale della malinconia, rispecchiata dalla grigia giornata come in un paesaggio dell’anima: il poeta potrebbe ben dire, con Verlaine, “Il pleure dans mon coeur / comme il pleut sur la ville”. Dice invece: “Piove. È mercoledì. Sono a Cesena / ospite della mia sorella sposa, / sposa da sei, da sette mesi appena”; in questo incipit è già evidente lo scarto dalla fonte, che pure viene richiamata per lievi ma precisi tocchi (il leit-motiv della pioggia, la presenza di un’interlocutrice femminile). Con una tecnica gozzaniana, Moretti trasforma il calendario in versi, dando subito le coordinate spaziali e temporali dell’avvenimento: siamo a Cesena, di mercoledì, e la pioggia sta fuori di casa (o dentro l’anima). Col passaggio dal plein air all’interno domestico, viene sconvolto soprattutto lo statuto noetico della Pioggia dannunziana, dove si verificava l’epifania del mito. (Gibellini 2023, pp. 627-628)
Un altro più labile riferimento porterebbe ancora all’immagine dell’acanto, impiegato da Moretti nelle Poesie scritte col lapis (come dal Gozzano di Vas voluptatis), ma si trattava di una presenza determinata più dal gusto già diffuso che da un dettato direttamente dannunziano.
In conclusione, al termine della prima stagione possiamo riscontrare che la presenza dannunziana è in Moretti ancora ingombrante. Ma se, come sottolinea Boggione (2022, p. 30), a proposito di Corazzini – e, più in generale, dei crepuscolari romani – si è parlato di una direzione della poesia che non va dal dannunzianesimo al rifiuto di d’Annunzio, semmai il contrario (a specchio c’è Gozzano che ringrazia Dio di non averlo fatto ‘gabrieldannunziano’ e intanto recupera materiali dannunziani in contesti di intonazione antidannunziana in virtù di una classicizzazione parodizzante del modello crepuscolare), di Moretti si potrebbe azzardare un percorso che sarebbe sfuggito ben presto all’intento parodico ma, facendo lucidamente i conti col tracciato aulico solcato dal Maestro, avrebbe consapevolmente optato per la strada del prosaico, inneggiata nel meta-testo de Il giardino dei frutti, ed emblematicamente concretizzata nel capolavoro di A Cesena.
Chiusa la prima fase poetica, sancita dall’auto-antologia del 1919, si era avviata per Moretti la grande stagione narrativa che l’avrebbe condotto ai romanzi maggiori, nell’orizzonte dei quali la figura di d’Annunzio si sarebbe inevitabilmente dissolta o per lo meno messa più in ombra. Tuttavia, nonostante l’abbandono definitivo (si scoprirà poi mai realizzato davvero) del verso a favore della prosa, il debito nei confronti della scuola estetica europea fin de siècle di cui d’Annunzio era il maggiore esponente italiano induce nuovamente Moretti a ricorrere alla messa in campo di temi e personaggi riconducibili a stilemi dannunziani anche nei romanzi, tra tutti, quelli di materia borghese come Guenda, del 1918, e Il trono dei poveri di dieci anni più tardi.
Nel primo, il personaggio di Riccardo Vareschi, incallito viveur e viaggiatore per l’Europa, è, non casualmente, poeta dannunziano, la cui natura è dichiarata da una battuta che rinvia direttamente all’inequivocabile profilo del Vate, a riprova del fascino non ancora spento malgrado il tentativo di dissimulazione: «“Mi spiace amici repubblicani”, pensò Riccardo muovendosi, “ma anche il vostro Ganganelli è di Sant’Angelo in Vado!”», che rifà, sotto altre spoglie, lo strale velenoso che d’Annunzio, fattosi parigino, rivolse contro Fogazzaro («Fogazzaro? È di Vicenza»). Vareschi era anche autore della raccolta dal titolo L’attimo arrestato,
un bel volume in-ottavo, stampato su quella carta ruvida e grossa dall’odor disgustoso che piace molto ai poeti e poco ai lettori: una raccolta di liriche fiorita di citazioni di poeti, esteti e filosofi stranieri, non escluso il mezzo versetto galeotto della Bibbia (il libro dei libri) e il solito “frate foco” e la solita “sora acqua” di San Francesco e un zinzin di pepe di Caienna del Cantico dei Cantici»: ingredienti liberty e decorativi per versi definiti dall’autore addirittura “dilettanteschi” e d’un signore elegante e coltissimo che ha appartenuto a tutte le scuole poetiche che gli hanno permesso di farsi con cura la cravatta. (1918, p. 143)
Un giudizio spericolato che verrà eliminato nella versione successiva poi inclusa nei Romanzi dell’Amorino, ridimensionato dal complimento: «Chi poteva negare che che questo Riccardo Vareschi avesse ingegno da vendere e sapesse, lui beato, tantissime cose?» (1968, p. 106). La versione del 1968 compresa nella raccolta dei «Grandi Classici», del resto, si apriva proprio con una citazione dal Notturno: «C’è l’amorino. È il più fradicio di pioggia, è tutto pregno d’acqua di nubi. Più odora all’apice, come l’ultima falange delle dita che lavorano i belletti. C’è in fondo al suo odore un che del fico latteggiante, del piccolo fico verdino. C’è pure, se insisto, un che della susina claudia matura. Odore di erba più che di fiore, di frutto più che di fiore». Parrebbe ancora, pur per paradosso, un tentativo di riavvicinamento, dopo che tutto avanzava polemicamente verso un abbandono dell’area dannunziana per le più rassicuranti zone pascoliane, simbolicamente rappresentate dalla stessa figura di Vareschi che, da Roma e Firenze, decide di portarsi in provincia e trasferirsi in Romagna.
Un tragitto compiuto anche da Marino Fogliani ne Il trono dei poveri, il romanzo del 1928, ambientato tra il Monte Titano, l’antica terra della libertà, e Roma, la cui visione antieroica contrasta con ironia, fin dalle prime pagine che riprendono l’esordio del Piacere, con l’ambientazione della capitale nella sua versione barocca, più mondana e salottiera, con l’estetismo sperelliano, con il bellicismo vigoroso del tempo, per proporre una visione e una trama in tutto antidannunziane. Nel romanzo sammarinese pare rafforzarsi la polemica che contrappone Moretti a d’Annunzio, non solo sul piano letterario ma anche su quello umano e politico; non una semplice questione di stile, ma una più esistenziale e filosofica, interpretata dal protagonista Fogliani, alter ego dell’autore, le cui ambizioni letterarie condurranno, sì, a Roma dov’egli si aprirà al mondo (e alle sue tentazioni più seduttive), ma dove anche diverrà più consapevolmente uomo di pace, «non protagonista ma presente» che, ben presto dimentico delle lusinghe della grande città, deciderà di tornare in provincia e ad una vita modesta che lo ha sempre atteso. Nel Trono dei poveri, Moretti recepisce tutta la lezione pacifista rollandiana (Capecchi 2010), proprio laddove d’Annunzio sarebbe stato onorato come «poeta soldato» al termine di un tragitto esistenziale tragicamente perseguito dall’imperterrita Viviana, già fervente dannunziana.
Di tutt’altro peso la presenza di d’Annunzio nella prosa di memoria – da Via Laura al Libro dei miei amici (1960) -, nella quale viene puntualmente registrato il percorso dei ricordi contrappuntato da suggestioni, episodi e documenti affatto insignificanti benché marginali. Nell’opera di Moretti, infatti, piuttosto che la rilevanza di debiti e collegamenti con la sua materia letteraria, è da ritenere ben più significativa proprio quella che Zollino individuava come la presenza del ‘personaggio d’Annunzio’ nel quale sovente ci si imbatte.
Curioso l’esperimento del volume autobiografico del 1951, in cui sotto le spoglie dell’alter ego Pazzo Pazzi, Moretti riprende nell’alternanza e nel contrasto di un giudizio mai sanato, come da un lato le molte letture dannunziane fatte nel fervore dei vent’anni l’avessero formato e anche nel maturo silenzio della libreria casalinga, tra i titoli dei soli amici fideles, emergesse su tutti, il nome del mago D’Annunzio, ma anche e di contro come «la voce dell’Ottocento non blandiva allora il padron di casa, qui nell’ex pizzicheria, con la lode ben modulata di chi, avaro e munifico insieme, Gabriele d’Annunzio, onorava quasi soltanto autori non letti» (1951, p. 65). Il riferimento era al Teneo te Africa e all’indice in prima pagina che riportava accanto ad un paio di titoli la dedica «A Benito Mussolini», elemento che riportava il Vate a «pericoloso e fastoso modello».
Nell’imminenza della morte di d’Annunzio, invece, benché affermasse di non esser mai stato dannunziano, Moretti scrisse un elzeviro dedicato a colui che riteneva il migliore tra tutti. L’articolo pubblicato il 24 aprile sul «Corriere della Sera» riassumeva i tratti esteriori dell’incontro tra lui e il pescarese: una storia segnata da pochi e scarni eventi, e tuttavia intrisi dell’enfasi di una venerazione. Un sorriso di D’Annunzio, infatti, riferiva di un paio di episodi ancor che minimi ma non privi di conseguenze nella biografia morettiana, e il ricordo fissato nell’elzeviro ebbe la potenza di una dilatazione che ampliò lo scritto negli anni a venire perché il brano fu poi ripreso, col titolo D’Annunzio mi sorride, in L’odore del pane (1942) e, in forma ancor più ampliata ne Il buon D’Annunzio (uscito nei «Quaderni Dannunziani» del 1958), e quindi riproposto col titolo D’Annunzio buono ne Il libro dei miei amici (1960) e infine, col titolo D’Annunzio, in Tutti i ricordi (1962).
I fatti salienti riferivano del lontano gennaio 1917 quando, a Milano trovandosi in casa Treves, Moretti aveva incrociato in modo del tutto inaspettato il Maestro. Un abboccamento – forse propiziato dall’editore, ovvero dal direttore editoriale Giovanni Beltrami – che Marino avrebbe ardentemente desiderato fin dai tempi di via Laura, quando l’amicizia con Gabriellino gli meritò i favori di De Carolis ma non quelli del padre, e che finalmente aveva consentito al primo e all’ultimo scrittore italiano, ovvero al «grande poeta tutto eroico» e al «dilettante o principiante tutto poveretto», di incontrarsi, riconoscersi e stringersi la mano. Il ricordo è di un Moretti ancora preda dei suoi complessi:
il colloquio a cui assistetti di straforo, stupito che non mi voltassero le spalle come alla tenda di velluto che avrebbe potuto celarmi. Non so, non ricordo: perché, in realtà, non ascoltai e quasi quasi aspettavo il mio turno. “Maestro” avrei detto “vi ho tanto amato nella mia adolescenza, nella mia prima giovinezza, e anche più tardi. Il vostro nome troppo bello mi faceva pensare, più che a un libro stampato, all’annunciazione d’un primitivo. Era come voi dite del nome d’una dolce donna: … e il vostro nome è come quel de l’ave, nome che pare un balsamo a la bocca. Balsamo prima di questa guerra, la vostra parola scritta, e sussurrata in sogno dalle anime di mille e mille adolescenti. (1942, p. 212).
La breve conversazione che ne seguirà avrà tuttavia come unico dato rilevante quel gesto modesto e affabile del Maestro che disorienterà il giovane Marino con un sorriso:
Ora, d’un tratto, quando credevo d’esser fatto dalla mia modestia invisibile, il grande poeta si piegò verso di me e leggermente, con infinita grazia, s’appoggiò alla mia spalla. Era solo una mano posata fugacemente su la mia spalla, e io mi sentii impallidire come se quella divina confidenza avesse raddoppiato la mia fede nel mio avvenire creando la stabilità della coscienza, la forza dell’intelletto e, non so come, l’eleganza dell’omero. Egli parlava quasi a contrasto col suo amabile interlocutore: si volse a me, mi sorrise: sorrise a me, lo sentivo, come non avrebbe sorriso al nostro editore. E sottintendeva: “In queste cose (cose dell’arte?) c’intendiamo noi soli”. (1958, pp. 17-18)
L’incontro fu davvero fugace (di lì a poco d’Annunzio avrebbe preso la via di Pescara per raggiungere la madre morente) ma non tutto finì lì. Per Moretti infatti si stava approntando un nuovo gesto di benevolenza del Comandante: uscito il Notturno, qualche anno dopo, infatti, l’autore ne fece inviare da Guido Treves «una copia splendidissima», con la dedica: «A M.M. / scrittore nostrano / di sapore non adulterato / offro questo libro italianissimo. / Gabriele D’Annunzio. / Decembre 1921». Lo stupore di quella inopinata cortesia metterà nuovamente in subbuglio Moretti:
«Era ben detto come tutto ciò ch’egli diceva e scriveva? Ed era vero che come artista e scrittore io ero questo e ch’egli aveva sentito o almeno fiutato questo di me? Anzi perfino mi domandavo come avesse fatto a ritenere il mio nome che poi mi suggerisse un’idea, a me non discara, di sanità paesana, perfino d’ingenua onestà nella scelta o fabbricazione delle parole di cui restava come salvaguardia il mio caro Panzini, o anche nell’espressione dei moti dell’animo di cui ero io però il solo giudice o assertore o ratificatore. Giudichino oggi gli altri se non vi fosse in quegli attributi alcunché di generico e non si dovesse in ogni modo scusare un grande scrittore di certo convenzionalismo di cui avrebbe accettato la lieve responsabilità solo per dire una buona parola a uno ch’egli aveva sentito, se mai, non de’ suoi» (1958, p. 20).
Ne seguì la gestazione del ringraziamento che Moretti volle inviare d’impulso a d’Annunzio, spedito da Cesenatico il 13 gennaio 1922:
Vorrei dire grazie al Maestro con parole nuove o rinnovate; ma questo prodigio dell’espressione e del sentimento è di Lui solo. Vorrei dire come ha balzato il mio cuore quando ha veduto sulla pagina bianca del Notturno le parole scritte da Lui, proprio da Lui, con quel carattere che amiamo quasi come la sua arte prodigiosa perché ci pare che la sua arte sia anche in quel segno grafico incisivo. E vorrei dire come ha sofferto il mio cuore quando ha veduto il Figlio in cima alla scala e poi nella prima, nella seconda e nelle altre stanze deserte e poi nella sesta dove la voce piana dice: “È là”. Brivido del dolore umano e dell’arte più che umana! Ricordo d’essere passato un giorno a Pescara dinanzi a quella casa e d’aver guardato trepidando le finestre a balconcino del primo piano. C’era la Madre dolorosa e gloriosa alla finestra? Mi parve, sì, di vederla immobile e aspettante; e avrei voluto scoprirmi come quando si passa davanti a una chiesa. Ma c’è un pudore che vieta le parole più belle e c’è un pudore che detta i gesti, i modi, l’umiltà necessaria. E vorrei dire come ha gridato il mio cuore quando ha veduto nel Notturno il “tronco sanguinoso” e inteso, veramente inteso, la voce di quel tronco dire ai piccoli giudici senza anima: “Giudicatemi”. Giudicate il tronco sanguinoso che abbevera i sassi del Carso! Credo che non si possa tentare il giudizio di un libro come il Notturno senza veder quella immagine dantesca e senza udir quella voce terribile: “Giudicatemi”. Vorrei; non posso. È difficile e anche goffo parlare a distanza. Per quanto noi possiamo migliorarci e perfezionarci (e non alludo solo all’arte ma anche all’anima) saremo sempre troppo distanti da Lui (1958, pp. 22-23).
La concatenazione degli eventi non si sarebbe facilmente spezzata. Quella missiva, così intensamente concepita, Moretti ebbe modo di ritrovarla, non senza un rinnovato e incontenibile stupore, trentasei anni dopo nell’archivio dannunziano conservato dal Sovrintendente Emilio Mariano, in un viaggio al Vittoriale del 1957, di cui si trova puntuale riscontro nel Notiziario dell’istituto curato dallo stesso Mariano («14 maggio 1957: Marino Moretti, scrittore», in «Quaderni dannunziani», 1957). Programmata con l’amico Giuseppe Ravegnani, allora impegnato sull’epistolario dannunziano e che tuttavia non riuscì ad essere presente, la visita diede modo a Moretti di esplorare ogni zona del Vittoriale, giardini, mausoleo, grandi cimeli:
«Non descrivo. D’altra parte, non so e non saprò mai dire quel che vidi e nemmeno quel che vedono ora gli occhi della memoria: lascio la parola a chi si sente perfino di dichiarare che il Vittoriale bello non sia affatto affatto, non però, voglio credere, che non cagioni alcuna emozione. Io non intendo, dico, render conto della mia visita quasi casuale, che sarebbe cosa ben poco interessante dopo quanto s’è detto e scritto del Vittoriale fin da quando vi s’inalzò il primo e maggior pilo o dacché le frotte dei visitatori sciamano nei giardini e salgono le scalee, su su fino all’aereo “barcone” (così si sente chiamare dal popolo la nave Puglia). Che m’importa se quassù, dentro e fuori, c’è veramente troppo di tutto, dalle colonne agli archi, dagli stemmi ai motti, dalle fontane alle cascatelle, dai calchi ai graffiti, ai cimeli, agli amuleti, alle corna e insomma ai famosi “orpelli”, e se il padron di casa, non sempre forse per sua colpa, fece le cose troppo alla grande e lo scrittore raffinatissimo in tante delle sue pagine (si pensi solo a quella precisione e unità di stile e di senso nelle Faville) denotò, poi in molti casi, come in questo dell’arredamento, un gusto di tipo meridionale e pletorico? Io non son qui per dividere mentalmente il bello dal brutto come in una galleria d’antiquario di lusso, e non mi terrei dal dichiarare che le mie naturali simpatie sarebbero per un visitatore del contado bresciano, che del D’Annunzio ne sa meno di noi, in cerca per prima cosa, se non forse soltanto, del succitato “barcone”. Come ne sorriderebbe il poeta che conobbe tanto popolo in guerra! Ed eccomi alla fine seduto in un ufficio della Sovrintendenza» (1960, pp. 73-74).
Egli soprattutto ebbe modo di compulsare l’archivio e di rinvenire, insieme alla lettera indirizzata al Vate, anche tutte le missive inviate a Gabriellino tra il 1903 e il 1905, insieme ad un altro “mucchietto” di epistole firmate Do, attribuite ad Aldo Palazzeschi.
L’emozionante episodio, prima ancora di divenire racconto, era stato riferito in una lettera inviata da Cesenatico, il 17 maggio ‘57, allo stesso Ravegnani (2000, p. 108) e, nel medesimo giorno e con maggiori dettagli, a Palazzeschi (2000, p. 175), che si sarebbe stupito di come D’Annunzio «così olimpico e altezzoso», non solo avesse conservato tutte le sue minuzie, ma anche quelle del figlio (2000, p. 179):
E ora passiamo a un altro discorso, cioè… al Vittoriale. Io vi sono stato invitato dal direttore. Ho accettato da prima senza entusiasmo. Sapevo che era una brutta cosa, ma neppure di quelle che incuriosiscono. E D’Annunzio come lontano! Mi sono invece accorto, avvicinandomi a quel luogo, ch’egli era vicino, ch’egli era addirittura un po’ della mia giovinezza. Intanto i giardini sono bellissimi e non tutto è cervellotico e… dannunziano nel senso peggiore. Non so se tu sappia che io incontrai D’Annunzio nel gennaio del ‘17, a Milano, in Casa Treves, nello studio del direttore ch’era a quel tempo Giovanni Beltrami. Egli era sui 56 anni, capitano in guerra. Pochi anni dopo, finita la guerra, pubblicò il “Notturno” e, non so come, si ricordò di me e mi mandò una copia di questo libro, con dedica, a mezzo di Guido Treves. Dovevo pur ringraziarlo, ma ero impacciatissimo: non sapevo scrivere a D’Annunzio, sopra tutto non sapevo come scrivere e che cosa (lodare il libro avuto in dono mi pareva non solo ridicolo, ma anche volgare). Però mi consolai pensando che la lettera sarebbe andata perduta in quelle ondate di carta scritta che assaliva Gardone subito dopo Fiume e anche l’idea che D’Annunzio non aprisse le lettere, come allora si sentiva dire. Così l’altro giorno ricordai questa mia lettera al direttore del Vittoriale il quale, con mia somma meraviglia, mi disse che ne avrebbe fatto ricerca. Insomma, meno di cinque minuti dopo la mia lettera era sotto i miei occhi. Non solo, ma dopo altri pochi minuti un impiegato dell’archivio mi presentò un’altra cartella dove erano tutte le mie lettere a Gabriellino del 903-4-5 insieme a un altro mucchietto di lettere d’autore non identificato, firmate da un solo monosillabo Do. Erano state messe nella mia cartella semplicemente perché nelle mie lettere io parlavo di Do e mandavo i saluti (e i baci) di Do. D’altra parte, anche quel Marino era stato identificato per via della lettera interamente firmata e conservata in altra cartella perché diretta al D’Annunzio e catalogata. Ora è inutile, Aldo, ch’io ti dica la mia emozione di quel momento e di poi. C’erano perfino lettere a lutto per la morte di mio fratello. Tu, caro Do, scrivevi a Gabriellino quasi unicamente di teatro. Non esagero dicendo che non ho potuto chiudere occhio quella notte. Troppo singolare la cosa e troppo forte l’emozione. E anche oggi se penso che quella “documentazione” è al Vittoriale e ch’io, disordinatissimo, non posseggo nulla di quel tempo… Insomma, non voglio che mi tornino le lacrime agli occhi. A voce tutto quel che non so dire ora. Quel che ho visto, specie del D’Annunzio, mi ha profondamente commosso. Ne parleremo a Parigi?
Col passare del tempo l’impressione di quell’evento coinvolse intertestualmente anche la poesia dell’ultima stagione, stretta tra memorie e bilanci, e quell’episodio avrebbe suggerito i versi di Gabriele dell’Annunzio, compresa nel Diario senza le date del 1974, la raccolta che avrebbe chiuso la vicenda letteraria di Moretti: «Gabriele, ho un tuo libro con la dedica! / Ma tu ne hai fatte, di dediche, tante!/ Eri lì su quel colle, eri distante, / ma ti giungeva qualche eco maledica. / Con la dolcezza dell’annunzio lieto, / col saluto dell’angelo soave / qui a Firenze, nell’aura dell’Angelico, / tu finivi le lettere con ave, / un ave quasi melico, / firmando Gabriele dell’Annunzio, / ai garzoncelli aprendo ogni segreto. // Oh, non a me che fui quello che tacque. / A me che, pur amandoti, rinunzio / oggi a qualunque cosa che ti piacque; / benché pur sempre l’ala del tuo annunzio / resti quella che tocca l’architrave. / Poi non fosti più tu su questa terra. / Che cosa hai fatto mai? Dove sei stato? // Tu… in divisa? Soldato? / Tu, tu, arcangelo, tu, quello dell’ave, entrato in guerra!» (1974, p. 132).
Al di là dei dati esteriori, quindi, malgrado le lontananze stilistiche e formali, Moretti mostrò un attaccamento alla figura dannunziana durato tutta la vita, e testimoniato nella scrittura da continui riferimenti all’opera del Vate. Una valutazione, tuttavia, che poté arrivare con lucidità solo nella fase più matura della sua esperienza letteraria, quando cioè fu in grado di guardare al suo lavoro oramai libero da condizionamenti, da definizioni e clichè. Non si trattò di stilare solo un bilancio, ma di stabilire come un doveroso riposizionamento della figura e dell’opera dannunziana (non già dei valori) nel quadro complessivo di una vicenda ricca e complessa anche laddove persistevano le giovanili resistenze: «Eppure, Maestro, io mai raccolsi le briciole delle vostre mense, non trafugai nessun frutto nell’opulenza dei vostri giardini. Forse, Maestro, ai tempi dei miei diciott’anni i ladroncelli mi parvero troppi…» (1938). Egli non vorrà neppure riferirsi ai sodali di Via Laura, tra i quali – e su tutti – anche lo stesso Palazzeschi che, nella condivisa vocazione, aveva compreso quale lezione di poesia era venuta da Firenze: «Chi ci aveva portati in quel luogo? / Sembra difficile indovinarlo, invece è facilissimo: / la poesia che a quel tempo aleggiava sul teatro / e della quale due adolescenti dotati di fantasia / avevano subito il fascino. / E fu proprio in quel luogo che la poesia / rivelò ai due adolescenti il proprio cammino». Il componimento raccolto in Via delle cento stelle (1972, p. 67), era dedicato a Moretti che a sua volta, solo qualche anno prima, sempre in poesia, nei versi di Teatrino di Firenze (1969, pp. 115-116) descrivendo una ormai cambiatissima Via Laura, ricordava come quel luogo fosse stato l’ispiratore di versi “acri e sereni” e di tante creature di romanzi.
Firenze e d’Annunzio, il maestro e la poesia: con la maturità l’ammissione di continui ritorni alla lettura di un autore amato e ripreso proprio perché al fondo non somigliante e, anzi, profondamente diverso da lui. Dichiarazioni rilasciate, forse anche per ricomporre quelle cesure e allontanamenti mai giustificati davvero, nel momento del suo ritorno alla poesia: «Non posso che scrivere in versi oggi», afferma spiegando che dopo quella della giovinezza sia giunto il tempo della «poesia della vecchiezza» oramai “liberata”, d’impostazione epigrammatica e più graffiante perché finalmente capace di tirar fuori le “molte unghie” dal suo velluto.
Nei versi delle ultime poesie viene riportata in luce, tramite il dato autobiografico, l’immagine del Vate in quel tentativo di Moretti di risolvere i miti della prima stagione e familiarizzare con quelli delle ultime poesie dannunziane. In questa pratica demistificante, se «pensare di eguagliare e superare la raffinatezza dannunziana» sarebbe stata follia, meno avventato era provare a prendere le mosse dalla pratica della scrittura dannunziana per poterne sostenere il confronto imitando almeno il maneggio della penna accettando, di contro, se pur con qualche ironia, la propria modesta inferiore ispirazione.
Nella raccolta Le poverazze (1973), ad esempio, un gruppo di poesie si riferisce direttamente a d’Annunzio proprio in tal senso: in Il callo (1973, p. 120), il rimando è al libro segreto («scrivere era già per me una necessità vitale, un offizio essenziale del mio spirito. Con fierezza giovenile mostravo nella prima falange del dito medio il callo della penna») e a quel dettaglio che sanciva chi fosse vero scrittore. E in Come si scrive, i versi «…si scrive nell’acqua? / si scrive nella rena? / o si scrive… nel vento? […] “Domande erano pur di Gabriele, / vecchio, finito, e non ancor degenere, / ma con se stesso e l’arte sua crudele / se pensava di scrivere / or nell’acqua or nel vento or nella rena.” / “Credo che ormai si scriva nella cenere”» (1973, p. 118) alludono direttamente al Notturno («non scrivo sulla sabbia scrivo sull’acqua») e all’Alcyone («Il vento scrive»). Il nostalgico cenno finale rimbalza poi nel rimpianto de La ceneriera di Cargnacco (1973, p. 114) dove, sulla scorta di “Io ho quel che ho donato”, Moretti riconosce che, malgrado la sua vena abbastanza ricca, non sia riuscito a raggiungere le vette ambite. Lo stesso rammarico è ancora ravvisabile in componimenti come Solitudine (1973, p. 153), in cui egli raffronta il grado del suo isolamento paragonandosi agli scrittori maggiori e, in particolare, proprio a d’Annunzio, «Tu sai quel che non sei / meglio di quel che sei… o che sarai. / Non sei D’Annunzio, re di solitudini, sempre più raro, sempre più sovrano» (1973: 153-54); del resto, oramai lontano dai suoi modelli e rassegnato, si dichiara consapevole d’una esclusione d’altra levatura: «nè ho maglio, non incudini / per battervi parole, / e non ho l’oro vero, l’oro buono, / per farne strali da gettare al sole».
Come detto, sarà tuttavia nella raccolta successiva che più scopertamente Moretti dedicherà interi componimenti a d’Annunzio. Nei versi de La corona di giovinezza, soddisfatto del proprio lavoro in una vecchiezza ancora ispirata da rinnovata vocazione, egli annuncerà finalmente un paragone senza troppi sensi di inadeguatezza: «È Gabriele, è sempre lui che invita / con la vocetta sua che non perdona. / O giovinezza, ahimè, la tua corona / su la mia fronte è già quasi sfiorita. // Non doveva sfiorire anche la mia, / fiori, fronde, poesia / e sfiorir presto? / Ma alcunché di domestico e fedele / restava in me, non più di Gabriele, / se oggi torno giovane e m’arresto / in mezzo a tante tante cose care. / Ma com’è bello poetare! / Come son nato per questo!» (1974, p. 64).
Bibliografia
Scritti di Marino Moretti
Le primavere. Novelle, Firenze, Tipografia Elzeviriana, 1902.
Il poema di un’armonia , Firenze, E. Ducci, 1903.
La sorgente della pace, Firenze, E. Ducci, 1903.
L’autunno della vergine, Firenze, E. Ducci, 1903.
(con F. Cazzamini Mussi), Leonardo Da Vinci, Poema drammatico in quattro atti, disegni di C.F. Zanelli, Milano, Baldini e Castoldi, 1909.
(con F. Cazzamini Mussi), Gli Allighieri, Poema drammatico, Milano, Baldini e Castoldi, 1910.
(con F. Cazzamini Mussi), Frate Sole, Poema drammatico in cinque atti, illustrazioni di C.F. Zanelli, Milano, Baldini e Castoldi, 1911.
(con F. Cazzamini Mussi), Giuditta, Drammatico in tre atti, illustrazioni di C.F. Zanelli, Roma, “Rivista di Roma”, 1912.
Guenda, Milano, Treves, 1918; Mondadori 19442; Mondadori 1968 (in Romanzi dell’Amorino).
Il trono dei poveri, Milano, Treves, 1928; Mondadori 19462; Mondadori 1965 (in Romanzi dal primo all’ultimo).
Ricordi dannunziani, «Pegaso», I, n. 9, settembre 1929, pp. 257-272.
Via Laura. Il libro dei sorprendenti vent’anni. Via Laura, Milano, Mondadori, 1931. Il capitolo Dopo D’Annunzio, oltre il Pascoli, era contemporaneamente apparso in «La Bordata», n. 10, 1 marzo 1931.
Un sorriso di D’Annunzio, «Corriere della Sera» del 24 aprile 1938; il brano fu poi ripreso col titolo D’Annunzio mi sorride, in L’odore del pane (Brescia, Morcelliana, 1942, pp. 207-215).
I grilli di Pazzo Pazzi, Milano, Mondadori, 1951.
Il buon D’Annunzio («Quaderni Dannunziani», nn. 8-9, 1958, pp. 13-24); riproposto col titolo D’Annunzio buono, in Il libro dei miei amici (Milano, Mondadori, 1960, pp. 61-78); infine col titolo D’Annunzio, in Tutti i ricordi (Milano, Mondadori, 1962, pp. 959-973).
Le poverazze, Milano, Mondadori, 1973, p. 120.
Diario senza le date, Milano, Mondadori, 1974, p. 132.
Marino Moretti a Giuseppe Ravegnani, Lettere 1914-‘21 / 1952-‘63, a cura di L. Benedini e C. Martignoni, Pavia, NTP, 2000.
Marino Moretti – Aldo Palazzeschi, Carteggio 1904-1974, voll. I-IV, a cura di Simone Magherini (I), Alessandro Pancheri (II), Francesca Serra (III), Laura Diafani (IV), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1999-2001.
Bibliografia generale
Armonia delle muse. Moretti e De Carolis tra arte e poesia, a cura di M. Ricci, Cesenatico, Casa Moretti, 2009.
Giovanna Amaduzzi, Marino Moretti: preistoria del narratore, in «Il Lettore di Provincia», XI, 1980, n. 41-42, pp. 7-17.
Isabella Benfante, Moretti e Palazzeschi a Gabriellino D’Annunzio. Lettere inedite, «Otto-Novecento», XVII, 3-4, 1993, pp. 89-113.
Piero Bigongiari, Moretti tra il sole e la morte, in Marino Moretti, Atti del Convegno di Studio Cesenatico 1975, Milano, Il Saggiatore, 1977, pp. 150-169.
Valter Boggione, Attraversare D’Annunzio? Corazzini, Gozzano e il Maestro (forse) avverso, «Archivio D’Annunzio», 9, ottobre 2022, pp. 27-40.
Giovanni Capecchi, Inter arma caritas. Il Trono dei poveri nella letteratura della Grande Guerra, in Marino Moretti, la Romagna, San Marino, Atti del Convegno del 23 ottobre 2009, Repubblica di San Marino, Biblioteca di Stato, 2010, pp. 63-72.
Francesco Cazzamini Mussi, Marino Moretti. Studio critico, Firenze, Vallecchi, 1931.
Vittorio Coletti, Fonti e precedenti del linguaggio poetico di Marino Moretti, in «Studi Novecenteschi», II, 1973, 5, pp. 181-225.
Renzo Cremante, Marino Moretti a Firenze tra Pascoli e D’Annunzio (e De Carolis), in La parola e l’immagine. Studi in onore di Gianni Venturi, a cura di M. Ariani, A. Bruni, A. Dolfi, A. Gareffi, Firenze, Leo Olschki Editore, 2011, pp. 575-581.
Franco Di Tizio, La tormentata vita di Gabriellino D’Annunzio nel carteggio inedito con il padre, Pescara, Ianieri, 2010.
Pietro Gibellini, L’Alcyone e la poesia del Novecento, «Rassegna Dannunziana», XXXIV, n. 72 (2018), pp. 11-23; ora nel capitolo I poeti del Novecento e l’Alcyone, in Un’idea di D’Annunzio. Trent’anni di studi, Lanciano, Carabba, 2023, pp. 625-650; (Moretti: 627-8).
Maria Teresa Imbriani, Simonetto: Gabriellino D’Annunzio Tra Moretti e Marinetti, «Archivio D’Annunzio», vol. 1, ottobre 2014, pp. 123-139.
Leonardo Mancini, Un ritrovo di poeti alla ricerca del nuovo: Luigi Rasi, Gabriellino d’Annunzio e la Regia Scuola di recitazione di Firenze, in «Archivio D’Annunzio», vol. 4, ottobre 2017, pp. 11-24.
Carlo Pedretti, Cesenatico e il Leonardo di Marino Moretti, Cesena, Tip. Sintini, 2002
Piero Pieri, La fiaccola sotto il moggio in Corazzini, Moretti, Palazzeschi, Govoni. La sorprendente alleanza crepuscolare di D’Annunzio, in Paradossi dell’intertestualità: D’Annunzio e i crepuscolari, Michelstaedter e i Leonardiani, a c. di P. Pieri, Ravenna, Allori, 2004, pp. 27-88.
M.G. Sanjust, Gabriellino D’Annunzio attor tragico (attraverso le pagine del carteggio col padre), in D’Annunzio e dintorni. Studi per Ivanos Ciani, Pisa, ETS, 2006, pp. 289-316.
Renato Serra, Le Lettere, Roma, Bontempelli Editore, 1914.
Antonio Zollino, Il personaggio D’Annunzio nella letteratura italiana, in D’Annunzio come personaggio nell’immaginario italiano ed europeo (1938-2008). Una mappa. Atti del convegno internazionale di Liège, a cura di Luciano Curreri, Bruxelles, Peter Lang, 2008, pp. 31-106; (Moretti: pp. 78-79; 96-99).
Antonio Zollino, La bella sorte. Il personaggio D’Annunzio nella letteratura e nella vita culturale italiana, Lugano, Agorà & Co., 2014 (Moretti: pp. 103-107).