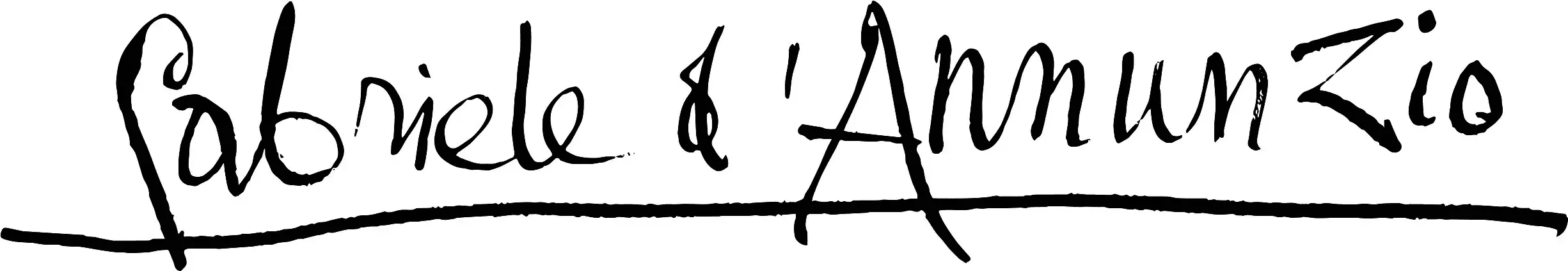di Raffaella Canovi, Enciclopedia dannunziana
Introduzione
I rapporti fra Gabriele d’Annunzio e la massoneria attraversarono diverse stagioni della vita del poeta, anche se con intensità differenti; tuttavia, l’unico momento nel quale questa vicinanza diede frutti concreti fu quello dell’impresa di Fiume. E seppure vi furono, certamente, legami tra il Poeta e il mondo della Massoneria, tuttavia nessuna iniziazione, nessun registro, nessuna tessera o documento può attestare, ad oggi, che vi sia stata una comunque denominata “affiliazione” di d’Annunzio alla massoneria.
La massoneria moderna comparve in Italia attorno alla prima metà del XVIII secolo; molti intellettuali, attratti dalle idee illuministiche di libertà e tolleranza le si avvicinarono, tra i quali non ultimo Giosuè Carducci.
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo nuovo, la massoneria italiana era divisa in due grandi ordinanze: il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani (GOI) e la Serenissima Gran Loggia d’Italia di Piazza del Gesù o ferana.
I primi contatti
Risalgono ai primi del Novecento i contatti del poeta con il mondo massonico, quando il 3 marzo 1901 il vate era intervenuto all’inaugurazione dell’Università Popolare di Milano nella sede di via Ugo Foscolo, fondata dal Gran Maestro Ettore Ferrari, ateneo dove successivamente avrebbe svolto attività di docenza.
L’anno successivo, Teodoro Mayer – tesoriere del GOI, proprietario de “Il Piccolo” di Trieste, fiduciario a Roma della loggia “Alpi Giulie” – organizzò il viaggio “italico” di d’Annunzio nelle città istriane (Trieste, Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pifino).
Nel 1907 il poeta conosceva a Carrara, durante la “varata” nella cava di Colonnata, Luigi Campolonghi, giornalista, massone e socialista riformista. Entrambi erano legati a Volterra dove il poeta avrebbe scritto il romanzo Forse che sì forse che no nel 1909, ospite di un altro massone, Arnaldo Dello Sbarba.
Massoneria, Grande Guerra e d’Annunzio
La massoneria aveva sostenuto d’Annunzio fin dal suo ritorno in Italia affinché assumesse il ruolo di vate al soldo dell’interventismo, un rientro dovuto quasi certamente anche alla libera muratoria internazionale. Era stato il massone Gino Bandini ad accompagnarlo in treno dalla Francia fino allo scoglio di Quarto per l’inaugurazione del monumento, opera di Eugenio Baroni, che celebrava i Mille. Bandini lo avrebbe seguito anche a Roma, avendo così occasione di assistere, ammirato, alle incredibili manifestazioni di affetto da parte di una folla radunatasi per accogliere il poeta già all’arrivo all’hotel in Via Veneto, entusiasmo sotto il cui segno aveva inizio il cosiddetto ‘maggio radioso’.
Durante il periodo del ‘maggio radioso’ il rapporto fra d’Annunzio e la libera muratoria si manifestò in diverse circostanze. Ad esempio, con la ripresa a Roma dell’orazione recitata a Quarto, evento combinato in sinergia con il discorso dell’onorevole e massone triestino Salvatore Barzilai, capo di un comitato di parlamentari interventisti appartenenti alla libera muratoria legato ai confratelli francesi e col quale il vate avrebbe dovuto condividere il palcoscenico anche a Napoli.
È necessario comprendere, nella prospettiva della futura avventura fiumana, come la massoneria si avvicinasse al mondo nazionalista condividendone gli obiettivi territoriali e indicando nella Grande Guerra l’ultimo ideale atto risorgimentale. Si sarebbe spinta ad affermare la necessità per il regno d’Italia di ricoprire un nuovo ruolo nello scacchiere geo-politico europeo, anche a costo di annettere provincie a scarsa componente italofona.
Massoneria e impresa di Fiume
La massoneria italiana aveva da subito posto particolare attenzione alla vicenda fiumana. Nel suo saggio La Massoneria italiana nella crisi dello stato liberale Aldo Alessandro Mola ipotizza che il Gran Maestro Domizio Torrigiani avesse avuto una «parte diretta se non nella preparazione dell’impresa quanto meno nell’avvallare il consenso dei massoni presenti nella zona d’operazioni», data la sua visita – a pochi giorni dalla marcia di Ronchi – alla loggia “Sirius” di Fiume.
Massone che ricoprì un ruolo importante fu Giacomo Treves, principale fonte di comunicazione fra il GOI e il Comandante. In Treves il comando dannunziano trovò uno degli essenziali e più efficaci collegamenti con l’esterno: grazie al suo impiego presso le Ferrovie dello Stato era in grado di organizzare spostamenti in incognito per i legionari, oltre a provvedere al trasporto di armi, denaro e corrispondenza varia.
È anche attraverso la corrispondenza fra Treves e il Gran Maestro Torrigiani che è possibile seguire l’intero percorso degli accidentati legami fra d’Annunzio e la massoneria.
Imprescindibile citare i sette granatieri di Sardegna, tutti iniziati alla massoneria, i sette giurati di Ronchi: Riccardo Frassetto, Vittorio Rusconi, Claudio Grandjacquet, Rodolfo Cianchetti, Lamberto Ciatti, Enrico Brichetti e Attilio Adami.
Va però detto che, oltre alla massoneria, oltre ai sette giurati, la volontà di marciare su Fiume fosse nata anche dall’azione dei militari e delle diverse associazioni patriottiche. In effetti non è corretto indicare un’unica scintilla: l’impresa dannunziana ebbe diverse ed eterogenee spinte. L’azione, che divenne ‘dannunziana’, fu formata da varie componenti: la massa dei militari, impossibilitati a tornare alla normalità della vita civile, i nazionalisti irredentisti di Giovanni Giuriati e della sua associazione Trento e Trieste, oltre al Consiglio nazionale fiumano, inizialmente propenso rivolgersi a Sem Benelli e Host Venturi.
Successivamente il poeta-soldato fu sostenuto dalla massoneria quale unica possibile guida del movimento fiumano, tanto che – funzionale ai preparativi della spedizione – era costituito un comitato segreto pro Fiume. Non si conoscono con esattezza i nomi dei suoi partecipanti, ma solamente che da Trieste il comitato fu in grado di tirare le fila dei Comitati Riuniti “Pro Fiume Italiana” grazie a importanti contatti tra funzionari pubblici e addetti alle comunicazioni. Era membro del direttorio segreto della sede di Milano il futuro capo di gabinetto Alceste De Ambris.
Il sostegno sia in termini di risorse umane sia di risorse materiali da parte della libera muratoria era dovuto all’identificazione nell’impresa dell’ultima rivendicazione risorgimentale e per tale motivo, almeno inizialmente, la massoneria difese a spada tratta il Comandante. Incapace di indirizzarlo, di condizionarlo, se ne sarebbe allontanata quando l’orientamento del comando fiumano avrebbe intrapreso una strada rivoluzionaria, lontana dagli ideali massonici.
La scelta di appoggiare d’Annunzio rientrava, principalmente, in un’ottica di contenimento del pericolo socialista e nella volontà di impedire che il blocco dominante al potere – in quel momento posto sotto accusa e gravemente minacciato dai movimenti di massa – fosse scalzato o dal bolscevismo o dalle manovre del Vaticano.
Il costante sostegno della libera muratoria – in particolare del GOI – non riguardava solo gli aspetti economico-finanziari, ma anche quelli politici: intervenne infatti più volte presso il governo italiano tentando una mediazione. Il GOI sosteneva convinto l’impresa ma nello stesso tempo era deciso a non compromettersi eccessivamente dal pinto di vista politico e soprattutto a non inimicarsi le istituzioni dello Stato.
Dalle carte dell’archivio del Gran Maestro Domizio Torrigiani emerge con chiarezza il legame non solo fra d’Annunzio e la massoneria durante l’occupazione di Fiume, ma fra quest’ultima e varie figure del comando dannunziano e del mondo legionario, figure di primo piano, da Giovanni Giuriati ad Eugenio Coselschi, oltre che con membri del Consiglio nazionale fiumano del quale molti appartenevano alla massoneria, come ad esempio Dardi e Ariosto Mini.
Il denaro della massoneria a Fiume
L’apporto massonico fu sicuramente fondamentale sia per la presa di Fiume sia per la permanenza di d’Annunzio e dei suoi legionari, un sostegno imprescindibile non solo dal punto di vista propagandistico ma anche per quanto concerne la raccolta di beni di prima necessità e di denaro.
Raul Palermi, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia, aveva domandato a tutte le sue logge di sostenere l’impresa e a Roma aveva istituito un comitato di raccolta fondi. A Milano invece in un’unica seduta, erano state raccolte ben Lire 72.000 (pari a circa € 106.000,00) consegnate al fratello Tomaso Cartosio in occasione di un suo viaggio alla ricerca di velivoli per la Fiume legionaria.
D’Annunzio da subito espresse la propria riconoscenza nei confronti della massoneria, soprattutto verso il GOI. A conferma dell’appoggio massonico e del fatto che il Comandante fosse pienamente consapevole, i calorosi ringraziamenti inviati al GOI a pochi giorni dalla marcia di Ronchi:
AL GRANDE ORIENTE
Io e i miei compagni ringraziamo caldissimamente i sostenitori della giustissima Causa. L’offerta non poteva esserci recata da un più nobile messaggero. La città di Fiume, infelice e beata nel tempo medesimo, ha bisogno di viveri e di denaro, ha, sopra tutto, bisogno di essere sostenuta dal puro fervore. I viveri e il denaro cominciano ad affluire, di sopra gli impedimenti. E gli umili soldati danno anche una volta l’esempio. I soldati dell’altra parte ieri ci mandarono una somma raccolta fra loro, con una generosità così candida che mi sembrò di veder per loro nella terra sorridere i morti. Confidiamo nell’alto soccorso. Viva l’Italia!
Il Comandante
Fiume, 22 settembre 1919
Scritto di notevole importanza sia come diretta conferma del ruolo attivo e del sostegno della massoneria all’impresa, sia come dimostrazione della nuova ‘religione’ fiumana: «Fiume, infelice e beata». Nella lettera rimaneva centrale la richiesta d’aiuto: la causa doveva essere sostenuta.
Il giorno stesso Torrigiani riceveva una comunicazione proveniente da Trieste con informazioni aggiornate sull’operato dei centri massonici della zona dopo la «santa entrata» in Fiume. Il Gran Maestro – oltre a un messaggio per la loggia “Sirius” – affidava ai fratelli l’incarico di istituire una rappresentanza che avrebbe dovuto portare al vincitore d’Annunzio il saluto della massoneria italiana.
Dopo essere stato a colloquio col Comandante a Fiume, Torrigiani si premurava di inviargli una lunga lettera nella quale riassumeva le intenzioni del GOI, ovvero: trarre il maggior vantaggio dall’impresa; seguire una politica di cooperazione; alimentare la città.
Fondamentale era stato l’intervento del Gran Maestro che permise l’immediato approvvigionamento da parte della Croce Rossa e l’invio di denaro alla città tramite il tenente Ulisse Igliori.
I rapporti fra il Comandante e Torrigiani sarebbero stati costanti durante tutta l’impresa, pure non scevri di screzi e incomprensioni.
L’appoggio del Gran Maestro era stato e rimaneva essenziale, anche per risolvere la questione della valuta, nonché per gli interventi nella gestione futura della città: chiare ‘prove’ dell’alta considerazione nella quale la massoneria era tenuta presso il comando.
L’invio di denaro e di beni materiali da parte della massoneria era iniziato da subito e sarebbe continuato fin quasi all’ultimo. Finanziamenti giungevano copiosi non solo dall’Italia ma anche, ad esempio, dal Brasile e dagli Stati Uniti.
Legato al rifornimento di Fiume è Giovanni Ciraolo, massone e presidente generale della Croce Rossa Italiana (già presidente della Gran Loggia di Rito Simbolico); approvvigionò Fiume per tutta la durata dell’impresa, da settembre 1919 a gennaio 1921, tanto da richiedere che tale attività di cooperazione fosse equiparata al servizio dei Legionari della Causa Fiumana. Per un valore complessivo di L. 13.000.000 (pari a circa € 14.578.587,00).
Il progetto dannunziano della marcia su Roma
A poco più di un mese dall’entrata a Fiume d’Annunzio già concepiva la seconda fase dell’impresa: dalla marcia su Ronchi alla marcia su Roma, passando per Trieste, con il proposito di sbarcare sulla costa adriatica e raggiungere la capitale. D’Annunzio aveva confidato a Treves e all’altro fratello Calavalle l’intenzione di sbarcare a Trieste per far scoccare la scintilla che avrebbe dovuto raggiungere e incendiare Roma, instaurando una breve dittatura militare per giungere prima a un ministero di coalizione, quindi a una vera e propria costituente, nell’ottica di un radicale cambiamento di regime. Il Comitato segreto pro-Fiume lo avrebbe scongiurato di non agire, sollecitandolo a preferire elementi democratici. Nonostante l’effettiva complessità dei rapporti fra la massoneria e l’impresa, si può affermare come il GOI non approvasse la svolta dannunziana nel timore di una avanzata del bolscevismo.
Alceste De Ambris
La situazione a Fiume dopo i primi mesi era in pieno stallo: da un lato il fallimento delle trattative per il modus vivendi, dall’altro l’organizzazione della ‘rivoluzione’ che procedeva a rilento, sia a causa della scarsità di risorse sia perché l’obbedienza di Palazzo Giustiniani cercava di ostacolarla.
Nel tentativo di uscire dall’empasse, d’Annunzio decise di estendere la base politica sostituendo il proprio capo di gabinetto, il nazionalista Giovanni Giuriati, con Alceste De Ambris, esponente di primo piano del sindacalismo rivoluzionario, considerato da Giuseppe Giulietti come l’unica figura in grado di unire l’ambiente massonico – al quale Giulietti apparteneva – a quello militare e a quello rivoluzionario. De Ambris era infatti legato al mondo della libera muratoria pur non essendo ancora un iniziato; era entrato in contatto con quell’ambiente in Francia, dove era maturato il suo appoggio alla guerra. Il sindacalista era caro amico dei giornalisti – socialisti e massoni – Carlo Bazzi e Luigi Campolonghi, quest’ultimo riferimento parigino del politico e massone Leonida Bissolati. De Ambris sarebbe stato iniziato (matricola 58596) a Parigi il 23 febbraio 1925 nella sede di rue Puteaux, presentato da Campolonghi e Francesco Ciccotti.
Gabriele d’Annunzio tra le due ordinanze
Durante l’avventura fiumana, d’Annunzio si ritrovò al centro delle mire massoniche sia di Palazzo Giustiniani, sia di Piazza del Gesù: poter esibire sotto la propria obbedienza il vate d’Italia, l’eroe di guerra, il Comandante di Fiume avrebbe avuto una risonanza propagandistica senza eguali.
La Gran Loggia d’Italia
La Gran Loggia d’Italia nel novembre 1918 aveva convocato un’assemblea a Roma dalla quale era emerso un chiarissimo sostegno all’annessione di Fiume secondo una linea nazionalista, abbastanza distante dalla posizione moderata del GOI – da sempre profondamente leale nei confronti del re Vittorio Emanuele III. Mentre il GOI preferiva attendere il risultato delle trattative diplomatiche in corso a Parigi, la loggia fiumana di Rito Scozzese “XXX Ottobre” del venerabile Attilio Prodam aveva da sempre incoraggiato i suoi componenti più giovani a iscriversi alle liste dei volontari fiumani e a partecipare direttamente all’impresa.
Si può in un certo senso affermare come la massoneria di Rito Scozzese fosse più vicina allo stile dannunziano, ovvero più adatta a recepire e rielaborare al meglio i concetti del poeta; basti scorrere alcuni brani del discorso misticheggiante di Tomaso Cartosio tenuto il 20 dicembre 1919 durante il convegno dei rappresentati delle logge “Trieste Redenta” e “Italia Nuova” di Trieste, “Nazario Sauro” di Capodistria e “XXX ottobre” di Fiume. Quest’ultima era infatti presentata da Cartosio come «lo sforzo più poderoso di Redenzione da giovare all’Italia; come titolo incontestabile per essere eletto dalla storia il più grande fattore consapevole della civiltà e della storia universale.» Intonazioni e parole che si legavano perfettamente allo stile e alla retorica dannunziana.
La consegna della sciarpa al Comandante
Il Comandante lesse certamente con piacere e autocompiacimento l’elegante lettera che giunse il 3 ottobre 1919 dal Sovr∴ Gran Commendatore Raoul Palermi Gran Maestro 33∴ della Gran Loggia d’Italia:
Il supremo Consiglio Confederato del Rito Scozzese Antico ed Accettato di Roma ove rappresenta la federazione Massonica Universale del Rito stesso invia lire cinquemila come modesto tributo all’opera altamente nazionale ascolta da VOI e dai Vostri nobili compagni per assicurare alla Patria Fiume e la Dalmazia italiana. Il Vostro Messaggio letto in solenne tornata di Aeropago fu acclamato da tutti i nostri fratelli che il 28 novembre 1918 Noi chiamammo insieme a quelli delle Camere Superiori e delle Logge d’Italia, al giuramento Fiume e Dalmazia o morte! (…). Il Grande Oriente della Serenissima Gran Loggia Nazionale, alla dipendenza di questo Supremo Consiglio Confederato, Vi invia per nostro mezzo un Messaggio contenente la nomina a Membro onorario della detta Gran Loggia ed un telegramma della Massoneria brasiliana inneggiate a VOI e a Fiume italiana. A nome del Supremo consiglio Vi comunico altresì la nomina a Fratello 33∴ onorario per la Giurisdizione dell’Italia e Sue Colonie. Ci auguriamo di festeggiarVi in Roma dopo il trionfo completo delle idealità italiane.
Una missiva fondamentale sotto due punti di vista: come conferma della volontà di appoggiare l’impresa tramite l’invio di denaro (pari a circa € 7.400,00); come conferma della non appartenenza di d’Annunzio alla massoneria, dato che ne veniva nominato «membro onorario» e contestualmente elevato – honoris causa – al 33° (e massimo) grado del Rito Scozzese Antico e Accettato.
La cerimonia di iniziazione e consegna della sciarpa bianca sarebbe avvenuta nel mese di ottobre a Fiume. Un’iniziazione importante dal punto di vista esoterico e simbolico, ma non da quello della pratica massonica, che si crede non sia mai stata seriamente seguita dal Comandante, tanto che la celebre sciarpa bianca non si trova – al momento – né all’interno del Vittoriale né in altro luogo.
Da notare come personaggi di rilievo in campo politico ed economico fossero spesso destinatari di tale onorificenza massonica da parte di Palermi, in un’ottica di ampliamento della visibilità dell’obbedienza che – rispetto al GOI – non godeva di uguale presenza sul territorio nazionale e di uguale forza all’interno delle istituzioni.
Da parte del poeta-soldato, si potrebbe dire che la sciarpa non abbia rappresentato se non l’ennesima onorificenza che si attendeva di ricevere.
Le reazioni dell’altra obbedienza non si fecero attendere.
Torrigiani non intendeva abbandonare il Comandante nelle mani di Palermi e chiese pertanto sia ala generale Pavone, sia a Treves di proporre l’affiliazione al poeta.
Ma, aldilà di sciarpe, insegne e gradi massonici, ciò che realmente stava a cuore al ‘signore’ di Fiume – e che domandava al GOI – erano gli approvvigionamenti: dal carbone agli indumenti invernali per i suoi legionari.
Per quanto concerne la presunta proposta di affiliazione, allo stato attuale non è possibile affermare se questa fu accettata dal poeta, nessun documento o carteggio ne testimonia l’esistenza.
Secondo alcune testimonianze (Conti e Vannoni), nel 1920 il vate risultava regolarmente iscritto alla loggia “Italia Nuova-XXX Ottobre” affiliata a Piazza del Gesù.
Interessante a tal proposito la testimonianza del 1928 di Marco Egidio Allegri, personaggio di primo piano nella storia del martinismo italiano, che dichiarò come d’Annunzio avrebbe partecipato ad alcune riunioni di questa loggia dove sarebbe stato iniziato da Ettore Vecchietti.
Il Grande Oriente d’Italia
L’obbedienza che fornì l’apporto maggiore all’impresa fiumana fu il GOI di Palazzo Giustiniani. Le sue logge di Trieste e Fiume erano state il fulcro attorno al quale aveva operato il comitato segreto pro-Fiume. Si è di fronte a un d’Annunzio circondato da massoni, quali Luigi Rizzo e Sante Ceccherini. Possibile conseguenza di tale numero di fratelli presenti a Fiume e del ruolo della massoneria stessa, fu il suggerimento del generale Pietro Badoglio a Nitti di rivolgersi a Torrigiani per tentare di negoziare con il Comandante e persuaderlo a rinunziare all’annessione.
Torrigiani poteva offrire al Comandante soltanto aiuto economico per contrastare l’embargo di Nitti, ma non poteva assolutamente assicurargli il proprio appoggio in caso di azioni rivoluzionarie che andassero contro la democrazia e la conseguente demolizione delle istituzioni. Certamente fu di parola: al suo rientro a Roma si attivò, oltre che per l’aiuto da parte della Croce Rossa Italiana, per far giungere a Fiume un contributo (non prestito) di due milioni di Lire (pari a circa € 2.242.860,00), grazie all’intervento diretto del fratello Cantoni della Loggia “La pace” di Padova.
L’impegno e l’appoggio massonico si sarebbero man mano affievoliti a partire dalla metà del novembre 1919 quando il Comandante avrebbe intrapreso un percorso che pareva pericolosamente condurre a una marcia dannunziana su Roma. Sempre a novembre, Nitti aveva tentato nuovamente un approccio nei confronti della massoneria chiedendo a Torrigiani d’esortare i confratelli presenti fra le file dannunziane ad azioni più caute e tentare così di far ‘rientrare’ il problema d’Annunzio.
Inequivocabile e risoluto sarebbe stato il rifiuto massonico di possibili programmi rivoluzionari manifestati da d’Annunzio e dal suo entourage; andava così aumentando l’allontanamento del GOI. Da parte sua il Comandante contradiceva quanto promesso alla massoneria imbarcandosi nella spedizione di Zara.
Torrigiani non sapeva come intervenire presso il governo di Roma. Sebbene avesse sostenuto l’impresa fin dal suo sorgere, il centro del potere massonico del GOI adottò via via un atteggiamento più moderato e sfuggente, pur sostenendo – come già indicato – l’invio di aiuti alla città.
Torrigiani riteneva inoltre d’Annunzio troppo compromesso con la Gran Loggia e troppo distante dai disegni di rinnovamento liberal-democratico propri del GOI, che progressivamente abbandonava Fiume.
La Carta del Carnaro
Promulgata l’8 settembre 1920, la Carta del Carnaro fu redatta da De Ambris fra gennaio e marzo 1920 sulla base di lunghi colloqui avuti con il Comandante, che la revisionò stilisticamente e l’arricchì di contenuti senza stravolgerla.
La costituzione fiumana si fonda sull’autonomia, il decentramento, la libertà di stampa, di parola, di pensiero e di religione, sancisce la parità fra i sessi, la partecipazione di tutti al mondo del lavoro.
Esaminandolo è possibile rilevare alcuni probabili rimandi massonici:
– il tema dei diritti, come ad esempio il divorzio, istituto giuridico discusso nelle logge fin dall’unità d’Italia e giunto fino all’aula del parlamento con le proposte dei fratelli Raffaele Morelli, Giuseppe Zanardelli e Agostino Berenini;
– il ruolo delle donne e la loro uguaglianza giuridica, in discussione fra le pareti di Palazzo Giustiani;
– la «proprietà attiva», già nell’estate del 1917 il GOI aveva avanzato la richiesta di obbligatorietà della coltivazione della terra, ovvero il superamento del «concetto quiritario della proprietà», e la concessione diretta delle terre ai lavoratori «a condizioni di equità.»
– nell’art. 19 della Carta dedicato alle corporazioni, il Comandante aggiunse la famosa “decima corporazione”, che «non ha arte ne novero ne vocabolo»; era
riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. È quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all’apparizione dell’uomo nuovissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l’ànsito penoso e il sudore di sangue. È rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un’antica parola toscana dell’epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano:
«Fatica senza fatica».
Essa raffigura non solo l’apice del misticismo estetizzante dannunziano, ma rappresenta contemporaneamente i valori cardine del pensiero massonico, ovvero il culto del progresso e la fede nell’uomo e nelle sue capacità. L’uomo è libero dalla fatica, perché il lavoro è considerato da una diversa prospettiva: non è più obbligo, poiché ognuno avrebbe lavorato non per sé ma per l’intera comunità, in fratellanza e secondo un sistema di corporazioni. La decima corporazione non è un bel esercizio di scrittura poetica, un abbellimento stilistico alla Carta, ma racchiude lo scopo dell’intero pensiero laico moderno: liberare l’uomo dalla fatica.
Entrambe le ordinanze massoniche espressero da subito la propria ammirazione nei confronti della nuova costituzione fiumana.
Fra i primi a ricevere una copia della Carta con dedica fu il Gran Maestro Torrigiani del GOI. Altre copie furono donate a importanti rappresentati della Gran Loggia.
È possibile affermare come la costituzione fiumana presenti alcuni rimandi all’istituzione massonica, specialmente nella normativa del lavoro, della scuola e della giustizia, ma essa è sostanzialmente il risultato dell’esperienza politica e sindacale di De Ambris, dei suoi studi. La Carta rappresenta lo sforzo di sintesi fra le spinte provenienti dalle varie parti sociali e – esattamente come per d’Annunzio – non può essere collocata né a sinistra né a destra, come non può essere definita ‘massonica’.
La separazione definitiva
Quando il 12 novembre 1920 veniva firmato il Trattato di Rapallo, grazie al ministro degli Esteri, in odore di massoneria, Carlo Sforza, la condotta filogovernativa del GOI emerse nitidamente e il distacco dall’impresa dannunziana non poteva che essere definitivo. Inutile fu il tentativo di Torrigiani che implorava d’Annunzio di cedere evitando così una probabile strage.
La massoneria era stata dalla parte dell’impresa assegnandole il ruolo di ultima lotta per l’unificazione dell’Italia, ma solo finché era rimasta nei binari della democrazia, appena allontanatasi dai principi massonici, l’Ordine se ne era allontanato a sua volta.
Dopo Fiume
Il legame tra Fiume e la libera muratoria proseguì anche dopo l’uscita del Comandante dalla città, avvenuta il 18 gennaio 1921. In particolare, il Grande Oriente svolse un ruolo primario nella divulgazione del mito di Fiume e nella sua salvaguardia da qualsiasi abuso. Giacomo Treves vi si dedicò con notevole impegno, concorrendo anche a dar vita alla Federazione Nazionale Legionari Fiumani, ramificata in tutta Italia e avente lo scopo di stabilire legami tra quanti avevano consacrato parte della loro vita all’impresa della città di luce.
Chissà se Italo Balbo e Dino Grandi quando si presentarono a Cargnacco nell’agosto 1921, decisi a convincere il vate a porsi a capo del partito fascista e marciare su Roma, erano emissari della massoneria alla quale entrambi appartenevano.
Tornando a Fiume, la libera muratoria rimase in contatto con i principali attori istituzionali fiumani in un’ottica di costante sostegno e, quando nel 1924 la città venne annessa all’Italia, prontamente ricordò la propria opera. Il regime rispose dichiarando come l’unica persona da ringraziare per Fiume italiana fosse Mussolini e non la massoneria. Nonostante quest’ultima avesse sostenuto la formazione e l’affermazione del PNF, fu da quest’ultimo prima abbandonata e quindi ostacolata apertamente, fino a essere messa fuori legge nel 1925.
In un’ottica di ricerca di consenso tra i fascisti, il GOI attraverso Torrigiani e Treves domandò a d’Annunzio lettere, telegrammi e quant’altro comprovante l’aiuto ricevuto da Palazzo Giustiniani. Il poeta non intendeva assolutamente condividere il successo della marcia di Ronchi, pertanto non cedette a tali richieste.
La massoneria nel 1923 tentò ancora una volta di influenzare – senza alcun successo – le scelte del vate attraverso il suo emissario l’avvocato e presunto massone Salvatore Lauro, spingendo affinché i manoscritti dannunziani emigrassero verso gli Stati Uniti, piuttosto che essere ceduti allo Stato fascista.
Si rileva come lo stesso Lauro fosse intervenuto due anni prima per aiutare il Comandante nell’acquisto di Villa Cargnacco: la proprietaria Hertha Tegner (vedova Thode) pareva infatti intenzionata a chiedere la restituzione dell’edificio. Lauro – assieme a Luigi Luzzatti – mediò fra il poeta, la donna e il ministero dell’Industria e del Commercio.
Conclusioni
D’Annunzio era stato senza alcun dubbio attratto dall’esoterismo, dall’occultismo, dalla libera muratoria ma solo ed esclusivamente nella misura in cui tali attività rispondevano alla curiosità di sapere, di conoscer, di «sempre apprendere» come era nell’indole dell’uomo.
Se non è ancora chiaro e definito il momento del ‘primo contatto’, si può affermare con sufficiente certezza – in base ai documenti ad oggi disponibili – che la libera muratoria non abbia influenzato le scelte politiche o di vita del poeta. Nel suo essere sopra tutto e tutti, d’Annunzio ha saputo ‘sfruttare’ la massoneria e il suo denaro piegando questo rapporto – indefinito – ai propri fini.
La vicenda stessa del modus vivendi è emblematica. La libera muratoria auspicava l’accettazione delle proposte governative giunte attraverso Pietro Badoglio e in tal senso aveva consigliato il Comandante che agì esattamente in maniera opposta: d’Annunzio fu sempre e comunque indipendente nelle sue decisioni politiche, forse maggiormente influenzato dal suo entourage legionario piuttosto che dalla libera muratoria.
Analizzando la vita, le scelte anticonformiste e antiborghesi del vate non pare possibile inquadrarlo come un massone, dato appunto il suo essere anarcoide, contrario praticamente da sempre a qualsiasi regola imposta. Questo sebbene segni massonici siano rintracciabili nel suo mondo, come ad esempio il simbolo del mattone, evocato per legittimare la ‘rivoluzione’ dei legionari, battezzati dal Comandante «costruttori», «edificatori», come lo erano stati i loro predecessori romani, o ancora l’uroboro, il serpente che si mangia la coda, simbolo nicciano dell’eternità e della ciclicità della stirpe presente nel gonfalone dello Stato libero di Fiume e nello stemma gentilizio del principe di Montenevoso.
Sarebbe quindi gioco troppo semplice individuare nelle mille suppellettili pietre, animali o altri simboli o oggetti riconducibili all’esoterismo o alla massoneria: la “Priorìa”, la dimora del priore, è talmente ricolma di oggetti che sarebbe strano il contrario. Era il suo mondo, creato a sua immagine. Pertanto non è possibile stabilire univocamente se il repertorio di ornamenti presente all’interno del Vittoriale (l’uroburo, la spiga, i melograni, le colonne della stanza della stanza della musica, il letto-bara della stanza del lebbroso, l’occhio alato, il Dantes Adriacus, la scelta del nome Officina per il proprio studio) sia una reale testimonianza di affiliazione o, come è molto più probabile che sia, il frutto di una scelta puramente estetica.
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Silvano Danesi, La Carta del Carnaro costituzione massonica, Prot. 35 GMSD – 2017 E∴V∴.
Bibliografia secondaria
AA.VV., Massoneria: Simboli, cultura, storia, Milano, De Vecchi, 2020.
Paolo Alatri, Nitti, D’Annunzio e la questione adriatica, Milano, Feltrinelli, 1959.
Michael Baigent, Richard Leigh, Origini e storia della massoneria: Il tempio e la loggia, Roma, Newton Compton Editori, 2007.
Antonio Binni et al. (a cura di), L’impresa di Fiume (1919-1920) Tra mito e realtà, atti del convegno (Udine, Castello di Villalta, 19 ottobre 2019), Etabeta, Lesmo (MB), 2022.
Carlo Francovich, Storia della massoneria in Italia. I Liberi Muratori italiani dalle origini alla Rivoluzione francese, Milano, Ghibli, 2013.
Raffaella Canovi, L’iniziato. D’Annunzio e la massoneria, Pescara, Ianieri, 2022.
Roberto Cauti, La Massoneria e i massoni, l’esempio di Carducci e di D’Annunzio, «Officinae, la rivista internazionale della Gran Loggia d’Italia degli ALAM», n. 8, 1995, p. 38
Zeffiro Ciuffoletti, Sergio Moravia, (a cura di) La massoneria: la storia, gli uomini, le idee, Milano, Mondadori, 2004.
Bègue Clavel, François-Timoléon Clavel, Storia della Massoneria e delle Società Segrete, Roma, Gherardo Casini Editore, 2010.
Pierluigi Romeo di Colloredo, La carne del Carnaro, Genova, Associazione culturale Italia storica, 2012.
Fulvio Conti, Storia della massoneria italiana. Dal Risorgimento al fascismo, Bologna, il Mulino, 2003.
Renzo De Felice, La Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e di Gabriele D’Annunzio, Bologna, Il Mulino, 1973.
Rosario F. Esposito, La massoneria e l’Italia dal 1800 ai nostri giorni, Roma, Edizioni Paoline, 1979.
Salvatore Farina, Il libro completo dei rituali massonici. Rito scozzese antico ed accettato, All’insegna dell’acacia, Roma, 1946.
Cinzia Guazzi, La Reggenza italiana del Carnaro nella storia del diritto costituzionale, Cremona, Centro di Cultura giuliano dalmata, 1982.
Patrick Karlsen, La Carta rivoluzionaria di D’Annunzio e De Ambris: origini, contesto, contenuto, in Raoul Pupo, Fabio Todero (a cura di) Fiume D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia, Trieste, IRSML, 2010, p. 6
Aldo A. Mola, La massoneria e la questione fiumana (1918-1924) in Fiume 1919-2019, Un centenario europeo tra identità, memorie e prospettive di ricerca, atti del convegno internazionale di studi, (Gardone Riviera, Il Vittoriale degli Italiani, 5-7 settembre 2019), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale 2020, pp. 329-357.
Aldo A. Mola, La Massoneria italiana nella crisi dello stato liberale (1914-1926), in Aldo A. Mola (a cura di) La Massoneria nella storia d’Italia, Roma, Editrice Atanòr, 1980, p. 124.
Aldo A. Mola, Storia della massoneria in Italia – Dal 1717 al 2018. Tre secoli di un ordine iniziatico, Milano, Bompiani, 2019.
Paul Naudon, La massoneria nel mondo dalle origini a oggi, Biella, Prealpina, 1983.
Francesco Perfetti, La carta del Carnaro, Roma, Edizioni De Luca, 2001.
Ferruccio Pinotti, Potere massonico, Milano, Chiarelettere, 2021.
Fiorella Pitocchi, L’esoterismo di d’Annunzio negli inediti dell’Istituto di frutticoltura di Roma, «Quaderni del Vittoriale», nuova serie, n. 10, 2014, pp. 83-91.
Luigi Polo Friz, La massoneria italiana nel decennio postunitario. Ludovico Frapolli, Milano, Franco Angeli, 1998.
Carlo Ricotti, La Carta del Carnaro, Roma, Fefè editore, 2015.
Lino Sacchi, Storie sorprendenti di liberi muratori, Torino, Edizioni L’età dell’acquario, 2014.
Augusto Sinagra (a cura di), Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro. Tra storia, diritto internazionale e diritto costituzionale, atti del convegno (Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di scienze politiche, 21 ottobre 2008) Milano, Giuffrè, 2009.
Luigi Troisi, Massoneria universale. Dizionario, Milano, Sugarco Edizioni, 1994.
Gianni Vannoni, Massoneria Fascismo e Chiesa Cattolica, Bari, Laterza 1980.