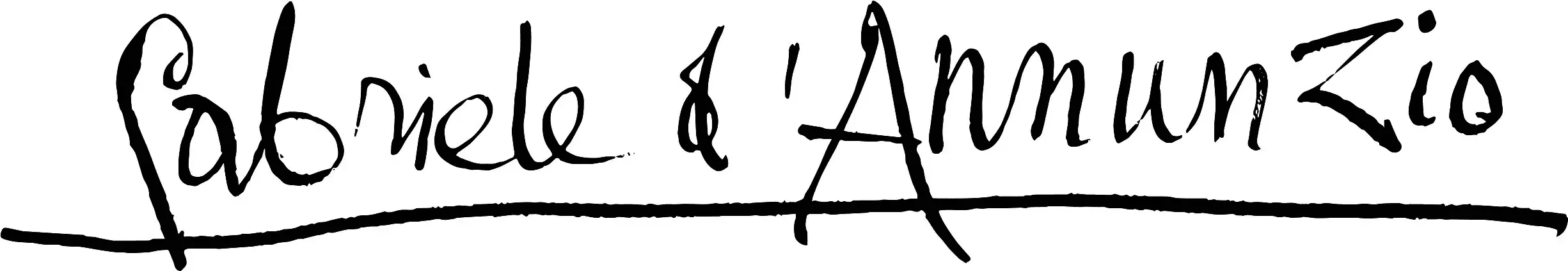di Gianni Oliva, Enciclopedia dannunziana
Malinconia o Melanconia o anche Melancolia, secondo un’accezione desueta e letteraria , è ritenuta, secondo una suggestiva tradizione romantica, uno stato d’animo di vaga e temporanea tristezza, spesso compiaciuto nell’ambito di stati di inquietudine o di delusione. Qualche volta si pensa ad un dolce dormiveglia in cui sono evocati ricordi lontani in un’atmosfera di sospensione del tempo presente; altre volte si confonde la Malinconia con la reverie, cioè con un abbandonato fantasticare tra i labirinti dell’immaginazione, la cosiddetta poeticosfera, per intenderci, secondo Bachelard.
In realtà la malinconia è un sentimento complesso e profondo, che investe l’intera concezione delle vita. Per semplificare, è l’insoddisfazione per come va il mondo, la coscienza della sua imperfezione, la reazione amara, accompagnata dal riso o dal pianto, dinanzi all’impossibilità di realizzare l’umana aspirazione all’eterno; essa può dirsi altrimenti la condizione dello spirito che ha il pensiero nell’infinito e il corpo nella finitezza.
Certo è che la modernità e il frenetico dinamismo dei tempi hanno accentuato come non mai lo status precario dell’essere (d’Annunzio dice che «la mancanza di equilibrio è il principal carattere dell’uomo moderno»: La morale di Emile Zola, in «La Tribuna», 15 luglio 1893), elevandolo a cifra incontestabile della sua identità. A guardar bene però tale malinconia storica non è se non l’espressione di una ferita perenne per nulla cicatrizzata. Si può dire allora, correggendo il tiro, che la Malinconia è una condizione che nasce con l’uomo, con Adamo che si vede negato, dopo il peccato, il bene supremo e l’immortalità. Malattia dell’assoluto, dunque, un male oscuro che si annida nella costituzione della collettività accompagnando il cieco destino degli uomini e il loro inevitabile tramonto.
Il tipo malinconico
Se alle caratteristiche fisiologiche ritenute indispensabili nell’antichità (l’equilibrio tra sangue, flemma, bile gialla e bile nera) si associano le capacità artistiche e scientifiche, al tipo malinconico sono riconosciuti senza esitazione talento e doti intellettuali. Aristotele nei Problemata XXX aveva già scritto che «Tutti gli uomini straordinari, eccellenti nella filosofia, nella politica, nella poesia, nelle arti sono palesemente malinconici», inaugurando così il legame indissolubile tra genio e malinconia.
La teoria aristotelica ebbe grande fortuna e, se si esclude l’età medievale che interpretò la malinconia come disordine psichico, prossimo al vizio, già il Quattrocento con Marsilio Ficino ripristinò la connessione fra capacità creativa e umore malinconico, e così tutto il Rinascimento, che considerò addirittura un dono divino il temperamento malinconico dei nati sotto Saturno.
Nello stesso periodo si colloca l’intervento di Timothy Bright e soprattutto, nel 1621, appare il volume The anatomy of melancholy di Robert Burton, ampio repertorio sul tema che alla fine dei conti si prefigge la demolizione della malinconia come stato patologico, secondo la teoria aristotelico-ficiniana, per affermare lo stato di follia, cioè la malinconia come male che nidifica facilmente negli eccessi dell’uomo e nella sua mancanza di controllo.
Fin dall’antichità Democrito ed Eraclito rappresentano due modi diversi di reagire dinanzi alla constatazione dei mali del mondo: al riso dell’uno fa da contraltare il pianto dell’altro. Due atteggiamenti psicologici contrapposti, due modi di guardare e meditare sulla vita.
Il riso di Democrito non trae origine dal non saper riconoscere il bene dal male, ma ha radici nel profondo dell’uomo che ride nella consapevolezza della vacuità dell’esistenza e per la sua stoltezza diffusa nel rincorrere chimere. D’altro canto Eraclito, dopo una lunga e meditata riflessione sulla vita , commosso e impietosito, prorompe in un pianto ininterrotto e lamenta la condizione di miseria, di follia e di insensatezza in cui versa l’uomo.
La coscienza afflitta per la disarmonia universale, per lo squilibrio tra spirito e materia, tra trascendenza e immanenza, porta alla disperazione e, tra l’altro, ad un’esasperata tendenza all’Eros che, come in d’Annunzio, nasce dall’impossibilità di abbracciare il tutto. In lui ( ma questo è solo un aspetto della sua malinconia) l’attività erotica scatena il disordine interiore ed è motivata dall’insoddisfazione di raggiungere l’irraggiungibile e dal proposito di possedere ciò che è inafferrabile.
Il labirinto sublunare, come lo chiamava Burton, è nel corso dei tempi fatto di disarmonie, corruzione, disordine e instabilità, di affanni per il non-senso delle umane attività. Da sentimento a malattia, tra piacere e depressione, dall’oscurità seicentesca alla forza incerta dei lumi settecenteschi, si arriva persino alla “moda di malinconia” di estrazione romantica che predilige l’emozione malinconica tra soavità e misticismo, la malattia dell’anima e la felicità di sentirsi tristi, allorché ogni godimento muta aspetto e diviene nausea non appena raggiunto, e quando ogni bellezza svanisce, così ogni fortuna . Più tardi le scienze della vita procederanno ad un tentativo di normalizzazione della devianza riconoscendola come disturbo concreto e clinicamente abbordabile, ma pensieri e sentimenti appartenenti alla cultura e alla storia comuni sfuggiranno ad ogni catalogazione nella letteratura che riflette il mondo sofferente, che sarà specchio dell’età del Nulla e della morte di Dio, nella società tecnologica addormentata e degenerata dall’opulenza e dal benessere. Il tedio, l’accidia, l’indolenza, la noia saranno i mali del secolo che scaturiscono dal fondo oscuro delle cose, dal vuoto abissale che ci circonda. Sarà, per dirla con un’espressione, il male di vivere dei poeti, da cui d’Annunzio non sarà esente.
In lui il sentimento malinconico coinvolge la sostanza dell’essere penetrando nell’oscurità del magma interiore e svelando ciò che si nasconde oltre l’apparenza di una vita a mille giri. Il sentimento del tempo, poi, non è tanto la scansione monotona e ripetitiva di momenti uguali, quanto il ritorno ciclico dell’emotività. Se il tempo della quotidianità è veloce e fuggevole, quello della malinconia, che investe la memoria, è immobile, allargato e allungato, esasperante nella sua staticità e inconsistenza. Tuttavia, all’interno della tragica sofferenza che esso procura, può materializzarsi un dato positivo nell’attività e nell’impegno, non esclusa la creatività artistica. Il che vuol dire che la malinconia, pur aprendo le porte al vuoto, sollecita l’individuo a dare spazio alle forze che si agitano dentro di lui. D’Annunzio in particolare è travolto dall’ansia di dare senso e forma al nulla. Sicché creare per lui è un modo per esorcizzare il dolore dell’abbandono dando espressione alle sollecitazioni del profondo, le quali, da linguaggio privato, diventano materializzazioni socializzate. Si realizza, attraverso questo meccanismo, l’unione tra psiche nascosta e mondo, al fine di soddisfare la necessità di procreare per lasciare ai posteri testimonianza di sé, per stabilire un filo rosso tra passato e futuro. La nausea del vivere dannunziano scaturisce dal suo delirio di onnipotenza, di chi non accetta la prigionia dei limiti umani e brama di assaporare il gusto dell’infinito crogiolandosi nell’autoinganno.
D’Annunzio, dunque, come Baudelaire, a sua volta vittima dell’insuperabile tensione tra realtà e idealità, tra carcere e libertà. Lo spleen, la milza sede della bile nera, è un mostro delicato e sensibile, una lacerazione dello spirito orfano dei propri ideali. Di qui il ricorso ai paradisi artificiali, all’estasi e alla redenzione poetica densa di allegorie, cartine di tornasole della malinconia; di qui i ricordi, come sarà in D’Annunzio, il fascino dei luoghi, i frammenti della memoria e dell’infanzia, l’assenza della patria, espressioni di una realtà trascorsa ma impressa e pietrificata nello spirito, rimpianti di un’armonia perduta. È la stessa stimmung malinconica di Leopardi, per intenderci, della sua malattia dell’anima che si rifugia nello studio come penitenza accettata per combattere la morte-in vita. Anche in lui si corrobora la sintesi tra genio creativo e malinconia, rappresentando la scrittura una valvola di salvezza davanti al deterioramento della vita presente. La poesia così si nutre di quella malinconia che spesso si scioglie nella dolce e indefinita rimembranza che cerca di catturare ciò che fugge, oppure esita nel riso democriteo, talora violento e irriverente che smaschera il patimento della disillusione.
Oltre alla vita pubblicamente esposta, spettacolarizzata mediante una gestualità eccentrica, c’è dunque un d’Annunzio addolorato, geloso custode della propria interiorità, che rigetta ogni rivelazione di sé, o per lo meno affida la sua riservatezza a pagine intime, riflessive, in cui scava dentro il proprio io “a chiarezza di sé”.
Il vate, l’eroe, l’istrione e tutte le immagini che egli dispensa di se stesso diventano ingranaggi di una macchina che a tratti s’inceppa per lasciare intravedere nuovi orizzonti. Ricercando la propria identità, ora con i suoi personaggi, ora con la memoria e l’autobiografia, d’Annunzio sperimenta la conoscenza dei campi inusitati della persona, ove risiede la malinconia, perché «Le profondità dell’oceano sono note; ma quelle della malinconia sono incommensurabili» (a Giancarlo Maroni, 21 gennaio 1924).
La malinconia è una componente della sua natura e gli siede accanto, non lo abbandona, convive con lui, se si vuole, fin dai giorni dell’infanzia e dell’adolescenza tormentata («vivo in un’atmosfera di tempeste interiori ed ondeggio in una perpetua vicenda di estasi e di martirii, di dubbi e di lacrime, di abbattimenti tragici e di ilarità convulse ed amare»), spesso, com’è noto, rivissuti in chiave mitografica nelle pagine intime della maturità. Il sentimento malinconico dell’uomo di genio, secondo la tradizione aristotelica, non gli è dunque estraneo; anzi si insinua nei meandri del pensiero e della riflessione che indaga sul fondo oscuro dell’esistenza alimentandone il mistero e il percorso verso il nulla. Insomma, la celebre “vita inimitabile” finisce, da questa prospettiva, per diventare una grande scena teatrale che lo stesso d’Annunzio aziona con l’abilità dell’esperto manovratore. Da una parte quindi le tante vite dell’Immaginifico, dall’altra la vita di cui egli è testimone solitario: «odio il mio vivere inimitabile, maledico l’ingiustizia che mi mozza e tronca, mi altera e mutila, mi storce e frange» (LS, 47-48), e altrove: «Questo ferale taedium vitae mi viene dalla necessità di sottrarmi al fastidio – che oggi è quasi l’orrore – d’essere stato e di essere Gabriele d’Annunzio, legato all’esistenza dell’uomo e dell’artista e dell’eroe» (LS, 257). Di questo passo si spiegano i versi finali del Libro segreto, scritti però il 3 marzo 1902, a riprova di una concisa ed eterna disperazione: «Tutta la vita è senza mutamento./ Ha un solo volto la malinconia./ il pensiere ha per cima la follia./ E l’amore è legato al tradimento».
Di questo passo è possibile intraprendere un itinerario conoscitivo nella testualità dannunziana che forse non sarebbe stato neppure sospettabile per quell’indirizzo di studi che ha sempre privilegiato il cliché indiscusso dell’uomo d’eccezione. Un modello di certo alimentato dal personaggio stesso e da lui difeso al di là di ogni limite, ma che si può tentare di smontare, almeno in parte, appellandosi ad una scrittura che fa leva sulle ragioni d’una vocazione complessa, spesso ripiegata su se stessa più di quanto non sembri, sorprendendola magari nell’attitudine a liberarsi della maschera per mostrare il vero volto dell’uomo alle prese con il proprio tormento.
La malinconia diventa così il risultato ultimo di un’indagine non convenzionale, la cifra caratterizzante di una personalità non sospettabile, che anzi si esprime in un crescendo drammatico sia nei documenti di natura diaristica, com’è logico, sia nelle pagine creative, ove il morbo è sotteso perché oggettivamente riflesso nelle situazioni poetiche e narrative.
In d’Annunzio, com’è noto, le impressioni, le associazioni e le visioni sono affidate all’arte della parola che tutto manipola e trasfigura, ma che non sempre riesce ad occultare quel fondo di tristezza che qua e là permette alla scrittura di raggiungere vertici d’incantata bellezza e di toccante sensibilità. La sua vicenda biografica scorre come un torrente in piena e le stagioni della vita si affastellano; nel tessuto narrativo il presente diviene passato e il futuro sbiadisce in lontananza, sicché la rimembranza, sotto forma di rimpianto, costituisce uno dei suoi temi conduttori. Il ricordo, la malattia fisica e morale, la vecchiaia e la contemplazione della morte sono i parametri di raccordo di un processo che ha come denominatore comune la maschera del genio malinconico, dapprima celata sotto mentite spoglie, poi coraggiosamente sempre più manifestata in prima persona, figurando ora un novello Democrito ridens, ora un novello Eraclito flens.
Intriso di quell’umore, insomma, d’Annunzio si fa conscio della caducità dell’essere e accetta la sfida contro il tempo e la vecchiaia impietosa, contro la morte crudele e il nulla imperante.
Questa visione delle cose non si può non ricondurre ad un contesto culturale di crisi che rispondeva pienamente alle esigenze dell’uomo contemporaneo, a certi impulsi del pensiero occidentale. Da questo processo non è esente la nuova diffusione di Schopenhauer nell’ambito della cultura romana degli anni Ottanta, documentabile proprio presso il gruppo di riferimento di d’Annunzio, in particolare testimoniata dalla lettura “estetica” che ne fece Angelo Conti in un clima in cui la mancanza di fiducia nella scienza positiva poneva l’esigenza di non accontentarsi della realtà superficiale ma di penetrare all’interno delle più segrete facoltà dello spirito. L’attenzione rivolta all’idealità naturale che regola il meccanismo della vita, il suo porsi come “forma dell’infinito”, mentre apriva la strada al raggiungimento della “contemplazione pura della eterna verità”, spianava la conoscenza del pensiero tragico schopenhaueriano che rifletteva in pieno la sensibilità dei tempi, il disequilibrio esistenziale della nuova generazione. Schopenhauer, insomma, finiva per costituire un modello inalienabile a cui guardavano i giovani intellettuali assettati di verità. Solo più tardi Nietzsche rafforzerà la diagnosi del concetto di vita come dolore e lotta vana, del divenire cosmico come necessità.
Aveva colto senza riserve, tra l’altro, questa condizione un critico molto vicino a D‘Annunzio in un coscienzioso esame della tendenza verso l’artificio. Parlando di Des Esseintes in rapporto all’Andrea Sperelli del Piacere, Giuseppe Saverio Gargàno annotava sulle pagine della «Vita Nuova» del 25 agosto 1889: «chi di noi può sottrarsi a quell’immenso sentimento pessimistico che ha per noi tutta l’esistenza? Quanti di noi hanno ancora la potenza di godere serenamente, quanti di noi, che pur lo credono, non s’accorgono degli artifizi che mettono in opera nella ricerca del piacere ? E se non sono arrivati alle sottili elaborazioni spirituali, sanno essi quanto ciò più che da loro sia dipeso dalla eredità e dalle condizioni esteriori? Togliete queste due cause, datemi un essere assetato del bello e con un organismo affievolito; dategli la libertà di potersi sottrarre a certe fatali necessità della propria conservazione, e mettetelo pure nella società nostra; e vedrete come s’avvierà anch’egli presto sulla via nella quale è Andrea Sperelli, nella quale è innanzi ancora Giovanni Des Esseintes». Indirettamente, dunque, è affermata la modernità di d’Annunzio come interprete di un’età complessa, di una generazione di deboli o di finti forti, destinata alla sconfitta. La tragica weltanschauung di Schopenhauer basata su un concetto della vita come lotta perenne nel tentativo di soddisfare i bisogni dell’uomo, di concretizzare le sue aspirazioni, è un dato di fatto acquisito presso l’individuo di fine secolo. La sua volontà di vita e di piacere è strettamente legato all’eventualità di appagare il desiderio, ma ogni ricerca in questo senso è destinata al fallimento, dato che le ambizioni riemergono naturalmente con tutta la loro fisionomia angosciante. Sicché la felicità diventa una méta irraggiungibile nel momento in cui la vita dell’uomo è preda dell’eterno ritorno dell’identico. Schopenhauer trasmetterà a Nietzsche la fede nell’identità sostanziale dell’uomo e del mondo e dei suoi meccanismi, ma quell’ andare di aspirazione in aspirazione alla rincorsa di un appagamento che mai soddisfa, determina per ora il carattere illusorio del piacere che si trasforma in sofferenza, in nausea, in malinconia: «Tra il volere e il conseguire trascorre intera ogni vita umana- afferma Schopenhauer. Il desiderio è per sua natura dolore: il conseguimento genera tosto sazietà: la méta era solo apparente: il possesso disperde l’attrazione: in nuova forma si ripresenta il desiderio, il dolore: altrimenti segue monotonia, vuoto, noia, contro cui la battaglia è altrettanto tormentosa quanto contro il bisogno».
Una troppo facile soddisfazione, quindi, conduce ad una nuova infelicità, a tal punto che l’esistenza tutta diventa preda dell’horror vacui, della fatica di essere uomini, dell’anelito disperato all’annullamento. La consapevolezza della negatività radicale, dello scorrere inarrestabile e rapido della vita verso la morte, genera il male del secolo, quella malinconia a cui d’Annunzio, come tanti altri , non può sottrarsi, perché la morte «è il termine ultimo del faticoso viaggio».
Certo, l’uomo fa di tutto per porre rimedio al destino ineluttabile e inventa sempre nuove esperienze per distrarsi, alimenta cioè quello che Kierkegaard chiamava «l’interessante». Nel Piacere, ma anche negli altri romanzi della “Rosa”, così nella vita privata dello stesso scrittore, il gesto di qualsiasi tipologia (erotico, militare, ecc: ), assume i connotati dell’apparente esorcizzazione del male di fondo. d’Annunzio è portato a rievocare attraverso la parola la gestualità perché rievocarla è godere della situazione vissuta e di se stesso in quella situazione. Purtroppo le esperienze di qualsiasi tipo, comprese quelle sentimentali del seduttore incallito, somigliano in qualche modo a quelle descritte dal filosofo danese, per cui la dedizione al godimento assoluto di carattere erotico-estetico (la dannunziana vita inimitabile, per intenderci) rivela prima o poi il suo lato oscuro e incontrollabile e il tutto si trasforma in vanitas vanitatum , ridando forza alla noia e alla malinconia. Il «demoniaco desiderio di vivere», in conclusione, nasconde l’angoscia e corre sull’orlo dell’abisso. Sogni, illusioni, utopie costellano l’esistenza umana, mentre la méta si allontana sempre più divenendo irraggiungibile. Come voleva Baudelaire, essa «è da per tutto» e in nessun luogo, perché “in eterno si sposta» (Il viaggio, II, 6).
Bibliografia essenziale
Questa voce è in gran parte la sintesi di quanto si legge nel libro di Gianni Oliva, D’Annunzio e la malinconia, Milano, Bruno Mondadori, 2007 (seconda edizione Lanciano, Carabba, 2024), che discute un’ampia bibliografia sul tema, da cui comunque è opportuno segnalare almeno:
Gabriele d’Annunzio, La morale di Emile Zola, 3, 10, 15 luglio 1893 , «Le Cronache della Tribuna», vol. II, Bologna, Massimiliano Boni editore, Bologna, 1993, pp. 658-677.
Rudolf e Margot Wittikover , Nati sotto Saturno, Torino, Einaudi, 1968.
Gaston Bachelard, La poetica della reverie, Bari, Dedalo, 1972.
Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione, trad. it. di P. Savy Lopez e G. Di Lorenzo, Bari, Laterza, 1972.
Sigmund Freud, Lutto e melanconia (1915), in Opere, vol. 8 1915-1917, Torino-Milano, Bollati e Boringhieri, 1978.
Robert Burton, The anatomy of melancholy, rist. a cura di J. Starobinsky, Venezia, Marsilio, 1983.
Timothie Bright, Della melanconia, a cura di F. Bugliani, Milano, Giuffrè, 1990.
Jean Starobinski, La malinconia allo specchio. Tre letture di Baudelaire, Milano, Garzanti, 1990
Elio Gioanola, Leopardi. La malinconia, Milano, Jaka Book, 1995.
Arcipelago malinconia. Scenari e parole dell’interiorità, a cura di B. Frabotta, Roma, Donzelli, 2001.
Gabriele D’Annunzio, Di me a me stesso, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 1990.
Id., Il libro segreto, a cura di Pietro Gibellini, Milano, Rizzoli (Bur), 2010.
Giorgio Barberi Squarotti, La scrittura verso il nulla. Gabriele d’Annunzio, Torino, Genesi, 1992.
Marziano Guglielminetti, A chiarezza di me. D’Annunzio e le scritture dell’io, Milano, Franco Angeli, 1993.
Ganni Oliva, I nobili spiriti. Pascoli, D’Annunzio e le riviste dell’estetismo fiorentino, Venezia, Marsilio, 2002 (II edizione).
Mèlancolie. Gènie et folie en Occident, prefazione di Yves Bonnefoy, Paris, Gallimard, 2005.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)