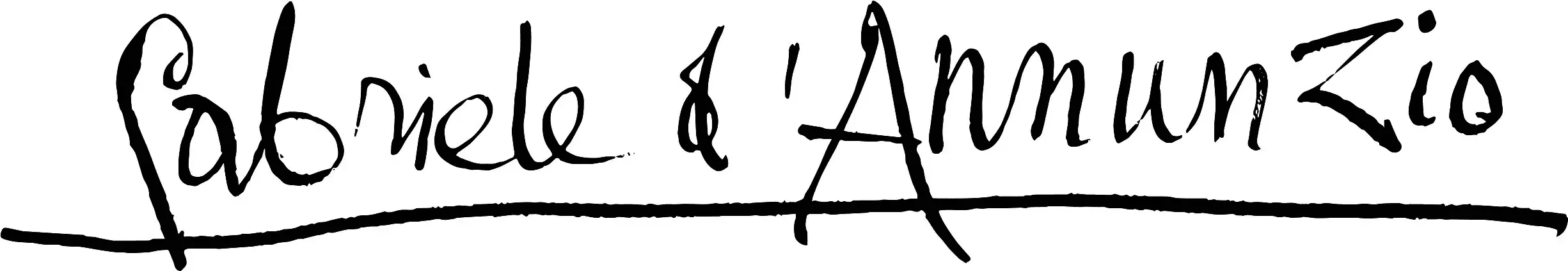di Cecilia Gibellini, Enciclopedia dannunziana
Genesi, elaborazione, vicenda editoriale
L’uomo che rubò la Gioconda è un soggetto cinematografico scritto da Gabriele d’Annunzio nel pieno dell’avventura fiumana (l’autografo che ci consegna il testo, conservato al Vittoriale – APV inv. nn. 10650-10767 – reca in calce l’indicazione «Fiume d’Italia, 30 giugno 1920»), ma da lui concepito già nell’estate del 1911, negli anni di Arcachon, a partire da un clamoroso fatto di cronaca: il furto del più celebre dipinto di Leonardo da Vinci, trafugato dal Museo del Louvre il 21 agosto, e recuperato solo due anni più tardi con la cattura del responsabile, il decoratore e imbianchino italiano Vincenzo Peruggia.
La notizia rimbalza immediatamente dai quotidiani parigini a quelli di tutto il mondo: ed è significativo che già il 25 agosto, sulla prima pagina del «Giornale d’Italia», l’anonimo articolo con la ricostruzione dei fatti, intitolato L’ultima avventura di Monna Lisa, sia preceduto da una serie di terzine dannunziane, precedute dall’intestazione “Anima con le labbra”. Parlando della “Gioconda” ad Andrea Sperelli, che corrispondono alla sezione conclusiva (i vv. 37-85) dei versi Al poeta Andrea Sperelli che chiudevano la Chimera, a testimonianza della duratura e ben nota ispirazione esercitata dal capolavoro leonardesco sullo scrittore allora esule in Francia.
In effetti, non appena la notizia lo raggiunge, d’Annunzio inizia a elaborare, in scritti privati e poi pubblici, il racconto, che costituisce il primo nucleo del soggetto del ’20, secondo cui l’allora ancora ignoto trafugatore lo avrebbe raggiunto ad Arcachon per consegnare la Gioconda direttamente nelle sue mani. Il primo interlocutore è Luigi Albertini, che in un telegramma del 26 agosto 1911 gli comunicava di attendere con «vivo interesse Faville sulla Gioconda», e a cui l’indomani d’Annunzio risponde: «Aspetto stasera l’uomo che ha rapito la Gioconda. Le manderò poi il colloquio. Da Bordeaux è venuto a nascondersi nelle Lande. Sono ansiosissimo» (Di Tizio 2003, p. 73). Inizialmente, dunque, l’idea è di dedicare al furto del dipinto e all’incontro con il responsabile una favilla da pubblicare sul «Corriere della Sera» e da passare anche all’editore dell’«Excelsior», Pierre Lafitte, al quale d’Annunzio ha promesso già dall’anno prima «una serie di Confessions et inventions», «racconti autobiografici, ricordi della mia vita d’avventura e di studio […] molto franchi, anzi temerarii» (Lettere ai Treves, p. 401); ma ben presto il proposito si dilata nel progetto più articolato di un racconto fantastico, che tuttavia, dichiara lo scrittore sempre ad Albertini (9 settembre 1911; Di Tizio 2003, p. 76), muoverebbe da circostanze reali:
Studiando il caso della Gioconda per farne una favilla (di data recentissima), m’è accaduto di adunare intorno al soggetto alcune immaginazioni. E queste immaginazioni mi tentano così che le ordinerò in un racconto, in una specie di storia meravigliosa, mista di realtà e di fantasia. Se io Le dicessi che il rapitore (l’uomo della Gare d’Orsay) è venuto qui a portarmi il quadro, Ella non mi crederebbe. Forse mi crederà quando leggerà la mia narrazione.
Questa histoire extraordinaire intitolata L’homme qui a volé la Joconde sarà pubblicata nell’Excelsior, in novembre […]. La scrivo, naturalmente, in italiano. Il ratto della Gioconda o La Gioconda rapita. […] Qui il caldo è accasciante. Le pinete s’incendiano. Vedrà uno di questi sublimi incendi nella mia Storia.
Diverse ipotesi sono state formulate intorno al rapporto tra realtà e finzione in queste dichiarazioni dannunziane, a partire dal perplesso Albertini (12 settembre 1911; Di Tizio 2003, p. 77):
Davvero non La capisco quando mi scrive che il rapitore della Gioconda è stato da Lei. Non posso immaginare dove cominci il fantastico e finisca il reale nelle Sue parole. Mi spieghi meglio il mistero. La prego. Certo sarei lieto di pubblicare l’histoire extraordinaire contemporaneamente all’Excelsior. Per quanto extraordinaire non sarà scabrosa, non è vero?
Nonostante il contratto firmato con Lafitte, e nonostante l’immediato lavoro di documentazione avviato dallo scrittore (nella biblioteca del Vittoriale si conservano – lemmi nn. 1751-1752 e 1755 dell’Inventario 1968 – le cartelle con i ritagli di stampa da lui raccolti a partire dal 1911, con segni di lettura e sottolineature), il progetto si arresta per cedere il posto alle Canzoni della Gesta d’oltremare cui egli si dedica allo scoppio della guerra italo-turca; d’Annunzio ha però già scritto il brano sull’incendio della pineta annunciato ad Albertini, consegnato a 15 carte datate anch’esse 9 settembre 1911 e intitolate Il Fuoco nella pineta (APV inv. nn. 22969-22983), che saranno poi rifuse nel Notturno (cfr. Prose di ricerca, pp. 307-317 e 3160-3165).
Un nuovo impulso alla scrittura è dato quindi, nel dicembre 1913, dalla cattura di Peruggia a Firenze e dal recupero della Gioconda: a questa altezza, d’Annunzio definisce compiutamente la trama del suo racconto, e la espone ad Albertini, che incontra a Parigi. Il direttore del «Corriere» riferisce il colloquio nel suo diario, sotto la data del 9 gennaio 1914, insieme allo sconcerto provocato dalle dichiarazioni dannunziane circa la veridicità dell’accaduto (Albertini 2000, p. 139; Di Tizio 2003, p. 221):
Mi racconta la tela […] de L’homme qui a volé la Joconde. La Gioconda è stata ad Arcachon da lui per 20 giorni subito dopo il furto, portatavi da un fiammingo […] che l’ha fatta rapire per tentare di estrarre dalla Gioconda la vita, le sensazioni che Leonardo, la Gioconda stessa hanno emanato attorno al quadro, per far rivivere anzi la donna fiorentina valendosi dello spirito che è raccolto nel quadro. […] Sarebbe un matto che avrebbe anche ucciso un uomo per arrivare ad estrarre la sostanza del cervello. Ma d’Annunzio dice che tutto questo è assolutamente vero, che il suo romanzo partirà da questa verità, che egli ha predetto il giorno prima la restituzione della Gioconda a Firenze […], ecc. ecc. È una plaisanterie? Impossibile arrivare ad acquistarne la certezza; la persuasione però sì.
Dichiarazioni che verranno ribadite da d’Annunzio nel Libro ascetico della giovane Italia (nel Comento meditato a un discorso improvviso, del 1922, al paragrafo IX, Il sorriso d’Italia: «Non è [il nostro sorriso] quello famoso della Gioconda che fu da me restituita per sazietà e per fastidio, come tanti sanno e come tanti temono di approfondire»), così come nel Ritratto di Luisa Baccara (1920) poi confluito nelle Faville (Il compagno dagli occhi senza cigli) con il titolo Di una pausa musicale nel tumulto di Fiume:
Mi ricordo che, quando il ladro sublime della Gioconda portò al mio rifugio nella Landa la tavola avvolta in una vecchia coperta di scuderia, mi posi ad abominare le mani molli di Monna Lisa costretto ad averla sotto gli occhi per giorni interi, durante la speculazione metafisica che mi aveva proposta il rubatore.
È proprio «nel tumulto di Fiume», nel giugno 1920, che d’Annunzio compie la stesura del racconto, che assume la forma di un soggetto cinematografico, intitolandolo L’uomo che rubò la Gioconda, dicitura che sostituisce la precedente, documentata da una carta isolata conservata sempre al Vittoriale (APV inv. n. 10649), su cui si legge: «La Gioconda rapita / Storia meravigliosa / L’homme qui a volé la Joconde / histoire extraordinaire».
Al Vittoriale si conservano l’autografo (di 116 carte numerate – APV inv. nn. 10650-10767), una sua copia dattiloscritta e un manoscritto apografo (APV inv. n. 31637-31639), copia fedele dell’autografo, come precisato dal copista, che su un foglietto rosso allegato al fascicolo informa: «Contiene la copia manoscritta L’Uomo che rubò la Gioconda imaginato e scritto da Ariel in Fiume e da me ricopiato contemporaneamente. Il manoscritto mi fu regalato da Ariel e richiestomi da Maroni per darlo in visione onde farne un film non mi fu più restituito e deve essere al Vittoriale. Ariel mi scrisse la copertina perché ne rimanesse sempre una copia».
Dall’autografo furono tratte, ad opera della Fondazione del Vittoriale, un’edizione di 100 esemplari numerati nel 1938 e una mondadoriana di 500 esemplari numerati, senza data (ma 1949), accompagnata (p. 7) dalla Notizia: «È questa una forma di visione cinematografica scritta da Gabriele d’Annunzio a Fiume. Fa parte degli scritti che il Poeta non aveva licenziati alle stampe e che la Fondazione del Vittoriale rende noti, adempiendo ad uno dei compiti per la quale essa fu creata, essendone presidente Eucardio Momigliano e consiglieri perpetui Leopoldo Banduzzi e Gian Carlo Maroni». Il soggetto fu poi incluso nelle edizioni mondadoriane delle Tragedie, sogni e misteri (1950, a cura di Egidio Bianchetti, e 2013, a cura di Annamaria Andreoli con la collaborazione di Giorgio Zanetti, edizione da cui cito); nel 2018 fu pubblicato autonomamente da Solfanelli, con una presentazione di Lucio D’Arcangelo.
La pubblicazione della versione francese del testo sull’«Excelsior» di Parigi, indicata nella bibliografia e assegnata al luglio 1920 (Tragedie, sogni e misteri, vol. II, pp. 1734 e 1740), in realtà non andò mai in porto, come segnalava correttamente Mario Guabello (Guabello 1948, pp. 244-246), indicandone la ragione in un «conflitto politico insorto tra d’Annunzio ed il giornalista».
Una traduzione inglese anonima del soggetto dannunziano fu invece inviata da d’Annunzio, probabilmente attraverso il figlio Veniero, trasferitosi a lavorare negli Stati Uniti già dal 1917, a David Wark Griffith, il regista di The Birth of a Nation e di Intolerance. In un’intervista apparsa sul «Los Angeles Times» il 17 aprile 1944, Griffith riconosceva d’Annunzio (accanto a Winston Churchill!) come il più brillante autore di soggetti cinematografici a lui noto, rammaricandosi di non avere, a suo tempo, avuto il denaro necessario a finanziare il film, e aggiungendo che il poeta avrebbe voluto, poco opportunamente, recitarvi nella parte di se stesso (Griffith 2012, p. 204):
Winston Churchill and the late Gabriel d’Annunzio are the smartest scenario writers I ever met […]. Unfortunately, I could not produce either the story outlined to me by Mr. Churchill in 1917, nor the one offered by the Italian poet. Their production would have cost more money than I had at the time. Besides, […] d’Annunzio, then in his sixties, wanted to act the hero in his play.
Trama e personaggi
Lo scenario si apre in un’ambientazione fiamminga: qui viene presentata la figura del «pittore mistico» Peter van Blömen, discendente dall’omonimo pittore fiammingo vissuto tra Sei e Settecento e soprannominato ‘Standaart’ o ‘Stendardo’, e dal fratello Jan Frans, paesaggista noto con il nome di ‘Orizzonte’, pseudonimo adottato anche dal protagonista dannunziano: «L’Orizzonte (così il Metafisico si compiace di lasciarsi chiamare, in memoria del suo Antico e per nostalgia dell’Italia bella e di Roma città dell’anima)». Peter è non solo un artista «solitario» e un «asceta» cultore della bellezza, ma si dedica anche «a studii misteriosi, a ricerche occulte, a speculazioni metafisiche, a operazioni d’alchimia»: la sua figura fonde in sé i tratti del genio leonardesco, cantato nei versi della Chimera come «insonne Prometèo, sottile Ermète» (nel solco dell’immagine di un Leonardo alchimista e mago divulgata a metà Ottocento da Alfred Dumesnil), con elementi faustiani, e insieme mistico-religiosi:
Per dipingere la sua donna morta, egli estrae i colori dai fiori.
Per trasfondere nei fiori l’imagine spirituale della sua donna, egli tenta di alchimizzare il suo quadro trasmutandolo in fiori viventi, restituendo la vita ai fiori premuti.
Le trasformazioni della spiritualità. Le transustanziazioni del perfetto amore.
Come ha suggerito Annamaria Andreoli (Tragedie, sogni e misteri, vol. II, p. 1737), è possibile che, nel nome del protagonista, d’Annunzio abbia voluto alludere anagrammaticamente (Peter/Pieter/Pieret) a un personaggio contemporaneo fortemente implicato nell’affaire della Gioconda: Géry Pieret, l’amico e segretario di Guillaume Apollinaire che, nelle polemiche scatenate dall’impresa di Peruggia, aveva confessato di aver sottratto allo stesso Museo del Louvre alcune statuette antiche, affidandole poi agli amici Apollinaire e Picasso, e che per questo era stato sospettato del furto della Gioconda, e rinchiuso per qualche giorno (7-13 settembre 1911) al carcere della Santé.
Alla presentazione di Peter van Blömen si intreccia la storia dell’«Uomo che perdette lo sguardo», un pittore, nominato «Gian Giuseppe Vermeer» in omaggio a Jan Vermeer, che ha contemplato con tale fervore un dipinto, una tavola d’altare con la Vergine custodita nella cattedrale cittadina, da lasciarvi lo sguardo, e anche «la miglior parte della sua anima e della sua vita». Nasce così l’antefatto della vicenda centrale: l’Orizzonte decide di trafugare la tavola con la Vergine per restituire il suo sguardo a Vermeer, il quale però, fedele al proprio sacrificio, si acceca rinnovando su se stesso «l’atto disperato di Edipo». Il sangue sgorgato dalle occhiaie di Vermeer rivela a van Blömen che il segreto «elemento perpetuo delle trasmutazioni» è «profondato nel cuore umano», e che per proseguire nella sua ricerca gli servirà una vittima. È il suo devoto discepolo Antonio van Diemen a offrire spontaneamente il proprio cuore per compiere il «grande atto creatore»: prende volontariamente la stricnina, e il maestro compie il primo esperimento estraendo dal cuore del giovane l’elemento necessario, chiamato cordastrum, che riesce a dar vita, per pochi attimi, alla Vergine della tavola.
A questo punto, «l’Orizzonte si propone di rubare la Gioconda, per compiere su quella l’esperimento definitivo»; visita il Louvre ed elabora il piano, per il quale si associa come complice «un giovine formatore carrarese», Castruccio Lunelli, incontrato la prima volta nella Corte Visconti del Museo mentre è intento a preparare dei calchi in gesso da spedire a «Gabriele d’Annunzio rifugiato nelle Lande, fra le dune dell’Atlantico»; da quel momento anche il nome del poeta, noto per essere «uno dei più acuti amanti della Gioconda», entra nel suo disegno.
Compiuto il furto, i due «rubatori» raggiungono in treno Arcachon, dove il poeta, appena rientrato da una cavalcata, sta leggendo commosso il telegramma che annuncia la scomparsa della Gioconda; van Blömen gli mostra il dipinto e gli rivela il suo piano. In una camera appartata della villa, il pittore mistico e il poeta stabiliscono l’officina in cui compiranno la metamorfosi, riportando in vita Monna Lisa. Anche questa volta, l’operazione richiede un sacrificio cruento, quello del dolce e malinconico Castruccio, che nel frattempo è stato sedotto dall’amante del poeta, Sonia, tormentata dalla gelosia suscitata dalla «presenza “misteriosa”» della «donna senza cigli» e diventata, via via, «ebra d’imaginazioni, folle di curiosità perversa, vendicativa e crudele». Quando Peter e il Maestro trovano Sonia e Castruccio nella pineta, nella quale sta divampando un incendio, il poeta si avventa sul giovane e lo uccide a colpi di pugnale, provocando l’orrore e la follia di Sonia, che monta a cavallo e si lancia nell’incendio, morendo come una «regina barbara».
Nella sequenza successiva, nell’officina, la figura viva della Gioconda si stacca dalla tavola davanti agli occhi del poeta:
Il prodigio.
L’animazione dell’imagine.
La figura viva si stacca dalla tavola.
Esce intera.
Posa i piedi sul pavimento.
È Monna Lisa del Giocondo.
Respira. Si muove… Scompone il suo gesto leonardesco. Vive. Non sorride più. Si smarrisce, si stupisce.
Nella tavola senza figura rimane il divino paesaggio di rocce, dove l’acqua tortuosa sembra perpetuare divinamente il sorriso umano.
«Siete voi, messer Leonardo?»
La voce della Gioconda! Monna Lisa ha parlato!
Ha ricominciato a vivere dal punto in cui il suo pittore venne a dare l’ultima velatura al suo dipinto.
Il poeta vede realizzarsi il sogno estetizzante di possedere in una donna reale l’opera d’arte e il suo mistero: «Egli ha, d’improvviso, l’amore del suo sogno, l’amore della sua poesia»; ma una volta uscita dal quadro, Monna Lisa appare paradossalmente più lontana, sorda all’ansia conoscitiva e al desiderio dell’artista (che le chiede «Làsciati conoscere! Làsciati possedere!»):
Nessuna comunione. I secoli stanno tra lui e lei.
La Gioconda non sorride più. Non ha più il sorriso misterioso che Leonardo trasse con la musica da quell’anima mediocre e ignara.
È smarrita, è trasognata.
Sembra talvolta ascoltare il delirio del poeta, che porta nell’anima sconvolta tutto il peso di quella notte incredibile.
Ma non comprende.
Il desiderio del poeta rimane frustrato: di lì a poco, l’apparizione dileguerà e van Blömen tornerà nella sua città, per riportare attraverso nuovi esperimenti la Gioconda perduta nella sua tavola, «su lo sfondo di rocce e di acque». L’ultima sequenza ci riconduce al Louvre: il dipinto è stato restituito al museo, dove irrompe, ormai folle, il poeta d’Annunzio, che agita davanti al quadro il pugno chiuso, scagliando infine contro l’enigmatico sorriso la cenere della donna reale da lui sacrificata:
La tavola rimessa nel suo luogo, richiusa nella sua cornice.
L’emozione, all’annunzio.
La ressa alle porte.
Gli amanti della Gioconda che si precipitano a ritrovare il sorriso perduto. Il poeta maniaco giunge, anelante. Fende la calca.
Ha il pugno chiuso. Leva il pugno chiuso, e grida, fra l’agitazione dei presenti.
Ha nel pugno la cenere dell’incendio lontano.
È folle.
Grida: «Ho dato tutto al fuoco. Ecco il mio amore! Ecco il mio amore! Ecco il mio amore!».
E getta sul sorriso inesplicabile il suo pugno di cenere fredda.
Agitazione. Indignazione. Tumulto. È afferrato da cento mani. È trascinato a forza.
La calca si riforma davanti al fàscino perpetuo.
Il cerchio si chiude, sembra suggerirci lo stesso autore autocitando l’ode Al poeta Andrea Sperelli, scritta una quarantina d’anni prima e fatta qui pronunciare da un «giovine poeta capelluto» che sfoglia una rosa in cui non è difficile indovinare un portrait of the artist as a young man; a lui il vecchio d’Annunzio sembra guardare ormai con un misto di rimpianto e di autoironia:
Un giovine poeta capelluto sfoglia una rosa e getta le foglie verso il sorriso inesplicabile.
«Tu non saprai giammai perché sorrido.»
Stile e interpretazioni
L’uomo che rubò la Gioconda rappresenta un’originale incursione di d’Annunzio nel genere del fantastico, che tra Otto e Novecento aveva rivitalizzato il motivo, in realtà antico (si pensi al mito di Pigmalione), della statua o del dipinto animati, facendone un vero e proprio topos (Ziolkowski 1977, Bettini 1992, Pellini 2000 e 2001): tra gli autori vicini al nostro autore, si pensi specialmente all’Oeuvre di Émile Zola (1886), ai racconti di Théophile Gautier, al Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde (1890), ma anche al romanzo Romae Carrus Navalis (1905) di Giulio Aristide Sartorio, amico e collaboratore di d’Annunzio, nel quale ad animarsi è la statua di un altro genio del Rinascimento, Raffaello Sanzio (Sartorio 2020), e naturalmente al Ritratto ovale di Edgar Allan Poe, nel quale lo scambio tra donna reale e donna dipinta (la moglie di un pittore ossessionato dalla propria arte muore a mano a mano che prende vita il dipinto in cui egli la ritrae) incarna il conflitto tra ideale artistico e passioni dell’esistenza. Del resto, la definizione di «histoire extraordinaire» usata da d’Annunzio nel carteggio con Albertini e nel primo titolo pensato per il testo, è un chiaro rimando alle Histoires extraordinaires di Poe tradotte da Baudelaire e pubblicate nel 1856-1857.
Quanto allo stile dello «scenario», la linearità della trama, la brevitas, la sintassi asciutta con largo uso di frasi nominali, la dominante paratattica, sono tutti elementi che da una parte rispondono alla natura del testo e alla sua destinazione cinematografica, dall’altro sono coerenti con gli sviluppi della scrittura dannunziana, che, negli anni della gestazione del soggetto, muove dalle Faville al Notturno. L’opzione di asciuttezza stilistica non vieta però all’autore di svolgere e intrecciare tra loro, entro il tema di fondo del quadro animato, una serie di motivi per lui centrali.
Il primo è quello della spiritualità dell’arte, che si traduce nell’attribuzione all’attività creativa – quella di Leonardo, quella del «Maestro» van Blömen e quella del «Maestro» d’Annunzio – del lessico religioso e mistico (oltre che magico-alchemico) e nell’introduzione di allusioni sacre e di riferimenti cristologici, ad esempio nella scena con il sacrificio del primo aiutante Antonio van Diemen: «“Eccomi” dice il discepolo. Egli si vuole sacrificare a un grande atto creatore. Il Maestro lo abbraccia. “Va. Va e vivi.” “Eccomi” ripete il discepolo. “Ecce cor meum”»; dove all’«Eccomi» evangelico si intrecciano gli echi dell’«Ecce cor meum» di sant’Agostino, ma anche del «Vide cor tuum» della dantesca Vita nuova.
Spiritualità dell’arte che, se trova il suo contesto ideale nelle atmosfere fiamminghe di van Blömen e Vermeer, o nell’«aspetto primordiale del paese selvaggio» della Landa di Arcachon, stride con la banalità e lo squallore della vita moderna. Il contrasto è emblematico nelle scene in cui i due trafugatori trasportano la tavola negli ambienti cittadini, in attesa di partire col treno:
Sosta in un bar. Visione del bar frequentato da ogni sorta di gente che va per tempo al suo mestiere o torna dalla sua vita notturna…
Sosta nel piccolo albergo losco, dove i due si tolgono i camiciotti e chiudono la tavola nella valigia fatta a misura.
L’ora della partenza.
La stazione popolosa. La visione dei binarii lucidi che s’irraggiano verso tutte le mète…
Il mistero che passa tra la brutalità delle cose e degli uomini.
Anche il motivo della cecità e della veggenza, caro al d’Annunzio prosatore e tragediografo, è qui affidato al personaggio dell’«Uomo che lasciò lo sguardo su l’imagine» e che, fedele al proprio sacrificio («Vermeer non vuole riavere il suo sguardo. Egli è felice di averlo lasciato su la tunica violetta della Donna del Paradiso»), dopo averlo riavuto indietro si acceca come Edipo.
C’è poi il motivo del triangolo amoroso che si crea tra il personaggio-d’Annunzio, l’amante Sonia (nei cui tratti, a partire dal nome russo, è chiaramente riconoscibile la figura di Nathalie de Goloubeff) e il giovane rivale Castruccio: della donna, che fa la sua prima apparizione «tra le amazoni» di una battuta di caccia, occorrerà «rilevare […] la sorda gelosia istintiva verso il “segreto” immediatamente divinato»; la gelosia trasforma la «bellissima belva» in «nemica» e la porta a sedurre Castruccio in un «gioco perverso […], a cui si mescola il dispetto e il sospetto verso il “mistero” che non le è rivelato…», provocando a sua volta la gelosia del poeta che, nello scenario drammatico della pineta incendiata, prende il sopravvento sulla razionale pianificazione dell’omicidio:
Il dramma nell’aria irrespirabile. Il dramma nel rogo.
Sonia e il giovine demente appariscono.
A un tratto, la ricerca della vittima per l’uccisione premeditata si cangia in sorpresa di amante ad amante, in furore di maschio contro maschio.
[…] La lotta. L’inseguimento, nella zona infernale tra fuoco e controfuoco.
L’uccisione a colpi di pugnale.
Altro motivo caro all’autore è quello della morte purificatrice, che nello scenario è scandita da un triplice sacrificio: quello quasi cristiano del primo assistente Antonio van Diemen, quello più brutale – perché mosso anche dalla gelosia – di Castruccio, e quello appassionato ed eroico della donna, che si getta nelle fiamme come Mila nella Figlia di Iorio, come Basiliola nella Nave o come l’Evadne di Fedra:
Con un balzo portentoso, rimonta in sella.
Il cavallo s’impenna. Ella lo lancia verso il fuoco. Lo lancia tra fuoco e controfuoco, nell’intervallo mortale.
È folle.
Scompare in un nuvolo di faville e di ceneri cocenti.
Il cavallo e l’amazone, neri, contro una fiamma che si torce per avvilupparli.
L’impennata suprema.
L’amazone cavalca la fiamma animale.
La disparizione abbagliante.
Lo scroscio dell’aroma.
Una morte di regina barbara.
La selva è il rogo.
Il rogo è la selva.
Quanto alla scena della Gioconda che prende vita, d’Annunzio vi fa convergere il topos fantastico del quadro animato con il tema, a lui caro, della metamorfosi, già variamente sviluppato nella direzione ovidiana della trasformazione vegetale (specie nel Sogno d’un mattino di primavera e, naturalmente, in Alcyone) o nel segno opposto della metamorfosi statuaria, tesa a «sublimare, nelle fantasie di un artifex e di un fascinatore, la femmina, l’amante, in un’ideale e composta bellezza, in un segno antico» (Curreri 2008, p. 27).
Ed è significativo che, riflettendo sui mezzi in grado di rendere artisticamente il «prodigio» della metamorfosi, dopo aver tentato alcuni esperimenti fotografici (si veda la serie di fotografie scattate alla Duse nei giardini della Capponcina nel 1898, oggi conservate alla Fondazione Cini), d’Annunzio si orientasse con entusiasmo verso il cinema e la «nuova estetica del movimento» consentita dalla sua tecnica, da lui saggiata proprio sul corpo femminile, come egli stesso raccontava in un un’intervista rilasciata a Parigi al «Corriere» il 27 febbraio 1914 (Interviste a d’Annunzio, p. 282):
Or è parecchi anni, a Milano, fui attratto dalla nuova invenzione che mi pareva potesse promuovere una nuova estetica del movimento. Passai più ore in una fabbrica di films per studiare la tecnica e specie per rendermi conto del partito che avrei potuto trarre da quegli accorgimenti che la gente del mestiere chiama “trucchi”. Pensavo che dal cinematografo potesse nascere un’arte piacevole il cui elemento essenziale fosse il “meraviglioso”.
Le Metamorfosi di Ovidio! Ecco un vero soggetto cinematografico.
Tecnicamente, non v’è limite alla rappresentazione del prodigio e del sogno. Volli esperimentare la favola di Dafne. Non feci se non un braccio: il braccio che dalla punta delle dita comincia a fogliare sinché si muta in ramo folto di alloro, come nella tavoletta di Antonio del Pollaiuolo che con gioia rividi a Londra pochi giorni fa. Mi ricordo sempre della grande commozione ch’ebbi alla prova. L’effetto era mirabile. Il prodigio, immoto nel marmo dello scultore o nella tela del pittore, si compieva misteriosamente dinanzi agli occhi stupefatti, vincendo d’efficacia il numero ovidiano. La vita naturale era là rappresentata in realtà palpitante…
C’è, infine, il mito della Gioconda e del suo autore, che attraversa tutta l’opera di d’Annunzio, dai versi della Chimera e dalle pagine del Piacere che sviluppano i motivi tardoromantici e decadenti dell’ambiguità leonardesca (l’androgino, la bellezza medusea, il mistero impenetrabile del sorriso…) a Le vergini delle rocce, romanzo che rende omaggio al Vinci fin dal titolo, dalla Gioconda Dianti protagonista dell’omonima tragedia alle riflessioni dedicate al genio del «quattrocentista meditativo» e al divino artefice nel Fuoco, in Elettra, in Alcyone… (Gibellini 2018 e 2019). Nell’Uomo che rubò la Gioconda, il sorriso che racchiudeva l’«Infinito», motivo ricorrente nelle pagine dannunziane dedicate a Leonardo, scompare nel momento in cui Monna Lisa prende vita, a segnare il «grande abisso» che la separa dal poeta: sorda e muta di fronte alle sue ansiose interrogazioni, torna a sorridere solo un istante prima di svanire:
Il sorriso misterioso – interrogato nei secoli dai sognatori – si riforma nel viso della Gioconda.
Ella si ricompone nell’attitudine dipinta dal pittore.
Ridiventa simile all’imagine della tavola.
Come il poeta delirante accosta a quel sorriso la sua faccia sconvolta e pone le mani su quella carne insensibile, subitamente la figura si dissolve, scompare.
Il poeta tenta d’inseguirla, di trattenerla, di afferrarla.
Invano.
Il testo assume così il significato di un bilancio e di una riflessione sul rapporto tra arte e vita, e sull’illusione estetizzante che perseguiva la loro perfetta fusione. Ponendo a confronto, nel finale, il vecchio «poeta maniaco» che ha perso tutto con il «giovane poeta capelluto» che sfogliando una rosa recita i versi della Chimera, d’Annunzio sdoppia il suo autoritratto, sancendo da una parte il fallimento di quell’illusione, ribadendo dall’altra il fascino sempre rinascente di un mistero inattingibile e l’adesione alla religione della bellezza: una palinodia e, insieme, la rivendicazione di una lunga fedeltà.
Bibliografia essenziale
Edizioni commentate
Gabriele d’Annunzio, L’uomo che rubò la Gioconda, in Tragedie, sogni e misteri, a cura di Annamaria Andreoli con la collaborazione di Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2013, tomo II, pp. 1435-1462 (testo) e 1734-1741 (notizia sul testo).
Gabriele d’Annunzio, L’uomo che rubò la Gioconda, presentazione di Lucio D’Arcangelo, Chieti, Solfanelli, 2018.
Bibliografia secondaria
Luigi Albertini, I giorni di un liberale. Diari 1907-1923, a cura di Luciano Monzali, Bologna, il Mulino, 2000.
Maurizio Bettini, Il ritratto dell’amante, Torino, Einaudi, 1992.
Gabriele d’Annunzio, Lettere ai Treves, a cura di Gianni Oliva, con la collaborazione di Katia Berardi e Barbara Di Serio, Milano, Garzanti, 1999.
Gabriele d’Annunzio, Notturno, in Prose di ricerca, a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2005, tomo I, pp. 161-395.
Luciano Curreri, Metamorfosi della seduzione. La donna, il corpo malato, la statua in d’Annunzio e dintorni, Pisa, ETS, 2008.
Donatella Dell’Aquilano, D’Annunzio e il leonardismo fin de siècle, «Critica letteraria», 100, 1998, pp. 553-577.
Franco Di Tizio, D’Annunzio e Albertini. Vent’anni di sodalizio, Altino, Ianieri, 2003.
Cecilia Gibellini, Gabriele d’Annunzio e Leonardo da Vinci, in D’Annunzio in Italia e nel mondo a ottant’anni dalla morte, Atti del Convegno internazionale di studi, «Rassegna dannunziana», 72, 2018, pp. 220-234.
Cecilia Gibellini, Il Leonardo apocrifo di Gabriele d’Annunzio, in Leonardo e la scrittura, numero monografico a cura di Cecilia Gibellini, «Rivista di letteratura italiana», 2, 2019, pp. 117-124.
Laura Granatella, L’arte rinascimentale nei Taccuini, in D’Annunzio, la musica e le arti figurative, «Quaderni del Vittoriale», 34-35, luglio-ottobre 1982, pp. 158-159.
David Wark Griffith, Interviews, edited by Anthony Slide, Jackson, University Press of Mississippi, 2012.
Mario Guabello, Raccolta dannunziana. Catalogo ragionato, Biella, Stabilimento Tipografico Ferrara, 1948.
Interviste a d’Annunzio (1895-1938), a cura di Gianni Oliva, con la collaborazione di Maria Paolucci, Lanciano, Carabba, 2002.
Inventario dei manoscritti di d’Annunzio al Vittoriale, «Quaderni del Vittoriale», XXXVI-XXXVII, 1968.
Sandra Migliore, Tra Hermes e Prometeo. Il mito di Leonardo nel Decadentismo europeo, Firenze, Olschki, 1994.
Gianni Oliva, Leonardo e leonardismo nella cultura decadente italiana, «Studi rinascimentali», 8, 2010, pp. 75-82.
Fernanda Palma, Influenze vinciane nel personaggio femminile dannunziano, in I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo, Atti del XVIII congresso dell’ADI, a cura di Guido Baldassarri, Valeria Di Iasio, Giovanni Ferroni, Ester Pietrobon, Roma, Adi editore, 2016.
Pierluigi Pellini, Un topos del fantastico: il quadro animato, «Allegoria», 34-35, 2000, pp. 68-92.
Pierluigi Pellini, Il quadro animato. Tematiche artistiche e letteratura fantastica, Milano, Edizioni dell’Arco, 2001.
Pierluigi Pellini, Il tema del quadro animato nella letteratura del secondo Ottocento, «Belfagor», 56, 2001, pp. 11-33.
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930), Firenze, Sansoni, 1996.
Ricciarda Ricorda, Angelo Conti e il leonardismo di fine secolo, introduzione a Angelo Conti, Leonardo pittore (1910), Padova, Programma, 1990.
Giulio Aristide Sartorio, Il ritorno di Raffaello. Romae Carrus Navalis, a cura di Cecilia Gibellini, Milano, Medusa, 2020.
Bianca Tamassia Mazzarotto, Le arti figurative nell’arte di Gabriele d’Annunzio, Milano, Fratelli Bocca, 1949.
Carlo Vecce, “O divino primitivo”. Leonardo in Campana, in “O poesia tu più non tornerai”. Campana moderno, a cura di Marcello Verdenelli, Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 237-257.
Theodore Ziolkowski, Disenchanted Images. A Literary Iconology, Princeton, Princeton University Press, 1977.