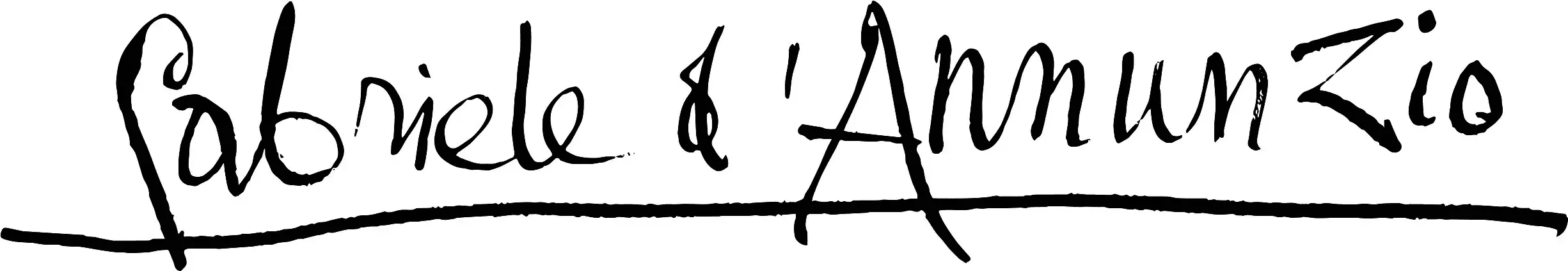di Kenichi Uchida e Yoko Shibue, Enciclopedia dannunziana
I rapporti tra d’Annunzio e il Giappone furono generalmente amichevoli. Nel periodo romano il giovane cronista scrisse vari articoli sul Japonisme, oltre ad alcune novelle e poesie che avevano come tema il Giappone. Compendiò poi tali esperienze nel suo primo romanzo, Il piacere. Dopo il 1900 parlò del Sol Levante soprattutto nell’ambito del nazionalismo e della guerra. In Giappone, invece, nel 1896 fu presentato per la prima volta in un articolo di rivista. Poi le sue opere furono tradotte, attraverso altre lingue europee, da letterati insigni come Bin Ueda e Ōgai Mori. Il Trionfo della morte fu l’opera più fortunata e ispirò perfino un tentato suicidio di coppia (Sōhei Morita e Raichō Hiratsuka). Dopo la seconda guerra mondiale, Yukio Mishima, influenzato presumibilmente dallo stile dannunziano, tradusse Le Martyre de saint Sébastien. In questa voce si parla prima del Giappone per d’Annunzio e poi di d’Annunzio in Giappone.
Il Japonisme del periodo romano
Nell’articolo Esposizione d’arte («Fanfulla della Domenica», 28 gennaio 1883), il giovane cronista d’Annunzio discorre dell’Esposizione romana, sotto forma di una conversazione con una dama: «Parlavamo quasi sempre di arte […] L’arte intanto era da per tutto a torno. Traverso le fioriture di un ombrello giapponese, strana ventola, la luce si diffondeva blandamente nella sala». In quell’epoca il Japonisme si diffonde dalla Francia verso l’Italia e molte case si adornano di giapponeserie, come nell’articolo viene descritto.
Nella favola mondana Mandarina («Capitan Fracassa», 22 giugno 1884), la protagonista marchesa Aurora Canale offre il tè per le cinque del pomeriggio, ogni sabato, in una sala con arredi giapponesi: «Le quattro pareti sparivano intere sotto una luminosa flora giapponese animata d’uccelli […] e da per tutto vasi di Satzuma» (Satsuma, un’antica provincia del Giappone). La stessa marchesa ha una fisionomia mongolica, da cui il nomignolo Mandarina affibbiatole dalle amiche.
Così ella somigliava forse un poco alla principessa Nabeshima, a quella dolce suddita del Mikado [un appellativo dell’imperatore giapponese], che nella volgare ampiezza di una carrozza della Legazione passò tra la selva di Villa Borghese, portando ai poeti un sogno dell’estremo oriente.
Dal punto di vista culturale (non politico) d’Annunzio apprezza il Giappone in modo positivo. Quasi alter ego dell’autore, Mandarina frequenta il negozio di giapponeserie: «Le vetrine della signora Beretta le fornivano ogni sorta di robe preziose, i broccati di Kiyoto [Kyoto], i ventagli di Yokohama». La marchesa, nella solitudine vedovile, tenta un approccio con il cavaliere Sakumi, «quel taciturno indigeno di Yedo» (Edo, il nome antico di Tokyo), che apparirà anche nel romanzo Il piacere. Nella descrizione non dell’ideale attraverso i libri e le cose, ma della realtà di un personaggio, sono accentuate le difficoltà della comunicazione e le barriere linguistiche: «Tra le nuove usanze e le nuove favelle, Sakumi da prima era caduto in uno stupidimento grave […] Ronzavano nel suo cervello, tra le sonorità della lingua nativa, alcune centinaia di parole francesi, confusamente». Cogliendo con un relativismo la tristezza di chi vive all’estero, d’Annunzio menziona anche l’Europa vista dal Giappone:
Il cavalier Sakumi sorrideva tra un balbettamento sconnesso, senza bene intendere. Egli, nato in un paese dove li uomini, benché impudichi, hanno dell’amore un concetto singolarissimo, era rimasto attonito d’innanzi a certe libertà di linguaggio cortese europeo.
Questo passo si basa su La maison d’un artiste (1881) di Edmond de Goncourt, un’importante fonte d’informazioni sul Japonisme, in cui un giovane giapponese indignato, dopo uno sfogo sulla grossolanità di lingua e di espressioni dei francesi, esclama: «Chez nous, ce serait comme si on disait: Madame, je voudrais bien coucher avec vous». A conclusione della favola, a Mandarina da Sakumi d’Annunzio fa pronunciare una tale frase, in Giappone semplicemente impronunciabile.
Circa mezzo anno dopo, d’Annunzio pubblilca su «La Tribuna» il suo primo contributo, Toung-Hoa-Lou, ossia Cronaca del fiore dell’Oriente – Giornate romane (primo dicembre 1884), con lo pseudonimo «Shiun-Sui-Katsu-Kava»: ossia Shunsui Katsukawa (o Miyagawa), pittore di ukiyo-e, citato in La maison d’un artiste. Allora, mentre a Roma prosegue il boom del Japonisme, i rapporti politici italo-giapponesi divengono stretti: «Ieri il nuovo ministro giapponese Fujimaro Tanaka, fu ricevuto da S.M. il Re d’Italia con molta pompa di cerimonie, nella sala del Trono». Il cronista descrive Tanaka come uno straniero privo di dignità originaria, con un tocco di pietà: «Il buon suddito del Mikado […] non portava alla cintola le due sciabole, segno di nobiltà nell’Impero del Sol Levante […]. Egli era tutto umiliato nel nero abito europeo, pur sorridendo d’un infaticabile sorriso». Non gli interessa il Giappone occidentalizzato, ma quello tradizionale ricco d’arte.
Quelli che per pregiudizio ritengono l’arte giapponese come un’arte falsa e fantastica, quelli dovrebbero vedere a che miracoli di verità e di animazione li artefici sanno giungere […] tutto insomma il sacro poema della vegetazione è rappresentato con una immensa pazienza d’amore.
L’arte giapponese, tanto amata e ammirata dal giovane d’Annunzio, sarà una fonte importante per la sua futura opera poetica.
Nello stesso mese esce Donna Claribel – Giornate romane («La Tribuna», 21 dicembre 1884), con la firma «Sir Ch. Vere De Vere». Appassionata del Japonisme, Donna Claribel offre il tè come Mandarina: «Ella è golosa. Il suo five o’ clock tea ha fama di grande squisitezza: servizio giapponese d’argento niellato rappresentante foglie e fiori del loto sacro». L’articolo, nella forma di diari di Claribel, riporta il fervore crescente per il Giappone, che non manca nemmeno nella scena di caccia fuori Roma: «Ma la campagna era meravigliosa di colore. Certe volte pareva che in mezzo a un vapore roseo, tutto roseo come un cielo di ventaglio di Yokohama, nevicassero falde d’oro». Claribel passa dai magazzini della signora Beretta, affollati per gli acquisti di regali di Natale, e pensa: «Intanto domani giungeranno da Yokohama finalmente le stoffe. E domani sera sarà la gran tentazione. Come resistere? / Aiuto! Il Giappone m’ingoia». Claribel, come Mandarina, è quasi un alter ego di d’Annnunzio.
In Piccolo corriere – La vita ovunque («La Tribuna», 19 maggio 1885), il «Duca Minimo» (un altro pseudonimo di d’Annunzio) analizza l’estetica del Giappone descrivendone estesamente l’arte, in specie la pittura: «L’artista dell’estremo Oriente disegna a mano libera, a mano volante, come si dice […]. E sono appunto la sicurezza e la destrezza e la rapidità le virtù più apprezzate nell’estetica giapponese». Considerandola totalmente diversa da quella europea, ne riconosce l’alto valore.
Da qui la ricerca degli aspetti transitorii della natura, dei movimenti vivaci […] da qui l’amore per li uccelli, l’insuperabile sapienza nella rappresentazione dei voli […] da qui la predilezione per tutte le cose fragili e leggere, per i fiori, per le foglie, per i rami capricciosi, per i frutti traforati dai vermi, per le rugiade, per le piume imperlate d’acqua, per le nuvole, pe’ i vapori.
Questa scoperta della delicata sensibilità giapponese verso le creature influenzerà le opere francescane come Le vergini delle rocce e Alcyone.
In Piccolo corriere – La vita ovunque del 7 giugno 1885, il Duca Minimo cita una poesia giapponese come un regalo alle lettrici, alla fine della cronaca mondana: «Per il five o’clock questo fiore di the, dai Poèmes de la Libellule […]. Il fiore d’oggi è della principessa Jssé [Ise, poetessa del nono-decimo secolo]. Ne offriamo uno al giorno alle japonisantes». La poesia di Jssé è posta all’inizio dei Poèmes de la Libellule (1885), una raccolta di antiche poesie giapponesi tradotte in francese da Judith Gautier. Nel Piccolo corriere del 9 giugno ne offre una della «principessa Sikisi», ossia Shikishi, poetessa del dodicesimo-tredicesimo secolo, per la verità non di Sikisi, ma di Sigué-Youki, da Shigeyuki, poeta del decimo secolo. Due giorni dopo ne cita una di Vari-Hira (Narihira, poeta del nono secolo) in giapponese traslitterato in francese. In fine il 14 giugno ne sceglie una del bonzo Nagaié (Nagaie, poeta dell’undicesimo secolo).
Il medesimo 14 giugno, d’Annunzio pubblica anche un saggio Letteratura giapponese su «Cronaca bizantina» e una poesia Outa occidentale su «Fanfulla della Domenica». Il saggio, che occupa dieci pagine dell’edizione dei «Meridiani» Mondadori, tratta principalmente i Poèmes de la Libellule. L’autore esprime prima la sua insoddisfazione per le illustrazioni del pittore giapponese Yamamoto, che vive «da parecchi anni a Parigi», sottolineando le differenze tra l’arte occidentale e quella orientale: «paiono piuttosto imitazioni e contraffazioni che originali opere d’un pittore giapponese». La sua opinione è negativa anche per la traduzione di poesie: «Pur tuttavia a noi pare che la frequenza della rima e il ritmo troppo accentuato tolgono alle outa gran parte del loro aspetto primitivo»; ma apprezza favorevolmente la poesia stessa del Giappone come una cosa del tutto diversa da quella europea:
L’amore così viene espresso dai poeti con una certa ingenuità naturale. Essi compongono i loro versi su concettini infantili per lo più. Rare volte si elevano fino alla passione e al vero dolore. Ma nelle imagini spessissimo raggiungono una grazia spontanea che invano cercheremmo nei nostri petrarcheggianti.
Nel saggio, inoltre, d’Annunzio spiega dettagliatamente cosa sia la outa (da leggersi uta, essendo ou un dittongo francese): «La più elementar forma di poesia giapponese è la strofa di cinque versi, di cui il primo è di cinque piedi, il secondo di sette, il terzo di cinque, e di sette li altri due. In complesso, trentun piede». Componendo Outa occidentale, d’Annunzio tenta di riprodurre in italiano la struttura della outa, cui aggiunge le rime: «Guarda la Luna / tra li alberi fioriti; / e par che inviti / ad amar sotto i miti / incanti ch’ella aduna». Seguono altre undici strofe, l’ultima delle quali non sarà inclusa nella Chimera: «Do questi versi / fragili come fiori / da l’acqua emersi / a te che i fiori adori / io novo Tomonori». Tomonori è un poeta del nono-decimo secolo e un suo outa è collocato all’ultima (ottantottesima) sezione dei Poèmes de la Libellule.
Ne Il piacere (1889) appare di nuovo Sakumi di Mandarina: «Egli pareva un daimio [daimyō, un signore feudale] cavato fuori da una di quelle armature di ferro e di lacca che somiglian gusci di crostacei mostruosi e poi ficcato ne’ panni d’un tavoleggiante occidentale». D’Annunzio è severo verso il Giappone che, nel tentativo di assimilarsi all’Occidente, perde la sua figura propria e tradizionale; ma, attraverso la presenza goffa di Sakumi, vorrebbe contrapporre alla sofisticatezza dell’amore occidentale la purezza di quello giapponese che accetta anche il sacrificio:
Forse egli [Sakumi] pensava: «Dolce cosa far harakiri [suicidio rituale] con quella piccola sciabola [wakizashi] ornata di crisantemi che paion fiorire dalla lacca e dal ferro al tocco delle sue [di Elena] dita!» / Ella non sorrise. Su la sua faccia era disceso un velo di tristezza e quasi di sofferenza.
È questo l’ultimo riferimento importante al Giappone del periodo romano.
Il Japonisme di d’Annunzio inizia con l’interesse per gli arredamenti, passa poi all’estetica raffinata dell’arte pittorica e arriva alla spiritualità primitiva attraverso la letteratura. Queste esperienze si manifestano nelle opere e sopravvivono come una fonte sotterranea della sua arte.
Il Giappone e il nazionalismo dopo il 1900
Circa dieci anni dopo Il piacere, nell’articolo Della coscenza nazionale («Il Giorno», 21 maggio 1900), d’Annunzio fa riferimento al Giappone analizzando la politica mondiale.
Un altro impero immobile, quello del Sol Levante, dà esempio inaudito d’una trasformazione che sembra piuttosto una creazione dal profondo. E qui la virtù e l’orgoglio di stirpe trionfano e divorano insaziabilmente. Coloro i quali vinsero il Figlio del Cielo, oggi aspirano a tutte le conquiste. Essi tendono non soltanto alla signoria dell’Asia ma dell’intero Pacifico. La loro cupidigia guarda alle Filippine, all’Indocina, alle Indie Olandesi, ad Hawai. È nota la parola superba di Okuma [Shigenobu Okuma, primo ministro, 1898, 1914-1916]: «L’Europa è decrepita; noi raccoglieremo la sua eredità».
Vinta la prima guerra sino-giapponese (1894-1895), il Sol Levante diviene una delle principali potenze imperiali.
Sette anni dopo d’Annunzio riutilizza il brano in Giosuè Carducci commemorato da Gabriele d’Annunzio («Corriere della Sera», 25 marzo 1907). Poiché il Giappone ha vinto la guerra russo-giapponese (1904-1905), nel brano, dopo «il Figlio del Cielo», d’Annunzio aggiunge «il Cesare slavo». Inoltre, avendo nell’articolo precedente affermato: «Noi ci crediamo decrepiti», qui, cambiando opinione e confutando la parola di Okuma, afferma: «Ma l’Europa non è decrepita».
Nel 1920 a Fiume, d’Annunzio utilizza il brano ancora una volta nel Saluto all’ospite d’Oriente («La Vedetta d’Italia», 4 febbraio 1920). Lo scrive per l’amico giapponese Haru-Kici Scimoi (Harukichi Shimoi, letterato e soldato), quindi modifica i passi negativi per renderli positivi: da «La loro cupidigia guarda» a «La loro forza guarda». Nell’articolo racconta l’incontro con Scimoi:
Credo di aver raccontato il mio incontro patetico con lui, in un battello veloce e rombante, attraverso la laguna grigia, poco dopo la sciagura di Caporetto. […] Parlavamo d’Italia dolorosa, parlavamo del nostro sacrificio e del nostro sangue, dei giorni disperati e delle speranze invitte. Se ne ricorda Scimoi? / Vidi a un tratto due lacrime vive sgorgare dai suoi sconosciuti occhi di straniero. E subitamente lo riconobbi fratello, come tutti lo riconosciamo qui. E il cuore mi si aperse.
Lo conclude ribadendo l’amicizia personale e nazionale: «Da Fiume d’Italia Porta d’Oriente salutiamo la luce dell’Oriente estremo […]. Beviamo alla fraternità di questo ospite luminoso che ci sa dire come le più belle aurore non sieno ancora nate».
Nella prefazione (datata alla Pasqua del 1919) al libro di Scimoi, La guerra italiana vista da un giapponese, d’Annunzio menziona il Raid Roma-Tokyo:
E io pensavo di venire a cercarvi in Tokio, sorvolando il continente, valicando Turkestan cinese per Samarcanda, e poi per Pekino e per Mukden intraprendendo il mar del Giapppone. […] Non mi avevate fatto un invito magnifico? / Ve ne ricordate? / Io volevo, avendo accolto l’invito, mantenere la promessa, magnificamente.
Poi, il 9 luglio 1919, pronuncia un discorso agli aviatori in Centocelle, che sarà incluso nella raccolta Il sudore di sanguecon il titolo L’ala d’Italia è liberata:
C’è qui qualcuno che si ricordi di quella sera grigia, nel campo di San Pelagio, quando per la prima volta […] io proposi la rotta dell’estremo Oriente? […] Dissi a Natale Palli: «Bisogna che andiamo a Tokio, in dieci o dodici tappe.» / Tutti vibravano, tutti erano pronti.
Non soltanto la voglia di avventura, ma anche la meta finale, il Giappone, avrà grande significato e fascino per loro.
Più tardi, durante la Conferenza di Washington per il disarmo, d’Annunzio cita di nuovo la parola di Okuma in D’Annunzio sees a vision of Commodore Perry warning the United States and world against Japan («New York American», 18 dicembre 1921; «Gazzetta del Popolo», 20 dicembre 1921, con il titolo Il gavitello veglia). D’Annunizo finge di parlare per bocca del Commodoro Perry (Matthew Perry, ammiraglio statunitense):
Pensate quale sforzo debbano fare i rappresentanti della forza gialla a doppio taglio perché i loro meschini abiti europei non sieno gonfiati e schiantati a ogni momento dalla parola superba di Okuma: – L’uomo bianco è decrepito. Noi raccogliamo la sua eredità. –
Cambia «L’Europa» dell’articolo del 1900 in «L’uomo bianco», per includere nel discorso gli Stati Uniti, che crescono nella politica internazionale, e la forma futura «raccoglieremo» in quella presente «raccogliamo», per esprimere la reale occidentalizzazione nipponica. Sempre per bocca di Perry, loda il Giappone pur considerandolo una minaccia: «Il popolo del Sol Levante esce dalle sue angustie insulari […] per presentare a tutte le genti asiatiche oppresse e smunte un esempio perfetto di Stato nazionale fiorito in libertà». Ma d’Annunzio, più poeta che politico, sogna dietro la maschera di Perry: «Ma il suo compito è ancor più vasto e solenne. È quello di fondere, è quello di armonizzare in perpetuo le due civiltà d’Oriente e d’Occidente».
Nel periodo del Vittoriale d’Annunzio sogna il Giappone come Mandarina, la protagonista della favola mondana del periodo romano, scrivendo in un appunto del 21 luglio 1923, incluso in Di me a me stesso: «Nel Giappone, nei dintorni di Kyoto abiterò un vecchio tempio di legno, fra i ciliegi lievi e gli stagni coperti dai fiori di loto e i sorrisi discreti dei bonzi…».
Fino agli ultimi anni di vita, nell’animo di d’Annunzio come negli arredamenti orientali del Vittoriale rimane il Japonisme di mezzo secolo prima. Ne parla in uno scritto datato 30 marzo 1936, A Toshio Kido, incluso in Teneo te Africa:
Mio caro Toshio Kido del Sol Levante, amico di lungi, amore di lungi […]. «Bene venuto, bene ti sia» ti dice il daimio [daimyō, signore feudale] d’Occidente nell’orto suo chiaro […]. Vuoi un haiku? […] Nella mia prima giovinezza, quando la mia ammirazione per le arti del tuo paese era studiosa e ansiosa, io composi alcuni di questi mottetti senza musica con versi di cinque e sette sillabe.
Anche a Fiume d’Annunzio preferisce il Giappone per la presenza di Shimoi, a cui recita haiku: «E mi ricordo che al nostro dilettissimo Shimoi una sera a cena in Fiume espugnata io ne recitai alcuni». Ma la loro relazione, purtroppo, non può essere estranea ai conflitti militari: «Egli, vero samourai [samurai, guerriero feudale] senza le due sciabole, mi abbracciava di tratto in tratto rievocando di contro alla nostra guerra libera le guerre di Daigo [Go-Daigo, imperatore del quattordicesimo secolo]». Nella visione dannunziana del Giappone si fondono l’estetica e la politica imperialisticamente:
Toshio Kido, la tua nazione mi rende il mio amore costante di cinquant’anni. Quel che già da prima io amavo nelle sue arti, […] era la potenza del rilievo, l’energia del segno, l’aspirazione eroica. Più d’una volta allora io ebbi il presagio della sua conquista vittoriosa, della sua vasta volontà nazionale.
L’autore auspica che lo scambio culturale tra i due paesi sia pacifico; in realtà è imminente la seconda guerra mondiale: «Sono io acciaiato. Bisogna che la tua nazione sia acciaiata come questa mia, contro tutto contro tutti e per sempre».
Bin Ueda, precursore dell’introduzione di d’Annunzio
Il nome di d’Annunzio appare nei media giapponesi per la prima volta, secondo le ricerche finora condotte, in un articolo del numero di settembre 1896 della rivista «Taiyō» (Il sole). L’articolo è una libera traduzione da Les Relations entre les poètes et les couleurs («La Revue des Revues», 1o giugno 1896), dove si afferma che a d’Annunzio piace il colore rosso. La fama del poeta italiano raggiunge il Giappone via via che le sue opere vengono tradotte in varie lingue europee.
Il primo a svolgere un ruolo importante nella primissima ricezione di d’Annunzio in Giappone è il letterato e professore Bin Ueda (1874-1916), noto per il suo studio della letteratura europea. Ispirato dall’articolo La renaissance latine di Melchior de Vogüé («La Revue des Deux Mondes», gennaio 1895), Bin elogia lo scrittore italiano nel 1898 su «Teikoku Bungaku» (Letteratura Imperiale), una rivista di letteratura dell’Università Imperiale di Tokyo; poi inizia a tradurre le opere dannunziane dalle traduzioni francesi e inglesi.
La sua raccolta di traduzioni, Miotsukushi (dicembre 1901), comprende Shōrō (Il campanile, traduzione di Campane di Terra vergine) e due brani del Trionfo della morte. Il primo di questi ultimi s’intitola Ennyo monogatari (Racconto della donna affascinante, tratto dal Libro Quinto, II): in cui Giorgio è inaspettatamente baciato da Ippolita sulla spiaggia. La forte sensualità e la fine analisi psicologica di questa scena colpiscono i giovani lettori e scrittori giapponesi. Nel secondo, Gakusei (Il suono della musica, tratto dal Libro Sesto, I), la musica wagneriana è evocata dalle parole: la musicalità nella scrittura è uno dei principali interessi anche per il letterato giapponese.
Nell’ottobre 1905 Bin pubblica Kaichōon (Il suono della marea), un’importante antologia di traduzioni di poesie europee, soprattutto di quelle simboliste francesi. Ciononostante al poeta italiano è riservato un posto d’onore: delle sue quattro opere, due sono collocate all’inizio del libro e altre due alla fine. Nella prima, famosissima Tsubame no uta (Il canto della rondine, dal terzo atto di Francesca da Rimini), il traduttore esprime attraverso la rondine, annunciatrice della primavera, il suo entusiasmo nel trasmettere le ultime tendenze letterarie europee. Nella seconda, Mononone (la melodia vocale, da Gakusei di Miotsukushi), Bin tenta, come Gabriele, di riprodurre la musica di Chopin con le parole. La terza, Suzukake (Il platano, dal Canto del sole, VII del Canto Novo) e la quarta e ultima, Kaikō (La luce del mare, da L’Annunzio delle Laudi) concludono il libro ricordandone il titolo Kaichōon con le immagini del mare e delle onde.
Per presentare d’Annunzio in Giappone, Bin non utilizza i testi originali in italiano (difficili da trovare, all’epoca), ma piuttosto le traduzioni e le riviste in inglese e in francese (per esempio, Francesca da Rimini di Arthur Symons, «Quarterly Review», «Fortnightly Review», ecc.). Inoltre non traduce parola per parola, ma quasi ricrea il testo, rispettando la metrica giapponese. Grazie ai suoi lavori, l’emergente poeta italiano ottiene un favore crescente da parte del pubblico giapponese.
D’Annunzio letto da Ōgai in tedesco
Ōgai Mori (1862-1922), medico militare e letterato, che studia nell’Impero tedesco dall’ottobre 1884 al luglio 1888, si informa sulle letterature europee attraverso i media tedeschi e ne riporta le notizie in Giappone. Si interessa naturalmente anche a d’Annunzio, suo contemporaneo, e ne legge i romanzi e i drammi in traduzione tedesca.
Nel luglio 1903, sulla rivista «Tōyō Gahō» (Rivista illustrata dell’Oriente), riassume la trama del Sogno d’un mattino di primavera e del Sogno di un tramonto d’autunno (pubblicati da Fischer), e di quest’ultimo pubblica la traduzione nel 1909 sulla rivista «Kabuki». Nell’ottobre 1903, sulla rivista «Myōjō» (Stella lucente), parlando del doppio suicidio amoroso, menziona il Trionfo della morte.
Nel gennaio 1904, su «Mannen gusa» (Piantine millenarie), la rivista letteraria fondata da Ōgai insieme a Bin, prende in esame i drammi dannunziani (La Gioconda, La Gloria e La Città morta) e afferma acutamente: «D’Annunzio sembra piuttosto adatto a fare il romanziere che il drammaturgo». Sulla stessa rivista, a marzo, commenta Il fuoco, ben informato anche sulla relazione amorosa tra il poeta e Eleonora Duse.
Nel marzo 1909, sulla rivista letteraria «Subaru» (Le Pleiadi), Ōgai avvia Mukudori Tsūshin (Notizie dello storno), la rubrica di informazioni estere. Utilizzando come fonte il quotidiano tedesco «Berliner Tageblatt» (spedito attraverso la Siberia), riporta spesso notizie su d’Annunzio, oltre ad altre su Goethe, Wagner, Tolstoj, Strindberg, Hauptmann, Wedekind… La rubrica, famosa per essere stata la prima in Giappone a trattare il Manifesto del Futurismo del febbraio 1909, si occupa di varie curiosità, come il caso del giugno 1909 in cui d’Annunzio è convocato nel tribunale di Siena per eccesso di velocità in automobile.
Nel maggio 1910, Ōgai parla della traduzione tedesca di Forse che sì forse che no (uscito in Italia nel febbraio precedente). Il letterato giapponese, avendo un forte interesse per gli aerei come d’Annunzio, scrive della prima traversata aerea della Manica compiuta da Louis Blériot nel luglio 1909, ma purtroppo non del primo volo compiuto dal poeta italiano a Brescia due mesi dopo.
Ōgai continua a seguire le vicende dannunziane (ad esempio, l’esilio volontario in Francia, la vendita all’asta fatta alla Capponcina, la rappresentazione de Le Martyre de Saint Sébastien e così via) fino a quando la rubrica chiude nel 1914, a causa della Prima guerra mondiale. Finita la guerra, nel 1919 il poeta soldato progetta il raid Roma-Tokyo, che poi realizzeranno i compagni Arturo Ferrarin e Guido Masiero: se l’avesse compiuto d’Annunzio stesso, sarebbe stato accolto a Tokyo degnamente da Ōgai, allora Direttore dell’Accademia Imperiale d’arte.
L’influenza del Trionfo della Morte sugli scrittori giapponesi
D’Annunzio, che assorbe e ricrea mirabilmente la letteratura fin de siècle, è accolto dagli scrittori giapponesi con grande curiosità ed entusiasmo. Il Trionfo della Morte, tradotto da Bin seppur parzialemente, per le frasi d’amore e le scene dei baci ha un enorme impatto sui giovani scrittori, soprattutto su Sōhei Morita (1881-1949) e Chōkō Ikuta (1882-1936).
Chōkō, laureatosi all’Università Imperiale di Tokyo nel 1906, insegna in una scuola d’inglese per donne e crea come attività extra-curricolare un’associazione letteraria femminile. Il suo amico d’università, Sōhei, allora insegnante di scuola media, vi tiene lezioni, e conosce Haru Hiratsuka, più nota con il nome d’arte di Raichō (1886-1971).
Nel gennaio 1908, Haru pubblica una novella sulla rivista dell’associazione e Sōhei esprime per lettera il suo parere. Questi, un romantico affascinato da d’Annunzio, vede in lei una femme fatale, e quella, una praticante dello Zen, nutre dubbi sullo stile di vita tradizionale. I due, travolti da eros e thanatos, decidono di morire insieme come nell’ultima scena di Trionfo della Morte (a differenza della coppia giapponese, la coppia del romanzo, Giorgio ed Ippolita, non si trova d’accordo): il 22 marzo 1908, Sōhei e Haru, portando un pugnale, si recano in treno a Shiobara (a circa 150 km da Tokyo) e il giorno dopo, attraversando un passo di montagna sotto la neve, abbandonano il loro proposito e vengono infine ritrovati dalla squadra di ricerca.
Questo tentato doppio suicidio d’amore desta un enorme scandalo e Sōseki Natsume (1867-1916), maestro di Sōhei e autorevole romanziere, incoraggia il suo discepolo a scrivere un romanzo sull’accaduto. Grazie alla mediazione di Sōseki, il romanzo Baien (La fuliggine) è pubblicato a puntate sul quotidiano «Tokyo Asahi» da gennaio a maggio 1909. L’autore utilizza vari motivi tratti da Trionfo della Morte: il ritorno alla città natale, il declino della sua famiglia, l’incontro con la femme fatale nella capitale, l’intensa relazione amorosa con lei e il doppio suicidio d’amore. Nel romanzo il protagonista presta alla sua amata addirittura la traduzione di Trionfo della morte, prima in inglese e poi in tedesco. In seguito, in realtà, Sōhei traduce Il piacere nel 1914 e L’innocente nel 1917, basandosi sulla traduzione in inglese e in tedesco.
Quando Baien è pubblicato come libro, diviso in quattro volumi per eludere la censura sempre più severa, Ōgai e Sōseki contribuiscono con le prefazioni al primo volume. Ōgai scrive una breve opera teatrale intitolata Kage to katachi(Ombre e forme), continuando la trama di Trionfo della morte. Nella scena finale del romanzo dannunziano Giorgio e Ippolita precipitano dal promontorio di San Vito nella morte avvinti. Nella pièce di Ōgai i due, ormai ombre, si ritrovano sullo stesso promontorio e conversano tra il rumore del mare e della maciulla su l’aia. Giorgio domanda scusa a Ippolita per averla trascinata con sé nell’abisso e le dice: «Tu sei una donna, una forza irresistibile». A un certo punto Ippolita propone: «Mi piacerebbe rinascere come essere umano. […] Che tipo di paese è il Giappone?». Giorgio le risponde: «Potrebbero soffiare venti di decadenza, ma dovrebbe rimanere ancora gran parte della genuinità primitiva della sua terra». I due promettono quindi di rivedersi in Giappone e si reincarnano infatti in una giovane coppia giapponese: i protagonisti di Baien. Questa operetta significativa sarà tradotta da Harukichi Shimoi per il primo numero di rivista «Sakura» (Il ciliegio) nel giugno 1920.
Sōseki invece scrive una nota saggistica con un atteggiamento distaccato. Dopo lo scandalo del suo discepolo legge il Trionfo della morte e Il piacere in inglese e rimane critico verso l’eccessiva sensualità delle opere dannunziane. Tuttavia, lo stesso Sōseki assimila dal romanziere italiano diversi elementi, per poi svilupparli in modo autonomo. Per esempio in Sorekara (E poi), il celebre romanzo d’appendice di Sōseki che appare sul giornale «Asahi» dopo Baien da maggio a ottobre 1909, il protagonista è un intellettuale con un’acuta sensibilità di stampo dannunziano.
Prima di Sorekara, in un altro romanzo d’appendice sull’«Asahi» da settembre a dicembre 1908, Sanshirō (1908), Sōseki descrive una donna enigmatica che attrae il protagonista Sanshirō. La sua modella è Haru, che l’autore non conosce direttamente, ma di cui sente parlare da Sōhei. Nel 1911, la pioniera del femminismo giapponese Haru, ormai con il nome d’arte Raichō, fonda la rivista letteraria femminile «Seitō» (Le calze blu), pubblicando sul primo numero il manifesto Genshi josei wa taiyō de atta (In età primitiva la donna era il sole). Nel 1912, Chōkō, che ha incoraggiato Haru a fondare la rivista, pubblica la prima traduzione completa del Trionfo della Morte. Il suo amico Toshio Kido, che l’aiuta a consultare il testo originale in italiano, riceverà una lettera (poi inclusa in Teneo te Africa) da d’Annunzio nel 1936. Tradotto più volte anche dopo la seconda guerra mondiale, il terzo dei romanzi della rosa avrà un’enorme influenza sugli scrittori giapponesi.
Altri scrittori giapponesi fino a Mishima
Tekkan Yosano (1873-1935), marito della poetessa Akiko Yosano (1878-1942) ed editore della rivista «Myōjō», su cui è pubblicato Il canto della rondine (Francesca da Rimini) tradotto da Bin nel gennaio 1905 prima di essere incluso nel volume, ha la fortuna di soggiornare in Francia dal 1911 al 1913. A Parigi traduce dal francese in giapponese più di cento poesie recenti, tra cui dodici dannunziane tratte dalla raccolta Poésies, 1878-1893 (tradotta da Georges Hérelle e uscita nel 1912); dopo il suo ritorno in Giappone, le pubblica nel 1914 con il titolo Rira no hana (Fiori di lillà).
Tōson Shimazaki (1872-1943), poeta e romanziere di grande fama e ammiratore delle opere dannunziane, soggiorna a Parigi dal maggio 1913 fino all’aprile dell’anno successivo. Nel giugno 1913, al Théâtre du Châtelet, assiste alla rappresentazione de La Pisanelle, ou la mort parfumée interpretata da Ida Rubinstein. Insieme a lui, c’è il drammaturgo innovatore Kaoru Osanai (1881-1928), che viaggia in Russia e in Europa per lo studio del teatro. Dopo il suo ritorno in Giappone, mette in scena nel 1918 un adattamento di Sogno d’un mattino di primavera, con il titolo Midori no asa (Il mattino verde).
Quando Tōson va al concerto di Debussy presso il Théâtre des Champs-Élysées, lo accompagna Torahiko Kōri (1890-1924), giovane scrittore e drammaturgo profondamente influenzato da d’Annunzio. Nel 1913, abbandonati gli studi della letteratura inglese all’Università Impariale di Tokyo, si trasferisce in Europa e nel 1915, mentre è in viaggio a Roma, vede d’Annunzio, oratore di guerra, acclamato dalla folla.
Yukio Mishima (1925-1970), definito da alcuni letterati del tempo come la reincarnazione di Kōri, frequenta la stessa scuola dei nobili, Gakushūin, e ama gli stessi scrittori: d’Annunzio, Wilde e Hofmannsthal. Nel 1966 pubblica la traduzione del Martyre de saint Sébastien in collaborazione con lo studioso di letteratura francese Kōtaro Ikeda, tacendo però sulla relazione con l’autore nella postfazione del libro. Nella sua ultima opera, Hōjō no umi (Il mare della fertilità), descrive la scena di un bacio dei protagonisti in carrozza sotto la neve, considerata la più bella della letteratura giapponese moderna, scritta sotto l’influenza dannunziana.
Del dannunzianesimo di Mishima discute Yasutaka Tsutsui (1934-), scrittore polivalente, nel saggio del 1989 Dannuntsio ni muchū (Affascinato da d’Annunzio). Prendendo il titolo da questo saggio, Mariko Muramatsu, insigne italianista presso l’Università di Tokyo, organizza la mostra sul rapporto tra d’Annunzio e il Giappone Dannuntsio ni muchū datta koro (Quando si era affascinati da d’Annunzio) nel centocinquantesimo anniversario della nascita del poeta, a Tokyo (2013) e a Kyoto (2014). Anche di recente d’Annunzio viene ricordato spesso da studiosi, cultori e cantanti lirici in Giappone, ma non in modo tanto speciale come nell’era Taishō (1912-1926), in cui Arturo Ferrarin (1895-1941) compie il Raid Roma-Tokyo ideato da d’Annunzio (1920) e testimonia nel suo libro Voli per il mondo:
Ma la più bella nota d’italianità era data dalle librerie, ove così spesso apparivano le opere di D’Annunzio tradotte in giapponese da farci convinti che il Comandante fosse l’autore prediletto fra le classi intellettuali del paese. (Ferrarin 1929, p. 94)

D’Annunzio sul quotidiano giapponese «Tokyo Asahi» del 21 maggio 1920, tra le notizie estere, con la didascalia: «Una recente immagine del signor d’Annunzio».
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Gabriele d’Annunzio, Di me a me stesso, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 1990.
Gabriele d’Annunzio, Prose di ricerca, a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, 2 voll., Milano, Mondadori, 2005.
Gabriele d’Annunzio, Prose di romanzi, I, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 2005.
Gabriele d’Annunzio, Scritti giornalistici 1882-1888, I, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 1996.
Gabriele d’Annunzio, Scritti giornalistici 1889-1938, II, a cura di Annamaria Andreoli, Milano, Mondadori, 2003.
Gabriele d’Annunzio, Tutte le novelle, a cura di Annamaria Andreoli e Marina De Marco, Milano, Mondadori, 1992.
Arturo Ferrarin, Voli per il mondo, Milano, Mondadori, 1929 (ristampa 1942).
Harukichi Scimoi (Shimoi), La guerra italiana vista da un giapponese, Napoli, Libreria della Diana, 1919.
Harukichi Shimoi, Un samurai a Fiume, a cura di Guido Andrea Pautasso, Milano, Oaks, 2019.
Bibliografia secondaria
Marisa Di Russo, Harukichi Shimoi, il giapponese amico di D’Annunzio, «Rassegna Dannunziana», XV, dicembre 1998, 34, pp. XXVII-XXXII.
Hideyuki Doi, Interlinee. Studi comparati e oltre, Firenze, Franco Cesati («Strumenti di letteratura italiana», 99), 2021, soprattutto i capitoli 4. Harukichi Shimoi e l’avanguardia napoletana, pp. 47-58; 10. Ōgai Mori e Gabriele D’Annunzio: interscambi letterari nel primo Novecento giapponese, pp. 133-136; 11. Mishima tra i letterati italiani: Moravia, D’Annunzio, Pasolini, pp. 137-145.
Joji Hirayama, Danuntsio to Nihon Kindai Bungaku [D’Annunzio e la lettaratura giapponese moderna], Tokyo, Shiron sha, 2011, 620 pp.
Reto Hofmann, The Fascist Effect. Japan and Italy, 1915-1952, Ithaca – London, Cornell University Press, 2015, soprattutto il capitolo 1. Mediator of Fascism: Shimoi Harukichi, 1915-1928, pp. 8-37.
Paolo Lagazzi, La seduzione della leggerezza. Tre sguardi eccentrici su D’Annunzio, Pescara, Edizioni Mondo Nuovo, 2023, soprattutto il capitolo Giappone, Japonisme e altri Orienti, pp. 29-86.
Carlo Leo, Japonaiserie nella cronaca mondana dannunziana al vaglio delle fonti francesi, Tentati di morire… e di vivere: moderni barbari, esteti armati, indomabili, fratelli separati, camaleonti, a cura di Luciano Curreri, Luca Di Gregorio, Frédéric Saenen, Cuneo, Nerosubianco («le bandiere», 21), 2019, 70-115.
Carlo Leo, Gabriele d’Annunzio orientalista. Intertestualità nella novella “Mandarina”, «Interface. Journal of European Languages and Literatures», 2020, 12, pp. 55-82.
Carlo Leo, Harukichi Shimoi a Vittorio Veneto. Un giapponese amante dell’Italia, Punti di incrocio, di attenzione, di briga e d’affetto. Lettere ai tempi di conflitti e di guerre nel Novecento, a cura di Elisabeth Kertesz-Vial, Isabella von Treskow, Firenze, Franco Cesati («Civiltà italiana», 33), 2020, pp. 37-46.
Niva Lorenzini, Giapponeserie e giapponismo alla prova della poesia: D’Annunzio, Govoni, Saba, Elpidio Jenco e la cultura del primo novecento, a cura di Mirko Lami, Viareggio, Pezzini, pp. 13-23.
Mario G. Losano, Le tre costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle costituzioni di Giappone, Italia e Germania, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History («Global Perspectives on Legal History», 14), 2020, soprattutto il capitolo I. 1. b) L’Italia in Giappone e il Giappone in Italia: D’Annunzio e il “fratello samurai” Shimoi Harukichi, pp. 17-26.
Felicita Valeria Merlino, Il giapponismo letterario in Italia. Il caso D’Annunzio, Italia – Giappone 450 anni, Roma – Napoli, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, a cura di Adolfo Tamburello, 2003, pp. 365-369.
Felicita Valeria Merlino, Il sodalizio Shimoi – D’Annunzio, Italia – Giappone 450 anni, Roma – Napoli, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, a cura di Adolfo Tamburello, 2003, pp. 387-391.
Mariko Muramatsu, Il buon suddito del Mikado. D’Annunzio japonisant, Milano, Archinto, 1996.
Mariko Muramatsu, Segni e voci dalla letteratura italiana. Da Dante a D’Annunzio, Tokyo, UTCP, 2012, soprattutto i capitoli 4. Outa occidentale di Gabriele D’Annunzio, ovvero quando la metrica giapponese plasma la poesia italiana, pp. 83-93; 5. La fortuna dannunziana nel Giappone del primo Novecento. Studi dei documenti giapponesi nell’Archivio del Vittoriale degli Italiani, pp. 95-120; 6. Il corpo e la letteratura in D’Annunzio e Mishima, pp. 121-141.
Mariko Muramatsu, D’Annunzio in Giappone, Gabriele d’Annunzio 150. “Vivo, scrivo.”, Milano, SilvanaEditoriale («L’Officina del Vittoriale», 4), 2014, pp. 183-191.
Yukiko Ozaki, Poèmes de la libellule e d’Annunzio: Nuovi documenti di Outa occidentale, «Rassegna dannunziana», XXIX, dicembre 2011, 59/60, pp. III-X.
Patrizia Paradisi, D’Annunzio “myrionymo”: metamorfosi onomastiche da Floro Bruzio ad Angelo Cocles, «il Nome nel testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria», XX, 2018, pp. 335-369.
Elena Segnini, Michael Subialka, Gabriele D’Annunzio and World Literature. Multilingualism, translation, reception, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2023, soprattutto i capitoli 2. Mariko Muramatsu, D’Annunzio and Japonism, pp. 48-66; 9. Noriko Hiraishi, Fin-de-Meiji as Fin-de-siècle: D’Annunzio and Japanese Literature, pp. 201-220; 17. Ikuho Amano, Infatuated with Il Vate: Mishima’s Transnational Mimesis of D’Annunzio as Decadent Poet, Patriot and Celebrity, pp. 330-344.