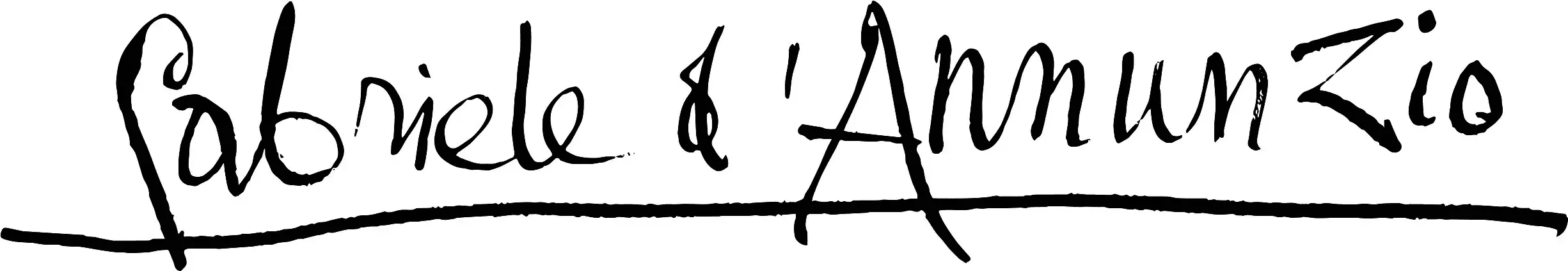di Davide Chindamo, Enciclopedia dannunziana
Gabriele d’Annunzio e il «parente» Michelangelo
Per comprendere la devozione che Gabriele d’Annunzio nutre nei confronti di Michelangelo, è utile rievocare un aneddoto. Quando nel 1910 è costretto all’esilio, direzione Arcachon, il Vate porta con sé i manoscritti autografi, le amate automobili e la copia dello Schiavo morente. Non si tratta soltanto di simbiosi con l’oggetto artistico in quanto tale, bensì del bisogno fisiologico di avere con sé una reminiscenza michelangiolesca, a mo’ di reliquia. La conferma di questa fede traspare dagli innumerevoli riferimenti all’artista nei testi del Vate, in poesia e prosa, in cui si celebra lo spirito del «creatore titanico» (d’Annunzio, Voci della riscossa). Michelangelo diventa suo «parente», un antenato ideale che ha influenzato la sua personalità. Il poeta muove i suoi passi seguendo le orme del Buonarroti, incoronato come guida; un ‘Virgilio’ distante nel tempo e nello spazio, spiritualmente accanto a lui, che con autorevolezza e credibilità anticipa ciò che d’Annunzio ambisce a diventare. Grazie ad una fotografia di Emilio Sommariva (conservata nella Biblioteca Nazionale Braidense di Milano) che immortala il manoscritto datato, sappiamo che nel 1924 Gabriele ha avviato la stesura della Buonarrota, un romanzo mai portato a termine. E da un sonetto incompleto pensato per quest’opera, oggi nel suo Archivio personale al Vittoriale, si ritrova il riferimento alla «parentela» ideale, ottenuta dagli «spiriti» bevuti dal «petto» materno:
“Arso e poi spento aver più vita aspetto
da fiamma che m’è dentro rinascente”.
Disse, o madre, colui che m’è parente
per gli spirti ch’io bevvi dal tuo petto.
Anche nelle lettere ad Olga Ossani, la Elena Muti del Piacere, si legge (Virelli, p. 92):
Posso dire come il mio Parente: “Non ho amici e non ne voglio”. Basta.
D’Annunzio rivede nel «parente» Buonarroti la sua stessa tensione, non essendo mai pago di ciò che crea; riconosce la medesima fatica, utile per nobilitare l’arte; scorge il proprio desiderio di placare un animo tormentato, affamato da ciò che non si vede ma che si vorrebbe ottenere; e condivide un modus operandi «proiettato verso il gesto eroico e puro» (Gibellini, L’arcangelo senza aureola, p. 19), verso la dimensione divina a cui egli tende. Così Michelangelo «diviene l’artifex eccelso: e tale rimarrà» (Gibellini, D’Annunzio paesista, p. 120). La sua anima titanica rivive nei testi dannunziani, come nel passo del Libro segreto (p. 1782):
Mi sovrasta il pensiero di Michelangelo, e quell’emistichio nella memoria vòlto alla mia significazione: “arder senza morte”.
La citazione michelangiolesca ricorda l’esclamazione dannunziana «vivere ardendo e non bruciarsi mai». Arder senza morte sono parole contenute nel verso finale del madrigale Spargendo gran bellezza ardente foco di Michelangelo. Protagonista assoluta è una «gran bellezza» che sparge «ardente fuoco», la quale genera amore, ma che «calcina» il cuore dell’artista come farebbe con il «sasso dur», al punto da renderlo «arso nelle parti interne». Tuttavia, Michelangelo desidera questo metaforico incendio, e accoglie altrettanto favorevolmente le conseguenti lacrime utili a spegnerlo. Poiché è molto meglio bruciare e poi morire per un amore distruttivo, piuttosto che «arder senza morte», in un fuoco che non ha fine. E l’analogia tra i due artisti sta proprio nell’accettare questo «fuoco», metafora della passione amorosa: molto meglio, scrive Michelangelo, un incendio che porta alla rovina, piuttosto che un sentimento che solletica il cuore ma non lo travolge, che «arde senza morte». Da qui, l’espressione dannunziana «vivere ardendo e non bruciarsi mai». Sembrerà paradossale, ma solo nelle fiamme ci si può dire vivi: la vera ustione è accettare che le «lacrime etterne» leniscano ustioni superficiali. E la morte non è nulla se è stato l’incendio a generarla.
La presenza del Buonarroti nelle opere dannunziane
Nei testi dannunziani, Michelangelo è il secondo elemento di paragone quando si tratta di titanismo, potenza, forza; ogni riflessione riguardante l’irraggiungibile, l’ideale, il sovrumano è un dialogo costante con la vita e la produzione michelangiolesca. Il riferimento più celebre svetta nel Piacere, quando Andrea Sperelli confessa «il suo gran sogno», che è «possedere un palazzo incoronato da Michelangelo» e diventare «Principe romano». Nel Trionfo della morte, «i cipressi michelangioleschi torti e dilaniati nel chiostro delle Terme di Diocleziano» evocano ancora una volta quella «infinita tristezza della meditazione solitaria» del «divino Michelangelo»; mentre nel Forse che sì forse che no, Ippolita Sanzio è «così elastica e così lasciva» che appare simile alle «grandi creature di Michelangelo».
In particolare, il «titano» Buonarroti si palesa quando d’Annunzio intraprende una sorta di catabasi poetica nel Notturno. Il poeta trascrive un sogno in cui gli è apparso lo scultore Vincenzo Gemito. Anatomicamente gli ricorda il Buonarroti della Sistina, e rinnova tutta la sua ammirazione per un uomo sfinito e spolpato dal lavoro. Un uomo malridotto e claudicante, ma fedele e devoto alla sua natura, che è quella dell’artista. Non a caso, d’Annunzio scrive di una barba «di profeta impazzito», di un «corpo esile e curvo» sorretto da «gambe rotte dalla fatica», ma soprattutto riconosce la «resistenza invitta». Michelangelo compare anche nel racconto del giorno di Pasqua, il 23 aprile del 1916. Il poeta osserva una copia del disegno della Resurrezione (1525 ca., Windsor Royal Collection, Londra) e coglie la tenacia di Cristo nello sforzare il masso del sepolcro. Lo ammira e lo invidia, e si interroga sulla forza del proprio cuore, incapace di sciogliere le catene del suo talamo. Fino a quel momento definitosi «parente» del Buonarroti, si domanda se il suo cuore sia «abbastanza precipitoso» come quello del Cristo, proiezione di Michelangelo, strumento necessario per vincere i limiti imposti dalla malattia.
Passando in rassegna le pagine del Libro segreto, si legge (p. 1682):
Giurami allora su questo mucchio di fogli intatti dove la tua opera vive come la statua nel masso informe di Michelangelo.
Questo potente giuramento deriva dai ricordi di d’Annunzio. Il poeta alloggia al Convento di Francavilla al Mare in Abruzzo, del pittore e amico Francesco Paolo Michetti. In questa «cella penosa» ha già scritto le pagine del Piacere e dell’Innocente, e intorno al 1893 si sta cimentando nella stesura di un nuovo romanzo; tuttavia, è imbrigliato in una impasse creativa, poiché attanagliato dalla mancanza di Barbara Leoni. Dopo essersi confidato con Michetti, il pittore gli impone un giuramento: se non si fosse più fatto del male, dato che in quei giorni «cozza con il muro» e ha «le dita spellate», gli avrebbe «condotto la sua donna» e gliel’avrebbe data «libera nelle mani». Di lì a poco, sarebbero nati i primi capitoli del Trionfo della morte e Barbara Leoni lo avrebbe ispirato per la protagonista Ippolita Sanzio. «Il mucchio di fogli intatti», su cui d’Annunzio avrebbe dovuto giurare, contiene il romanzo proprio come il sasso per Michelangelo “imprigiona” la scultura, già esistente al suo interno.
Ne Il sorriso d’Italia, dalle Faville del maglio, d’Annunzio si chiede (p. 476): «Chi ha detto che il Buonarroto non conobbe se non mammelle di pietra?». La domanda del poeta sorge dall’incredulità: per trasferire una componente così erotica, così carnale, nella sua scultura, Michelangelo deve averla sperimentata; pertanto, non si è limitato ad un’educazione artistica di pura idealizzazione. Infatti, «l’Aurora è una mole di sensualità e tragica e insaziabile» (Lo splendore della sensualità, p. 1418): questo rende Michelangelo non solo esperto di marmi e di scalpelli, ma anche della più profonda palpitazione dell’animo. L’immagine tenera e lasciva della mammella riemerge in un ricordo molto significativo per il poeta, riportato nel Libro segreto. Gli sovviene alla memoria un emistichio di Michelangelo e si interroga da quale sonetto sia tratto, probabilmente da un testo «rinvenuto in Vaticano»; successivamente, continuando la sua elucubrazione, «passando attraverso il borgo di Settignano», si ricorda di un altro madrigale (p. 1782):
un altro madrigale di quel medesimo che non conobbe se non le mammelle di pietra dell’Aurora, ecco, mi figura la mia mutazione inebriante:
“Tanto sopra me stesso
mi fai, donna, salire
che, non che ‘l possa dire,
no ‘l so pensar; perch’io non son più desso”.
Nemmeno nelle Laudi il «parente» viene dimenticato. Nella Laus vitae si legge una sezione dal titolo Saluto al Maestro. Il «Maestro» è Giosue Carducci; essendo lui nato a Valdicastello in Pietrasanta, d’Annunzio lo paragona alla «terra natale», la medesima in cui «ruggì» Michelangelo con i suoi lavori. Questi luoghi, cari a d’Annunzio, si fanno inviolabili ed entrano di diritto nel tempo (pp. 243-244):
E io dissi: «Padre, il tuo grande
aspetto è come la terra
natale, tra l’Alpe di Luni
ove il Buonarroto ancor rugge
e il Tirreno Mar navigato
dalle prue dei Mille in eterno.
In Elettra è contenuta l’ode Per la morte di Giuseppe Verdi, avvenuta a Milano il 27 gennaio 1901. D’Annunzio si immagina che la salma del compositore sia stata vegliata da Dante, Leonardo e ovviamente dal «ferreo Michelangelo». Il Buonarroti ha generato «imperituri figli» sotto forma di «duri massi»: un esempio sono «i ribelli eroi / silenziosi», probabilmente i Prigioni, che nella loro ineluttabilità dichiarano che il «Destino è vinto».
Nella poesia Le madri, contenuta in Alcyone, Michelangelo viene citato per esaltare l’ispirazione artistica e il ruolo maieutico dell’artista. D’Annunzio incentra tutta la poesia, composta da due lunghe strofe di versi liberi, su una semplice analogia: le «cavalle feconde coi gravidi fianchi» sono paragonate alle Alpi Apuane, entrambe in procinto di dare alla luce una creatura; nel caso delle giumente, sarà la natura a fare il suo corso, mentre nel caso dell’«Alpe di Carrara» sarà l’artista a trarne fuori la più nobile prole. Per questa motivazione si cita Michelangelo: secondo lo scultore, l’opera è già «imprigionata» nella materia e l’unico compito è quello di rimuovere il marmo in eccesso, così da dare alla luce il soggetto primigenio. Infatti «attendono in pace / la genitura / le madri». L’ispirazione giunge come una nave gravida di «marmi», ovvero le future statue, che sono «sogni dormenti nel profondo». Infine, nel Commiato, poesia posta a chiusura di Alcyone, si legge di una corona di alloro con la quale d’Annunzio omaggia Pascoli. Questo serto proviene da ulivi toscani, originari della costa versiliese in cui si allestisce la crematura del corpo di Shelley, che è la medesima area in cui Michelangelo preleva il marmo per le sue opere: come nel caso della Pietrasanta carducciana, nobilitata dal passaggio del Buonarroti, le terre di Viareggio sono ancora più degne di lode poiché calcate da Michelangelo e dai suoi «furori» (p. 641):
Fatta è d’un ramo tenue che crebbe
tra l’Alpe e il Mare, ov’ebbe il Cuor de’ cuori
selvaggio rogo e il Buonarroti v’ebbe
i suoi furori.
Tra i tanti riferimenti nel Libro ascetico, d’Annunzio si chiede anche chi abbia avuto l’onore di conoscere realmente il «sorriso di Michelangelo», un «sorriso profondo, terribilità annidata negli angoli delle labbra». Per via negationis, implicitamente si intuisce che l’unico ad averlo compreso è lui (Il sorriso d’Italia, p. 476):
Chi conobbe e comprese il sorriso di Michelangelo, lampeggiante in quella sua barba di capro? Non Giorgio Vasari. Non Vittoria Colonna. Non Tommaso dei Cavalieri.
Infine, nella Passione di Michelangelo, un’altra pagina delle Faville, il Vate si immerge nel 1530, annus horribilis per il Buonarroti. Per evitare il linciaggio, Michelangelo è costretto a rifugiarsi prima in una piccola stanza sotto al campanile della chiesa di San Niccolò a Firenze; poi in una cappella della Basilica di San Lorenzo, dove, nel frattempo, traccia sulle pareti dei disegni meravigliosi riconducibili ad alcune sue opere. Lui, neo-repubblicano, infatuato dalle teorie di Savonarola, contribuisce alla cacciata di quegli stessi Medici che prima lo hanno cresciuto, protetto, e che in quella circostanza lo vogliono morto. In città imperversa la guerra civile tra i sostenitori della Repubblica e l’esercito imperiale-papale, collaudato da Carlo V e papa Clemente VII per il ripristino della Signoria. E Gabriele, consapevole dell’agonia di Michelangelo, assorbe la tragedia di quell’uomo «decrepito e infermo» e lo compatisce come un figlio (pp. 1409-1412):
Rasentai San Nicolò dove forse nella Torre era ancor nascosto Michelagnolo, ripiegato e contratto sul suo cruccio e su la sua onta più disperatamente che quando discendeva dalle impalcature della Sistina rotto e si gettava nello strame di bestia egli dio, senza togliersi gli stivali, forati in ambe le tomaie dal soperchio delle unghie inselvatichite e adunche. Mi parve che un tratto il petto mi s’incavasse. come a lui quando nel suo travaglio di cielo e d’inferno ei se lo sentiva appiccato sotto ‘l mento. Mi s’incavò il petto; e mi si riempì di un dolore che mi mostrava l’incendio meridiano del sole come un supplizio da patire con gli occhi fissi. […] Ma il Buonarroto avea potuto consentire a salvar quanto in lui era divino e inimitabile con un’azione fiacca, con una rinnegazione vile. Avea dovuto piangere il pianto del gallicinio, il più amaro de’ pianti annunziato dal secondo canto del gallo. Soffrivo per lui, mi disperavo per lui; non potevo andare più oltre. […] Mi sarei strappato gli occhi piuttosto che assistere all’uscita di Michelangelo dal suo nascondiglio. E tuttavia li chiudevo, gli occhi, per cercar di scoprire nel mio buio rosseggiante il volto del creatore umiliato.
E la sua vicinanza, di gran lunga superiore alla comune empatia, deflagra nella Favilla intitolata Lo splendore della sensualità (p. 1418):
Addossato alla torre di San Niccolò, non ho io sofferto pel Buonarroti come altri soffre per Gesù, come altri è segnato dalle stimate di Cristo? Mi bisogna ancóra ripiegarmi su questo mistero. In quel tempo a Michelangelo la vita era supplizio titanico, era umiliazione sanguinolente. Di continuo egli sanguinava sotto la tirannia della menzogna. E la sua vita era casta, la sua disciplina era quasi monacale. Ora bisogna ch’io guardi bene a dentro, bisogna che io veda.
Non ci sono dubbi. Se d’Annunzio avesse saputo che in quella cripta, sotto San Lorenzo, o in quel pertugio a San Niccolò, ci fosse stato Michelangelo, avrebbe sfidato perfino il papa. Lui non lo avrebbe tradito, ma capito, perché la sofferenza michelangiolesca è la stessa che vive d’Annunzio in relazione agli eventi significativi del suo tempo (il testo è scritto nel 1907, quando il patriottismo, poi evoluto in interventismo, dannunziano si scontra con l’inconsistenza giolittiana). La sofferenza alterna «cruccio» a «eroismo», dialogo con l’«errore» e sguardo fisso nel «destino» (Sette documenti d’amore. Il Vittoriale, p. 606):
La statua del giovine Vincitore imperitura è uscita dalle mani dell’uomo che ha l’aspetto del vinto, la tristezza del vinto, dall’arte dell’uomo che vide svergognata la sua città, la libertà spesa nel vomito della crapula, l’Italia data per secoli alla voglia dei vecchi e nuovi padroni.
La seduzione delle opere michelangiolesche
Il poeta scrive osservando i calchi e i disegni delle opere del Buonarroti, e lo confessa nella Prefazione alla Vita di Cola di Rienzo (p. 2024):
Quivi [nella villa La Capponcina di Settignano, con Eleonora Duse] tutta in piedi ardentemente fu scritta la Laus Vitae, con una lena ininterrotta, mentre su l’altra tavola era disteso il ròtolo che recava la raffigurazione della Sistina.
Il Vate contempla i capolavori di Michelangelo, pater omnipotens di un pantheon ideale. Con le opere instaura un dialogo, considerando i blocchi marmorei o le pitture come personaggi in cerca di ascolto. Si confida con loro, rivelando segreti, tormenti e inquietudini. Al Vittoriale conferma il suo essere collezionista di copie, calchi e riproduzioni, come si legge nella seguente lettera di Eleonora Duse in merito al Prigione dal drappo d’oro (D’Annunzio-Duse, Come il mare io ti parlo. Lettere 1894-1923, pp. 770-771):
Ti ho telegrafato che ho spedito – cioè, che il Prigione di M. A. partirà fra otto giorni. […] Dove lo collocherai? È alto 2 metri e 35.
Un altro aneddoto riguardante Lo schiavo morente coinvolge questa volta Elena Sangro (nel testo «Elena Zancle», nome greco del fiume abruzzese). Si assiste alla sola critica che il poeta muove all’artista, dovuta alla sproporzione delle gambe rispetto al tronco. Queste vengono coperte con un drappo d’oro, «dalla cintola in giuso», e una sorta di cinghia, sempre dorata, percorre il busto e le braccia e ne amplifica il fascino e la sensualità. La scarsa armonia della scultura ricorda a d’Annunzio la sproporzione tra quartine e terzine all’interno del sonetto (Libro segreto, pp. 1728-1729):
s’addossa però a un Sepolcro assente l’un de’ Prigioni dal Bonarroto estorto al Sagro: il più bello e il più triste, fasciato dalla cintola in giuso per dissimulargli la corta fiacchezza delle gambe in confronto di quel sublime torso. Per celargli il tradimento del masso che la strapotenza dello scarpellatore troppo spesso tralasciava di misurare nella illusione che la sua creatura vi fosse perfettamente inclusa dal soverchio e ch’ei fosse per arrivarla come nel sonetto anch’esso traditore, Dio ne guardi [e dal marmo solo e dal concetto circoscritto].
Il medesimo appunto compare nel Piacere (p. 147):
La forma del sonetto, pur essendo meravigliosamente bella e magnifica, è in qualche parte manchevole; perché somiglia una figura con il busto troppo lungo e le gambe troppo corte.
Nella tragedia Più che l’Amore, protagonista è «il tumulto» di Michelangelo, durante la realizzazione del Mosè. I protagonisti Virginio e Corrado fanno riferimento ad un «altro patrono», oltre a Dante: si tratta proprio del gigante di pietra michelangiolesco, e con eccitazione rivivono la loro sensazione di inferiorità di fronte a quella «massa enorme di volontà e di orgoglio» (pp. 63-64). Inoltre, si soffermano sulla transustanziazione compiuta da Michelangelo creando il Mosè, grazie alla quale ha riversato in «un altro corpo di pietra gigantesco» tutti i «turbini di tanta anima». Ecco che la vita del Buonarroti, attanagliato da «tutta la sua tempesta» e condannato a non avere «amici di nessuna sorte», diventa antesignana della loro, e quindi di d’Annunzio stesso. Ancora una volta, il poeta celebra la disposizione dello spirito michelangiolesco ad opere che travalicano la misura umana, e al contempo riprende il motivo della tristezza dell’artista.
Ma tra tutte le opere michelangiolesche, l’assoluta protagonista è l’Aurora. Opera fondamentale per il poeta, in lei d’Annunzio ritrova la componente sensuale dell’arte del Buonarroti, complementare alla sua cifra terribile, titanica e sofferente (Il diario della volontà delirante e della memoria preveggente, p. 498):
vedo un poco di luce nelle pieghe della tenda. La lampada è spenta. È già l’alba? E fra poco sarà l’aurora? S’è svegliata l’Aurora di Michelangelo? Ho sete; ma io non posso dissetarmi se non a quel seno scolpito.
L’unicità del petto dell’Aurora è confermata dopo una lunga sezione di sestine nel Libro segreto. D’Annunzio dichiara: «Finisco. finire laborem incipio. finisco nel nome dell’Aurora»; e si accosta al calco della scultura. Come Michelangelo, che «casto nell’animo e nel cuore», «non conobbe se non quella mammella e quella coscia di sasso», così il Poeta si rifocilla esclusivamente nelle forme dell’Aurora (p. 1737):
Finisco. finire laborem incipio. finisco nel nome dell’Aurora. ed è giorno chiaro, è giorno alto, forse prossimo al meriggio. […] Mi volgo alla parete dove l’Aurora di Michelangelo s’adagia secondo la curva dell’arca di Lorenzo, adunando l’infinito della voluttà nella sua forma sculta da colui che animoque et corpore castus non conobbe se non quella mammella e quella coscia di sasso.
In una condizione di «ossessione tumida», d’Annunzio capisce che non può reprimere «il maschio comandamento», poiché «l’opera di carne» è in lui «opera di spirito, e che l’una e l’altra opera concordano nell’attingere una sola unica bellezza». E questa bellezza nasce soltanto dalla «sensualità rischiarata dalla divinazione». Infatti, afferma che la «sensualità» lo «accomuna alle cose che» guarda, tanto che esprime il desiderio di «tornare alla Sagrestia nuova, a rivedere l’Aurora» (Lo splendore della sensualità, pp. 1417-1418):
L’Aurora è una mole di sensualità tragica e insaziabile. Par tagliata nella primitiva compagine de’ sessi concatenati e discordi. Non v’è creatura che tra le mammelle e gli inguini e tra gli inguini e le ginocchia aduni, come questa, una somma di voluttà bastevole a trarre dall’oceano primevo un nuovo mondo di forme immortali. Bisogna che io la riveda, che io la contempli, che io la mèditi, che io rimanga a lungo a lungo dinanzi a lei come dinnanzi a questa collina de’ miei aromati. Veggio, Aurora, né so quel ch’io mi spero.
La Cappella Sistina con gli occhi di Gabriele
Nel Notturno, d’Annunzio rievoca narrativamente, attraverso l’espediente di un sogno, la realizzazione della «fatidica volta» della Cappella Sistina (pp. 360-361):
Il ponte di travi di tavole di ruote, dove Michelangelo saliva per dipingere la volta della Sistina, mi s’è ricomposto nel sogno. Ho sfiorato il prodigio con le ciglia, ho toccato il prodigio con la mano.
Confessa di aver «rapito con le unghie un pezzetto» dell’intonaco e di volerlo incastonare in un «anello di ferro per farne un dono eroico» al suo «spirito che non dorme». Questa «opera titanica è bella come un’ala di farfalla», e aggiunge (pp. 360-361):
ha la perfezione compatta di un guscio d’ovo, una continuità simile alla politezza di un dente d’elefante. È una tra le materie più belle del mondo, nata intiera da un cervello maschio.
Il poeta immagina Michelangelo sul ponteggio, e si domanda come riuscisse a «proporzionare […] il resto della grandezza mentre il pennello gli gocciolava sopra il viso e il ventre gli s’appiccava sotto il mento». Questa immagine deformata è presente nel sonetto caudato I’ ho già fatto un gozzo in questo stento del Buonarroti, scritto intorno al 1510, un paio d’anni dopo l’inizio della volta, e accompagnato, sul manoscritto, da uno schizzo con il suo autoritratto mentre dipinge in piedi con la testa rivolta verso l’alto (Buonarroti, Rime e lettere, pp. 258-259):
I’ ho già facto un gozzo in questo stento,
come fa l’aqua a’ gatti in Lonbardia
o ver d’altro paese che si sia,
ch’a forza ‘l ventre appicca sotto ‘l mento.
La barba al cielo, e la memoria sento
in sullo scrigno, e ‘l petto fo d’arpia,
e ‘l pennel sopra ‘l viso tuttavia
mel fa, gocciando, un ricco pavimento.
E’ lombi entrati mi son nella peccia
e fo del cul per contrapeso groppa,
e’ passi senza gli occhi muovo invano.
Dinanzi mi s’allunga la corteccia
e per piegarsi adietro si ragroppa,
e tendomi com’arco sorïano.
Però fallace e strano
surgie il iudizio che la mente porta,
ché mal si tra’ per cerbottana torta.
La mia pittura morta
difendi orma’, Giovanni, e ‘l mio onore,
non sendo in loco bon, né io pittore.
Ma perché, tra tutte le opere formidabili di Michelangelo, d’Annunzio è morbosamente legato alla «sovrumana volta»? Perché è un tempio da adorare, un condensato di meraviglia; una successione di aruspici e profetesse dalle cui labbra sgorga il corpo del segreto, la rivelazione del mistero: infatti, le Sibille diventano ispiratrici dei suoi personaggi femminili.
Nel Fuoco, Foscarina «leggendo le cantiche di Dante […] fu severa e nobile come le Sibille che nelle volte della Sistina sostengono il peso dei sacri volumi con tutto l’eroismo dei loro corpi commossi dal soglio delle profezie». Isabella Inghirami, nel Forse che sì forse che no, «s’apparentava con le grandi creature di Michelangelo. […] non somigliava alla Libica se non forse pel fiosso arcuato del piede emergente dal flutto», mentre percorre lo scalone del Palazzo ducale. E tra queste pagine, dedicate all’aviazione, evoca il sopraggiungere della notte sulla città di Mantova e la conquista del cielo da parte di Paolo Tarsis (p. 595):
Il polo del cielo era sgombro, in forma di orbe, come veduto dall’arena di un anfiteatro, cupola incurvata sull’ordine dei pilastri e degli archi. I portici colossali delle nubi lo sostenevano, domato l’incendio. Uno spirito misterioso inspirava le figure informi, che su i fastigi s’allungavano s’inchinavano si rovesciavano come la Notte e l’Aurora sui sepolcri medicei, come nel volume della Sistina i Profeti e le Sibille.
L’ultimo d’Annunzio, l’ultimo Michelangelo: la «nemica vecchiaia»
L’ultimo d’Annunzio è disarmato, fragile, ma finalmente sincero dopo un’esistenza di menzogne e di «smania di fingere» (Croce, Gabriele d’Annunzio, p. 86): si sgretola quel «sontuoso personaggio araldico, re di fiori o di picche» (Praz, Esperienza dannunziana, p. 733). Il Vate riconosce «infanzia e vecchiezza» come «una sola sciagura», perché la prima dura poco e la seconda non risparmia nessuno (Notturno, pp. 391-392):
Invecchiato, curvato, spezzato, orbo, con le ginocchia vacillanti, con le gomita cigolanti, ecco che attendo fermo sulla ripa del mio fiume. E qual è il mio fiume? […] L’ispirazione dell’eroismo soffia anche sugli invalidi, soffia anche sui tronconi umani, soffia anche su le carcasse impotenti.
Sia nelle poesie che nelle lettere, non solo da novantenne, Michelangelo ripudia la vecchiaia, e non dipinge la litterata senectus come un periodo florido dell’esistenza: nel capitolo I’ sto rinchiuso come la midolla, il Buonarroti si dipinge «dilombato, crepato, infranto e rotto / […] per le fatiche», con lo stesso andamento iterativo ripreso poi da d’Annunzio. E sul finire della vita subisce una contraddizione dello spirito, poiché l’amore, nonostante continui a ribollire nelle vene, non concede i frutti che offriva in gioventù; come dimostra Che fie di me? che vo’ tu far di nuovo (Buonarroti, Rime e lettere, pp. 140-142):
Ahi, Amor, come se’ pronto in vista,
temerario, audace, armato e forte!
che e’ pensier della morte
nel tempo suo di me discacci fori,
per trar d’un arbor seco fronde e fiori.
Dunque, per Gabriele e Michelangelo il nemico principale sembra essere l’irreversibilità del tempo. Difatti, lo spirito dannunziano è affetto dal morbo dell’eterna giovinezza, incapace di metabolizzare la scansione naturale delle cose (Notturno, p. 266):
Tutto è presente. Il passato è presente, il futuro è presente. Questa è la mia magia. Nel dolore e nelle tenebre, invece che diventare più vecchio, io divento sempre più giovane.
Allo stesso modo, il «parente» Buonarroti riconosce la fonte di ogni supplizio nell’impossibilità di godere di ulteriori anni. Lo logora la consapevolezza che la vita trascorsa è maggiore di quella a disposizione; chiede una tregua all’amore (Buonarroti, Rime e lettere, p. 73):
Non è più tempo, Amor, che ‘l cor m’infiammi,
né che beltà mortal più goda o tema:
giunta è già l’ora estrema
che ‘l tempo perso a chi men n’ha più duole.
A ciò si aggiunge la pena del decadimento fisico: Michelangelo ritiene che i volti, giunta l’anzianità, siano «offesi dagli anni» e bisogna accettare che le «bellezze […] ogn’or ti vengono meno»; d’Annunzio è ancora più drastico, poiché copre gli specchi pur di evitare il suo stesso riflesso (Notturno, p. 240):
il mio viso consunto e smorto, la mia bocca livida e piegata dalla tristezza, i nuovi fili bianchi nella mia barba negletta, il mio collo scarnito: una imagine di miserabile accoramento, che si fissa nella retina e vi rimane.
È vero, la vecchiaia è soprattutto deperimento, insoddisfazione costante, abbandono delle forze fisiche. Tuttavia, nel caso di Gabriele e Michelangelo, si rivela l’ennesimo banco di prova per la loro eterna ispirazione. Il poeta ripensa ai grandi come Dante e Napoleone, Giorgione e Vincenzo Bellini, e capisce che nei loro casi «la turpe vecchiezza non umiliava la potenza né la grazia». E ripensa proprio all’anziano Michelangelo, quando, una volta riesumato il Torso del Belvedere, si faceva condurre per palparlo (Contemplazione della morte, p. 2126):
La grandiosità del Torso Erculeo bastava a riempire le mie mura, perché era quel terribile frammento titanico presso cui Michelangelo decrepito e quasi cieco si faceva condurre per palparlo. (Or potevan dunque le sue mani toccare un marmo senza riscolpirlo intero?) Avevamo dinanzi ai nostri occhi un esemplare sovrano e quasi direi il cànone eroico.
Questo è il motivo per cui d’Annunzio ne conserva una copia al Vittoriale, proprio accanto al busto del Buonarroti, sotto al Portico del Parente.
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Michelangelo Buonarroti, Rime e lettere, a cura di A. Corsaro e G. Masi, Milano, Bompiani, 2016, pp. 7-806.
Gabriele d’Annunzio, Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire (nel testo Libro segreto), in Prose di ricerca, I, a cura di A. Andreoli e G. Zanetti, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 2005, pp. 1659-1922.
Gabriele d’Annunzio, Forse che sì forse che no, in Prose di romanzi, II, cit., pp. 521-870.
Gabriele d’Annunzio, Il commiato, da Alcyone, in Versi d’amore e di gloria, II, cit., vv. 173-176, pp. 635-641.
Gabriele d’Annunzio, Il fuoco, in Prose di romanzi, II, a cura di N. Lorenzini, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 1989, pp. 197-518.
Gabriele d’Annunzio, Il libro ascetico della giovane Italia, in Prose di ricerca, I, cit., pp. 415-737.
Gabriele d’Annunzio, Il piacere, in Prose di romanzi, I, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 1988, pp. 3-358.
Gabriele d’Annunzio, Il trionfo della morte, in Prose di romanzi, I, cit., pp. 639-1018.
Gabriele d’Annunzio, Laus vitae, da Maia, in Versi d’amore e di gloria, II, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 1984, pp. 13-252.
Gabriele d’Annunzio, Le faville del maglio, in Prose di ricerca, I, cit., pp. 1071-1656.
Gabriele d’Annunzio, Le madri, da Alcyone, in Versi d’amore e di gloria, II, cit., pp. 488-490.
Gabriele d’Annunzio, Notturno, in Prose di ricerca, I, cit., pp. 161-410.
Gabriele d’Annunzio, Per la morte di Giuseppe Verdi, da Elettra, in Versi d’amore e di gloria, II, cit., pp. 322-326.
Gabriele d’Annunzio, Scritti giornalistici 1889-1938, II, a cura di A. Andreoli e G. Zanetti, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 2003.
Bibliografia secondaria
Annamaria Andreoli, Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 2000.
Piero Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 1978.
Benedetto Croce, Gabriele d’Annunzio, «La Critica», Laterza, Bari 1904, in Id., Letteratura della nuova Italia, IV, Bari, Laterza, 1914.
Franco Di Tizio, La Santa Fabbrica del Vittoriale nel carteggio inedito d’Annunzio-Maroni, Pescara, Ianieri, 2009.
Pietro Gibellini, D’Annunzio paesista, «Archivio d’Annunzio», 3, 2016, pp. 111-125.
Pietro Gibellini, L’arcangelo senza aureola, Brescia, Editoriale Bresciana, 2008.
Bianca Tamassia Mazzarotto, Le arti figurative nell’arte di Gabriele d’Annunzio, Milano, F.lli Bocca editore, 1949.
Mario Praz, D’Annunzio nella cultura europea, «Lettere Italiane», XV, 4, ottobre-dicembre 1963.
Mario Praz, La carne, la morte, il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 1948.
Ezio Raimondi, D’Annunzio: una vita come opera d’arte, in Id., Il silenzio della Gorgone, Bologna, Zanichelli, 1980.
Giuseppe Virelli, Febea. Gabriele d’Annunzio e Olga Ossani «attraverso le carte», Argelato, Minerva, 2019.