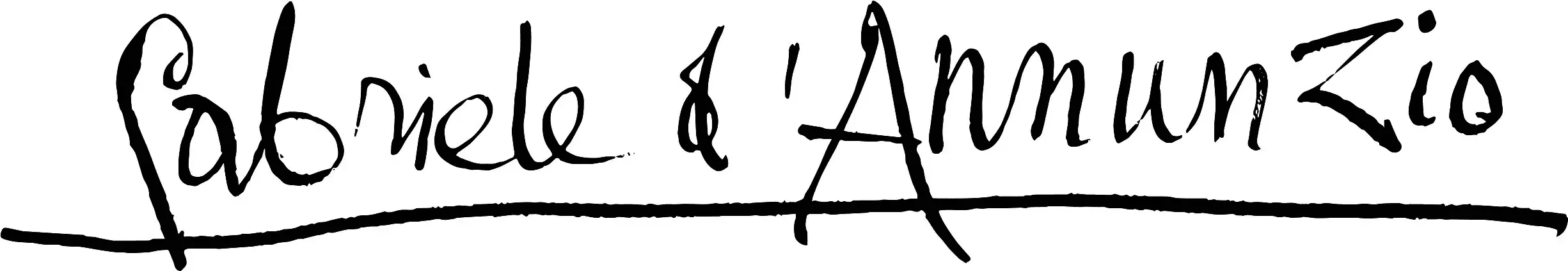di Gian Mario Anselmi, Enciclopedia dannunziana
Pier Paolo Pasolini ( 1922-1975) ebbe, come è noto, un rapporto complesso con la tradizione letteraria italiana ed europea: giova ricordare qui che, nonostante le sue molteplici, funamboliche e innovative “incursioni” in tutti i mondi della produzione artistica (narrativa, cinema, televisione, giornalismo, teatro, disegno e pittura, fotografia) egli rimase sempre e soprattutto un “poeta”. E lo fu fin dalla tesi di laurea in Lettere a Bologna con il grande Maestro di critica letteraria e storico-filologica, Carlo Calcaterra: in quella tesi, dedicata a Pascoli, già si affacciavano una non convenzionale attenzione di Pasolini alla “svolta” della poesia italiana postcarducciana e un suo desiderio di misurarsi con chi, come Pascoli, nell’innovare profondamente il canone poetico italiano, pure seppe cimentarsi in una rivisitazione profonda di tutta la tradizione letteraria a partire da una finissima attenzione alla cultura classica tanto da divenire, in un certo senso, l’ultimo dei grandi poeti neolatini (come in saggi ed edizioni fondamentali ha mostrato Alfonso Traina). Pasolini entra da grande innovatore nel campo poetico e subito le sue raccolte giovanili in dialetto friulano colpiscono la critica più significativa del tempo (Contini ad esempio). Il percorso si dipanerà per tutta la sua vita con raccolte poetiche di innovazione spiazzante pur nella “risignificazione” di moltissime suggestioni classiche e romantiche: lo stesso capolavoro Le ceneri di Gramsci (1957) propone una sorta di realismo e di impianto ideologico marxista “straniati” rispetto a corrivi linguaggi correnti attraverso il recupero di immagini, stilemi, metriche del tutto rielaborate al fuoco della tradizione letteraria, da Dante con la ripresa della terza rima ai grandi poeti visionari romantici inglesi (con particolare attenzione per Shelley) a continue ritrascrizioni della letteratura greca e latina tanto elegiaca quanto tragica, da Pindaro a Eschilo, a Sofocle a Euripide a Lucrezio e Orazio fino alle Metamorfosi di Ovidio. E questo certamente può essere individuato, seppure in modo molto generico, come un primo e non secondario punto di contatto di Pasolini con d’Annunzio. Ma la questione è molto più complessa e deve fare i conti con altre dimensioni dei due poeti qui messi a confronto e per molti versi inaspettate. Ma procediamo con ordine e seguendo un sentiero particolare, non sempre messo in luce in modo adeguato per la nostra tradizione poetica novecentesca. C’è infatti una particolare linea di pensiero e di riflessione che attraversa la storia intellettuale a artistica italiana dal Novecento fino ai nostri giorni. Ovvero una sorta di movimento duplice e solo in apparenza contraddittorio che pertiene al rapporto col sacro (e con il mito nella sua dimensione religiosa): se da un lato infatti la frattura con la tradizione religiosa cristiana e il tramonto stesso irreversibile degli “antichi dei” come manifestazione del tramonto di un “classicismo” di maniera divengono manifestazioni egemoni, dall’altro queste “perdite” producono un senso di sgomento, di nostalgia, di esigenza di ritrovare il sacro non più come espressione di fede dogmatica ma come necessità di risalire all’”origine”, all’essenza prima della capacità mitopoietica e fantastica dell’uomo nella sua natura più profonda. Una sorta di immersione che travalica la letteratura per contaminarsi, per certi aspetti, con l’antropologia e con lo “specifico umano” nel suo rapporto con il “divino”.Questo tragitto in Europa si apre fin dalla grande stagione romantica, specie tedesca, e ha poi un punto culminante con la filosofia di Nietzsche, grande serbatoio cui attingeranno a piene mani letterati e filosofi del Novecento di là dall’adesione al suo pensiero. D’Annunzio si dispose in modo clamoroso e irriverente (com’era del resto tipico della sua concezione di esibizione della vita come arte e come provocazione) lungo questo crinale con modalità paradossali: lo “scandaloso” d’Annunzio, il lettore spregiudicato di Nietzsche, il combattente in armi insofferente delle leggi morali borghesi, sovente, e soprattutto nell’ultima fase della sua vita al Vittoriale, testimoniò ed esibì una sincera ammirazione per San Francesco e il suo movimento fino a indossare, in alcune occasioni (anche di fronte ai visitatori che giungevano al Vittoriale in attesa di un suo motto quasi fosse una sorta di Pizia), il saio dei francescani. Questo d’Annunzio “ossimorico”, sospeso tra la violazione di ogni morale in una residenza sontuosa e con un tenore di vita sempre dissipato e il recupero esibito della modestia francescana, non paia un mero gioco di prestigio ad uso del suo personale mito tra la gente: si farebbe un torto alla sua straordinaria intelligenza. Tale comportamento è esattamente il corrispettivo di ciò che affermavamo in apertura: agisce in lui, fin da giovane e con continuità negli anni a seguire, specie nella produzione teatrale ma anche in alcune straordinarie poesie delle Città del silenzio, una sorta di nostalgia per un passato al tempo stesso magico e religioso, una malinconia per valori semplici e “rustici”, contadini, ormai irrimediabilmente in via di scomparsa (ed egli fu tra i primi in Italia a cogliere questo mutamento epocale ben prima di Pasolini). Il Cristianesimo morente per sentenza di Nietzsche non lascia indifferente d’Annunzio, lo invita anzi ad una riflessione poetica non meno che filosofica sulla “perdita” che quella morte comportava: era la morte infatti per lui, abruzzese di mare e abruzzese di monti e transumanze arcaiche, millenarie, non solo di un costume religioso ma di una intera civiltà povera e aspra di cui anche l’estenuato esteta ormai “metropolitano” e “parigino” sentiva una malinconia immedicabile. Che poi questa malinconia, questo senso della perdita venissero ovviamente trascritti dal poeta in chiave estetizzante e persino provocatoria (specie nei confronti della Chiesa ufficiale, quella che aveva stipulato con Mussolini i Patti Lateranensi e per la quale sempre d’Annunzio ebbe un laico disprezzo ) nulla toglie all’intuizione formidabile di un Cristianesimo francescano e delle “origini” simbolo di un mondo arcaico e religioso/magico la cui fine imminente era colta da d’Annunzio come perdita assoluta di una civiltà stessa. Del resto questa singolare disposizione arcaicizzante e francescana di d’Annunzio non è poi di tenore tanto diverso in lui rispetto ai miti e agli dei della amatissima civiltà classica e pagana: gli dei sono fuggiti dalle loro dimore, i protagonisti del mito classico non hanno più luogo. Però, sulla scia probabile di Hölderlin, la parola del poeta può evocarli, ridare loro voce, riallogarli nei cuori e nella vita dei lettori. Se l’amante è Ermione non è per un iperbolico gioco di adulazione; lo è perché davvero è Ermione, non può che essere l’eterno ritorno del mito e delle sue immortali figure. La poesia crea, il mito antico può rinascere con i suoi Dei (il grande lascito di Ovidio con le sue Metamorfosi riletto da Dante nel Paradiso): il dolore di una “perdita” assoluta può trovare nell’estetica come vita, nel poeta come “mitopoieta” una sorta di risarcimento che è anche una sorta di nuovo Rinascimento. Così il Sacro pagano e il Sacro cristiano (la religiosità classica che in qualche modo aveva consegnato la staffetta alla nuova religiosità cristiana nel Medioevo dannunziano come appare evidente nella tragedia La nave) non rinascono certo ma “porgono” le parole per dire del nostro passato fondativo, per risarcirne la perdita dolorosa, per evocarlo come voce capace di agitare il nostro stesso presente. È questo davvero forse allora l’unico, vero punto per cui pare possibile accostare Pasolini a d’Annunzio: come è noto infatti Pasolini usò parole molto dure verso d’Annunzio. Negli anni Sessanta quando cominciava ad affermarsi, specie tra alcuni critici e professori universitari, una rivalutazione di d’Annunzio soprattutto come poeta (ma anche per il Notturno), Pasolini prese posizioni molto nette: non solo condannò esplicitamente la deriva fascista del poeta pescarese, il suo narcisismo ed esibizionismo ma dichiarò un’operazione critica insostenibile quella di distinguere l’uomo (con le sue deprecabili scelte politiche, militari e di vita) dal poeta. Entrambi andavano ampiamente ridimensionati e messi in mora (come già aveva lapidariamente espresso Natalino Sapegno nel suo celeberrimo Compendio di Storia della letteratura italiana): il poeta d’Annunzio per Pasolini restava un poeta mediocre come mediocri e dannose erano state le sue scelte di vita. Su questo giudizio senza remissione Pasolini non venne mai meno e quindi sarebbe un arrampicarsi sugli specchi voler trovare un “dannunzianesimo” consapevole in Pasolini: certo il Pasolini degli ultimi anni e dei suoi ultimi film prima “vitalistici” (la straordinaria trasposizione cinematografica dei tre grandi capolavori narrativi della letteratura medievale, Decameron, I racconti di Canterbury e Le mille e una notte) e poi il cupo e “decadente” Salò o le 120 giornate di Sodoma (dall’opera del Marchese de Sade) evocano immagini, provocazioni, compiacimenti estetizzanti da cui è impossibile escludere del tutto la presenza dannunziana (specie nella sfera della sessualità gioiosa e trasgressiva della trilogia della vita e in quella degradata e sadica dell’ultimo film). Ma il vero punto di contatto inaspettato e di assoluta rilevanza (consapevole o meno che fosse in Pasolini) resta quello del terreno del sacro e del mito come ulteriore dimensione di una ancestrale e rurale religiosità di cui anche Pasolini avverte una lacerante nostalgia, un senso lancinante della sua definitiva “perdita” (come proclama fino alla fine, in polemica, anche in lui feroce come in d’Annunzio, contro la Chiesa cattolica Romana del presente, nei suoi Scritti corsari). E come d’Annunzio anche Pasolini avvertì il fascino di San Francesco e del suo Ordine: non a caso il suo asciutto e scabro film Il Vangelo secondo Matteo nasce dopo un soggiorno ad Assisi presso il convento francescano la cui “atmosfera” capace di evocare un cristianesimo originario e non corrotto molto lo colpì e lo suggestionò. Ma per proseguire il nostro argomentare occorre per Pasolini e le sue scelte ampliare ulteriormente lo sguardo. Se sappiamo infatti osservare con attenzione il recente passato non possiamo non percepire con nitidezza che il grande dibattito sulla modernità in Italia nel secondo Novecento toccò le sue punte più alte e significative nel dialogo fertile e polemico, via via, fra Vittorini, Calvino, Moravia, Pasolini. Come a dire che, per la peculiarità stessa della nostra tradizione, usa (in un certo senso, da Dante in poi) a dislocare il proprio fuoco ermeneutico e speculativo nella letteratura, tra scrittori e letterati, anche nel Novecento, in Italia, si è condensata una riflessione di fondamentale rilievo, ovvero quella che pertiene al “passaggio” del Terzo Millennio (e in questa ottica due raccolte saggistiche di Calvino, Una pietra sopra e Lezioni americane, rappresentano proprio per un verso il bilancio di quella combattuta stagione e per l’altro la straordinaria apertura al nuovo ancora da percorrere). In quel dibattito che poneva al centro in modo drammatico e prioritario (come già era avvenuto in altri momenti cruciali della nostra storia e della nostra cultura, con Dante, con Bembo, con Manzoni) il problema della lingua, della fruizione della letteratura e degli autori, del rapporto tra testo e lettore fino al ganglio dei rapporti coi linguaggi dialettali e settoriali, in realtà si faceva largo una più complessiva riflessione sulla “cultura” in senso lato, antropologico e sociale, e nell’intreccio col delicato processo di passaggio dell’Italia arcaica e contadina verso la “modernità” con le sue mitologie nuove e le nuove contraddizioni. Pasolini (grande lettore di Gramsci da sempre, e anche in questa chiave) più di altri entrò con piglio deciso e “corsaro” nell’arena, costringendo tutti a misurarsi, attraverso il dibattito sulla letteratura, sulla lingua, sui nuovi metodi di comunicazione, con i drammatici problemi del cambiamento e delle trasformazioni che investivano innanzitutto il vasto mondo dei “subalterni” (ancora Gramsci). Che le risposte dei vari interlocutori fossero fra loro molto diverse e che la più sostanzialmente pessimistica fosse proprio quella di Pasolini, ma tutte comunque di altissimo livello, mostra il rilievo di quel dibattito e il ruolo essenziale in esso giocato dalle provocazioni pasoliniane. >Pasolini, quindi, non ebbe timori a collocare la sua formazione letteraria, il suo stesso essere prioritariamente poeta, scrittore e lettore al centro delle ragioni fondanti della sua vita e delle sue battaglie: poco si comprende Pasolini infatti (e molto di lui si fraintese, appunto, per tanto tempo, in modo anche ingeneroso da parte di certa critica militante) se non si coglie come fulcro costante della sua riflessione questa adesione alle ragioni profonde della letteratura e dello specifico ruolo del poeta. Ragioni e ruolo che richiamano quelli già vivissimi nella nostra tradizione dantesca e rinascimentale e che il romanticismo fece integralmente propri, ridifinendoli nel contesto del proprio nuovo “soggettivismo”. La letteratura, in effetti, come luogo che spezza l’egemonia del logos e fa coesistere gli opposti, diviene il terreno della contraddizione e del “dialogo”; la poesia spacca la storia, la sfida, ne mostra l’altro possibile, quasi in concorrenza con l’autentico concetto di “profeta” che è dato cogliere nei testi sacri (altro tema che intrigò molto d’Annunzio, appunto il nuovo “Vate” dopo Carducci). Il “poeta-profeta” cioè non come “divinatore” di assolute certezze o di facili “predizioni” ma come lacerato cantore di un’umanità dolente in cerca della sua “patria” (la Ginestra di Leopardi): non è un caso che Pasolini, in aperta polemica con ermetismi ed esasperati sperimentalismi, riscopra la “poesia civile” e, in tale contesto, riprenda l’uso della terzina dantesca (unico forse dopo i grandi romantici inglesi) e citi, in un passaggio cruciale delle Ceneri di Gramsci, Shelley, il geniale interprete romantico e moderno di questa visione peculiare di poeta e poesia. In tale crogiuolo nasce la bipolarità irresolubile, per Pasolini, di “passione” e “ideologia”, ovvero di irriducibilità all’unica dimensione ideologica dell’”alterità”, alterità non sillabata dalla politica e dai suoi soggetti e che è carne e sangue dell’arte, della poesia: Pasolini giunge ad affermare appunto che non si può chiedere al poeta di far tacere la propria voce “profetica”, quella irrimediabilmente alternativa ad ogni visione storicistica e giustificazionista e quindi, per ciò stesso, anche irrimediabilmente “scandalosa”, contraddittoria, sempre oltre o altrove rispetto ai quieti porti dogmatici delle ideologie fideistiche, di destra o di sinistra che siano (c’è una qualche contiguità con l’ultimo d’Annunzio poeta appunto disincantato e polemico verso il regime fascista e apertamente avverso a Hitler e al Nazismo). Ed è ancora a partire da questa sua forte caratura di poeta che, da laico, egli guarda con sgomento al processo di desacralizzazione dell’occidente moderno: l’omologazione, l’appiattimento, l’usura delle esperienze e dei linguaggi sembrano appunto impedire la fertile contaminazione con l'”altrove” che sta alla radice stessa dell’arte e della sua “aura”, con l’ansia utopica che non si ferma alla banale quotidianità. L’irruzione del sacro, dell’ “angelo necessario”, per dirla con Cacciari (o con Wim Wenders e Peter Handke de Il cielo sopra Berlino ispirati dalle poesie di Rilke), l’improvviso squarcio epifanico nella tranquilla quotidianità borghese si accampano al centro di quello straordinario romanzo (uno dei grandi testi del nostro Novecento, da sempre sottovalutato dalla critica) che è Teorema, nato in unisono con l’omonimo film (e pubblicato in un anno emblematico, il ’68). C’è, in Pasolini, rispetto al senso del sacro come un doppio movimento: da un lato la percezione di qualcosa di irrimediabilmente compromesso nella società moderna e dall’altro una nostalgia profonda (appunto come in d’Annunzio) per una perdita che pertiene all’identità profonda dell’uomo in quanto tale e tanto più dell’uomo occidentale calato nella tradizione biblica e cristiana (tradizione di cui Pasolini fu attento ermeneuta ed interprete se solo si sappia guardare al Vangelo secondo Matteo o ad alcuni degli Scritti Corsari). Proprio se ci soffermiamo su questi snodi possiamo allora comprendere il rilievo drammatico e pieno di genuino pathos che assumono, in Pasolini, altre essenziali dicotomie o bipolarità, da collocare nell’alveo già ben scandito, come si è visto, di “passione/ideologia”: così è per il nesso “mito/storia” (che attraversa tutta la sua riflessione sul mondo antico, dalla traduzione dell’Orestiade a film come Medea); così, ancor più, fino agli ultimi anni di vita, per quell’irrequieto trascorrere, come già si disse, dal polo di un inesausto vitalismo a quello di una morte devastante (Salò) e che, si può intuire, avrebbe assunto un ruolo centrale nello stesso vasto progetto dell’incompiuto romanzo Petrolio. E del resto, in tutta la sua attività di poeta, scrittore e regista, la dialettica, ora antinomica ora contaminante, fra “corporeità” (fisicità pulsante), “dissolvimento” e “sacralità” (Accattone, Ragazzi di vita, Una vita violenta, come ben dimostrano gli studi di Giona Tuccini) si attesta al cuore della sua poetica, terreno emblematico di ciò che è dicibile solo col discorso straniante del mito, dell’arte, della letteratura; e invece negato dalla banalità inespressiva e conformista della comunicazione quotidiana, massmediologica, ideologica; anzi di fatto inesprimibile, censurato, perennemente frainteso nelle articolazioni dei linguaggi che ineriscono a tale comunicazione. La società contemporanea ha infatti tragicamente messo in luce la lacerazione originaria dell’uomo, sospeso tra la sua violenza ferina e devastante e il processo di costruzione della “civiltà” fondata sulla ragione, sulle leggi, sul mito del progresso (Humana feritas, come recita un bel volume curato, fra gli altri, da Loredana Chines). Che poi, a guardar bene, è il grande tema nietzschiano ritrascritto da d’Annunzio in una pratica di vita “feroce”, dispersiva e “ingorda” da un lato e dal lato opposto in una inesausta curiositas “futurista” per ogni tipo di innovazione tecnologica e scientifica (l’aereo, il cinema, le armi più sofisticate, la radio, ecc.) con ricadute tutt’altro che secondarie sulla sua poetica. Perciò a Pasolini è così caro il mito dell’Orestea di Eschilo. Il testo di Eschilo non è solo tradotto nel 1960 ma è da Pasolini successivamente fatto proprio come uno dei possibili viatici per interpretare la radicale dualità di ogni tipologia di progresso “emancipatore”. L’antropologia di Pasolini non è infatti un sistema: è piuttosto il frutto di una osservazione poetica sostanzialmente pessimistica del processo di “civilizzazione” dell’umanità (torna il legame con Leopardi e con Montale). All’origine, per Pasolini, non vi è comunque alcun paradiso perduto da riconquistare: l’innocenza è già perduta dall’uomo nel suo stesso essere “gettato” nel mondo. Il rimpianto di Pasolini è per una innocenza non raggiungibile, fruibile solo per via mitica e analogica ovvero poetica; una innocenza ugualmente importante da rievocare come “luogo” utopico dell'”altrove”, pietra di paragone che impedisce di soccombere all’omologazione della quotidianità corrotta e corrosiva. Per questo la cultura occidentale deve continuare a confrontarsi con il mito greco: quel mito ha messo a nudo una volta per tutte l’origine della lacerazione e della dualità, il distacco definitivo tra uomo e Dio, il faticoso cammino della civiltà come necessità talora cieca e imponderabile. Non è casuale che Pasolini, accanto a Oreste, rimediti, nei suoi film, le figure di Edipo e Medea. Le Erinni non diventeranno mai del tutto Eumenidi, Medea e Giasone non si riscatteranno dalla propria violenza originaria e tutta la sua sapienza non salverà Edipo dalla maledizione propria dell’uomo (l’antropologia di Pasolini e la sua tragica rilettura del mito greco richiamano, per tanti versi, Machiavelli, specie il memorabile XVIII capitolo del Principe). L’accesso poetico, artistico, filmico a quei miti è forse l’unico ancora possibile, di là da ogni logos filosofico: non a caso Pasolini, con i versi di un’altra opera significativa, Pilade, tenta di dare un seguito alll’Orestea di Eschilo, rinnovando il tema della dualità non risolta tra uomo e civilizzazione, tra ferocia primitiva e ragione, logos, tra brutale istinto di sopraffazione e legge, nomos. Altrettanto la lezione del Vangelo o di alcuni passaggi del Vecchio Testamento o la riflessione sul senso del sacro delle popolazioni primitive induce in Pasolini l’idea di un tramonto dell’innocenza originaria e di una radicale dualità tra le leggi della modernizzazione e ogni forma di religiosità, cui solo l’arte può in parte sopperire all’interno di una percezione sostanzialmente romantica della Sehnsucht, ovvero dello straniamento inconsolabile da ciò che è perduto per sempre e di cui si ha nostalgia lacerante (bellissime sulla nostalgia e in generale sulle emozioni le pagine letterarie non meno che filosofiche di Ilaria Gaspari).
Non a caso questo è il tema dominante del suo approccio ai cosiddetti paesi in via di sviluppo, ai paesi africani in particolare: se essi sono negli anni Sessanta il luogo di un'”origine” che sembra ancora incontaminata e perciò apparentemente “innocente” (si veda l’uso che Pasolini fa di questi spunti nei film di “mito” greco) essi sono anche il luogo di una “civilizzazione” dirompente e devastante ovvero il luogo di uno scontro senza precedenti tra “ragione” illuministica e “ragione” analogica e simpatetica. L’una non riesce ad annullare del tutto l’altra: la ferocia di fondo dello scontro (e le vicende africane di oggi danno ancora una volta ragione al Pasolini “profeta”) non fa intravedere alcun possibile Oreste africano vincitore. La dimensione tragica della perdita originaria dell’innocenza, della inattingibilità dell’innocenza sembra accumunare Occidente colonizzatore e predatore e Paesi del Terzo mondo nella loro storia. Pasolini quindi non ha verso il Terzo mondo una curiosità asettica da scienziato né tantomeno un trasporto ingenuo di entusiasmo facile e acritico com’era allora frequente tra i militanti di sinistra e in certe comunità cristiane a vocazione “missionaria”: con determinazione, con scrupolo (anche con i suoi appunti di viaggio) Pasolini tenta invece di capire come nasca il conflitto originario, verificandolo nei luoghi dove esso è appunto ancora eclatante, e reso ancor più tragico e incombente dalle pesanti responsabilità del mondo occidentale nel cosiddetto processo di “civilizzazione” dei Continenti colonizzati. Pasolini non “cerca” miti africani o orientali dal sapore esotico, mistico o ideologicamente salvifico, non pretende di convertirsi a tradizioni non sue: vuol mettere alla verifica dell'”origine” i suoi personali miti, il suo approdo culturale e antropologico, di uomo forgiato dalla civiltà greco-occidentale, di intellettuale controcorrente e imprevedibile. Pasolini è insomma prima di tutto poeta educato dalla tradizione classica e romantica; non è un antropologo culturale: e in ciò sta forse la singolare forza delle sue intuizioni o, come si diceva all’inizio, quel suo statuto di “poeta-profeta” civile dell’Occidente al punto forse più alto della sua crisi novecentesca (Il tramonto dell’Occidente di Spengler? Un libro che sicuramente d’Annunzio ebbe presente e che certamente, pur non condividendolo ideologicamente, era presente anche a Pasolini). Non c’è consolazione nell’antropologia pasoliniana (anzi, con Salò, vi è ormai solo disperazione, nel senso originario e forte del termine, contiguo al suicidio, al dissolvimento per “mancanza di speranza”): c’è però a lungo (anche con i film dedicati alla Trilogia della vita) il senso di una grande funzione conoscitiva della ragione poetica ovvero mitopoietica, secondo la migliore tradizione rinascimentale e poi romantica (specie inglese) e infine dannunziana! Questa conoscenza, questo particolare rispetto per la tradizione mitografica e sacra e la sua forte valenza metaforica certo non “consolano” ma danno il senso originario del nostro continuo “rimpianto”, della nostra incessante necessità dell’aver cura (questi temi hanno avuto negli ultimi anni, sulla scia ora dannunziana ora pasoliniana, una ripresa di alto livello nella cinematografia e serialità televisiva italiane con Nanni Moretti, Sorrentino, Ammanniti, Guadagnino, Matteo Rovere fra i tanti). Il mondo moderno, la sua banalità, la sua devastante piattezza antropologica non possono impedire al poeta e al suo pubblico di rimpiangere l’innocenza, di far vivere comunque l’utopia, di dare testimonianza estrema di ogni irriducibile alterità, in un certo senso nella scia di Rousseau: per Pasolini infatti questa ricerca è tanto dolorosa quanto ineludibile, sta nella natura stessa dell’uomo e il mito che può dirne è della cifra del mito greco, il mito appunto che narra la dualità, la lacerazione, la necessità in cui operano i figli di Prometeo (quella grecità “originaria” così cara appunto anche a d’Annunzio). I miti della contemporaneità sono fasulli, non apportano conoscenza, non sono segno di contraddizione, sono altro dal mito come poetica e dolorosa ricerca: sono, per paradosso, portatori essi (non quelli greci o arcaici o cristiani delle origini) di piattezza, di staticità, di allontanamento dalle cause ultime.
Fuggono la morte: non parlano la morte; fuggono la passione: non parlano la passione. Descrivono l’uomo senza saperne. Antropologia autentica si dà col mito antico o con la sapienza biblica ed evangelica. Questo allora è forse il punto di congiunzione imprevedibile tra poli opposti come d’Annunzio e Pasolini: il mito antico si dà con il sapere del poeta, del “profeta”, di chi sta al punto di rottura tra uomo e storia e se ne fa testimone. D’Annunzio seppe articolare questa paradossale condizione dell’uomo novecentesco ammantandola della sua personale “aura” di decadente trasgressivo pronto ad accogliere i miti moderni che ancora oggi fanno scuola nella società digitale contemporanea: insieme a Marinetti e ai futuristi d’Annunzio celebra la velocità, la simultaneità, il coraggio bellico dell’azione, insofferente del tutto a una visione di poeta come colui che si “confina” nel suo studio, nella sua torre d’avorio per non contaminarsi con la realtà (anche “confinato” dal Fascismo al Vittoriale continuerà a “intervenire”). Come più avanti Pasolini, pur restando sostanzialmente poeta e pur usando gli strumenti della letteratura, entrerà senza esitazioni nel “mondo” e nelle contraddizioni che lo laceravano, altrettanto d’Annunzio aveva già indicato molto prima (seppure da sponde ideologiche opposte) la via del poeta “nuovo” come poeta “curioso” e sperimentatore, nel caso suo sentendosi erede dei classici ma pronto a signoreggiare i salotti, a cimentarsi negli sport come nella guerra, a prestare attenzione al “contemporaneo” persino non disdegnando una grande curiosità per le innovazioni tecnologiche in continua evoluzione. Anzi, non dimentichiamo il d’Annunzio sceneggiatore e “regista” (altro singolare punto di contatto con Pasolini) in cimento con la nuova arte ancora ai suoi albori!; e si pensi infatti per esempio a Cabiria , film colossal “fondativo” del genere, del 1914, cui d’Annunzio diede come soggettista, sceneggiatore e, oggi diremmo, promoter un contributo decisivo. E si potrebbe dire che la stessa storia d’amore travolgente e lacerato per Eleonora Duse (la divina come in tutto il mondo veniva definita), la più grande e affascinante attrice teatrale del tempo, si innesti in questa costante frequentazione curiosa e “vorace” dannunziana del mondo dello “spettacolo”. E come non rilevare, su questo terreno, un’altra analogia con Pasolini, folgorato (e ricambiato con amore struggente) da un’altra divina, la più grande e passionale soprano e diva di tutti i tempi, Maria Callas? Che Pasolini da regista seppe trasformare in maschera tragica cinematografica in Medea contaminando con dolcezza la sua ammirazione “amorosa” (quasi in grado di porsi al limite della sua omosessualità), la sua fascinazione per la Callas (a sua volta innamorata perdutamente di Pasolini, l’amore “impossibile”) con il senso stesso di esserci nelle nuove dinamiche dei linguaggi artistici e musicali attraverso il legame unico e straordinario con la loro più grande interprete. Pasolini non amerà certo la “postura” dannunziana, il gesto esibizionistico del poeta/vate ma pure la “vocazione” è , nella sostanza, simile: ovvero entrambi profondamente e soprattutto poeti tenteranno in ogni modo però di sperimentare e testimoniare la vita, di non estraniarsene. Con un’altra prospettiva che già richiamavamo e che non va certo dimenticata: entrambi, pure al culmine di frenetiche ricerche e sperimentazioni, di autentica curiositas verso il terribile crogiuolo novecentesco di cui, in epoche diverse, furono protagonisti, da veri “attori” sulla “scena” del mondo, continuarono a ripensare a tutto ciò che si stava perdendo, mondo contadino, tradizioni popolari, dialetti, e soprattutto senso “religioso” pagano classico e poi francescano ed evangelico di un “sacro” originario; una “perdita” che non poteva non comportare “nostalgia” in un ossimorico gioco di rimandi fra attrazione per il nuovo che avanzava e senso irredimibile delle tracce perdute dell’”origine” e dei miti sacri che la fondavano. Se Pasolini, attento a Marcuse, nel temere la omologazione (una delle sue più incisive intuizioni e definizioni del mondo contemporaneo oggi universalmente riconosciuta) tentava la sfida ai linguaggi tutti dell’arte e della comunicazione fino alla più spregiudicata denuncia giornalistica (in piena sintonia con l’etica del J’accuse di Zola), d’Annunzio aveva in altro modo (e con l’illusione dell’azione e della volontà di potenza incarnate dal fascismo) sfidato le convenzioni borghesi (non molto dissimili dall’omologazione denunciata da Pasolini) attraverso la vita come arte e trasgressione, provocazione, attraverso l’incarnazione del poeta come uomo d’azione e testimone fuori dall’etica piccolo borghese e pure in perenne attesa (maestri Hölderlin e Nietzsche) del risveglio dei miti e degli dei antichi, di una classicità davvero contemporanea. Percorso di lunga durata nell’Italia controversa del Novecento che aveva lambito, intatto, ad esempio già un Curzio Malaparte, autore che, da questo punto di vista, andrebbe completamente rivisitato come esemplare dei lasciti al confine fra letteratura e crisi novecentesche di identità perdute e senza speranza a cavallo della tragica stagione della seconda guerra mondiale e della fine delle dittature. Pasolini, nella scia di un Novecento dal cui novero, come abbiamo visto, certo d’Annunzio non può essere escluso, ha sempre cercato di non fuggire quel punto di frattura irrevocabile, di ricordarcelo, di narrarcelo, di testimoniarcelo appunto, affrontandone tutte le conseguenze fino a quelle estreme segnate dalla sua tragica e “profetica” morte.
Bibliografia essenziale
Bazzocchi, M.A., Pier Paolo Pasolini, Milano, Bruno Mondadori, 1998. Bazzocchi, M.A., Alfabeto Pasolini, Roma, Carocci, 2022. Cacciari, M., L’angelo necessario, Milano, Adelphi, 1992. Chines, L.; Menetti, E.; Severi, A.; Varotti, C. (a cura di), Humana feritas. Studi con Gian Mario Anselmi, Bologna, Pàtron, 2017. Gaspari, I., Vita segreta delle emozioni, Torino, Einaudi, 2021. Gibellini, P., «Le controparabole di Gabriele D’Annunzio». Rivista di letteratura religiosa italiana, 2, 87‑96, 2019. Martellini, L., Invito alla lettura di Malaparte, Milano, Mursia, 1977. Ricorda, R. , «Pier Paolo Pasolini: epifanie del sacro», Gibellini, P.; Di Nino, N. (a cura di), La Bibbia nella letteratura italiana. Vol. 2, L’età contemporanea. Brescia, Morcelliana, 397‑417, 2009. Scioli, S. , La Grecia classica in Maia di Gabriele D’Annunzio, Bologna, Pendragon, 2021. Scioli, S., Contro l’errore del tempo. Dittico sul teatro dannunziano, Lanciano, Carabba, 2023. Traina, A., Il latino del Pascoli. Saggio sul bilinguismo poetico, Bologna, Pàtron, 2006. Tuccini, G. , Degno del cielo. Umanesimo plebeo e poetica del sacrificio in Accattone di Pasolini, Roma, Carocci, 2021.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)