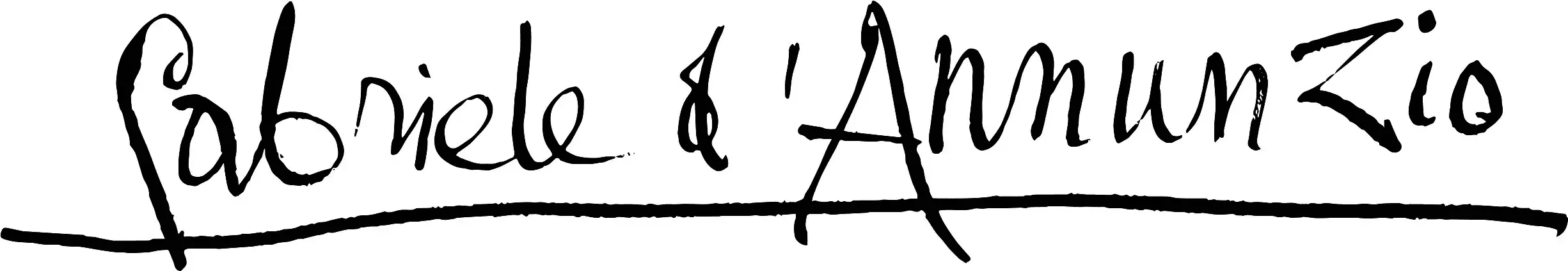di Simone Di Valerio, Enciclopedia dannunziana
Un ritratto: l’ambiente familiare, la formazione e il matrimonio (1873 ‒ 1891)
Olga Treves (1873 ‒ 1945) nacque a Vienna da Enrico Treves (1829 – 1913), fratello maggiore di Emilio (1834 ‒ 1916) e di Giuseppe (1838 ‒ 1904) ‒ direttori della casa editrice milanese Fratelli Treves ‒ e da Elena Michajlovna Vjvodcova (1848 – 1940), originaria di Odessa, all’epoca porto dell’Impero zarista (per i rapporti tra la Vyvodcova e d’Annunzio, che nel 1922 favorì l’espatrio della madre e della sorella dalla Russia, vd. Pagani). La donna insegnò il russo ai suoi tre figli: Olga ebbe infatti un fratello, Guido (1875 ‒ 1932), amministratore dell’illustre casa editrice dalla dipartita dello zio Emilio nel 1916, e una sorella, Giulia (nata nel 1877). Enrico Treves, di professione avvocato, risiedette per alcuni anni con la famiglia nella capitale austriaca dell’Impero Asburgico, arrivando a ricoprire anche la carica di viceconsole presso l’ambasciata del Regno d’Italia a Vienna. Nel 1885, a causa di ragioni economiche, legate a un tracollo in Borsa, e politiche, Enrico e i suoi si trasferirono a Milano, in via Bagutta 6, l’uomo esercitò così la sua professione di semplice impiegato presso la prestigiosa casa editrice dei fratelli, specializzandosi nella giurisprudenza sui diritti d’autore (Rebora 2006): in queste vesti, fornì assistenza, ad esempio, anche a Verga, come testimonia la lettera del 23 aprile 1896 indirizzata allo scrittore siciliano (Raya 1986, p. 161). Una volta a Milano, come tutti i membri della famiglia Treves, Olga animò i salotti letterari che si riunivano nelle case degli zii Emilio e Giuseppe, sia in quelle di città, sia in quelle sul Lago Maggiore, nella località di Pallanza, sponda verbanese. Ebbe modo così di conoscere e diventare confidente dei letterati e degli artisti che gravitavano intorno alla casa editrice, tra cui Giovanni Verga e Gabriele d’Annunzio, con i quali intrattenne un durevole rapporto umano ed epistolare (Rebora 2006). Considerata la condizione economica e sociale in cui nacque e crebbe, e i contatti anche intellettuali che ebbe con siffatte personalità, Olga ricevette sicuramente un’educazione di prim’ordine, come testimoniato anche dalle ricorrenti espressioni in lingua francese che popolano la corrispondenza sia con il poeta abruzzese (Di Valerio 2023) che con lo scrittore siciliano (Raya 1986). Ricevette inoltre una solida educazione musicale che le permise di diventare un’apprezzata pianista nei salotti del bel mondo meneghino: dal programma con tutti i brani che avrebbe eseguito, inviato a d’Annunzio in una lettera, si ricostruisce che il 30 marzo 1919 tenne un concerto da solista nelle sale del Regio Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e un telegramma, di due anni dopo, lo informò che i suoi «concerti di Brescia» erano rimandati (Telegramma del 25 febbraio 1921).
Nel 1891 convolò a nozze con Arnaldo Ferraguti (1862 ‒ 1925), pittore, illustratore e a sua volta collaboratore a più riprese di Gabriele d’Annunzio, soprattutto per l’allestimento della tragedia La figlia di Iorio nei primi mesi del 1904, e questo matrimonio finì col consolidare l’amicizia e la confidenza tra la donna e il Vate. L’anno dopo, la coppia diede alla luce il primogenito Mario (1892 ‒ 1976), dal brillante futuro accademico e politico, agronomo al fianco di Mussolini nella “battaglia del grano”; poi nacque Alessandro (1896 ‒ 1971), che sembra ereditasse le doti musicali della madre se il musicologo Giulio Confalonieri lo salutò come un «genio mancato» sul numero di «Epoca» del 2 aprile 1972, ad un anno dalla morte (Rebora 2006); infine nel 1904 nacque Renata. Dal carteggio con il poeta emerge questo suo ruolo di madre premurosa, che si preoccupa del «malatino che continua ad avere un po’ di febbre» (Lettera del 9 febbraio 1902), da identificare con Alessandro – Sandro. Per questo figlio, molti anni dopo, ormai laureato in medicina ma che «non sente di fare il medico», che definisce «spirito randagio e senza riposo» e «spina della vita mia e di suo padre», chiede una raccomandazione sempre al Vate: la preghiera è di farlo «imbarcare come medico di bordo su di una bella nave che tocchi le terre lontane» (Lettera del 2 agosto 1924).
Il carteggio (1901 ‒ 1934). Le ultime ricerche d’archivio
Il carteggio è in effetti il principale strumento, se non l’unico, per ricostruire i rapporti tra Gabriele d’Annunzio e Olga Treves Ferraguti ed è consultabile presso gli archivi della Fondazione del Vittoriale degli Italiani. Le lettere scritte dalla donna si trovano nella cartella «Olga Treves Ferraguti» dell’Archivio Generale, quelle di pugno di d’Annunzio sono conservate nella cartella con il nome della donna appartenente all’Archivio Personale, insieme a cartoline e a telegrammi. La corrispondenza dura dal 1901 al 1934, e attraversa varie fasi in cui muta la natura del rapporto tra i due. All’inizio il loro fu un semplice legame d’amicizia, maturato alla luce di una decennale conoscenza del poeta con il marito di lei e della frequentazione comune del salotto dei fratelli Treves: di questa fase è testimone appena una manciata di documenti, una lettera del 5 marzo 1901 in occasione dell’inaugurazione dell’Università Popolare di Milano al Teatro Olimpia, e delle cartoline inviate da d’Annunzio nella tarda primavera 1902, spedite dalla zona di Trieste e di Gorizia dove era impegnato nella tournée della Francesca da Rimini. Ma le carte successive documentano una svolta imprevista nel giro di pochi mesi, inedita fino a recenti ricerche d’archivio (Di Valerio 2023): all’incirca dall’autunno 1902, d’Annunzio fu l’amante segreto della coniugata Olga. In quei mesi infatti, sicuramente a ottobre e novembre, il poeta, già all’epoca alle prese con la stesura delle Laudi, dopo l’estate fruttuosa passata nel Casentino, fu ospite a Villa Cordelia presso Giuseppe Treves (Andreoli 2000, p. 385). Lì e allora, evidentemente, «c’era stato il tempo», nel senso biblico del libro dell’Ecclesiaste (3, 1 ‒ 8) citato da Olga nella lettera del 23 marzo 1903, per il loro amore: nella stessa missiva la Treves ricorda appunto a d’Annunzio «l’autunno sul lago, il rilasciamento del tuo cervello dopo i grandi sforzi, i conversari colle donnucole, l’aria molle, la vita pura, la forza dormiente». La prima dichiarazione d’amore esplicita che s’incontra nel carteggio è affidata d’altronde sempre alla «viva voce» della donna:
Vedo già spuntare il tuo sorriso dubbioso; lavoro, non so quale forza mi costringa alla dissimulazione del mio ardore. Forse il presentimento confuso che la conoscenza del mio diminuirebbe il tuo amore che è pure la mia vita stessa! Tu m’hai incendiata. Io vivo – o perirò – nel fuoco che tu hai acceso senza pietà (Lettera del 31 dicembre 1902).
Poche righe più avanti, Olga rincara la dose, vagheggiando una passione tanto assoluta quanto improbabile, almeno considerando il temperamento del poeta:
Vorrei essere l’Unica! S’io lo fossi porterei il mio peccato come un manto di porpora! Così come tu sei – alto e solo ad abbellire il mondo colle tue canzoni, così vorrei esser io – alta e sola – ad abbellire la tua vita col mio amore.
La corrispondenza «occulta» (1902 ‒ 1903). Il romanzo di un amore
Queste lettere che attestano la relazione clandestina vanno dal 4 dicembre 1902 al 13 novembre 1903 e sono contenute in una cartella diversa da quella «ufficiale» con il nome di Olga Ferraguti Treves dell’Archivio Generale, rinvenuta solo recentemente attraverso un riferimento incrociato contenuto nella cartella dell’Archivio Generale con materiale del marito Arnaldo Ferraguti (Di Valerio 2023).
Sempre da questo nucleo di lettere a lungo rimaste nascoste, si è capito che il senhal Maria Dastro, riferito in precedenza, anche dalla Andreoli (Andreoli 2000, p. 423), alla sola Giuseppina Giorgi Mancini, amante del periodo 1907 – 1908, fu originariamente usato proprio per Olga. È lei a dirgli
Scrivi a Maria Dastro, fermo in posta Imma se vuoi far sparire la piega triste della mia bocca che l’attesa va scolorando» (Lettera del 18 febbraio 1903).
Da questo dettaglio, speculare al fatto che la Treves inviasse le sue missive indicando come destinatario Rocco Pesce, il maggiordomo conterraneo dell’amato, si evince chiaramente come i due mantenessero un doppio canale di corrispondenza: uno ufficiale, formale, in cui recitare la parte degli innocenti amici di lungo corso; l’altro, occulto, parallelo, clandestino che dir si voglia, in cui lasciare libero sfogo ai ricordi, alle confessioni, alle aspettative, ma anche alle incomprensioni, d’amore. Una corrispondenza occulta che però agli occhi di un ipotetico lettore si presenta necessariamente come un monologo della donna, non essendosi ancora rinvenute le missive di risposta di mano del Vate, che evidentemente furono distrutte, ed è sempre Olga Treves a svelarlo:
Ho finito poco fa di cremare i cari fogli. Non ho osato di tenerli più a lungo […]. Eppure avrei dovuto sfidare l’apprensione, disobbedirti, conservare in qualche buca sotto terra il mio solo bene duraturo! (Lettera del 9 febbraio 1903).
D’Annunzio dunque l’avrebbe convinta a questa «distruzione mostruosa», a questo «sacrificio sproporzionato», bruciare le sue lettere, il che è un altro dettaglio biografico interessante, singolare, considerando che il poeta, per quanto l’abbia nascoste, ha invece conservate quelle scritte a lui. Ad ogni modo, tutte le precauzioni prese dalla coppia clandestina furono vane almeno agli occhi di quella che la Treves presto ribattezzò, sprezzante, «la nemica»: una figura di sesso femminile, forse già legata a d’Annunzio da un qualche tipo di rapporto o solo innamorata di lui. Si legge infatti in una lettera:
Lei è la fortunata, quella che ha arso prima e ha sofferto dopo, quella che non dovette ardere e soffrire insieme, vedendo sul cuscino lo spettro del passato. (Lettera del 18 febbraio 1903).
La figura anonima quasi certamente aveva sorpreso gli amanti in atteggiamenti compromettenti, pur non facendone parola con nessuno, ma tra le due donne dovette comunque scattare un’acerrima competizione: si instaurò così una sorta di ménage à trois, con il poeta nel mezzo, conteso. Per contrastare l’odio, ampiamente ricambiato, della nemica, la Treves così incalza l’amante:
Se ti preme d’evitare una catastrofe cosacca conduci il pretendente, e fa che tutto si combini rapidamente. Vieni subito e portalo subito! Noi non sappiamo ardere sullo stesso rogo. Dividici se vuoi salvarci. (Lettera del 18 febbraio 1903).
E riferisce che quella stessa, poi, le ha scritto
Una preghiera che pare un’ingiunzione ed è carica d’oscure minacce. «Serviti dei tuoi argomenti» dice, «perché egli venga ai primi di marzo con l’altro». (Lettera del 23 febbraio 1903).
Insomma, la nemica aveva un pretendente ufficiale, il cui tramite evidentemente era lo stesso d’Annunzio, se viene chiesto proprio a lui di portarlo, per risolvere il triangolo. Questi dettagli hanno contribuito ad individuare l’identità misteriosa della rivale: nel corso dell’anno 1903, infatti, il poeta fece da sensale matrimoniale, in combutta con Giuseppe Treves, per nessun’altro se non per Annibale Tenneroni (1855 – 1928), letterato e bibliotecario conosciuto negli anni romani, diventato amico e collaboratore fidato soprattutto per le ricerche bibliografiche, ma ancora non accasato a cinquanta anni. Tenneroni era innamorato di una donna appartenente alla cerchia di casa Treves, ovvero di Ketty Nagel (1862 ‒ 1914), che alla fine effettivamente sposò il 6 dicembre 1903 grazie alla citata mediazione di d’Annunzio, rimasta però a lungo inspiegata dai biografi fino alle recenti ricerche riguardanti il carteggio con Olga (Di Valerio 2023). Nipote di Virginia Tedeschi (1849 ‒ 1916) ‒ in arte Cordelia, moglie scrittrice di Giuseppe Treves ‒ Ketty era all’epoca addetta agli uffici amministrativi della casa editrice, nonché traduttrice e scrittrice. Dunque non a caso Olga angosciata chiede all’amante:
Per quale necessità ch’io ignoro hai tu inflitto alle creature già strettamente unite — una tortura così rovente? (Lettera del 18 febbraio 1903).
L’astio tra le due contendenti dovette in ogni modo continuare anche dopo il matrimonio combinato, se spesso la donna infarcì le sue lettere a Verga con «scenette briose come quelle riguardanti i coniugi Tenneroni» (Raya 1986, p. 19), nelle quali il pettegolezzo sfocia spesso in un’ironia malevola dai risvolti grotteschi, con l’evidente scopo di esorcizzare quella certa carica aggressiva ancora in azione nei confronti della Nagel, antica rivale.
La relazione tra Olga Treves e d’Annunzio andò avanti nella primavera 1903, segnando una prima battuta d’arresto testimoniata dalla lettera del 23 marzo 1903, quando la donna definisce il poeta, scarso di attenzioni nei suoi confronti perché impegnato a terminare i primi tre libri delle Laudi, «un bene intriso di molto male», e rassegnata lo apostrofa: «Non ti domando neppure perché non vieni più. Così dev’essere, la vita ci divide». Azzarda anche un’analisi della fenomenologia della loro passione, di amara e lucida consapevolezza:
Negli ozii dei pomeriggi lenti e mediocri le curve molli piacciono ai tuoi occhi esperti che spogliano. E tu aspetti l’amore come la settima aspetta l’accordo di risoluzione.
Nel carteggio segue un silenzio di due mesi circa, non è dato sapere se dovuto a lacuna, o a una reale crisi tra i due; poi la relazione sembra continuare, e si arriva alla misteriosa lettera del 29 maggio 1903, quando la Treves, terrorizzata, chiede:
Hai ricevuto tutte le nuove lettere? Questa è l’ultima, la decima. Sono tutte nelle tue mani? Le hai distrutte come ho distrutto le tue? Una di quelle lettere basterebbe per perdermi. Non ho più dubbi. S’è avverata la sgradevole cosa! Io credevo ‒ ma invece non sopporto. Amico mio, tu saprai dall’amica comune se sarò viva, morta, o malata. Io tremo e non posso scrivere. Ho troppo da soffrire!
E d’Annunzio, come si diceva, verosimilmente dovette distruggere le lettere, celando quindi un segreto ancora più compromettente della stessa relazione adulterina, della quale, invece, sono state mantenute ampie testimonianze, evidentemente. Si possono formulare due ipotesi sulla natura della «sgradevole cosa»: o il marito, Arnaldo Ferraguti, oppure qualche altro membro di casa Treves aveva scoperto la coppia clandestina; oppure nelle lettere precedenti Olga, sempre più in preda ai malesseri tipici, preannunciava al poeta una gravidanza e gliene diede conferma con questa del 29 maggio. A far propendere decisamente per la seconda ipotesi è però anche la frase successiva «saprai dall’amica comune se sarò viva, morta o malata»: potrebbero sembrare delle espressioni di rito dettate dalla paura per l’eventuale reazione del consorte scopertosi tradito, ma in verità confermano l’ipotesi che la donna si stia riferendo ad una gravidanza. Come infatti riportato nella lettera di Giuseppe Treves a Giovanni Verga del 20 marzo 1902 (Raya 1986, p. 212), Olga aveva subito un aborto spontaneo tra 1900 e 1902, e si era ristabilita soltanto dopo circa due anni, rischiando la vita. Insomma, la donna aveva dei seri motivi per paventare che il fatto stesso di essere incinta potesse rappresentare per la sua salute una minaccia fatale, tanto da farle temere di morire o di ammalarsi gravemente: uno stato d’animo perfettamente in linea con le espressioni della lettera. La «sgradevole cosa» dovrebbe quindi essere proprio un riferimento alla gravidanza della donna, che, partorendo poi la figlia Renata agli inizii di febbraio 1904, alla fine di maggio 1903 doveva comunque già essere in stato interessante. Si comprende facilmente allora come il ruolo e le responsabilità di Gabriele d’Annunzio in questa gravidanza sono per forza di cose ambigui: densa di significati impliciti è l’evidenza, documentata dalle lettere appena viste, che, nel periodo del concepimento, il Vate aveva ancora un rapporto clandestino con la Treves. E non è la sola, a leggere tra le righe: la terzogenita Ferraguti porta infatti lo stesso nome, Renata, dell’unica amatissima figlia riconosciuta dal poeta, Renata Montanarella, nata nel 1893 dal matrimonio con Maria Gravina (Di Valerio 2023).
La maternità dovette rappresentare, in ogni modo, un grosso ostacolo alla già precaria relazione. La lettera della definitiva rottura del vincolo amoroso, e quindi anche l’ultima degna di interesse circa il canale occulto di corrispondenza tra i protagonisti, è datata 13 novembre 1903. Anche tra queste righe di commiato amoroso non mancano passi sibillini, espressioni fortemente allusive che ad un occhio malizioso sembrerebbero ventilare la responsabilità del poeta, o meglio la sua «paternità», come viene chiamata senza perifrasi anche se in riferimento alle Laudi, riguardo alla «prossima maternità» di Olga:
Voglio scrivervi una lettera buona, caro amico! – Mi dicono che presto verrete – caro amico. Le Laudi me lo dicono; lo dicono al mio cuore avvilito, scuotendo le loro teste superbe. Voi verrete a prodigar loro le amorose cure paterne, rivedrete la città nebbiosa e una povera amica atrocemente sformata dalla maternità. Prossima inesorabile maternità! ‒ Vorrei vedervi… a poco a poco… per poterlo sopportare. Sono tanto malata e fragile. Abbiate pietà! Voi leggerete sul mio viso stanco quello che è bene non scrivere e un profumo leggero vi riporterà al passato per un attimo, nel momento propizio alla commozione.
La missiva si chiude con una promessa: «Perdonate! Non scriverò più – mai più!». Promessa tutto sommato mantenuta, come si diceva, tranne per un paio di lettere intime del 1906. Da questo momento in poi, Olga non scrisse più nella veste di amante: a partire dal 1904, e per 30 anni, fino al 1934, le lettere, tutte di corrispondenza ufficiale, tornano a testimoniarci un rapporto di amicizia ormai più che decennale, velato di continue nostalgie verso i tempi passati.
La corrispondenza «ufficiale» (1904 ‒ 1934). Il romanzo di un’amicizia
Analizzando le altre lettere della corrispondenza, si nota come la donna si confermi un’attenta e appassionata lettrice di d’Annunzio dal quale, in più occasioni nel corso degli anni, riesce a ottenere copie delle opere appena varate, tramite gustosi escamotages frutto dell’ironia, una delle tante frecce nella faretra della sua vivacissima e godibilissima penna. Era già successo, nel 1903, con una copia della Francesca da Rimini, succede, molto probabilmente, con la tragedia La Nave (Lettera del 4 agosto 1908), con una copia di un discorso tenuto nella rovente estate del 1919 (Lettera del 13 giugno 1919), con il volume del Venturiero senza ventura (Lettera del 2 agosto 1924) e infine con Il Notturno (Lettera del 20 dicembre 1929). Oppure, il filo diretto che può vantare con d’Annunzio le dà la possibilità di confrontarsi direttamente con l’autore sulla natura stessa di quelle opere, sogno proibito di ogni lettore appassionato. Ad esempio gli scrive:
Dal mare, sul finire di luglio vi avevo scritto a lungo: La favilla che parla di creta e delle vostre mani aveva acceso in me il bisogno di dire, di parlarvi, vincendo ogni scoraggiamento (Lettera del 20 settembre 1911).
Così in risposta, qualche mese dopo, il poeta:
Come fui contento di sapere che leggete con attenzione le “faville”! Che strano effetto mi fa, di vedere quella prosa in un giornale quotidiano! E quanto mi piacerebbe di udire le riflessioni meneghine su l’argomento! (Lettera del 26 marzo 1912).
Sono circostanze che confermano la raffinatezza e l’elevata cultura della donna, i cui pareri letterari erano tenuti in profonda considerazione da parte del Vate. A tal punto che in alcune occasioni è lo stesso d’Annunzio a confidarle per primo i moventi profondi della sua ispirazione, svelandole i meccanismi reconditi sottesi al processo creativo di un’opera:
Ier notte terminai la «Parisina». La quale è una vera e propria tragedia, concepita musicalmente, con larghe parti corali, con opposizioni potentissime di colore, e con un fondo poetico che richiederà – nel compositore ‒ il dono divino dell’ispirazione – e una scienza non meno alta dell’ispirazione. Dopo la malvagia avventura della Figlia di Iorio, son diventato prudentissimo. Allora si trattava di un’opera già nota e consacrata; ora si tratta di un’opera inedita, la quale non avrà la sua vita scenica se non insieme con la musica (Lettera del 26 marzo 1912).
Si parla della Parisina, che Pietro Mascagni compose su libretto appunto di d’Annunzio tra 1912 e 1913, e si fa riferimento alla versione musicata della Figlia di Iorio del maestro Alberto Franchetti del 1906, di scarso successo. La lettera è di risposta a una congiunta di Olga e di Arnaldo, in cui la coppia raccomanda al poeta «un musicista di vero talento», al quale l’editore Lorenzo Sonzogno, dopo averlo udito a Roma, aveva pensato di affidare proprio la Parisina (Lettera del 18 marzo 1912). Ma nel primo messaggio i coniugi hanno dimenticato di indicare il nome del giovane, e così d’Annunzio gliene chiede conto:
Quanta fede mi chiedete dunque, voi e Arnaldo! Dovrei affidare l’opera mia a un giovine – valente ‒ del quale non soltanto non conosco il valore ma nemmeno il nome!
Come si scopre dall’accorata replica di Olga, il nome era quello di Luigi Ferrari Trecate (1884 ‒ 1964), poi divenuto compositore e importante organista, autore di fiabe teatrali di successo e vicepresidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che aveva avuto come maestro al liceo musicale di Pesaro proprio Pietro Mascagni, al quale infine venne comunque affidata l’opera. Lo scambio è dunque significativo anche del rapporto confidenziale tra il poeta e Olga Treves, se la donna non mancava di chiedergli favori per i suoi giovani protetti artisti.
D’altronde, quella della donna era una cultura in primo luogo musicale, che la porta a chiosare un’altra lettera con una veloce ma dotta disamina della biografia e carriera verdiane:
Oramai siamo rientrate in città – la Scala si è già riaperta con un’infelice esumazione verdiana sul finire della prima maniera, all’inizio della seconda, probabilmente in quell’infelice svolta di chi lascia la strada vecchia esitando e incespicando (Lettera non databile).
O ad evocare in tono scherzoso Wagner e Debussy, compositore quest’ultimo che nel 1911 aveva musicato Le Martyre de Saint Sébastien: «Per voi Siegfrid ritornerebbe alla foresta e l’Isle joyeuse di Debussy vi prodigherebbe i suoi sottili incanti di colore» (Lettera del 4 agosto 1919). O ancora, sapendo di ingolosire l’esteta musicofilo, imbastisce un’astrusa chiusa per i digiuni della disciplina: «Con devota amicizia vi saluta la vecchia esecutrice dell’Andantino di Michelangiol Rossi» (Lettera del 1 ottobre 1922). D’Annunzio, d’altronde, descrive chiaramente come si svolgevano le occasioni in cui i due riuscivano ad incontrarsi: «Sono tanto infelice pensando che perdo le belle ore di musica e d’amicizia» (Lettera non databile). Un’amicizia che negli anni si fa nostalgica dei tempi andati di Pallanza, per d’Annunzio: «E mi ricordo delle sere musicali di Pallanza, tanto lontane, che sembrano riavvicinarsi» (Lettera non databile); come per Olga:
Tutto vi racconterò ma preferirei tacere e ascoltarvi, come un tempo quando si era così giovani. Ricordate? Non si è più giovani – ahimè! Tutto questo rinverdire d’erbe e di fronde è vuoto di senso. La natura manca d’imprevisto – tutto si ripete sempre nello stesso modo – nel peggiore dei mondi (Lettera del 18 aprile 1913).
E i ricordi riaffiorano numerosi nel vagheggiare questa sorta di età dell’oro, i soggiorni in riva al lago a Pallanza, ospiti di Giuseppe Treves a Villa Cordelia, così chiamata in onore della moglie Virginia Tedeschi, o a Villa Olga, dedicata proprio alla Treves, comprata dai coniugi Ferraguti nel 1895 ma già venduta nel 1900 per ripianare la situazione economica familiare (Rebora 2006). La località verbanese diventa così un vero e proprio locus amoenus, complice l’invio di vecchie fotografie da parte del poeta, che si autodefinisce «il pastore di questa piccola greggia feminile così mal vestita» (Lettera del 31 marzo 1913):
Vi ricordo lassù, quando si correva intorno alla fontana di Villa Cordelia. Eravate il più fanciullo, così ridente e avido da far paura e gioia. Ma voi era la nostra legge – allora ‒ e vi seguivamo senza volontà come dei piccoli soldati entusiasmati, pronti al trapasso (Lettera del 7 aprile 1913).
«Nella mia vita tutto si perde al di qua e al di là del ricordo e dell’attesa», così scrive la donna il 31 agosto 1917, e in effetti su questo doppio binario procede il resto del carteggio, con incontri rievocati, appuntamenti dati e non rispettati, rincorsi, intervallati da sollecite richieste di notizie da parte di entrambi, sull’altro e sui suoi cari. Una corrispondenza che attraversa e accompagna gli anni dell’esilio francese del poeta, poi della guerra: per esempio, a conflitto non ancora scoppiato, nel febbraio 1914, Olga colse come occasione per scrivere all’amico l’annuncio del fidanzamento tra il primogenito Mario Ferraguti e la cugina Emilia Mosso (1890 ‒ 1937), detta Mimì. Figlia unica di Maria Treves, a sua volta figlia di Emilio, e di Angelo Mosso, illustre medico e fisiologo torinese, Mimì fu educatrice e scrittrice, biografa dello scrittore Edmondo De Amicis e del nonno Emilio, oltre che curatrice dell’edizione delle prime lettere del carteggio tra questi e Gabriele d’Annunzio, uscita per «L’Illustrazione Italiana» nel 1923 (D’Annunzio 1999, p. 243). Il Vate non potè assistere alle nozze celebrate il 5 gennaio 1915, ma rimediò inviando un dono per gli sposi accompagnato da una lettera, dove descrive all’ amica la sua nuova sistemazione parigina di Rue Geoffroy ‒ L’Asnier numero 26:
Vi scrivo nella malinconia («Las! Merencolie») d’una verdissima casa francese del secolo XVII, «entre cour et jardin», mentre la campana del Convento attiguo squilla e i passeri fanno un gran ciarlìo beccando la mia canape e la mia mollica (Lettera del 2 gennaio 1915).
Poche righe più avanti è il poeta stesso a svelare il regalo di nozze che ha personalmente fabbricato per i due sposi:
In questi tempi duri, non posso mandare se non un piccolo dono fragile: un vetro soffiato da me, antico vetraio muranese, che mi son ridato all’arte del fuoco (non potendo andare al fuoco) in una fornaretta ch’io ho nella via Humblot.
In chiusura il poeta si dice «triste e inquieto», in riferimento alla mutata situazione internazionale, con il conflitto deflagrato alla fine di giugno del 1914 e la Francia in guerra già dal 4 agosto, a causa dell’avanzata del Reich tedesco in Belgio, Lussemburgo e in alcune sue regioni nord orientali. Espliciti riferimenti alla guerra si trovano così nella risposta di ringraziamento di donna Olga:
Davvero verrete per la prima della «Fedra»? Ciò mi sembra più inverosimile della condizione di pace, pur altrettanto desiderata!.. Oso raccomandarvi di non passeggiare per Parigi col naso in aria. Pensando alle insidie aeree vorremmo sapervi tappato nella casa conventuale (Lettera del 22 gennaio 1915).
Effettivamente d’Annunzio poi non tornò a Milano per la prima della Fedra musicata da Ildebrando Pizzetti, tenutasi al Teatro alla Scala il 20 marzo 1915, e ciò dimostra quanto bene Olga conoscesse l’indole dell’amato amico: il Vate rientrò in Italia, per restarvi sino alla fine dei suoi giorni, solo il 3 maggio ‒ giorno in cui il Ministro degli Esteri Sydney Sonnino ratificò il ritiro dell’Italia dalla Triplice Alleanza ‒ arrivando alla stazione di Genova la sera del 4. Il giorno successivo, 5 maggio, l’Imaginifico tenne a Quarto l’orazione Per la sagra dei Mille, inaugurando le «radiose giornate» del maggio 1915 (Andreoli 2000). Dalla risposta di ringraziamento si apprende inoltre che il vetro soffiato non fu l’unico regalo per la coppia, ma d’Annunzio ne spedì un altro speciale, allora tragicamente di moda, per lo sposo Mario:
Gli sposi sono bersagliati dal richiamo alle armi del bersagliere e marito, il quale – considerando il vostro elmetto prezioso – si prepara a dare gli ultimi esami d’ufficiale complementare, arso da tutte le febbri della giovinezza.
«Dono allo sposo soldato questo elmo germanico da me per lui raccolto sui campi insanguinati della Marna», recitava infatti la dedica con cui il poeta accompagnò il dono dell’elmo brunito (Rebora 2006, p. 27). L’epilogo di questo scambio di missive nuziali è idealmente rappresentato da quella del 20 agosto 1917, quando Olga gli annuncia la nascita del nipotino Sergio Ferraguti, figlio della coppia:
Forse l’ultima mia vi sarà giunta? Lo spero – oggi vi annunzio il mio avanzamento al grado di… nonna. È nato un bimbo. Bello con due occhi lucenti – tutto mio per questi primi giorni – vorrei tanto vostre care notizie. Scrivetemi un rigo volando e la mia riconoscenza saprà raggiungervi ovunque – dovunque siate vi pensa e saluta l’amica Olga.
La guerra era invece ancora lontana dall’avere un epilogo, al cui esito vittorioso per l’Italia contribuì, materialmente e spiritualmente, proprio d’Annunzio con gesta eclatanti come il volo su Vienna del 9 agosto 1918, così prontamente salutato dall’amica: «Leggo dell’azione gloriosa; siamo tutti raggianti e commossi! All’Eroe tutte le rose della Riviera!» (Lettera del 10 agosto 1918). Ugualmente, nelle battute finali, poco prima della battaglia di Vittorio Veneto e dell’armistizio di Villa Giusti (ottobre ‒ novembre 1918), la Treves sembra volersi informare direttamente da quello che era «uno dei maggiori – se non il maggiore artefice dei nuovi destini d’Italia!» (Lettera del 15 ottobre 1918), partecipando sinceramente allo slancio patriottico di tutta la Nazione, ma soprattutto del suo «caro amico grande e lontano».
Il carteggio si protrae fino agli anni del Vittoriale, nonché gli ultimi di vita di d’Annunzio, al quale, pur non incontrandolo da molto tempo, nel 1932 la donna desiderò far conoscere il fidanzato della figlia Renata:
Caro amico,
che da anni non rivedo, permettetemi una preghiera, lasciate che il fidanzato di Renata vi porti il nostro saluto. Ve lo presento: il giornalista avv. Raffaello Guzman che è a Gardone per le gare motonautiche. Egli sogna d’essere ammesso alla vostra presenza ed io non dispero per lui; anzi, vi prego e riprego con l’insistenza tutta femminile che vorrebbe saper vincere anche i grandi rifiuti!.. . Guzman vi porterà anche il mio «grazie» per il divino Messaggio che ha sollevato le spoglie del povero Guido verso il Cielo della più grande Gloria (Lettera del 21 maggio 1932).
Era infatti da poco venuto a mancare il fratello di Olga, Guido, che dal 1916, anno della dipartita dello zio Emilio, aveva diretto la gloriosa casa editrice di famiglia, con il quale d’Annunzio coltivò rapporti di amicizia e collaborazione (su questi rapporti si veda Di Tizio 2014). Era stato anzi suo testimone nel 1909 nelle nozze con Antonietta Pesenti (1882 ‒ 1978), amica e corrispondente anche lei del Vate (Iannuzzi 2008), citata di sfuggita in qualche lettera della cognata Olga, come quando riferisce di essere stata da lei informata sulla salute del poeta dopo il volo dell’Arcangelo del 13 agosto 1922: «Da Antonietta so che tutto è oramai superato e che siete perfettamente ristabilito. Dio ne sia lodato» (Lettera del 1 ottobre 1922). D’Annunzio venne invitato infine anche alle nozze tra Renata Ferraguti e Raffaello Guzman (1905 ‒ 1984), giornalista automobilistico per «Il Messaggero» e per «Il Tempo», celebrate il 18 gennaio 1934 a Santa Maria dei Miracoli in Piazza del Popolo a Roma. L’opportunità dell’invito in sé, dopo anni che la donna e il poeta non si erano più visti, denuncia la sollecitudine della madre nel volerlo presente al matrimonio, guarda caso, di Renata, ultimo indizio lasciato da Olga Treves Ferraguti per suggellare un cerchio che si chiude in simbiosi con il carteggio stesso, undici anni prima la sua scomparsa, avvenuta nel 1945.
Conclusione
Incrociando i dati biografici a disposizione e il contenuto delle lettere scambiate con Gabriele d’Annunzio e non solo, è evidente come Olga appaia una figura femminile sui generis in rapporto all’epoca in cui visse. Una donna colta, pianista professionista, amante del teatro e appassionata di letteratura, anzi vera e propria animatrice, tra le tante, dei salotti culturali dei fratelli Treves, mantenendo inoltre negli anni una corrispondenza diretta anche con Giovanni Verga. Già Raya notava come «le stesse lettere al Verga rivelano una cultura e una spigliatezza […] senza visibile sforzo letterario, con una spontaneità ch’è testimoniata da certi periodi trasandati e dall’abbondanza dei punti esclamativi» (Raya 1986, p. 19). Pure nel caso dello scrittore siciliano, si sottolineava «la complessità del sentimento» provato dalla donna nei suoi confronti, suggerita da espressioni «con sfumature troppo accorate o ambigue per non oltrepassare il loro significato letterale» (Raya 1986, pp. 19 ‒ 20).
Questa non indifferente cultura di Olga Treves traspare plasticamente anche dal carteggio conservato al Vittoriale: uno stile sintatticamente impeccabile, per di più scorrevole, vivace, impreziosito da registri sempre diversi ma sempre efficaci, che contemplano l’intera tavolozza dei colori di cui può ornarsi il mezzo comunicativo. Dal tono appassionato ed esplicito delle lettere vergate in preda alla passione più travolgente e carnale, a quello più innocente ed onirico dell’amore sentimentale, all’ironia spensierata, anche ad una intelligente autoironia, per ridere insieme all’amante complice, che però sa presto mutarsi nel livido sarcasmo, nel disprezzo e nella disapprovazione per il poeta, veicolati a chiare lettere oppure evocati con un linguaggio allegorico, obliquo. Di glaciale chiaroveggenza sono poi le missive in cui la donna sembra essersi definitivamente persuasa della natura effimera del rapporto con d’Annunzio: il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, senza perifrasi, raggiunge picchi di lucidità, di disillusione quasi violenta, e le «frecce avvelenate» che Olga scaglia assomigliano molto alle invettive lanciate dagli antidannunziani di ogni epoca, letterari e non.
Insomma, dalle righe scritte da Olga Treves Ferraguti viene fuori l’avvincente romanzo di una passione, e poi di un’amicizia, che avvolge la curiosità di chi le legge nelle sue continue svolte, così imprevedibili, tormentate e brillanti come la donna che le visse e le fissò sulla pagina.
Bibliografia essenziale
Annamaria Andreoli, Il vivere inimitabile, Milano, Mondadori, 2000
Arnaldo Ferraguti 1862 ‒ 1925. Tra pittura e letteratura alla fine di un secolo, a cura di Sergio Rebora, con la collaborazione di Maria Cristina Brunati, Massimiliano Cremona, Mariella Milan, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2006
Gabriele d’Annunzio, Lettere ai Treves, a cura di Gianni Oliva, Milano, Garzanti, 1999
Franco Di Tizio, Guido Treves e d’Annunzio negli anni del declino della Casa Editrice, Pescara, Ianieri, 2014
Simone Di Valerio, «Vorrei essere l’Unica!». Lettere inedite di Olga Treves Ferraguti a Gabriele d’Annunzio, «Archivio d’Annunzio», vol. 10, ottobre 2023, pp. 139 ‒ 153
Lina Iannuzzi, D’Annunzio e la Comarella, Pescara, Ianieri Editore, 2008
Maria Pia Pagani, Elena Michajlovna Vyvodcova, «Russi in Italia», https://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=774
Gino Raya, Verga e i Treves, Roma, Herder editore, 1986