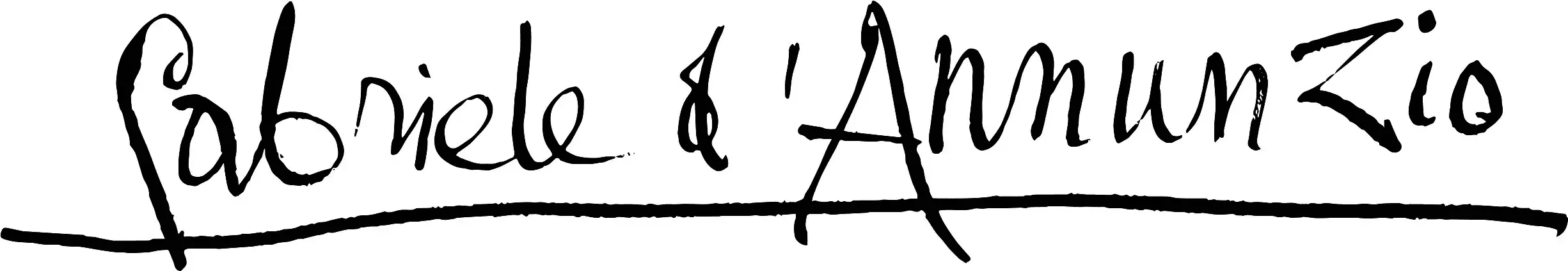di Pietro Sarzana, Enciclopedia dannunziana
La cultura di Ada Negri
Fu sui banchi della scuola che Ada Negri (1870-1945) iniziò ad amare «i vènti azzurri dell’Odissea, […] l’irruente cavalcata notturna degli endecasillabi dei Sepolcri, e sovra tutto certe immobili e portentose serenità del Leopardi» (Negri 1921a, 82): ciò fu dovuto essenzialmente all’insegnamento e alla passione del suo professore di italiano nella Scuola Normale Femminile di Lodi, l’esule triestino Paolo Tedeschi, che fu anche il primo a intuire le potenzialità scrittorie della sua alunna lodigiana. Ma non si può certo dimenticare il ruolo della madre, Vittoria Cornalba, che con le sue letture serali le diede modo di conoscere precocemente molti autori della letteratura francese come Ponson du Terrail, Hector Malot, Xavier de Montépin, Eugène Sue, Alexandre Dumas père e soprattutto Emile Zola.
Giunta poi a fine secolo a Milano, indiscutibilmente a quei tempi la capitale culturale d’Italia, Ada nei decenni successivi ebbe modo di approfondire le sue letture soprattutto nell’ambito della letteratura francese contemporanea: Eugénie de Guérin e Francis Jammes, Alfred De Musset e Lucien Descaves, Mme de Staël e Anatole France, Marguerite Audoux e George Eliac, Simone Bodève e Marianne Damad, Maxime du Camp e Gustave Flaubert, Blanche Marie de Fischer, i fratelli de Goncourt, Charles Foley furono certamente fra le sue letture. Senza dimenticare i belgi George Rodenbach e Maurice Maeterlinck, lo svizzero Jules Ernest Tissot e autori di lingua inglese, da Elisabeth Browning a George Eliot, da Israel Zangwill a Gilbert Chesterton e ad Agnès Tobin, cui fu dedicata la sua prima recensione nel 1903. Nel corso degli anni poi la sua competenza culturale andò arricchendosi della conoscenza di scrittori italiani e stranieri di assoluto primo piano, da Dostoevskij a Victor Hugo, da Ibsen a Whitman, da Carducci a Fogazzaro, da Pascoli a Fontana, da Buzzi a Gozzano; e ancora Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Amalia Guglielminetti.
In questo quadro di conoscenze, anche raffinate, certamente poliedriche, stupisce l’assenza di qualsiasi commento o recensione all’opera di D’Annunzio, praticamente suo coetaneo, che aveva esordito giovanissimo nel 1879 e che a fine secolo dominava la scena italiana ed europea, mentre Ada Negri iniziava la sua carriera poetica. Per lui nemmeno un cenno, nell’arco di una produzione critica più che trentennale, che vede puntualmente e tempestivamente recensiti molti scrittori italiani, tra cui Giovanni Bertacchi e Paola Lombroso, Guido Gozzano ed Enrico Cavacchioli, Alessandrina Ravizza e Federigo Tozzi, Massimo Bontempelli e Marino Moretti, Gaspara Stampa e Margherita Sarfatti.
Riferimenti significativi al Vate non si trovano neppure nell’immenso epistolario, dove è possibile incontrare numerosissimi letterati, critici e giornalisti, da Agnoletti ad Angelini, da Bacchelli a Benco, da Beonio Brocchieri a Bontempelli, da Borgese a Buzzi, da Cecchi a Croce, dalla Deledda alla Duse, da Falqui a Flora, da Gentile a Govoni, da Linati a Gianna Manzini, da Guglielmo Marconi a Fausto Maria Martini, da Momigliano a Montale, da Marino Moretti a Ugo Ojetti, da Pancrazi a Panzini, da Papini a Pascarella, da Piovene a Romain Rolland, da Matilde Serao a Bonaventura Tecchi, da Arturo Toscanini a Federigo Tozzi, da Diego Valeri a Orio Vergani a Giuseppe Villaroel. Gli unici due brevi accenni si trovano in una lettera a Fernando Agnoletti del gennaio 1922 dove scrive: “Una mia pagina di puri e sinceri ricordi natalizii è nel Numero di Natale di Novella. Te la manderò. Anzi, ti manderò il Numero, se lo ritrovo: contiene due Leggende di Natale di Gabriele d’Annunzio, soavissime. Hai letto il Notturno? Vuoi che te lo invii?” e in una ad Eleonora Duse del 21 gennaio 1923 dove è un breve riferimento alla Città morta.
Gabriele d’Annunzio e Ada Negri: possibili incroci
Eppure le occasioni per incrociare il Vate non erano certo mancate, fin dai primissimi anni del Novecento, in special modo sui periodici cui entrambi collaboravano: dall’Illustrazione Italiana a Nuova Antologia, dal Secolo XX al Marzocco, dalla Lettura al Corriere della Sera, dal Giornale d’Italia al Rinascimento all’Eroica. E non si può dimenticare la loro presenza nel volume in onore di Roberto Sarfatti, giovanissimo eroe di guerra, figlio della cara amica Margherita, morto a diciotto anni sull’altopiano dei Sette Comuni.
Ma tornando al Notturno, si può immaginare che, a dispetto dell’esiguità del riferimento, la lettura dell’opera dannunziana da parte della Negri sia stata attenta ed esaustiva, e che nella sua capacità di assorbire e trasformare i suggerimenti degli autori che leggeva, ella ne abbia tratto indicazioni fondamentali per l’opera che avrebbe realizzato di lì a poco, I canti dell’isola (Negri 1924b). In realtà già nel precedente Libro di Mara (Negri 1919b) la poetessa era approdata a un verso lungo che da un lato certamente si riallaccia all’esempio whitmaniano, ma che sicuramente trova nuovi spunti nella prosa notturna di D’Annunzio. Questo è visibile nell’utilizzo di un ritmo cadenzato, quasi cantilenante, e nelle atmosfere trasognate, che si pongono in forte contrasto con le passioni intense che la protagonista delle due raccolte vive: nel Libro di Mara l’amore struggente per un giovane morto precocemente («uragano di amore e di morte» lo definisce Ada in una lettera al Patrizi: Giardini 2000-01); nei Canti dell’isola la passione altrettanto ardente (anche se ormai pacificata) per l’incantevole isola di Capri.
Il dannunzianesimo del Libro di Mara
Nella prima delle due sillogi, cui Ada lavora a partire almeno dal 1916, l’intensa emotività della protagonista e il tormentoso rimpianto per la morte dell’uomo amato sono resi con accenti dolorosi e solenni: passioni estreme dipinte con una terminologia intenzionalmente esuberante, in un impasto stilistico di penetrante efficacia. Molte delle scelte lessicali appaiono qui ispirate a quelle dannunziane, ad esempio nella poesia Il sole e l’ombra, dove espressioni come la «bianca vibratile fiamma» (Il sole e l’ombra, v. 3, in Negri 1919b, 1) o «l’incendio dell’aria» nel giorno assolato (Negri 1919b, 1) rinviano esplicitamente a sintagmi usati dal pescarese («Le larghe onde di quella musica metallica si propagavano per l’incendio dell’aria», Il piacere in d’Annunzio 1988, 357). Così gli «artieri obbedienti» (Il costruttore, v. 2 in Negri 1919b, 49) che collaborano con il costruttore amato dalla donna rimandano agli «artieri delle antiche fogge» delle Laudi (Canto di festa per Calendimaggio, v. 27 in d’Annunzio 1984, 402); e la «nascente luna» (Accettazione, v. 10 in Negri 1919b, 34) verso cui ella affranta volge il viso può avere le stesse caratteristiche della luna che il Vate ammira presso l’Affrico, la «nascente luna, in cielo esigua come | il sopracciglio de la giovinetta» (Lungo l’Affrico, vv. 11-12 in d’Annunzio 1984, 427).
E se la protagonista di Notturno nuziale è stata «ghermita» come Berenice da Glauco in Alcyone, gli «occhi dell’anima», gli «occhi senza palpebre» (Il trionfo della morte I, 4 in d’Annunzio 1988, 682) con cui Giorgio Aurispa guarda l’amante sono gli stessi «occhi senza pàlpebre» con cui piange la protagonista del Libro di Mara (Anniversario, v. 20 in Negri 1919b, 58). Ancora il «mistero sacro dei monti» (La sera fiesolana, v. 38, in d’Annunzio 1984, 430) può aver ispirato il «mistero inviolabile d’ombra» dell’amato che appare in sogno alla donna (La mano, v. 5 in Negri 1919b, 59), così come nella stessa poesia la «menta selvaggia» (La mano, v. 9 in Negri 1919b, 59) è l’identico arbusto che profuma il mare nella Città morta. La «torbida sofferenza» di Ada è forse la «torbida sofferenza interiore» che prova Andrea Sperelli nel Piacere; mentre i «murmuri | di polle nascoste» (La terra, v. 8 in Negri 1919b, 66) riprendono il «mare | di murmuri e di brividi» di Canto novo (Canto del sole. XI, vv. 11-12 in d’Annunzio 1982, 150) e gli «acri fermenti» si estendono da Maia (Laus Vitae. V. Il vento avverso, v. 134, in d’Annunzio 1984, 45) all’Ode canicolare (v. 45 in Negri 1919b, 89).
Il dannunzianesimo dei Canti dell’isola
Più o meno negli stessi anni Ada Negri inizia a comporre le liriche che confluiranno alla fine del ’24 nei Canti dell’isola, dove sono ribadite le scelte metriche e lessicali del Libro di Mara. Nell’una e nell’altra raccolta si trovano ad esempio riferimenti a quei colori cangianti, a quelle tinte di estrema raffinatezza, che appare ragionevole pensare siano di derivazione dannunziana: l’azzurrigno e il verdiccio nel Libro di Mara, la porpora, il violetto e il turchino, l’amaranto, l’argento, l’ametista nei Canti dell’isola; sfumature di colori che contribuiscono a ingentilire il dettato, regalandogli un’impronta di estetismo. D’altronde anche la trasfigurazione di fiori, animali, luoghi e persone, attuata con uno stile ricco di echi panici, rimanda con ogni probabilità a testi dannunziani. Come dubitare infatti che i «lucenti vitiferi colli» che ingemmano Anacapri («Il Rosaio», v. 1, in Negri 1924b, 54) non siano altrettanto incantevoli dei «vitiferi colli» di Montecorno rievocati in Canto novo (III, v. 8 in d’Annunzio 1982, 203)? O che gli «occhi di smalto» non siano stati traslati direttamente dal Notturno (d’Annunzio 2005, 268) ai Canti dell’isola («Il Rosaio», v. 1, in Negri 1924b, 55)? E l’immagine della «tristezza d’essere eterna» che chiude Addio della luna (v. 8, in Negri 1924b, 64) non rinvia forse alla «tristezza dell’eterna solitudine» che coglie Giorgio nel Trionfo della morte (d’Annunzio 1988, 975)? Nella Cintura di giada infine l’eleganza delle metaforiche pietre («le perle del pianto, e i diaspri della passione, | e gli smeraldi della speranza, e le ametiste della nostalgia», vv. 4-5, in Negri 1924b, 19) rinvia alle numerose squisite gemme che d’Annunzio dissemina nella sua opera: le agate, i diaspri e gli avori del San Pantaleone (San Làimo navigatore, in d’Annunzio 1992, 495), i «diamanti, camei, perle e smeraldi» della Chimera (La chimera, Donna Francesca, VIII, v. 8, in d’Annunzio 1982, 481), e ancora agate, ametiste, topazi, granati e turchesi nel Fuoco (Il fuoco. II. L’impero del silenzio in d’Annunzio 1989, 376).
Sempre a proposito di colori, si potrebbe far riferimento al sangue del Vate che «ha la vivacità di una rosa di porpora» (Notturno. Seconda offerta in d’Annunzio 2005, 305), ma che colora anche le «rose di porpora» che Ada intende portare sulla tomba dell’amato (Per la tomba, vv. 1 e 3, in Negri 1924b, 36); e il «drappo dell’ultimo sogno […] tramato in porpora», cioè il sudario chiesto alla tessitrice in vista della propria stessa morte (La tessitrice, vv. 5-6, in Negri 1924b, 79).
E ancora la clematide tinta di «un azzurro di viola, un turchino violetto, più denso e più cupo d’uno di quegli zaffiri misteriosamente sposati all’ametista» (Le faville del maglio, Il secondo amante di Lucrezia Buti, La bugia, in d’Annunzio 2005, 1419) è paragonabile al «càctus con grappe violette» (Rifugio fiorito, v. 2, in Negri 1924b, 33) e ai «chicchi violetti di grandine» del glicine che Ada osserva nell’”isola azzurra” (Il pergolato di glicini, v. 2, in Negri 1924b, 18). O si veda il «tulipano viola, d’un viola intenso, chiazzato di nero» (Viola e nero, v. 1, in Negri 1924b, 41); gli «occhi di gemma turchina» (L’uomo e la casa, v. 5, in Negri 1924b, 449); e il «pianto d’oro nel mar di viola» (Addio della luna, v. 1, in Negri 1924b, 63). Infine «l’alba color d’ametista» dei Canti dell’isola (Mattutino, v. 5, in Negri 1924b, 59) fa pendant col «ciel d’ametista» di Montecorno, dove brilla la falce d’oro della luna nuova (Canto novo, III, 8, v. 1, in d’Annunzio 1982, 203)
Tutto sembra insomma confermare una diligente e partecipe lettura dell’opera di d’Annunzio da parte di Ada Negri, da sempre pronta a cogliere nelle sue vastissime letture occasioni per arricchire e variare il proprio stile. E se il nome del Vate è pressoché assente negli scritti negriani, la motivazione di questo mancato sodalizio va forse semplicemente ascritta a un difetto di empatia, ben comprensibile in due caratteri profondamente differenti.
Bibliografia
D’Annunzio, G. (1935). Cento e cento e cento pagine del Libro segreto di D’Annunzio tentato di morire. Milano: Mondadori.
D’Annunzio, G. (1975). La città morta. Milano: Mondadori.
D’Annunzio, G. (1982). Versi d’amore e di gloria, vol. 1. Milano: Mondadori.
D’Annunzio, G. (1984). Versi d’amore e di gloria, vol. 2. Milano: Mondadori.
D’Annunzio, G. (1988). Prose di romanzi, vol. 1. Milano: Mondadori.
D’Annunzio, G. (1989). Prose di romanzi, vol. 2. Milano: Mondadori.
D’Annunzio, G. (1992). Tutte le novelle. Milano: Mondadori.
D’Annunzio, G. (2005). Prose di ricerca. Milano: Mondadori.
Giardini, L. (2000-01). Vita e scrittura nell’opera e nell’epistolario di Ada Negri [tesi di laurea], Firenze: Facoltà di Lettere e Filosofia, A.A. 2000/2001.
Negri, A. (1892). Fatalità. Milano: Treves.
Negri, A. (1903a). Recensione di Love’s Crucifix. Nine Sonnets and a Canzone from Petrarch by Agnès Tobin. Unione Femminile, 3 (1, gennaio, 11) (rist. «Recensione a Love’s Crucifix by Agnès Tobin». La Vita Internazionale, 6 (2 [20 gennaio 1903], 60).
Negri, A. (1903b). «Liriche umane». Recensione di Liriche umane, di Bertacchi, G. Corriere della Sera, 6 agosto.
Negri, A. (1905a). «Delitti d’amore». Corriere della sera, 18 agosto.
Negri, A. (1905b). «Il poema della vecchiaia». Corriere della sera, 27 agosto. 80 Negri, A. (1906). «I ‘figli della Madonna’». Corriere della sera, 24 aprile.
Negri, A. (1907). «Eugénie de Guérin». Recensione di Journal et fragments, di de Guérin, E. Corriere della sera, 7 settembre (rist. Rivista minima, 10 (41, 17 settembre 1907, 305-7; rist. Rivista per le Signorine, 18 (6, giugno 1911, 59-66).
Negri, A. (1909a). «La signorina Felicita ovvero la felicità». Recensione di La signorina Felicita ovvero la felicità, di Gozzano, G. Nuova Antologia, CXXXIX, sr. V, 894, 228 (rist. Corriere della sera, 27 maggio 1909).
Negri, A. (1909b). «A Enrico Cavacchioli». Poesia, 5 (7-8-9, agosto-settembre ottobre, 43).
Negri, A. (1909c). Recensione di Princesses de Lettres, di Tissot, E. Corriere della Sera, 5 dicembre.
Negri, A. (1910). «La vita è buona». Recensione di La vita è buona, di Lombroso, P. (zia Mariù). La Donna, 6 (124, 20 febbraio, 14).
Negri, A. (1911a). Recensione di Marie Claire, di Audoux, M. Corriere della sera, 12 gennaio.
Negri, A. (1911b). «Maria Di Borio». La Donna, 7 (149 (5 marzo, 20-1) (rist. Rivista per le Signorine, 19 (2-3, 31 gennaio-15 febbraio 1912, 22-4).
Negri, A. (1911c). «Notre-Dame de Pleurs». Recensione di La vie douloureuse de Marceline Desbordes Valmore, di Descaves, L. Il Marzocco, 16 (21, 21 maggio, 1-2).
Negri, A. (1911d). «Storia di una vocazione». Recensione di Vers les sommets En haut! Lettres de la Comtesse de Saint Martial, di de Fischer, B.M. Il Marzocco, 16 (25, 18 giugno, 1-2).
Negri, A. (1912a). «L’anima e il salotto di Julie de Lespinasse». Recensione di Un après midi chez Julie de Lespinasse, di Eliac, G. Il Marzocco, 17 (7, 18 febbraio, 1-2).
Negri, A. (1912b). «Donne amate, donne amanti». Recensione di Femmes aimées, femmes aimantes, di Foley, C. Il Marzocco, 17 (21, 26 maggio, 1-2).
Negri, A. (1912c). «Bassifondi». Recensione di La Petite Lotte e Clo, di Bodève, S. Il Marzocco, 17 (24, 16 giugno, 2).
Negri, A. (1912d). «Gli uni e gli altri». Recensione di Pour une autre, di Damad, M. Il Marzocco, 17 (31, 4 agosto, 1).
Negri, A. (1912d). «Una donna e un libro». Recensione di Nota della lavandaia, di Ravizza, A. Il Marzocco, 17 (26, 30 giugno, 1).
Negri, A. (1913a). «Quelle che lavorano». Recensione di Celles qui travaillent, di Bodève, S. Il Marzocco, 18 (28, 13 luglio, 3).
Negri, A. (1913b). «Rileggendo Gaspara Stampa». Il Marzocco, 18 (42, 19 ottobre, 1-2).
Negri, A. (1914). Esilio. Milano: Treves.
Negri, A. (1918). Roberto Sarfatti: le sue lettere e testimonianze di lui. Milano: Istituto Editoriale Italiano.
Negri, A. (1919a). «Con gli occhi chiusi». Recensione di Con gli occhi chiusi di Tozzi, F. L’illustrazione italiana, 46 (22, 1 giugno, 555).
Negri, A. (1919b). Il libro di Mara. Milano: Treves.
Negri, A. (1920). Recensione di La vita intensa di Bontempelli, M. I libri del giorno, 3 (10 (ottobre, 527-8).
Negri, A. (1921a). Stella mattutina. Roma; Milano: Mondadori.
Negri, A. (1921b). «Le donne dei romanzi nuovi. Meneghina, serva». Recensione di La voce di Dio di Moretti, M. La Donna, 17 (342, 20 gennaio, 23).
Negri, A. (1924a). «Italiani ad ogni costo». Recensione di Tunisiaca, di Sarfatti, M. L’Ambrosiano, 3 (56, 5 marzo, 1. 81).
Negri, A. (1924b). I canti dell’isola. Milano: Mondadori.
Negri, A. (1928) Sorelle. Milano: Mondadori.
Negri, A. (1934). Recensione a Fernando Agnoletti. Arte mediterranea, 2 (2, marzo-aprile, 33-6).
Negri, A. Lettera a Balsamo Crivelli (10 febbraio 1911). Fondo «Ada Negri», lettera 7/4. Lodi: Fondazione Banca Popolare di Lodi. https://bit.ly/3wJbI8u.
Negri, A. Lettera a Balsamo Crivelli (28 agosto 1913). Fondo «Ada Negri», lettera 7/18. Lodi: Fondazione Banca Popolare di Lodi. https://bit.ly/3Twlip2.
Negri, A. Lettera a Fernando Agnoletti (3 marzo 1919). Fondo «Ada Negri», lettera 1/12. Lodi: Fondazione Banca Popolare di Lodi. https://bit.ly/3CEAr1w.
Negri, A. Lettera [gennaio 1922]. Fondo «Ada Negri», lettera 1/75. Lodi: Fonda zione Banca Popolare di Lodi. https://bit.ly/3KBQLlK.
Pellicanò, G. (2017). Due vite. Una storia. Le lettere di Ada Negri a Ettore Patrizi 1892-1896. Orvieto: Intermedia.
Sarzana, P. (2022), Ada Negri e d’Annunzio: un mancato sodalizio?, «Archivio d’Annunzio», 9, 2022 (https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/archivio-dannunzio/2022/1/art-10.30687-AdA-2421-292X-2022-01-007.pdf), di cui la presente scheda è una rielaborazione aggiornata.
Senna, P. (2017). «Un’occasione mancata. Cinque lettere di Ada Negri a Gian Dàuli». Otto/Novecento, 1, 177-86.
Stagnitti, B. (a cura di) 2008. Diorami lombardi. Carteggio (1896 1944). Ada Negri e Paolo Buzzi. Padova: Il Poligrafo. 82