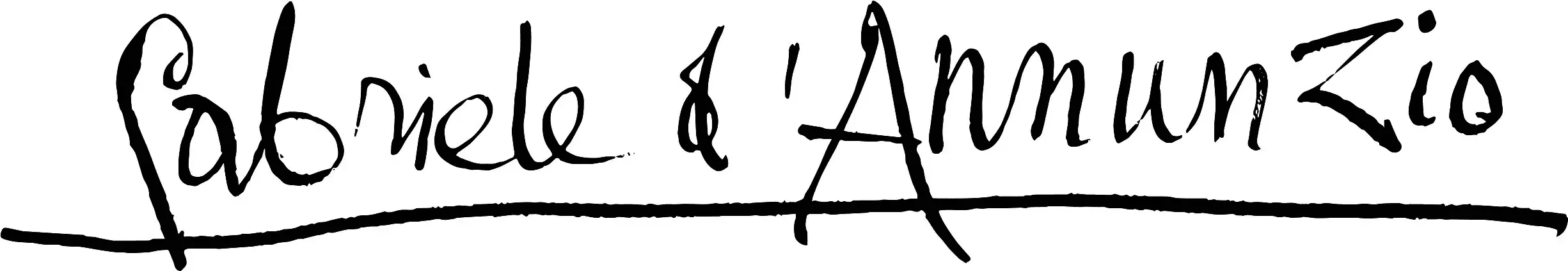di Elena Aceto, Enciclopedia Dannunziana

Giselda Zucconi è la maggiore dei nove figli di Tito Zucconi. Quest’ultimo, insigne patriota e pregevole letterato, succede a Vincenzo Bianchi nell’insegnamento delle lingue straniere presso il collegio Cicognini nell’anno scolastico 1880-81, lo stesso che per il giovane d’Annunzio chiude la lunga clausura pratese.
Esigue ed incerte sono le notizie biografiche su Giselda: secondo il barone Giuseppe Rapisardi (I. Ciani, 1985, p. 51), legato alla donna da vincoli di parentela ed amicizia, ella nasce il 7 ottobre 1864 a Pratolino, comune di Fiesole, nella villa di campagna della zia Amalia, sorella maggiore di sua madre.
Per tre anni Gabriele d’Annunzio manterrà con la figlia del suo stimato maestro il «primo, cospicuo e significativo epistolario amoroso» (I. Ciani, 1985, p. 7), avviato dallo stesso, nella primavera del 1881, con quest’audace missiva:
[Prato,] 29 aprile 1881. Ore 10 ½ di sera
Ora che tutti dormono, e che di fuori è bujo, e che non si sente né un grido né un canto, ora se tu sapessi come ti vedo bene qui nel fondo del mio cuore co ’l tuo viso bianco e i grandi occhi neri pieni di luce e di pensiero!… Tu che fai? Sai tu ch’io t’amo? Forse dormi? Sogni? Mia, mia, mia Giselda!… Provo una gioia intensa nel dirti così, e insieme ho paura, sì, ho paura. Tu chi sei? Dimmelo chi sei. Se tu fossi una maga? Se tu mi uccidessi con un raggio del tuo sorriso? (G. d’Annunzio, 1985, p. 15)
Prima di confessare il proprio amore a colei che assurgerà ufficialmente a dignità di ‘prima Musa’ (A. Andreoli, 2000, p. 69), il giovane Gabriele d’Annunzio si era già recato una volta, ignaro dell’imminenza dello strale di Cupido, a far visita al professor Zucconi.
Ospite a Firenze del convittore Mario Foresi durante le vacanze pasquali del 1881, il nostro aveva approfittato della permanenza nell’ex capitale per approfondire la conoscenza del maestro toscano, «il cui fascino derivante da una solida cultura filologica e da una facile vena poetica si sommava a quello insito nel passato di esule politico e di eroico combattente garibaldino» (I. Ciani, 1985, p. 7). L’indomani 16 aprile, un’altra visita aveva seguito la prima e, verosimilmente, muoveva da un ulteriore proposito, quello di rivedere Giselda:
La seconda volta eri vestita di nero: eri più cara, io ti voglio veder vestita sempre così. Fu allora che il mio Toto ti commosse; e fu allora che tu entrasti tutta nel mio cuore. (G. d’Annunzio, 1985, p. 15)
L’affinità elettiva, scoperta per mezzo della lettura del bozzetto abruzzese da poco pubblicato sul «Fanfulla della Domenica», darà luogo ad un altro incontro, il 20 aprile; mesto rendez-vous, questo, per via dell’incombente ritorno in collegio di Gabriele:
Poi quella sera, quella brutta sera!… Avevi l’abito chiaro e gli occhi più lucidi del solito; io avevo la morte nel cuore e il capo confuso. Ti dispiacque veramente che io non potessi restare? (Ibidem)
A partire dal 29 aprile, data della prima epistola d’amore, i giovani avviano una corrispondenza fitta ed appassionata, corredata sovente di fiori sfogliati, fotografie, poesie, nonché, più avanti, di notizie circa la produzione e la pubblicazione, presso le riviste romane, di molta materia poetica dannunziana, tra cui i «Canti marini» (Ivi, p. 43), ovvero quei Thalassica di cui il nostro aveva già parlato a Paolo de Cecco, e i «Canti di maggio», che con tutta probabilità confluiranno nel libro I del Canto novo
Pur impegnato nella preparazione per l’esame finale, Gabriele non si mostra insensibile agli afflati poietici emanati dalla sua prima musa, per la quale, anzi, inizia a vagheggiare ambiziosi progetti d’arte, sospinto dalla fiamma dell’amore:
Io ti canterò; ho concepito delle liriche divine: di fronte a te Lilia e Nemesi impallidiranno. Io sono stato un po’ scettico fino ad ora in fatto di amore; non credevo che nell’amore si potesse fare una così profonda astrazione del senso. Ora mi ricredo; tutte le mie donne poetiche sono fantocci, son burattini di legno con delle teste di cera. Tu, tu fremerai, piangerai, riderai nelle mie strofe, palpiterai di vita vera, mi darai immagini meravigliose e armonie transumane. (Ivi, p. 19)
In estate, finalmente liberato dalla clausura pratese, d’Annunzio si precipita a Firenze, dove, ospite degli Zucconi, si tratterrà dall’1 al 6 luglio: dolci giorni nei quali gli innamorati tenteranno di appagare il desiderio maturato negli atroci mesi di lontananza, e che dal poeta verranno nostalgicamente rievocati nelle lettere, prima dalla città natale, e poi, a partire dalla metà di novembre, da Roma, dove aveva scelto, infine, di frequentare l’università, spegnendo definitivamente le speranze dell’amata, fiduciosa nella possibilità che il nostro optasse invece per l’Istituto di Studi Superiori di Firenze.Da Pescara, in particolare, il giovane d’Annunzio coinvolge idealmente l’amata nella riscoperta di quella Terra vergine che pure l’aveva generato, e di cui, per ora, apprezzerà unicamente l’elemento naturale, compendiato nelle missive da quel trittico mare-fiume-monti che già campeggiava nelle liriche di Primo Vere (1879) e che ora torna per echeggiare l’amoroso ardore.
Non solo, nelle lettere ad Elda vengono testimoniati anche i primi frutti di quel lavoro poetico che, di lì a poco, avrebbe preso forma cosciente ed organica nel Canto novo (1882), «la prima, vera, e per molti aspetti decisiva parola poetica dannunziana» (I. Ciani, 1982, p.16), di cui lei sarà dedicataria.
Il patimento per la lontananza da Lalla, esibito soprattutto nella corrispondenza di agosto, verrà individuato dal giovane Gabriele come movente di una dissennata (quanto prevedibile) défaillance, confessata prontamente nella lettera del 13 agosto:
Il fatto si è che la sera e la notte di domenica furono un orrore per me. Ricorsi a un rimedio violento: in quello stato non potevo durare; ricorsi all’orgia, ai folli piaceri. […] Oh perdonami, perdonami! Ma perché non dovrei dirti tutto, tutto confessarti, o mia buona, o mia buona, o mia buona madonna? Fui indegno di te in quelle ore, ma con il corpo soltanto; l’anima era pura; all’anima non bastavano quelle orgie; all’anima ripugnavano quei baci comprati; l’anima spasimava atrocemente e si contorceva senza trovare un momento, un momento solo d’oblio; era rimorso, era angoscia inesprimibile, che era?, che era? (G. d’Annunzio, 1985, p. 196)
Comunque, da Roma, pur oberato da svariati impegni che non manca di restituire puntualmente alla sua «fata», d’Annunzio seguita ad inviarle lettere con cadenza giornaliera, fino al periodo natalizio, per trascorrere il quale preferirà l’alcova fiorentina al focolare pescarese.
Le due settimane in casa Zucconi a cavallo tra il 1881 e il 1882 ridestano nel giovane slancio e devozione, ben attestati nelle missive inviate ad anno nuovo. Alle suppliche di Lalla per un nuovo incontro in primavera, tuttavia, d’Annunzio sembra indugiare: l’intensa attività giornalistica presso «Il Fanfulla» e la «Cronaca Bizantina», come pure l’impegnativa poiesi di Terra vergine (1882) e di Canto novo (1882), si sommano alle contrarietà del padre di lui, secondo il quale lo status della fanciulla fiorentina per nulla conveniva al nome del figlio, destinato alla fama poetica. Da qui, un esibito parossismo di disperazione:
Io non la leggerò più questa tua di oggi: ci sono delle frasi che mi son rimaste inchiodate nell’anima. Una specialmente, una di cui forse né anche tu hai misurata tutta la tragica terribilità. Tu scrivi: “Morire, morire! Almeno finirebbero tutte le battaglie! Chi sa come sarebbe contento il tuo babbo!”
Oh, non l’avresti dovuto dire: io voglio credere, sì, voglio voglio, ho bisogno di credere ch’egli non sarebbe contento. Se fosse altrimenti, io, te lo giuro, mi ucciderei non solo per raggiungerti, ma anche per non avere l’inesprimibile spasimo di odiare chi mi ha dato la vita. (D’Annunzio, 1985, p. 309)
In gennaio si fanno decisamente più consistenti nelle missive le trascrizioni di alcune liriche dal Canto novo, di imminente pubblicazione: sei poesie del II libro, due del III e una inedita, nelle quali, rispetto al testo edito in primavera, «Lalla» viene sostituito da «Elda» e, complessivamente, sembra venir ribaltata, quando non direttamente espunta, la materia negativa di certi versi, «per adeguarli al contenuto generalmente positivo di una lettera d’amore» (G. Beniscelli, 1982, p. 139).
A marzo si aggiunge pure l’incursione di alcuni parenti del poeta, smaniosi di scoprire con lui le meraviglie della capitale; per placare l’irrequietezza della «fata», le missive vergate dal nostro traboccano di promesse circa il ricongiungimento venturo, che egli prefigura come sempre più vicino e più dolce, sebbene puntualmente osteggiato dalla permanenza imprevista degli zii e dal timore che il severo genitore possa accorgersi del perdurare della relazione. Un altro, e forse più efficace, balsamo per lenire i tormenti di Lalla sono le notizie circa lo stato dell’opera a lei ispirata e dedicata:
Sai?, te l’ho detto? Il 20 di Aprile oltre il Canto novo, dedicato a… non mi rammento a chi, uscirà la Terra vergine, volume di novelle dedicato a Nannina sorella mia. Libri dedicati ad angeli devono aver fortuna per necessità; no? (Ivi, p. 367)
Tuttavia la partenza per Firenze, prevista l’11 aprile, verrà prorogata; nonostante le mille accortezze del poeta, Francesco Paolo sospetta:
Non verrò, aspetterò ancora qualche altro giorno.
Jeri l’altro ebbi una lettera di mio padre; è una lettera crudele. Egli sospetta ch’io in questi giorni venga da te; non lo dice apertamente, ma lo fa capire e fa trasparire dalle sue parole una minaccia. Poi aggiunge che probabilmente egli sarà a Roma quanto prima per affari e che io stia sull’avviso. (Ivi, p. 371)
Altri e sempre nuovi obblighi costringono d’Annunzio a Roma anche nel giorno dell’«anniversario divino» (Ivi, p. 367), e tanti altri ne trascorreranno prima che egli lasci la capitale il primo maggio, non alla volta di Firenze, ma verso le terre di Sardegna, per un reportage commissionato dal «Capitan Fracassa», in compagnia di Cesare Pascarella ed Edoardo Scarfoglio.
In risposta, Lalla dedica al suo adorato carnefice «dieci pagine atroci» (Ivi, p. 392) che daranno al nostro linfa poetica per redigere missive colme di sgomento e malinconia, benché prive di rimorso. Accordatogli il perdono, Elda potrà rivederlo solo tre settimane dopo, il 14 giugno; le lunghissime lettere del 26 e del 27 giugno rievocano dieci giorni inobliabili, trascorsi in un’«ebrezza indescrivibile d’amore» (Ivi, p. 409) e seguiti da grandissima angoscia.
Angoscia che avrà però breve termine: a partire da luglio, infatti, il poeta, preceduto dalla fama procuratagli da Terra vergine e da Canto novo, torna in Abruzzo, e le missive a Lalla, oppressa da una malattia nervosa e abbattuta dalla lontananza dell’amato, si accompagnano a quelle di un nuovo mittente, la sorella Nannina, che cerca di rassicurarla sui sentimenti del fratello:
È venuta su Nannina e mi ha portata questa piccola lettera per te: l’ho letta anch’io, scusa. Credo che quelle parole affettuose ti faranno bene all’anima. Se tu non vuoi dar retta a me, ascolterai almeno la mia povera sorella che ti conforta, che ti prega di non disperarti. (Ivi, p. 428)
Le premure di Nannina sembrano voler compensare quanto inizia a scarseggiare nelle lettere di Gabriele, le quali, soprattutto dopo il ritorno a Roma in novembre, perdono di intimità e regolarità.
Al nostro non mancano giustificazioni credibili, tra cui incombenze lavorative, improvvisi malanni e l’imperitura inflessibilità paterna, rivelate tuttavia con un’afflizione che stride decisamente con le vivaci abitudini e i frizzanti costumi intrapresi in questo periodo dal «Duca minimo» tra le strade e nei salotti della capitale.
Sicché, il Natale venturo non vedrà realizzarsi il desiderio di Giselda di riabbracciare il suo amato; per di più, le missive da parte del nostro si fanno sempre meno, – 5 lettere ed un telegramma a gennaio, una lettera ed un telegramma a febbraio -, ed il carteggio si chiude, a marzo (Ivi, p. 502), con la promessa di una risposta, verosimilmente mai redatta:
[Roma, 22.3.83]
Ricevuta tua lettera. Scrivo. Sono mezzo malato. Tristissimo. Addio.
Gabriele
D’altronde proprio in questo periodo d’Annunzio veniva accolto in una ben più nobile dimora, quella del duca Hardouin di Gallese, in qualità di precettore del suo rampollo, studente liceale in difficoltà; ma è sulla figlia che il nostro ebbe modo di testare le sue doti di seduttore, e «non tardò molto ad avere ragione di Maria, come egli poco signorilmente rivelò il 16 maggio 1883 pubblicando […] i molti espliciti versi del Peccato di maggio» (I. Ciani, 2001, p. 167).
Se l’abbrivio dell’anno 1883 doveva aver assistito all’estinguersi ineluttabile della fiamma d’amore per Lalla, in quello del 1896 il pensiero dell’ormai romanziere di fama internazionale era certo caduto sulla prima musa durante la rielaborazione di Canto novo, per la quale aveva sostituito all’intimo e vivo epiteto «Lalla», tenero interlocutore di svariate liriche nell’edizione sommarughiana, quello freddo e grecheggiante di «Ospite»: segno inequivocabile questo, corroborato inoltre dall’espunzione della dedica, della conversione poetica del sentimento di gioventù in un «simbolo dell’amore indefinito, del “piacere”» (J. Tosi-Rivet, 1982, p. 173).
Il 1921 convoglia invece due apparizioni di Elda, che riemerge dal buio della temporanea cecità nel Notturno (1921) come «compiuta donzella», e si riaffaccia altresì in una desolata missiva spedita da Firenze, il 20 ottobre.
Rompendo «quaranta anni di oscuro silenzio» (G. d’Annunzio, 1985, p. 505), Giselda Zucconi si trova nell’amara condizione di dover chiedere un favore all’antico innamorato, croce e delizia di gioventù: l’unico figlio rimastole dopo il suicidio del primo, non può sposare la donna amata perché sprovvisto di mezzi economici; per aiutarlo, Elda pensa di vendere ad un editore una parte delle missive inviategli dall’Imaginifico, ma necessita del consenso dell’ormai celeberrimo mandante.
Alla disperazione di Lalla il nostro risponde, il 24 gennaio del 1922 (Ivi, pp. 506-507), con parole che testimoniano uno spirito ancora indomito, una disposizione naturale alla sensualità poetica, ma anche una gratitudine sincera:
Cara Elda, faccio un ultimo tentativo per giungere a te.
[…]
Le lettere da Gardone raramente giungono a destinazione, se non sieno raccomandate.
La mia pervenne nelle tue mani?
Non ho nessuna notizia, da mesi. E il pensiero di te mi tormenta.
Perdonami. Oso affidare a uno dei miei più fidi legionari – Eugenio Coselschi – il carico di avvertirti, e di dichiararti che sono pronto a venirti in aiuto. Le lettere potranno essere recuperate da me, o da un amico, o da un editore fido, quando vorrai.
Nell’incertezza presente, rinunzio a dirti quel che m’è nel cuore.
Ma il ricordo della mia Elda non si oscurò mai, neppure nelle tenebre della mia cecità.
Ti mando il notturno. Troverai una pagina misteriosa − quella del “rossore” – che forse risolleverà in te quel nostro sogno musicale…
Non ti rammaricare d’avermi scritto. Non v’è in me nulla che non sia per te d’una dolcezza e d’una riconoscenza senza fine.
Gabriele
Ancora afflitta dalla malattia nervosa, Elda dà seguito alla travagliata corrispondenza svelando al primo amore le pene e le angosce di un’esistenza condotta, a suo dire, da uno «spietato destino» (Ivi, p. 509), che sembra averle concesso, a conti fatti, un unico momento di felicità, quella primavera della vita sognata insieme a lui. Commovente il pensiero dedicatogli in occasione dell’«anniversario divino» (Ivi, p. 513):
15 aprile 1881
[Firenze,]
15 aprile 1922
Carissimo Gabriele
Nella trepida ma fiduciosa attesa tornano i ricordi del passato.
Il più bello e il più rimpianto giorno della mia vita rammento a te, la tua
Elda
L’ultima missiva di Lalla a d’Annunzio risale al 25 novembre 1926; due anni prima il padre, il maestro Tito Zucconi, era morto, come pure, qualche tempo dopo, il marito, un modesto professore di disegno.
In questa lettera Elda annuncia all’antico amato di aver fortunatamente rinvenuto la restante parte dell’epistolario a casa della sorella, e lo sollecita affinché le dia il consenso per la pubblicazione, finora negato per proteggerne, secondo quanto si desume, la reputazione di moglie e madre.
Il Vate lascerà questa lettera senza risposta, forse perché adirato dal brutto tiro di Ugo Ojetti, che, il 22 agosto del medesimo anno aveva pubblicato quelle stesse missive rinvenute, in un articolo dal titolo Lettere d’amore, sul «Corriere della Sera» (ora in G. d’Annunzio, 1954, pp. 180-188); o forse perché dimentico, per una seconda volta, delle sorti della «strana bimba da li occhi erranti» (G. d’Annunzio, 1882, p. 7), la quale si spegnerà in una casa di cura per malattie mentali nel 1942.
Bibliografia essenziale
Le citazioni dalle lettere e dalle opere dannunziane sono tratte da:
G. d’Annunzio, Lettere a Giselda Zucconi, a cura di I. Ciani, Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani, 1985.
G. d’Annunzio, Canto novo, Roma, Casa Editrice A. Sommaruga e C., 1882.
G. d’Annunzio, Canto novo – Intermezzo (1881-1883), Milano, Fratelli Treves editori, 1896.
G. d’Annunzio, Prose di ricerca, di lotta, di comando, di conquista, di tormento, d’indovinamento, di rinnovamento, di celebrazione, di rivendicazione, di liberazione, di favole, di giochi, di baleni, vol. I, Milano, Arnoldo Mondadori editore, 1950.
Bibliografia secondaria
A. Andreoli, Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 2000.
G. Beniscelli, Per un’edizione critica del Canto novo, in Canto novo nel centenario della pubblicazione, Atti del IV Convegno internazionale di studi dannunziani (Pescara, 7-8 maggio 1982), Pescara, Ediars, 1983, pp. 135-146.
I. Ciani, Femmine, donne e alcune muse in id., Esercizi dannunziani, a cura di G. Papponetti e M. M. Cappellini, prefazione di P. Gibellini, Pescara, Ediars, 2001, pp. 163-177.
I. Ciani, La nascita dell’idea di Canto novo, in Canto novo nel centenario della pubblicazione, Atti del IV Convegno internazionale di studi dannunziani (Pescara, 7-8 maggio 1982), Pescara, Ediars, 1983, pp. 15-34.
G. Fatini, Il cigno e la cicogna. D’Annunzio collegiale, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1935.
T. Fracassini, Gabriele d’Annunzio convittore, Roma, Casa del Libro, 1935.
G. Gatti, Le donne nella vita e nell’arte di Gabriele d’Annunzio, Modena, Guanda, 1951.
J. Tosi-Rivet, La fortuna di Canto novo in Francia, in Canto novo nel centenario della pubblicazione, Atti del IV Convegno internazionale di studi dannunziani (Pescara, 7-8 maggio 1982), Pescara, Ediars, 1983, pp. 167-178.
M. Serra, L’Imaginifico. Vita di Gabriele D’Annunzio, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2019