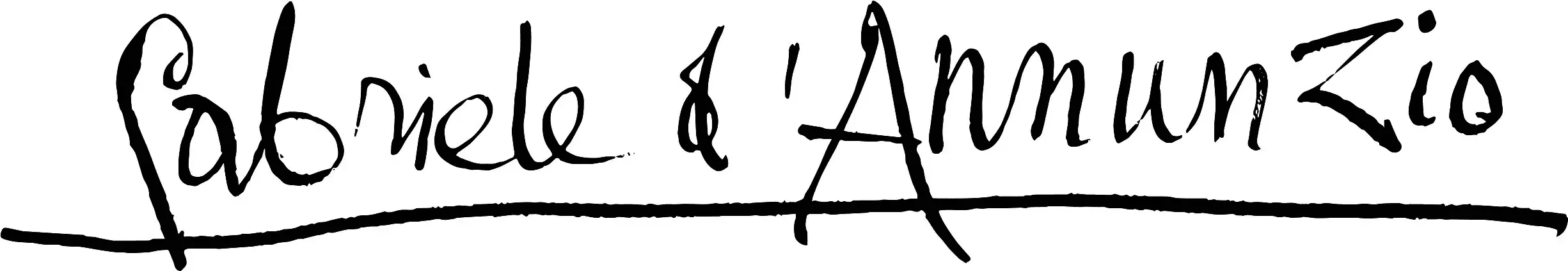di Fabio Cammilletti, Enciclopedia dannunziana
Genesi, elaborazione e vicenda editoriale
Quella che conosciamo e leggiamo come Trionfo della morte è opera dalla gestazione ramificata e complessa, che si prolunga su quasi cinque anni: situazione dovuta in parte a contingenze autobiografiche ma anche – e soprattutto – a un significativo riorientamento in termini di influenze e di poetica, che dall’estetismo disimpegnato de Il piacere conduce alla singolare commistione di vitalismo superomistico, nazionalismo e décadence de Le vergini delle rocce, primo e unico titolo dell’abortita trilogia dei Romanzi del giglio. È un transito, questo, del quale la storia compositiva del Trionfo appare il cardine, e non è dunque un caso se un primo germe di quello che sarà il romanzo affiori già nel marzo del 1889, in una lettera all’editore Treves, a due mesi dalla consegna del manoscritto del Il piacere e due mesi prima che l’esordio romanzesco di d’Annunzio arrivi nelle librerie. Si tratta, a questa fase, solo di un titolo – Un’agonia –che già preannuncia, tuttavia, alcuni dei motivi dominanti del romanzo che sarà, a partire dai temi della malattia mentale e dell’ereditarietà delle disposizioni suicidarie che d’Annunzio va esplorando tramite le opere, tutte d’area francofona, di psicologi come Théodule-Armand Ribot (Maladies de la mémoire, 1881; Maladies de la personnalité, 1883; Maladies de la volonté, 1885), filosofi come Henri-Frédéric Amiel (Fragments d’un journal intime, 1883-84) e scrittori come l’Émile Zola del ciclo dei Rougon-Macquart (1871-93) e Paul Bourget (Le disciple, 1889). La prima stesura ha luogo già nell’estate del 1889, di concerto a quell’altro congedo dal disimpegno estetizzante che è la collezione definitiva dell’Isaotta Guttadàuro. D’Annunzio spera in una pubblicazione periodica già nel primo autunno e in un’uscita in volume per novembre: di questa prima versione – intitolata L’Invincibile, ed embrionalmente influenzata da autori della rinascita spirituale russa come Fëdor Dostoevskij, oltre che dal già citato Amiel –verranno tuttavia materialmente scritti solo diciotto capitoli all’incirca, sedici dei quali pubblicati tra il 6 gennaio e il 16 marzo 1890 sulle pagine del settimanale romano “La Tribuna Illustrata”. Il 6 aprile di quell’anno, una nota redazionale chiuderà bruscamente la pubblicazione di questo primo testo, adducendo a motivazione la chiamata dell’autore alla leva militare. Tra il 1892 e il 1893 buona parte del materiale che componeva L’Invincibile – edito o inedito – verrà disseminato in varie forme: articoli, racconti e novelle indipendenti che escono, a volte con modifiche e integrazioni anche rilevanti, su vari periodici (Il violinista, “Rassegna per l’Arte”, 15 dicembre 1892; Lo straniero, “Il Mattino”, 1-2 gennaio 1893; Il primogenito, “La Nuova Rassegna”, 1, 2, 4, 22, 29 gennaio e 5, 12, 26 febbraio 1893). È una fase, questa, di ripensamento e riscrittura, che vede d’Annunzio rielaborare e integrare radicalmente quanto già prodotto alla luce di incontri fondamentali: quello col pensiero di Friederich Nietzsche, innanzitutto, letto in traduzione francese nel 1893, ma anche col Tristan und Isolde di Richard Wagner, pure giuntogli per il tramite della cultura d’Oltralpe in quello stesso anno; ed è da segnalare l’uscita del Lourdes di Émile Zola (1894), a ridosso della stesura e della pubblicazione definitiva del Trionfo, che oltre a segnalare un più ampio interesse transnazionale in tematiche analoghe può guidare d’Annunzio nel re-inquadrare il problema dell’irrazionale campagnolo, sviscerato già negli anni precedenti tramite la lettura di alcune opere sulla cultura popolare e il “mondo magico” abruzzese. L’assimilazione di queste nuove influenze determina un ampio riorientamento nella struttura del romanzo, che esce a puntate, sulle appendici de “Il Mattino” di Napoli, tra il 13 febbraio e l’8 settembre 1893 e fra il 21 aprile e il 7 giugno 1894 (ma già a maggio, per Treves, è apparsa l’edizione in volume). Prestissimo, già nell’estate del 1895, appare la traduzione francese di Georges Hérelle (Triomphe de la Mort, pubblicata a puntate sulla “Revue des Deux Mondes” e quindi in volume per l’editore parigino Calmann-Lévy), seguita da quelle inglesi di Arthur Hornblow (The Triumph of Death, G. H. Richmond & Co., New York 1896) e Georgina Harding (Heinemann, Londra 1898) e da quella tedesca di Maria Gagliardi (Der Triumph des Todes, Fischer, Berlino 1899). È del 1903 l’ascrizione del libro al ciclo dei Romanzi della Rosa, dei quali costituisce il capitolo conclusivo dopo Il piacere e L’innocente.
Se il nuovo titolo rimanda scopertamente a modelli trecenteschi – dal Petrarca dei Trionfi al tema del Triumphus Mortis nell’arte macabra e cimiteriale del XIV secolo –, la nota dedicatoria al pittore Francesco Paolo Michetti, preferito da ultimo a Giosuè Carducci nel nome di un’ideale comunione d’intenti tra artisti abruzzesi, reitera tale connessione rivendicando una continuità con “gli asceti, i casuisti, i volgarizzatori di sermoni, di omelìe e di soliloqui” del Trecento italiano: d’Annunzio non rinnega le ispirazioni originarie di Un’agonia – “concorrere efficacemente a constituire in Italia la prosa narrativa e descrittiva moderna” attraverso lo studio della moderna psicologia, in particolare di scuola francese – ma dichiara di volerle perseguire attraverso una comunicazione intergenerazionale “col Frate da Scarperìa, con Bono Giamboni, con Caterina da Siena, con Giordano da Ripalta, col Cavalca, col Passavanti”, comunicazione il cui veicolo principale sarà la “bella prosa musicale” che dai trecentisti è travasata nell’orecchio dei contemporanei più attenti. Accanto all’ispirazione neomedievale, infatti, a dominare la prefazione è l’idea che la prosa debba conservare un timbro ritmico, di modo da poter rivaleggiare con la “grande orchestra wagneriana nel suggerire ciò che soltanto la Musica può suggerire all’anima moderna”. La menzione di Wagner serve anche a creare un’eco con l’altro, importante elemento paratestuale che è la citazione, posta in epigrafe, dall’Al di là del bene e del male di Nietzsche: nonostante la divergenza che aveva allontanato il compositore dal filosofo già dai primi anni Settanta dell’Ottocento, d’Annunzio vede nel sodalizio tra Wagner e Nietzsche il disegno di un’arte totale ed extramorale che superi le aporie del romanzo psicologico à la Bourget, conciliando il cerebralismo che pare dominare la letteratura della fin de siècle col vitalismo oltreumano di Zarathustra. Non a caso, la citazione nietzscheana – presentata in tedesco e come tratta dall’originale Jenseits von Gut und Böse (1886), benché d’Annunzio non avesse letto Nietzsche che in francese e in forma antologizzata –introduce l’idea di un’ambivalenza dell’opera d’arte, letale per i fruitori dalla debole forza vitale (die niedrigere Lebenskraft) ma capace di invitare i prodi (die Tapfersten) a realizzare compiutamente il proprio potenziale eroico (ihrer Tapferkeit).
La prima ricezione italiana del Trionfo fu tiepida, anche per una diffidenza radicata e diffusa nel confronti del romanzo psicologico di matrice francese, cui l’opera fu frettolosamente assimilata, e incontrò valutazioni miste in ambito internazionale: ben accolto in Francia, il libro fu oggetto di critiche di carattere moralistico in ambito anglosassone, sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti.
Contenuto e struttura
La fabula del Trionfo della morte è estremamente esile, caratteristica peraltro comune alla quasi totalità della produzione romanzesca dannunziana: gli eventi esterni, i personaggi e le loro relazioni o il contesto paesaggistico e culturale rilevano esclusivamente in funzione del protagonista Giorgio Aurispa e delle conflittualità che lo abitano, e che lo spingono infine alla scelta del suicidio – più precisamente, dell’omicidio-suicidio assieme alla sua amante, Ippolita Sanzio – che pare inscritta nel romanzo familiare degli Aurispa a partire dalla morte autoinflitta di suo zio Demetrio. L’opera è divisa in sei libri, seguendo un movimento circolare che dal tentativo di fuga dalla morte da parte di Aurispa e Sanzio conduce, da ultimo, alla morte di entrambi, sul modello dei protagonisti wagneriani. Da un punto di vista geografico, l’azione è centrifuga: da quella Roma che de Il piacere era per molti versi la protagonista, Sanzio e Aurispa si spostano dal Tirreno all’Adriatico – Orvieto, Albano Laziale, le pendici della Maiella e infine la costa teatina – in un itinerario fisico e immaginale che prelude alla riscoperta dell’Abruzzo più ferino de La figlia di Iorio e de La fiaccola sotto il moggio.
Il primo libro, Il passato, si pone sotto il segno della fuga. Testimoni di un suicidio – premessa dell’azione e, al tempo stesso, anticipazione della chiusa del romanzo – Aurispa e Sanzio lasciano Roma nella speranza di liberarsi dalle ossessioni mortifere che li dominano. Come il titolo dichiara, il capitolo serve anche a d’Annunzio per delineare la storia pregressa dei due personaggi principali, l’uno in fuga dalla sua terra natale e dalla tabe familiare che immagina perseguitarlo, l’altra da un matrimonio fallimentare e violento e da una malattia che l’ha lasciata sterile. Tale incapacità di dare la vita è anche all’origine della singolare attrazione che Aurispa ha sviluppato per lei sin da subito: quanto attrae Aurispa, di Sanzio, è la morte che la donna porta con sé, e l’erotica delineata da queste prime pagine è segnata fin da subito da un sottotesto necrofiliaco, che si appunta sull’incarnato innaturalmente bianco di lei, sulla sua passività cadaverica e sulla sua bellezza androginica, che alla “primitiva” e ingannevole “purità virginale” del ventre unisce una “esiguità dell’anca” che “la faceva somigliare un giovinetto”. Al tempo stesso, inizia a emergere la differenza profonda che separa i due amanti, tra la volontà di donarsi di Sanzio e l’incapacità di Aurispa di ricambiare quel sentimento, immerso in un cerebralismo che sfiora l’ossessione. Il tentativo di sfuggire al labirinto romano si rivela fallimentare, e i due fanno ritorno in quella Roma dove “parve loro […] altro non si potesse che morire”.
Ne La casa paterna, secondo libro del Trionfo, mentre Sanzio si reca a Milano dalla sorella, Aurispa è costretto da questioni familiari a ritornare alla casa natale di Guardiagrele, borgo medievale del teatino. Il capitolo serve a d’Annunzio per sviscerare il contrasto tra il passato glorioso degli Aurispa – e dell’Abruzzo più rurale e selvaggio – e la degenerazione che ha colpito la famiglia, rivelata in tutta la sua sordidezza dal comportamento ambiguo e moralmente abietto del padre di Giorgio. Viene così introdotto il tema dell’ereditarietà delle inclinazioni morali e della propensione al suicidio, già al centro de L’Invincibile: il ricordo della morte di suo zio Demetrio, che si era ucciso con un colpo di pistola, spinge Aurispa a tentare un macabro esperimento di emulazione, dal quale lo salva il ricordo di Ippolita e dei “[m]ille fili invisibili” che “lo legavano ancóra alla vita”.
Il terzo libro, L’eremo, descrive il tentativo di Aurispa di ricostituire l’armonia perduta col mondo naturale e il proprio retaggio attraverso la vita a due con Sanzio in un borgo della costa adriatica. La donna, per l’occasione, pare trasfigurarsi in una beatrice capace di ricondurre il suo amato “alla forza fisica, alla sanità possente, a una vita di gioia quasi selvaggia, all’amore semplice e rude, alla grande libertà primordiale”, in un sogno panico cui Aurispa dà il nome dantesco (e paolino) di “Vita Nuova”: e La vita nuova si intitola difatti, sempre sul modello di Dante, il quarto libro, nel quale l’utopia di Aurispa finisce però per infrangersi al contatto con gli aspetti più sordidi e torbidamente superstiziosi del mondo popolare. L’episodio del bambino tormentato dalle streghe, ispirato a d’Annunzio dalla frenetica lettura di opere dedicate al folclore abruzzese, e soprattutto la descrizione della degradazione umana e del mercimonio che proliferano ai margini del santuario della Madonna dei Miracoli di Casalbordino – cui non è estranea l’ispirazione, come s’è detto, del Lourdes di Zola – spezzano l’immagine idilliaca del popolo abruzzese che Aurispa s’è creato, risospingendolo nella sua modernissima e “civilizzata” pulsione di morte.
Tempvs destrvendi, infatti, e non a caso, si intitola il quinto libro, preludio alla catastrofe del sesto: allusione non solo al “filosofare con il martello” di Nietzsche – citazioni dall’Also sprach Zarathustra dominano l’intero capitolo, puntellando la progressiva adesione di Aurispa all’ideale del superomismo, pur se, ovviamente, nella sua singolare declinazione dannunziana – ma anche rimando a Charles Baudelaire e a Stéphane Mallarmé che segnala, implicitamente, il rigetto del modello vitanoviano del libro precedente (si veda sotto la sezione Temi e influenze). È del resto in questo capitolo che Sanzio, da beatrice e donna della nuova alleanza tra l’esteta e il mondo naturale, si converte definitivamente ne “la Nemica”, termine, peraltro, già anticipato nel quarto libro, e forse derivato da Jules Barbey d’Aurevilly (Une vieille maîtresse, 1851): antitesi della beatrice, la Nemica è colei che, “effeminando” il superuomo, gli impedisce di realizzare compiutamente il suo destino, che Aurispa è ormai giunto a identificare con l’accettazione del proprio retaggio di morte quale superamento ultimo e indefettibile di ogni contraddizione. Tale proposito troverà la sua concretizzazione nel sesto e ultimo libro, che per l’occasione recupera l’antico titolo de L’Invincibile. La fuga a Samarra di Giorgio Aurispa, illusoriamente guidato dalla volontà di potenza verso quella che crede una piena affermazione della vita, l’ha in realtà gettato diritto nelle braccia dell’unica, vera, “invincibile”: quella morte in cui egli e la sua amante precipitano, lottando eppure “avvinti” fino alla fine.
Temi e influenze
Il Trionfo della morte viene concepito e scritto in un decennio-chiave per la cultura italiana ed europea, quei Naughty Nineties che segnano l’apice della Belle Époque e al tempo stesso la fase in cui le contraddizioni dell’epoca paiono giungere al punto di massima tensione: tra Italia ed Europa, come si sa, è spesso la figura di Gabriele d’Annunzio a fare da cerniera, e non stupisce dunque che nella gestazione laboriosa e intermittente del Trionfo trovino posto, in una sintesi a tratti discontinua ma sempre intellettualmente stimolante, gran parte dei temi e delle ossessioni che permeano il dibattito transnazionale della fin de siècle.
Come si è visto, il romanzo nasce al crocevia di tre grandi correnti di pensiero, assimilate da d’Annunzio tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta dell’Ottocento: il romanzo psicologico francese e il suo legarsi a filo doppio agli sviluppi della psichiatria tardo-positivista, l’intransigente ritorno alla spiritualità di una larga fetta del mondo intellettuale di area slavo-ortodossa – che trova i suoi interpreti più acuti e tormentati in romanzieri come Tolstòj e Dostoevskij – e l’asse Nietzsche-Wagner, che, benché storicamente limitato ai pochi anni che intercorrono tra La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali, sembra annunciare, nell’Europa di fine secolo, un ritorno del vitalismo dionisiaco per il tramite di un’arte totale e dell’erosione delle fondamenta storiche e filosofiche dell’etica giudaico-cristiana.
Sull’onda del successo de Il piacere, d’Annunzio imposta il suo originale tentativo di sintesi rimettendo al centro dell’opera, ancora una volta, una figura maschile di esteta: il modello di Andrea Sperelli, tuttavia, evocato nel primo capitolo tramite l’ambientazione romana e l’insistere sull’estenuato ménage erotico tra Aurispa e Sanzio, lascia presto il posto a un uso del protagonista quale filtro e voce delle diverse istanze intellettuali che abitano il romanzo, seguendo la struttura di un itinerario fatalistico e circolare, strutturato per blocchi episodici che conservano traccia della rapsodica gestazione dell’opera (si veda Contenuto e struttura). È una commistione, questa, di cui i primi critici, unicamente concentrati sul contenuto psicologico del romanzo, non si accorsero che limitatamente, ma che oggi – proprio, e paradossalmente, a causa dei suoi effettivi limiti tecnici – rende quest’opera, fondamentalmente di transizione, un perfetto esempio delle tensioni che percorrono la cultura della fin de siècle e dell’impossibilità di ridurle a sintesi unitaria.
Nella sua ossatura generale, il Trionfo mantiene l’antico modello de L’Invincibile, strutturato com’è sul motivo dell’ineluttabilità della morte autoinflitta quale tabe ereditaria e malattia della volontà. Primo e principale tema dell’opera è, dunque, l’ereditarietà di disposizioni e comportamenti, soggetto ampiamente discusso dalla psicologia, dalla psichiatria e dal romanzo tardo-positivista – specialmente in area francofona – e che si rifletterà, nel nuovo secolo, nella definizione freudiana di “romanzo familiare” (Familienroman) quale topografia immaginale attraverso la quale il soggetto nevrotico perviene alla definizione del Sé. Tutto il secondo capitolo può essere letto come un tentativo, da parte di Aurispa, di conciliare il proprio romanzo familiare con la degenerazione – dell’individuo, della famiglia, della stirpe – che sembra affliggere la modernità e che egli vede in ogni istante intorno a sé. Il Trionfo, del resto, è coevo all’Entartung di Max Nordau (1892-93) e rappresenta un primo scavo, da parte di d’Annunzio, del tema della degenerazione, che pochi anni dopo, ne Le vergini delle rocce, si allargherà alla dimensione dell’intera nazione italiana quale “stirpe” degenerata e da rinnovare in chiave messianica.
Al solipsismo di Aurispa fa da contraltare la figura, onnipresente e tuttavia elusiva, di Ippolita Sanzio, che nell’erotica costruita dal libro – e suo secondo, altrettanto importante tema – conosce, nella mente del protagonista e nell’immagine che ne viene di conseguenza offerta al lettore, almeno tre incarnazioni. Se la Sanzio del primo libro porta ancora i segni del femminino enigmatico e languido de Il piacere e dell’Isaotta, a partire dal terzo libro la donna viene esplicitamente costruita quale beatrice, in linea con le suggestioni neomedievali che permeano il libro – come da dedica a Michetti – e concordemente a un uso generalizzato della Vita Nova dantesca quale modello di narrazione autopsicologica nell’Europa della fin de siècle: il Trionfo, da questo punto di vista, appare pienamente allineato a opere coeve quali, tra le altre, The House of Life di Dante Gabriel Rossetti (1882), Amori di Carlo Dossi (1887), Sixtine, roman de la vie cérébrale di Rémy de Gourmont (1890), Les Cahiers d’André Walter di André Gide (1891) e le memorie del mistico russo Vladimir Sergeevič Solov’ëv (m. 1900). A partire dal quarto capitolo, tuttavia, Sanzio si converte nella sua terza e ultima incarnazione, “la Nemica”, inversione del modello della Beatrice dantesca che, pure, trova appiglio in precedenti letterari di area francese: oltre al già citato Barbey d’Aurevilly è sintomatico, da questo punto di vista, il titolo del quinto capitolo, Tempvs destrvendi, che può leggersi – oltre che in chiave nietzscheana – come rimando sia a Baudelaire (La destruction, CIX composizione delle Fleurs du mal seguita a poca distanza, e non a caso, da La Béatrice, CXV) che, soprattutto, a Mallarmé, che in una lettera del 27 maggio 1867 aveva definito la propria prassi poetica tramite il celebre aforisma “La Destruction fut ma Béatrice”. La definizione della “Nemica” quale antitesi, infeconda, sensuale e beffarda, del superuomo, prelude alla catastrofe finale dell’opera e – più largamente – all’abbandono, da parte di d’Annunzio, di ogni suggestione preraffaellita e vitanoviana: un immaginario dal quale l’autore si congeda definitivamente ne Le vergini delle rocce attraverso la figura di Massimilla, “colei che ascolta, ammira e tace” e che, vocata al chiostro, resta, non a caso, impossedibile e imposseduta, sottratta a un desiderio maschile già rivolto altrove. Rinunciando a lei, l’“esteta armato” Claudio Cantelmo la immagina fondersi con le acque e la vegetazione palustre che ha ormai invaso l’antico feudo di famiglia, sancendo l’opposizione – fattasi ormai irriducibile – tra la vocazione fallica, patrilineare e generativa dell’Übermensch e un femminino melmoso e linfatico, unica forza distruttrice capace di minacciare e di erodere la Wille zur Macht (volontà di potenza)
A questo femminino liquido, predatorio e minacciosamente passivo, fa da specchio la massa popolare, da sempre oggetto di scherno e disdegno da parte di d’Annunzio ma che nel Trionfo diviene l’altro, potente emblema della degenerazione dalla quale il soggetto maschile deve guardarsi. Tra il secondo e il quarto capitolo, Aurispa si confronta con il mondo popolare abruzzese, le sue credenze e la sua religiosità: questo confronto, tuttavia, non prende la forma di un interesse etnografico o sociologico – come poteva essere per Zola – né tantomeno di un’adesione o di una consonanza affettiva, come sarebbe accaduto a Huysmans con Les Foules de Lourdes (1906), ma si fa piuttosto preludio di una visione più esasperatamente aristocratica dell’esperienza intellettuale (ed, embrionalmente, politica) che troverà definitivo compimento, ancora, nelle Vergini.
Da questo punto di vista, il fallimento di Aurispa, tradito dalla sua fede nella volontà di potenza, e infine catturato dall’inesorabile morte che l’ha braccato sin dal principio, non va inteso come una palinodia del pensiero nietzscheano ampiamente enunciato nel quinto capitolo, quanto come parentesi interlocutoria all’interno di un percorso ancora in fase di stabilizzazione. La potenza e la rilevanza del Trionfo stanno in questa sua natura ondivaga e frammentaria, tra il congedo dalle esperienze intellettuali e letterarie degli anni’80 quella scelta di un vitalismo intransigente, elitario e marziale, che segnerà la produzione dell’autore nei decenni a seguire.
Bibliografia essenziale
Edizioni apparse in vita:
Trionfo della morte, Milano, Treves, 1894.
I romanzi della rosa. Trionfo della morte, Milano, Treves 1903.
Il trionfo della morte, 2 voll., Verona, Istituto Nazionale per la edizione di tutte le opere di Gabriele d’Annunzio, 1929.
Trionfo della morte, Roma, Per l’Oleandro, 1933.
Trionfo della morte, Verona, Per l’Oleandro, 1934.
Edizioni commentate:
Trionfo della morte, a cura di Giansiro Ferrata, Milano, Mondadori, 1980.
Trionfo della morte, in Gabriele d’Annunzio, Prose di romanzi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, 2 voll., Milano, Mondadori, 1988, vol. I, pp. 637-1019.
Trionfo della morte, a cura di Maria Giulia Balducci, Milano, Mondadori, 1995.
Bibliografia secondaria:
AA.VV., Trionfo della morte (Atti del III Convegno internazionale di Studi, 22-24 aprile 1981), Pescara, Ediars, 1982.
Luigia Abrugiati, Edoardo Tiboni (a cura di), Trionfo della morte. Atti del III Convegno Internazionale di studi dannunziani, Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani, 1983.
Galbo, Joseph, A Decadence Baedeker: D’Annunzio’s “The Triumph of Death”, “The European Legacy”, 22, 1 (2017), pp. 49-67.
Stefano B. Galli, Alla ricerca dell’Übermensch: il mito del superuomo nel pensiero dannunziano, in Romain H. Rainero, Stefano B. Galli (a cura di), L’Italia e la “Grande Vigilia”. Gabriele d’Annunzio nella politica italiana prima del fascismo, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 17-34.
Thomas Grey, James Westby, Gabriele d’Annunzio’s “Il caso Wagner” (The Case of Wagner): Reflections on Wagner, Nietzsche, and Wagnerismo from fin-de-siècle Italy, “Leitmotive”, 3 (2012), pp. 7-26.
Marja Härmänmaa, Celebrating Decadence: The Image of Abruzzo in D’Annunzio’s “Trionfo della morte”, “The European Legacy”, 18, 6 (2013), pp. 698-714.
Marja Härmänmaa, Anatomy of the Superman: Gabriele D’Annunzio’s Response to Nietzsche, “The European Legacy”, 24, 1 (2019), pp. 59-75
Jonathan Littell, Il secco e l’umido. Una breve incursione in territorio fascista, Einaudi, Torino, 2009.
Andrea Lombardinilo, D’Annunzio da “L’Invincibile” al “Trionfo della Morte”: un percorso variantistico in “Studi medievali e moderni”, n. 1, 2001, pp. 135-178.
Guylian Nemegeer, Umanesimo, Rinascimento e rinascita nazionale in Gabriele d’Annunzio, “The Italianist”, 42, 1 (2022), pp. 24-42.
Pieri, Giuliana, Gabriele D’Annunzio and the Italian Fin-De-Siècle Interior, “Italian Studies”, 62, 2 (2007), pp. 219-30
Patrizia Piredda, Dallo Übermensch etico di Nietzsche al superuomo estetico di D’Annunzio, “Spunti e Ricerche”, 27 (2012), pp. 30-48.
Jeffrey Schnapp, Nietzsche’s Italian Style: Gabriele d’Annunzio, in Thomas Harrison (a cura di), Nietzsche in Italy, Stanford University Press, Stanford, 1988, pp. 247-64.
Maurizio Serra, L’esteta armato. Il Poeta-Condottiero nell’Europa degli anni Trenta, Il Mulino, Bologna, 1990.
Klaus Theweleit, Fantasie Virili. Donne Flussi Corpi Storia. La paura dell’Eros nell’immaginario fascista, Il Saggiatore, Milano, 1997.