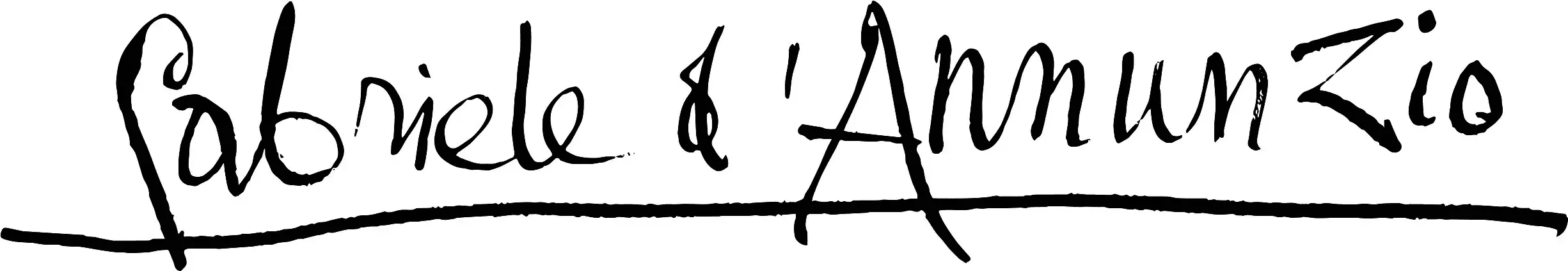di Stefano Giordanelli, Enciclopedia dannunziana
Nato a Genova il 10 ottobre 1880, Mario Maria Martini vive e lavora nel capoluogo ligure soprattutto come giornalista. Collabora con il quotidiano «Caffaro» dal 1903 al 1929, dedicandosi in particolare alla critica teatrale.
In Martini, fin dagli esordi, emergono preponderanti e costanti nel tempo una chiara influenza dannunziana in ambito letterario e la propensione verso il nazionalismo – e successivamente verso il fascismo – in ambito politico.
Nel 1902 pubblica e dirige «Il Convito», di cui si conoscono solo quattro fascicoli. Il titolo richiama esplicitamente l’omonimo periodico romano, in quel periodo temporaneamente sospeso, e fautore di uno ‘spirito latino’ a cui Martini resterà sempre fedele. Testimonianze dell’epoca riportano che il motivo della repentina chiusura fu dovuto a un articolo dello stesso direttore dedicato alla conquista di Tripoli (1902), ma è più ragionevole pensare che l’indirizzo politico non fu gestito in modo adeguato, generando dubbi e conflittualità tra collaboratori e finanziatori. Tra le partecipazioni più significative si possono citare: Gian Pietro Lucini, Filippo Tommaso Marinetti e Luigi Pirandello.
Tra il giugno 1907 e l’agosto 1908 si registra la seconda impresa editoriale, con la pubblicazione de «La Rassegna Latina di Lettere – Arte – Politica e Scienza». Martini in questo caso, già a partire dal titolo, riesce a dare alla rivista un’impronta chiaramente nazionalista, ospitando anche un intervento di Enrico Corradini (Le aristocrazie intellettuali). L’intenzione fu probabilmente quella di radunare intorno alla rivista le esperienze da poco disperse de «Il Leonardo» e «Il Regno», ma senza riuscire nell’impresa. Il periodico in ambito letterario segue sempre le orme dannunziane, pur senza escludere altre collaborazioni che lo rendono in parte eclettico: partecipano, tra gli altri, Gustave Kahn (grazie alla mediazione F.T. Marinetti, anche lui collaboratore), Guido Gozzano e Carlo Vallini. Oltre a questi si possono anche ricordare: Gustavo Botta, Francesco Chiesa, Adolfo De Bosis e Carlo Linati.
Tra il 1910 e il 1913 Martini è attivo come autore teatrale, mettendo in scena le opere: L’ultimo Doge (1910), Il dittatore (1911) e Gli emigrati (1913, quest’ultima poi pubblicata sulla rivista «Comoedia» nel 1920), trittico in cui emerge forte l’idea di un governo oligarchico e nazionalista di chiara tendenza antidemocratica.
Sempre nel medesimo anno del debutto teatrale si avvicina alla politica, diventando consigliere regionale per la Liguria dell’Associazione Nazionalista Italiana.
Nel 1911, probabilmente visto il suo acceso entusiasmo verso la conquista della Libia, si trova a ricoprire l’inedito incarico di corrispondente di guerra per il «Caffaro».
Nell’ottobre 1915 partecipa alla Grande Guerra da volontario, presumibilmente come sottotenente del 90° Reggimento di Fanteria. Da questa esperienza nasce la raccolta poetica Fiamme, edita da Sonzogno nel 1919 (e di cui il Vittoriale conserva copia con dedica manoscritta dell’autore).
Il 1919 è inoltre l’anno dell’impresa di Fiume, da cui ricaverà il volume La passione di Fiume (Sonzogno).
Dopo tale evento Martini, nel febbraio 1921, costituisce a Genova la Legione Gabriele d’Annunzio, indirizzandosi sempre più verso il fascismo. Il 28 ottobre 1922, con la Legione, partecipa attivamente alla Marcia su Roma, presidiando il capoluogo ligure.
È durante l’impresa che il genovese conosce Giovanni Comisso. Il giovane scrittore, su suggerimento di Guido Keller, si trasferisce nel capoluogo ligure (parte il 28 febbraio 1921), nella speranza di lavorare a «Le Opere e i Giorni», la nuova rivista diretta e fondata da Martini. Tale esperienza risulta estremamente negativa, tanto da essere riportata nelle pagine del romanzo Il delitto di Fausto Diamante (Milano, Ceschina, 1933). In questa opera Fausto Diamante – alter ego dell’autore Giovanni Comisso – uccide Mario Massimo – ovvero Mario Maria Martini -, poeta che lo aveva attirato a sé promettendogli un impiego in un giornale.
Sempre nel 1922 esce l’ultima impresa editoriale di Martini, la già citata rivista «Le Opere e i Giorni». Il progetto nasce sicuramente durante l’esperienza fiumana, con l’intento di aggregare gli scontenti in un periodo di forte instabilità. La rivista è inizialmente vicina a d’Annunzio, tanto che sarà lui a fornire il titolo e il motto biblico che fa da sottotitolo («ciascuno acuisca il suo vomero e fornisca il suo compito»); non solo: il Vate scrive direttamente a Mondadori per averlo come editore, promettendogli una prosa inedita da far uscire nel primo fascicolo. In realtà di d’Annunzio si può leggere unicamente la riproduzione di una lettera manoscritta pubblicata nel primo numero, vergata per salutare la nuova impresa editoriale e destinata al «Mio Caro Mario»; così come non si vedrà mai il nome di Mondadori nel frontespizio o nel colophon della rivista (inizialmente fu sostituito dalla casa editrice Alpes per il primo anno). Il periodico tuttavia non esita a virare immediatamente verso il fascismo, tanto che, per poco meno di un anno (agosto 1923-maggio 1924), per il tramite di Enrico Corradini, riceve dei finanziamenti occulti del governo gestiti da Cesare Rossi, capo dell’Ufficio Stampa di Mussolini. Tra le collaborazioni letterarie più importanti, si possono ricordare: Giovanni Comisso, Adriano Grande, Eugenio Montale, Luigi Pirandello, Camillo Sbarbaro, Giuseppe Tomasi di Lampedusa (che per la rivista scrisse tre articoli, gli unici pubblicati in vita). La rivista cesserà le pubblicazioni nel 1938, facendo in tempo a pubblicare un articolo dichiaratamente antisemita di Amerigo Cerea, Razzismo e filosofia.
Nel 1925 Martini è ufficialmente iscritto al Partito nazionale fascista, ricevendo la tessera ad honorem. Inizia per lui una stagione ricca di incarichi: nel 1926 è Commissario aggiunto per la Grande Genova, nel 1928 diventa socio corrispondente dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, mentre nel 1932 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Genova.
Nel 1930, in seguito alla chiusura del «Caffaro», inizia a collaborare con il quotidiano fascista «Giornale di Genova» (diretto da Giorgio Pini dall’aprile 1930 all’ottobre 1936). Martini vi lavora fino al luglio 1943, scrivendo principalmente articoli di letteratura e storia; cura inoltre la rubrica Il mondo in giro, firmandosi, in quest’ultimo caso, come Il Giramondo (anonimato che gli permette di avere un approccio più disinvolto e a tratti umoristico).
Nello stesso anno inizia a collaborare con «Il Telegrafo» di Livorno diretto da Giovanni Ansaldo, conosciuto a Genova nei primi anni Venti.
Il direttore del quotidiano livornese aiutò Martini a ottenere, nel 1939, il posto di direttore dell’Istituto per la Storia di Genova. Tale istituto nasce con l’intento di pubblicare quindici volumi dedicati alla storia del capoluogo ligure. Dell’opera escono i primi tre volumi per l’editore Garzanti (1941-1942), mentre il quarto fu distrutto durante il bombardamento su Milano del 22 agosto 1943 (anche se uscirà successivamente nel 1951 per la cura dello storico Vito Vitale e per i tipi dell’editore napoletano Riccardo Ricciardi).
Il 16 maggio 1945 Martini, personalità fascista ormai ben nota in ambito genovese, viene arrestato. Trascorre cinque mesi nel carcere di Genova e successivamente viene rilasciato libero da ogni accusa.
Nel dopoguerra, ormai stanco e malato, inizia a collaborare: per «Il Secolo XIX» (dal luglio 1948 al gennaio 1949), per il «Corriere Ligure» (dal marzo 1949 al gennaio 1950) e infine per «Il Corriere Mercantile» (giugno-dicembre 1953), riproponendo in gran parte articoli già pubblicati in precedenza.
Muore il 20 dicembre 1953 a Genova in seguito ad asma bronchiale.
La memoria di Martini sopravvive grazie al ricordo che ne restituisce Montale nella poesia Caffaro, scritta nel 1972. Nel componimento il poeta ricorda il periodo dell’infanzia, quando, tornando a casa da scuola, percorreva via Caffaro. In questa strada, sede dell’omonimo giornale, incontrava il direttore dell’epoca Pietro Guastavino e il suo collaboratore Mario Maria Martini. Quest’ultimo viene citato sia per essere l’autore del dramma l’Ultimo doge (sostenendo che la rappresentazione andò malissimo, anche se in realtà fu l’esatto contrario), sia per essere stato considerato come un possibile traduttore dell’opera dell’annalista medioevale Caffaro, creando così un ulteriore gioco di rimandi.
Martini e Gabriele d’Annunzio
Già nel 1898 Martini, insieme a Carlo Panseri e Tito Alberto Roncali, prende le difese di d’Annunzio, indirizzando una lettera polemica a Giovanni Lanzalone della «Gazzetta Letteraria», colpevole di aver pubblicato un articolo favorevole alla censura del Sogno di un mattino di primavera nella sua traduzione inglese.
Martini e il Vate si conobbero molto probabilmente prima del 1908, ma è a questa altezza cronologica che si può documentare l’effettivo incontro tra i due. Lo testimonia un ritratto fotografico con dedica manoscritta conservato in un archivio privato e datato 15 maggio 1908, periodo in cui il poeta si trovava nel capoluogo ligure per presenziare alla prima cittadina de La Nave presso il Teatro Carlo Felice.
Nei decenni successivi il giornalista genovese, come critico sia teatrale che letterario, dimostrò una lunga fedeltà a d’Annunzio, schierandosi sempre in suo favore, lodandolo e talvolta prendendone le difese nei momenti più critici.
Così, nel tempo, Martini si guadagnò una sempre più solida fama di dannunziano, diventando in tal senso un punto di riferimento negli ambienti intellettuali genovesi. Il suo nome compare sempre nelle cronache cittadine quando il Vate si reca nel capoluogo ligure. Una testimonianza di Carlo Panseri lo colloca come presente al momento della partenza di d’Annunzio verso la Francia. Tramite Giovanni Del Guzzo si viene a sapere che il poeta pescarese lo cercò per farsi fare un certificato medico nel marzo del 1910, in modo da non dover più partecipare a delle serate organizzate dall’impresario Frattini, colpevole di aver scelto una sede non adatta, il Lido d’Albaro di Genova, per la conferenza Per il dominio dei cieli.
È invece documentabile, grazie ai quotidiani dell’epoca, la presenza di Martini al rientro del Vate dalla Francia. Lo riceve alla stazione di Piazza Principe e partecipa all’inaugurazione del monumento di Eugenio Baroni sito a Quarto dei Mille (5 maggio 1915). In questa occasione d’Annunzio riceve dal Comune di Genova il calco del Leone di San Marco (opera murata presso Palazzo Giustiniani), con dedica accompagnatoria di Martini.
Il rapporto tra i due si intensifica poi grazie all’impresa di Fiume; anche il carteggio conservato presso il Vittoriale, circoscritto a quel periodo e alla fase immediatamente successiva, ne è una chiara testimonianza.
I contatti con d’Annunzio riprendono il 4 aprile 1921, proprio nel giorno in cui il Comandante riceve Mussolini. Due mesi prima, febbraio 1921, Martini fonda a Genova la Legione Gabriele d’Annunzio. Dalla corrispondenza conservata al Vittoriale emerge che il genovese vorrebbe inglobare gli arditi e fascisti nell’organizzazione appena creata nel capoluogo ligure; contemporaneamente manifesta a d’Annunzio la preoccupazione riguardante un possibile avvicinamento della Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani verso i comunisti.
Martini si reca a Gardone Riviera nello stesso mese, proprio nei giorni in cui Gramsci stava tentando un avvicinamento con il Vate, poi non concretizzatosi. Secondo le testimonianze di Nino Daniele ed Eno Mecheri, il genovese fu in qualche modo decisivo riguardo a questo mancato incontro, facendo emergere il contrasto tra il raffinato esteta e il comunista definito come un «gobbo con la camicia sporca». Bisogna tuttavia segnalare che già il mese precedente d’Annunzio rifiutò un incontro con il politico.
Il 28 aprile 1921 Martini, ancora fedele a d’Annunzio, scrive che i Legionari genovesi restano in attesa dei suoi ordini e che nel frattempo si asterranno dalla propaganda elettorale così come dalle urne (con riferimento alle elezioni del 15 maggio 1921). Sempre per l’appuntamento elettorale appena citato subentra la questione riguardante la FILM (Federazione Italiana Lavoratori del Mare), presieduta dall’onorevole Giulietti. Martini vuole screditare Giulietti agli occhi di d’Annunzio e contemporaneamente vorrebbe sfruttare il Vate per avvicinare la Federazione ai fascisti e agli armatori. D’Annunzio si guarda bene dal compiere un gesto simile, tanto che nell’aprile 1922 prenderà sotto la sua protezione Giulietti e la FILM nel tentativo di difenderla dalla corporazione fascista, dimostrando così anche un debito di riconoscenza verso il presidente della Federazione, che durante l’impresa di Fiume fece dirottare a suo favore il piroscafo Persia carico di armi e munizioni.
Il distacco tra d’Annunzio e Martini, visto ormai sempre più vicino al fascismo, è tale che tra il 22 e il 24 ottobre 1922 non viene nemmeno ricevuto a Gardone nonostante la sua presenza in loco.
Martini indirizza chiaramente il movimento legionario da lui guidato in orbita fascista: si unisce ai CAUR (Comitati d’azione per l’universalità di Roma) capitanati da Eugenio Coselschi e successivamente partecipa attivamente alla marcia su Roma, contribuendo a occupare il capoluogo ligure fin dalle prime ore del 28 ottobre 1922.
Nella corrispondenza di questo periodo si affronta parallelamente una ulteriore questione decisamente meno importante, che riguarda l’albero di nave alto ventitre metri utile per issare lo stendardo del Carnaro. Tale «antenna» fu lavorata nel Cantiere Ansaldo di Sestri Ponente e donata a d’Annunzio dall’imprenditore Perrone. Fu appunto Martini a gestire tale richiesta.
È proprio in questo periodo che si conclude la corrispondenza tra d’Annunzio e Martini, almeno per quello che risulta conservato (eccezion fatta per un telegramma commemorativo del 1933).
Martini e l’impresa di Fiume
Martini al momento della marcia di Ronchi (11-12 settembre 1919) è ancora in Liguria e partecipa a una sottoscrizione inviando denaro tramite il quotidiano per cui lavora. Inizialmente scrive articoli dedicati alla questione; in particolare si segnalano alcuni scritti polemici, apparsi sotto il comune titolo Ombre cinesi, nella rivista «Satana».
Martini si reca a Fiume alla fine del mese, così come risulta dal suo primo articolo come inviato speciale del «Caffaro», datato 29 settembre 1919. Il 3 ottobre d’Annunzio lo colloca a capo della segreteria speciale, ma il 21 dello stesso mese Martini è costretto a rassegnare le dimissioni perché non informato a proposito di alcune missioni che si stavano compiendo in territorio italiano. Martini prosegue comunque nella sua attività di giornalista, progettando la raccolta dei suoi articoli in quello che diventerà La passione di Fiume (Sonzogno), vero e proprio instant book già pronto alla fine del 1919, ma commercializzato a partire dal 1920 per questioni legate alla censura.
Intorno al 10 novembre 1919 è a Genova, alla fine dello stesso mese scrive a d’Annunzio di continuare a lavorare alla causa fiumana e di voler organizzare una lotteria internazionale tramite la Banca Casareto, progetto che tenterà di organizzare ancora nei primi mesi del 1920 senza alcun risultato.
Martini torna a Fiume nel novembre 1920: il 12 è a colloquio con Millo – governatore della Dalmazia dal novembre 1918 – che era in accordi con d’Annunzio, poi rivelatisi falsi, per non cedere la sua zona di competenza alla Jugoslavia.
Il giorno dopo, 13 novembre 1920, partecipa allo sbarco sull’isola di Arbe, così come previsto da d’Annunzio, che aveva progettato l’occupazione di quell’isola e di Veglia per poi «puntare più lontano».
Il 16 novembre 1920 riceve la cittadinanza onoraria dell’isola «come tributo di riconoscenza per aver il giorno 13 novembre 1920, colle gloriose truppe di Gabriele d’Annunzio, liberata l’isola, dogale, già assegnata dal Trattato di Rapallo alla Jugoslavia».
Il 2 dicembre 1920, tramite un lasciapassare di d’Annunzio, si reca a Zara per avere conferma della defezione di Millo, orientato a non opporsi agli ordini del governo.
La situazione da lì a poco inizia a precipitare: il 9 dicembre la Reggenza del Carnaro comunica che non tratterà in alcun modo con Roma. Il 19 dicembre il generale Caviglia trasmette al Vate che il Trattato di Rapallo è ormai legge dello Stato. Il Comandante rifiuta di ritenere eseguibile un documento non ratificato dalla Reggenza e il 21 dicembre proclama lo stato di Guerra. Il 23 dicembre, giorno della scadenza dell’ultimatum di Caviglia, d’Annunzio fornisce un altro documento a Martini definito «ufficiale addetto alla persona del Comandante per compiti speciali». Il giorno dopo inizia il conflitto che vedrà la sconfitta della Reggenza e la partenza da Fiume di tutti i legionari. Di Martini non si hanno ulteriori documenti, salvo risultare presente negli elenchi di coloro che parteciparono al “Natale di sangue”.
Bibliografia essenziale
Anita Ginella Capini, Un letterato genovese alla corte di d’Annunzio. La corrispondenza fra Mario Maria Martini e il Comandante, in Scritti in onore di Bianca Montale, Genova, Università degli Studi di Genova-Brigati, 2000.
Anita Ginella Capini, Gabriele d’Annunzio il ‘Genovese’, Genova, De Ferrari, 2010.
Stefano Giordanelli, Mario Maria Martini, tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, 2010.
Stefano Giordanelli, Il dannunziano Giovanni Comisso tra Fiume e Genova. La tormentata amicizia con Mario Maria Martini in un carteggio inedito, «Nuova Storia Contemporanea», XVI, 3, maggio-giugno 2012, pp. 75-96.
Stefano Giordanelli, Carteggio Mario Maria Martini-Gabriele d’Annunzio, in Mario Maria Martini, La passione di Fiume. Diari, cronache, documenti, a cura di Daniele Orzati, Milano, NovaEuropa, 2019, pp. 241-269.
Stefano Giordanelli, Insieme al Comandante, postfazione a Mario Maria Martini, La passione di Fiume. Diari, cronache, documenti, a cura di Daniele Orzati, Milano, NovaEuropa, 2019, pp. 311-417.
Mario Mario Martini, La passione di Fiume, Milano, Sonzogno, 1919.
Mario Maria Martini, Tripoli, «Il Convito», I, 2, 15 aprile 1902, pp. 2-3.
Eugenio Montale, Caffaro, in L’opera in versi, edizione critica a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1980, p. 677.