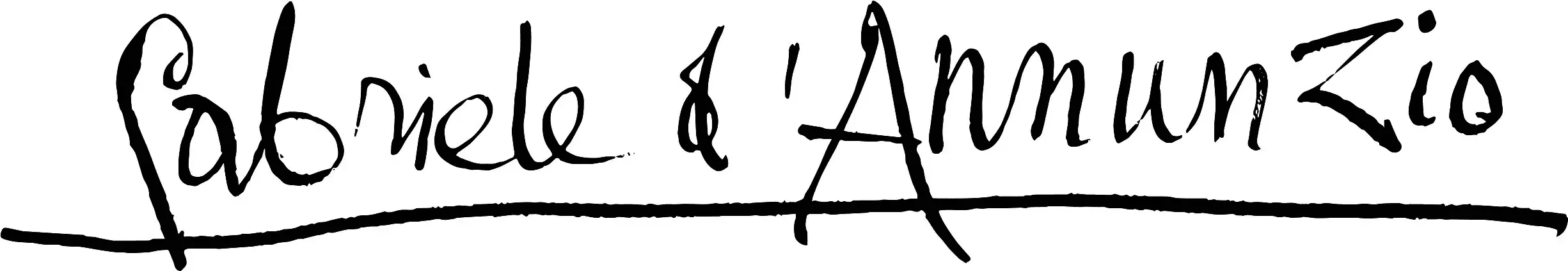di Raffaella Bertazzoli, Enciclopedia dannunziana
Genesi, elaborazione, vicenda editoriale
Con il titolo Isaotta Guttadàuro ed altre poesie usciva «nel dì Natale mdccclxxxvi (1886)» dalle stamperie della «Tribuna» un elegante volume di liriche dannunziane. La veste editoriale, particolarmente curata, si arricchiva di ventidue tavole fuori testo, disegnate da pittori, legati da un comune interesse per il gusto preraffaellita e riuniti nel cenacolo, fondato proprio nel 1886, sotto l’insegna «In Arte Libertas». Comparivano nel volume tavole di Vincenzo Cabianca, Onorato Carlandi, Giuseppe Cellini, Enrico Coleman, Mario De Maria, Cesare Formilli, Alessandro Morani, Alfredo Ricci e Giulio Aristide Sartorio.
L’editio picta fu commentata in termini elogiativi sulla «Tribuna» del 1° gennaio 1887 (Isaotta Guttadàuro. Le illustrazioni) da Angelo Conti, il «Doctor Mysticus», magister e guida spirituale dei nuovi artisti. Il volume ebbe una tiratura di 1500 esemplari e nonostante la grancassa pubblicitaria sui fogli del giornale rimase sostanzialmente invenduto.
Constatato il deludente esito commerciale del libro, nei primi mesi del 1889 d’Annunzio decideva di ripubblicare i versi dell’Isaotta Guttadàuro. Scriveva dunque a Emilio Treves il 26 marzo 1889: «Vorrei combinare con Lei una edizione dei miei ultimi versi in due volumetti del formato panzacchiano. L’Isaotta Guttadàuro è quasi ignota, si può dire quasi inedita. Io vorrei riunire le poesie quattrocentistiche in un volumetto intitolato Isottèo; e le altre, con aggiunte e trasformazioni molte, in un volume di cui troverò il titolo». Nel luglio dello stesso anno, languendo il progetto sulla carta, d’Annunzio si risolveva a sollecitare l’editore: «Come già vi dissi alcun tempo fa intendo di ristampare l’Isaotta Guttadàuro che è quasi ignota. Dividerò il libro in due volumi, con emendazioni, aggiunte e soppressioni molte. Un volume conterrà tutte le poesie d’intonazione antica in onore di Isaotta, e sarà intitolato Isottèo. Potrà essere messo in vendita a 2 o a 3 lire, perché sarà piccolo. L’esito commerciale è sicuro. L’altro volume conterrà le restanti poesie moderne, ordinate diversamente, con aggiunte. Il formato Panzacchi è adatto per ambedue le opere».
Il libro, a quel tempo, era già definito. Venne inviato al Treves il 7 di agosto: «Vi mando il materiale del volume di versi isaotteo. Ci sono parecchie aggiunte. Il libro, ora, così composto, è più armonioso: racchiude l’essenza quinta dell’eleganza poetica. Dategli anche una veste elegante. Vorrei che su la prima pagina del volume fosse riprodotta, dalla cintola in su, la figura della Primavera che è nell’Allegoria di Sandro Botticelli. La cosa è facile da ottenere. Io stesso potrei fornire il disegno da riprodursi. Rispondetemi in proposito. Manderò fra giorni il materiale dell’altro volume, più copioso. Non ho ancora trovato il titolo […]. Ditemi quando potrete incominciare le stampe dell’Isottèo. Mi raccomando per i tipi: che sian nuovi e nitidi».
Nonostante le «parecchie aggiunte», così al Treves, l’esiguità numerica dei componimenti contenuti nel volume «isaotteo» non dovette convincere l’editore, che manifestò a d’Annunzio le proprie perplessità. La risposta non si fece attendere. Il 22 agosto 1889 d’Annunzio ribadiva la giustezza della proposta: «Mi dite che l’Isottèo viene un volume troppo esiguo. Io desidererei da gran tempo che quella diletta opera di poesia rimanesse chiusa in un volume solo a parte. Inoltre, i volumi di poesia dovrebbero sempre essere sottili, secondo me. Stampate, dunque, tale qual è, questo Isottèo: e stampatelo con squisitezza, voi che sapete. Vi spedirò fra giorni l’altro volume che è assai grosso e s’intitola: La Chimera. I versi dell’Isottèo non devono andar mescolati con altri: hanno troppo un carattere speciale. La Chimera raccoglie tutti i miei versi migliori: ed ha per chiusa le Terzine al poeta Andrea Sperelli, che forse avrete vedute sul «Corriere di Napoli». Ha per prologo altre terzine inedite. È coerente come un dramma. Si comporrà, tipograficamente, di più che trecento pagine […]. Ho già commesso il disegno della Primavera».
Non convinto delle ragionevoli osservazioni di d’Annunzio, il Treves incominciò a stampare le due raccolte in un solo volume. A partire da settembre, intercorse tra l’editore e il poeta una corrispondenza di routine: d’Annunzio riceveva e rispediva bozze. Quindi aggiungeva: «Credo inutile la prefazione. Una prefazione in prosa ad un libro di poesie è di cattivo gusto. Perché spiegare l’indole del libro? La data (1885-1888) indica che vi sono raccolti tutti i miei versi composti in quel periodo. Manderò l’ordine delle prime pagine. La dedica a Donna Maria è soppressa. Mi raccomando l’eleganza […]. Il disegno della Primavera doveva essere fatto da quel povero Alfredo Ricci che è morto di recente. Non so ora a chi rivolgermi per avere una cosa veramente botticellesca. Il Ricci era un finissimo artista. Peccato!».
Qualche giorno più tardi, d’Annunzio scriveva all’editore per gli ultimi ritocchi: «Accludo […] le bozze delle prime pagine delle poesie. Sul frontespizio desidero stampato così L’Isottèo-La Chimera […]. Il sonetto primo, che non ha titolo (mi pare) deve aver per titolo la seguente dicitura: Al libro detto Isottèo (Isottèo in un carattere diverso almeno d’inclinazione)». Ancora il 29 ottobre: «Sono a Roma da alcuni giorni. Fatemi spedire qua, al solito indirizzo, le bozze del volume poetico. Il quale si va, pare, arenando. Sarei in tempo a mandarvi, fra cinque o sei giorni, il disegno della Primavera di Sandro Botticelli? Ho trovato un artista preraffaellita che può sostituire il povero Ricci. […] In che giorno, su per giù, metterete in vendita il volume di Poesie? Sollecitate. Sarà per il 1° di dicembre?».
Il libro sarebbe uscito alla fine di dicembre ’89, con la data 1890, nella collana «Bijou» e senza il vagheggiato disegno botticelliano, mentre permaneva la dedica alla moglie: «A Donna Maria di Gallese // Gabriele d’Annunzio // dedica». Così al Treves, dopo aver ricevuto il volume: «Ho avuto il libro delle Poesie. L’Edizione mi piace molto, nella sua semplice eleganza».
Anche questa edizione non ebbe il successo sperato. La sezione intitolata «L’Isottèo (A. D. 1886)» conteneva tutti i componimenti dell’Isaotta Guttadàuro (con lievi varianti) e in più comprendeva: la Cantata di Calen d’Aprile (pubblicata sulla «Tribuna» il 1° aprile 1888), i Madrigali dei sogni (i primi due escono sul «Fanfulla della Domenica» il 29 aprile 1888; l’altro è inedito), i Sonetti del giovine Autunno (pubblicata sul «Fanfulla della Domenica» il 16 ottobre 1887) e il Trionfo d’Isaotta (pubblicato nel «Capitan Fracassa» il 17 aprile 1887). Seguiva la dicitura: «Qui finisce l’“Isottèo”», e quindi un Epodo con i Quattro sonetti al poeta Giovanni Marradi in onore della nona rima (editi nel «Fanfulla della Domenica» il 16 ottobre 1887).
A partire dall’Edizione nazionale (1930), il libro sarebbe stato stampato con il titolo L’Isottèo [1886] – La Chimera [1885-1888], con la massima «Il verso è tutto». Seguiranno l’edizione del Vittoriale degli Italiani del 1939 e le stampe mondadoriane nei Versi d’amore e di gloria nei «Classici contemporanei italiani» (1950) e nei «Meridiani» (1982).
Le poche giunte dell’edizione del 1890, volte a rimpinguare l’esigua consistenza dell’Isaotta, sottolineata a più riprese da Treves, non avrebbero mutato la sostanza poetica del libro. Nell’espressione, divenuta poi celeberrima, del «verso è tutto», che Andrea Sperelli avrebbe chiamato «emistichio sentenziale», d’Annunzio racchiudeva le diverse tendenze poetiche di quegli anni, emblematicamente interpretate dal protagonista della grande avventura estetizzante del Piacere.
Contenuto, struttura, interpretazioni critiche
In sede teorica, l’approdo poetico del volume trevesiano era stato preparato da tempo sui fogli delle riviste romane. Per comprendere a fondo la posizione estetica di quel momento, è illuminante lo scritto che d’Annunzio pubblicò sulla «Tribuna» dell’8 ottobre 1887, intitolato Un poeta d’autunno. In quel saggio, D’Annunzio cercava di analizzare il senso delle esperienze poetiche inglesi contemporanee, parlando di «esattezza e musicalità», di «parola plastica e musicale» che non ha agganci con il «moralismo» e si libera dalla «dissertazione dimostrativa». Quegli stessi principi estetici, trasversali alle altre forme d’arte, che il Nencioni, pochi mesi prima, con la sua recensione al Libro di Isaotta, pubblicata sul «Fanfulla della Domenica» il 6 febbraio 1887, proiettava sulla nuova poesia dannunziana:
I poeti […] si direbbe che amino staccarsi da ogni religione, da ogni filosofia, da ogni febbrile passione umana per non riprodurre che le belle forme e i colori, la luce e i suoni. Adoratori della bellezza plastica, sono i più felici trovatori di parole e di note che evocano belle immagini e dilettosi fantasmi e rivaleggiano con la pittura, con la scultura e con la musica, di effetti materiali e immediati all’occhio e all’orecchio del lettore. Tali Keats dell’Endymion, Swinburne nei Poems and Ballads, Dante Rossetti in gran parte delle sue poesie, e il Morris e il Gautier in tutti i loro versi. Tali i Parnassiens di Parigi, e Gabriele d’Annunzio.
Per il Nencioni, tuttavia, il giovanissimo Gabriele era «incomparabilmente più poeta di tutti i versificatori Parnassiens […] sprovvisti […] di quella che Wordsworth chiamava la “seconda vista” poetica. E questa, il D’Annunzio l’ha in grado eminente».
Nella raccolta dell’Isaotta Guttadàuro, con i componimenti legati al «Libro d’Isaotta», e così pure nell’edizione più tarda dell’Isottèo, appare dominante l’esperienza della scrittura parnassiana: sono i francesi come Gautier, Banville, Lorrain, Mendès a suggerire i toni e le forme nell’ideale del verso polito e cesellato. E «orefice e cesellatore» d’Annunzio si sarebbe definito in una lettera al suo traduttore del novembre 1892, in un periodo di riflessioni e di bilanci, quando si stava avviando al termine, con la conclusione del Poema paradisiaco, la prima grande fase poetica dannunziana. Interpretando l’esperienza dell’Isaotta, posteriore alla «demenza afrodisiaca» dell’Intermezzo di rime, d’Annunzio scriveva a Georges Hérelle il 14 novembre 1892:
Tra il 1884 e il 1886 pubblicai due volumi di novelle: – Le vergini e San Pantaleone; e un volume di versi: – Isaotta Guttadàuro. Il mio stile in prosa accennava a cambiarsi, in poesia era totalmente cambiato. Alla furia selvaggia del Canto novo, alle grasse pitture dell’Intermezzo era succeduta una maniera più calma, più fine. Attraversavo anch’io il mio periodo alessandrino. Facevo l’orefice e il cesellatore, non ad altro intendevo che a raggiungere l’assoluta perfezione della forma. […] Ma queste sottigliezze di forma rendevano sterile la mia intelligenza, restringevano il cerchio del mio spirito. […] Nel libro di versi intitolato Isottèo io volli rinnovare le forme metriche tradizionali o dell’antica poesia italiana e riprodurre in una vasta imagine la vita italiana del secolo XV, cantando le ballate alla maniera di Lorenzo il Magnifico.
Simili convincimenti apparivano già in un articolo sulla «Tribuna» del 14 marzo 1887, in cui d’Annunzio precisava: «Io sono, in arte partigiano della tradizione e delle forme stabilite, delle forme ch’io chiamerei fisse» (Scritti giornalistici (1882-1888), p. 854). In quel fondamentale momento di riflessione teorica che fu il 1892 (la lettera all’Hérelle è del novembre), Gabriele scriveva un saggio su Pascoli («Mattino», 30-31 dicembre 1892), in cui fa il bilancio dell’arte poetica italiana. Probabile l’influenza esercitata sullo scritto dell’Enquête sur l’évolution littéraire di Jules Huret, che esce a puntate nel 1891 (Tosi 1978). Parlando della tendenza, tutta parnassiana, a cercare nel passato lo spunto per il «rinnovamento», evidenziava alcuni aspetti di quell’arte e per riflesso alcune tendenze che erano state anche sue:
I poeti sono nell’arte loro più esperti. Parlo, naturalmente, dei pochi. […] Come i Parnassiani di Francia derivarono la copia della lingua, la varietà dei metri, la ricchezza delle rime da Pierre de Ronsard e dagli altri poeti del XVI secolo, così questi pochi hanno voluto proseguire e rinnovare le forme tradizionali italiane riallacciandosi ai poeti dello stil novo e a quelli del tempo di Lorenzo il Magnifico, ma ben di rado riuscendo a infondere nei versi antichi il sentimento moderno e ben di rado anche riuscendo a ottener dalle rime quella musica tenue e misteriosa che è l’inconoscibile incanto di certe ballate e di certi sonetti primitivi in cui il simbolo è occulto o involto di velami troppo densi. La loro fatica però non è stata vana, poiché essi hanno voluto immettere nella lingua poetica alquanto della freschezza di quelle fonti pure.
È proprio su quest’idea di «freschezza» che nasce la raccolta isottèa, espressione liberatoria di certa atmosfera greve e vischiosa dell’Intermezzo di rime; un’esperienza che avrebbe portato nuova ricchezza di lingua sui modelli antichi, assecondando la parola nel suo magico cerchio fonico; parola che trascina, nei ritmi di testure antiche, canti, cori, trionfi e lontane epopee.
Di questa fase «alessandrina», Alfredo Gargiulo (1941, p. 108) aveva sottolineato solo l’aspetto artificioso, di «esercitazione»: «giacchè l’Isottèo, se soddisfa riccamente l’udito, se meraviglia per la sensualità e dovizia delle cose che vi son nominate, se produce un complesso godimento acustico-visivo, lascia in fondo al lettore il vuoto e lo scontento».
Mentre Guy Tosi (1968, pp. 426-427) poteva cogliere soprattutto il gusto di una riproposizione di «exotisme dans le temps», alla Théophile Gautier: una sorta di «évasion dans le passé», secondo modi di lettura che attraversano le esperienze del parnassianesimo francese. Una tendenza letteraria, la riscoperta dell’antico, che percorrerà tutto il secolo come recupero memoriale della «nostalgie d’un autre siècle», alla Huysmans.
Con premesse diverse, Walter Binni (1984, p. 68) aveva parlato di «un decadentismo cortigiano, piacevole, di scarso impegno, di voluto riflesso stilnovista e preraffaellita», in cui si coglie oltre «alla malìa della parola e del verso il profumo del passato e di altri climi poetici». Vi insisteva anche Niva Lorenzini (1982, p. 1031) nel suo commento, nel quale si sofferma sulla volontà di ripresa del passato come «idea, nostalgicamente perseguita, di un assoluto di finzione che soppianti il precario, la scansione del tempo, in un indistinto continuum atemporale» che «esprime, assieme ad una disposizione assimilativa, un bisogno profondamente avvertito di alterità e di travestimento». «La tecnica del catalogo onomastico», prosegue Lorenzini, «l’ansia onnivora del collezionista, non mirano certo a un fine cognitivo; semmai a un mimetismo pseudostorico che il Roda […] identifica nella fattispecie “coll’inalterabile e rassicurante datità del passato”».
Ettore Paratore (1966, p. …) riconobbe nell’Isottèo una «compagine d’immagini e di ritmi, che voleva rappresentare una perfetta resurrezione […] del mondo lirico e figurativo tardo-gotico, che altro era se non un perfetto duplicato italiano delle posticce riesumazioni dugentesche e quattrocentesche dei preraffaelliti inglesi». Di aspetti «neogotici» parlò anche Giorgio Bàrberi Squarotti (1982, p. 60), che vide l’Isottèo oscillare «fra la suprema abilità di un puro esercizio decorativo e risultati clamorosamente kitsch, soprattutto là dove finiscono, nel discorso poetico, a mescolarsi stili e forme secondo un gusto decorativo che è proprio degli ultimi anni dell’Ottocento».
A proposito delle teorizzazioni estetiche dell’Isottèo, Emerico Giachery (1991, p. …) sottolineava la «concezione, non soltanto tradizionalmente umanistica, ma puramente decorativa» dello stile dannunziano.
Decorativismo cromatico, secondo strategiche presenze (Giannantonio 1992), immaginario preraffaellita, rivelato in alcuni simboli caratterizzanti (Oliva 1990), ossessione di frequenze rimarie e foniche dai testi antichi (Grasso 1982), questi alcuni degli elementi su cui si è soffermata la critica. Sulla presenza del dato prezioso e sull’abilità dell’artifex, secondo una «concezione fabbrile dell’arte teorizzata da Banville e Gautier», insisteva Alida D’Aquino.
Evidenziando collegamenti alle esperienze prosastiche delle novelle e del mondo abruzzese, Giorgio Bàrberi Squarotti (1987, p. 114) legge la poesia dell’Isottèo come «il sogno assoluto della letteratura, quello che il sonetto proemiale così efficacemente espone: ma è sognato là dove ben altra letteratura si era incardinata, una letteratura di cose e di gesti concreti, economici e fisiologici».
Raccolta «autunnale» questa dell’Isottèo, dove predominano i colori preziosi, l’oro, il rosso nelle sue sfumature, note cromatiche che, per la loro altezza cronologica, sembrano anticipare certo sensualismo decadente. Ma è proprio il libro, come luogo della parola poetica, che riafferma il senso della raccolta: la lode di Isaotta è cercata attraverso i modi della poesia antica, lungo i rapporti drammatici delle cantate, nella riproposizione ‘trionfale’ del mondo passato, attraverso la mimesi di uno spiritualismo stilnovistico, celebrando la donna che «sale» verso la sua apoteosi letteraria.
Se ne arricchisce il componimento dal titolo Al libro detto Isottèo (nell’Isaotta con il titolo Sonetto liminare), che ha la funzione di testo proemiale, acquistando in tal modo ben altro significato e soprattutto in rapporto al suo contraltare, il sonetto finale al Marradi con explicit «il Verso è tutto». I due testi assolvono, così specularmente posti, una funzione ideologico-estetica, aprendo e chiudendo la raccolta con precise dichiarazioni di poetica. Il Sonetto diviene un luogo di meta-poesia, dove si evocano, in preziose metafore, i contorni del sogno letterario: «Palagio d’oro», «Selva d’oro», «Fonte d’oro». Sono i luoghi chiusi della ‘civil conversazione’, secondo le forme del novellare cortese, e gli spazi aperti degli antichi poemi medievali, teatro di avventure d’armi e d’amore. Il circuito simbolico si chiude nella «fonte», dove sgorga la poesia, e dove scivola il cigno, che altrove è detto «divino». Si ricordi, ad esempio, la Romanza («Lungo il bel fiume, taciti / muovono i cigni a schiera» ecc.) che figurava nelle «altre poesie» dell’edizione 1886 al quarto posto dell’Intermezzo melico, espunta nella Chimera. Il motivo del cigno è tipico di certa lirica di quegli anni: nella Romanza rivive il mito di Leda e della sua unione divina, cantata nelle forme di una poesia nobile e riccamente forgiata. Il tema del cigno che scorre su acque tranquille, pare tuttavia rimandare anche a significati meta-poetici e il connubio viene così a definirsi come rapporto tra il cigno – simbolo della poesia – e l’artefice.
Nei sonetti al Marradi il poeta invita a godere delle gioie di cui è ricolma la vita, mentre nella terzina finale l’accento cade sulla Bellezza dell’arte della Parola di cui il motto «il Verso è tutto» è il concetto significante. Col pretesto di celebrare la «nona rima», D’Annunzio avvia un discorso articolato e dialettico, in cui la riflessione s’incardina su precise posizioni di poetica. L’idea del façonner, secondo formule preziose e stilizzate, il gusto di cesellare e di piegare in forme armoniose, secondo una precisa tendenza dell’arte parnassiana («convien che più sfavilli / sonante il verso») trova nella sezione dedicata al Marradi la sua teorizzazione.
La religione dell’arte e della bellezza, unica vera essenza della vita, avevano già avuto espressione in un articolo dell’8 ottobre 1887, sulla «Tribuna», a firma Duca Minimo, dal titolo Un poeta d’autunno, nella rubrica Cronaca Bizantina:
Tutti […] i poeti inglesi del principio di questo secolo furono rosi internamente dal baco moralista; e quasi tutti anche i lor continuatori romantici. Cosicché, a furia di filosofare e di moralizzare liricamente e di mescere fantasie e dissertazioni, la poesia romantica inglese giunse a non essere più né artistica né plastica. Unico fra tutti, il Keats, fu esente dal contagio. Egli era, sopra ogni cosa, un artista. Non ebbe culto che per la Bellezza. […] E così poco a poco, espulsa ogni dissertazione dimostrativa e cacciato in bando lo spirito moralista, l’arte si purificò, la tecnica fece immensi progressi, lo stile raggiunse una lucidità impeccabile […] Un verso, ben rimato e ben costruito secondo le leggi della prosodia e secondo quelle più delicate e più misteriose del senso musicale, è necessariamente e assolutamente bello di forma e di sostanza, poiché la forma e la sostanza sono inseparabili. (Cronache, II, pp. 150-153)
Eppure, come suggerisce parte della critica, occorre superare la lettura frammentaria del sonetto, troppo spesso citato per il suo ultimo e celebre verso; ed è anzi opportuno considerare globalmente l’intera sezione dei sonetti al Marradi, in cui la poetica viene ricercata attraverso un andamento binario e dialettico. La poesia, lungi dal divenire espressione di un facile ripiegamento sentimentale, si riconosce nella forma pura, coagulata nella limpida assolutezza del verso: «Giova, o amico, ne l’anima profonda / meditare le dubbie sorti umane, / piangere il tempo, ed oscurar di vane / melancolìe la dea Terra feconda?». A tale domanda, volutamente retorica e provocatoriamente rivolta all’amico, d’Annunzio risponde con la proposta di una letteratura d’evasione, quella allontanata nel passato remoto di un mondo epico-cavalleresco, tempo di giostre e tornei, di re e regni fantastici. E non a caso la quartina è calco di un passo dell’Intelligenza, a significare la funzione meta-poetica della letteratura: «Evvi Ginevra ed Isotta la blonda, / e sonvi i pini e sonvi le fontane, / le giostre, le schermaglie e le fiumane, / foreste e lande, e re di Trebisonda!».
A quell’altezza cronologica, vicina alla gestazione del Piacere, d’Annunzio poneva il senso dell’esistenza in quel «Bevere […] con aperta gola / ai ruscelli de ’l canto», in quelle forme dell’edonismo estetico riprese da Lorenzo e riproposte nel Trionfo d’Isaotta. E qui nell’Epodo riassunte nei versi «e coglier rose, / e mordere ciascun soave frutto». Ma è la Parola, «divina», a rendere tutto questo possibile, una parola che ha del Verbum tutta la forza costruttiva, come dirà lo scrittore nel futuro, lontano Libro segreto, caricandola di misteriosa forza simbolica: «La scrittura, l’arte del verbo, è veramente fra tutti i giochi mentali il compiuto: di là dalla pittura, di là dalla scultura, continua l’opera di creazione e dà forma al mistero estraendolo dalla tenebra per esporlo alla luce piena».
La parola, eco preziosa di suoni lontani e di reconditi significati, è creatrice di Bellezza, è essa stessa la «pura Bellezza» che confluisce nell’essenza assoluta del «Verso». La parola può ricreare, far rinascere epoche lontane, quel mondo antico di corte nel quale si snoda la vicenda poetica dell’Isaotta e poi dell’Isottèo. Un Rinascimento di maniera, ripreso e riannodato da tanta letteratura del tempo, riscoperto e riproposto dal bric-à-brac dei salotti e delle mode: spazio nobile e sfarzoso, richiamato nel «Palagio d’oro» dei primi versi del sonetto proemiale. Lo sfavillio del verso, con quel rimando dantesco alle «forme» che «ridono» (in Purg. XI, 82, «carte») sotto la mano dell’abile cesellatore, si adatterà all’espressione della «loda» per una donna che incede, secondo forme della poesia stilnovistica: «quando Isaotta Guttadàuro sale».
Percorrendo la raccolta si ha dunque l’impressione di compiere una rilettura: e d’Annunzio guida in questo percorso di riscrittura tenendo ben saldo il filo del testo – l’Intelligenza – che fa da tessuto connettivo alla raccolta e dal quale rimodula i temi che compongono lo sfondo più antico della vicenda: sono i personaggi mitici o fantastici, con i quali sposta in un passato remoto testi come la Ballata d’Astìoco e di Brisenna, o alcuni componimenti dell’Isaotta nel bosco.
L’identificazione dei due personaggi, il poeta e Isaotta, con le mitiche figure del mondo antico, si formalizza in un Abruzzo senza tempo, ma sempre più simile a una Toscana laurenziana, in cui si alternano solisti e cori. Il paesaggio è ricreato secondo i modi del locus amoenus, spazio del ragionare e del narrare. E poi rinvii al Poliziano delle Stanze, a Lorenzo, a Tasso e Petrarca, ai francesi Flaubert e Gautier, qualche spunto da Carducci e da Swinburne. Da un tema privato e celebrativo (l’amore per Maria di Gallese) la poesia si allarga su territori squisitamente letterari, e la reinvenzione spazio-temporale è possibile grazie alla virtù della parola. Una parola «divina» non ancora caricata della forza esoterica del simbolo, ma che nulla tiene dell’interesse realistico: così avrebbe precisato lo stesso d’Annunzio sulla scelta di certa terminologia geografica: «Il Latamone è nome trovato nell’idrografia mia mentale e nei miei modi di suggerire lo spazio nel suono: latum flumen, effusum…». La precisazione vale a scardinare il rapporto tra significante e significato; eppure quella forza d’invenzione sembra già spianare la strada alla formula di Amiel, che gli sarà cara tra poco, predisponendolo ad una nuova maniera di percepire il reale, lontano dalla realistica sensualità delle novelle: «Le paysage est un état de l’âme».
A completamento dell’Isottèo, come accennato più sopra, d’Annunzio aggiunge alcuni componimenti. La Cantata di Calen d’Aprile, composta in onor d’Isaotta conferma l’interesse dannunziano per i metri antichi. Si tratta di nove ballatette di settenari per gli a solo, alternate da strofette quaternarie o quinarie a canto amebeo fra i due cori. Pubblicata sul numero straordinario della «Tribuna» del 1° aprile 1888, la cantata era accompagnata da una lettera di d’Annunzio (ora in Cronache, II, p. 420). Il componimento fu inserito nell’opuscolo Per le nozze d’Elvira sorella molto diletta, «preceduto da tre sonetti e seguito da un madrigale di Commiato» (9 aprile 1888). La pubblicazione nuziale portava sul frontespizio quattro versi del Poliziano (Stanze, 46): «Con lei se ’n va Onestade umile e piana, / che d’ogni chiuso cor volge la chiave: / con lei va Gentilezza in vista umana, / e da lei impara il dolce andar soave».
Il Guabello scrive che il poeta donò a Barbara Leoni due esemplari dell’opuscolo, uno dei quali portava la data 4 maggio 1888 e che «in fondo alla Cantata svolta nei modi cari al Poliziano nel manoscritto c’è la lode per Barbara». Questa la dicitura: «La sera del 31 marzo 1888 – Barbara sia lodata! – Amen» (Guabello 1948, p. 28). Nell’Isottèo i versi del Poliziano sono sostituiti dalla seconda stanza della ballatetta di Lorenzo il Magnifico, «Chi non è innamorato / esca di questo ballo».
La didascalia iniziale echeggia volutamente i Ragionamenti del Firenzuola. Il Forcella (1887, p. 230), prendendo spunto da un articolo del Doctor Mysticus, apparso sulla «Tribuna» del 2 aprile 1887, dal titolo Il vascello fantasma, riconosce alla Cantata una sorta di esperimento di poesia in musica: «Importante […] anche per l’annunzio […] di un Poema lirico di Gabriele d’Annunzio scritto per la musica di Edoardo Mascheroni. Come tutti sanno, il Poema lirico in musica non è mai apparso in pubblico, e, forse – dico forse – il Poema in poesia è la Cantata di Calen d’Aprile». Giorgio Bàrberi Squarotti (1982, p. 61) ravvisa nel testo «quasi un primo esperimento delle successive esperienze drammatiche». L’aspetto teatrale del componimento è sottolineato anche da Alida D’Aquino, nella introduzione alle Concordanze.
Altra parte aggiunta al libro sono i Madrigali dei sogni. I primi due testi vennero pubblicati sul «Fanfulla della Domenica» del 29 aprile 1888, sotto il titolo di Madrigali notturni insieme ai quattro madrigali della Tristezza d’una notte di primavera (ora accolti nella Chimera). Il terzo compare per la prima volta, assieme agli altri, nell’edizione Treves 1890. L’atmosfera, come dice il titolo, è onirica. Si uniscono e si confondono forme di certo preziosismo parnassiano e temi più direttamente classici.
I Sonetti del giovane autunno furono pubblicati sul «Fanfulla della Domenica» del 16 ottobre 1887 col titolo Prologo d’una allegoria dell’Autunno. Il primo rimanda al poema frammentario in nona rima dell’Allegoria dell’Autunno, avendo con questo alcuni versi in comune. Il secondo venne composto in onore di Ippolita (Barbara Leoni), direttamente nominata in prima stesura e poi sostituita (ed. Treves 1890) da Primavera Isotta. Secondo il Forcella (1887, p. 365), è un «importantissimo documento autobiografico». Significative alcune analogie con il Sogno di un mattino di primavera delle Elegie romane, di poco posteriore alla pubblicazione dei due sonetti in rivista.
Il Trionfo d’Isaotta. Alla maniera di Lorenzo de’ Medici apparve nel «Capitan Fracassa» il 17 aprile 1887 e qui inclusa nella sezione terminale appena prima dell’Epodo. Le fonti d’ispirazione sono da ricercare nel Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo il Magnifico (giusta l’indicazione del sottotitolo) e nel Trionfo d’Amore del Petrarca. Ancora presente il poemetto dell’Intelligenza. Metricamente sono stanze di ottonari, precedute da quattro versi a rima incrociata, variamente ripresi all’interno del testo e dai quali si trae il tema portante della vanitas e della conseguente voluptas nel saper cogliere le gioie dell’amore.
L’Epodo raggruppa i Quattro sonetti al poeta Giovanni Marradi in onore della nona rima. Vennero pubblicati sul «Fanfulla della Domenica» il 16 ottobre 1887 insieme a due sonetti intitolati Prologo d’una Allegoria dell’Autunno sotto il titolo comune di Sonetti. Nell’Isottèo verranno poi chiamati Sonetti del giovane autunno.
I testi vennero scritti per celebrare la poesia in nona rima Notte umbra (quattro stanze poi col titolo di Sotto la Rôcca, nelle Poesie, Barbèra 1902), pubblicata dal poeta livornese Giovanni Marradi sul «Fanfulla della Domenica» il 9 ottobre 1887. Il Guabello (1948, p. 21) dà notizia dell’esistenza degli autografi («Quattro cartelle, datata l’ultima 12 ottobre ’87 e firmata Gabriel») provenienti dalle carte di Angelo Conti. Così ricorda questi componimenti d’Annunzio nel Libro segreto: «o divinazione remota! come posso io rileggere i miei sonetti giovenili al mite poeta Giovanni Marradi senza che il cuore mi balzi e la mente mi baleni?» (Prose di Ricerca, II, p. 918).
Altra l’ispirazione del Marradi che risponde con quattro sonetti pubblicati sul «Fanfulla della Domenica» il 16 ottobre 1887 con il titolo Oh il verso non è tutto… In questi componimenti il Marradi chiariva in realtà una posizione estetica opposta a quella di d’Annunzio, come già il titolo dei sonetti suggerisce: quasi una parodia del famoso emistichio dannunziano «il Verso è tutto». Questi i versi ripresi del secondo dei sonetti marradiani Arte e vita (vv. 1-2 e 5-8): «Oh il verso non è tutto se non vola / su l’ale d’un pensiero alto, o poeta / […] Indarno il vate ai puri si disseta / rivi del canto con aperta gola, / se è sordo al grido delle cose, asceta / della Bellezza inanimata e sola».
D’altronde, nel 1888, anno dei due ultimi componimenti dell’Isottèo, La cantata di Calen d’Aprile e I madrigali dei sogni, d’Annunzio si stava preparando ad aprire la sua poesia verso un nuovo orizzonte. Le prose giornalistiche di questo periodo ci offrono una sorta di testo parallelo, un luogo della meditazione: «C’è una sola scienza al mondo, suprema: – la scienza delle parole. Chi conosce questa, conosce tutto; perché tutto esiste solamente per mezzo del Verbo» («Mattino», 22-23 settembre, 1892, Note su la vita). Basterebbe un testo significativo come Dal Monte Pincio (Elegie romane), composto pure nel 1888, per riconoscere alla poesia dannunziana una nuova risonanza. Nel distico finale si formalizza il senso di una filosofia rivolta al rapporto tra l’io e il mondo, tra il poeta e la realtà: «L’anima sta: tranquilla rispecchia la vita e raccoglie / entro il suo vasto cerchio l’anima delle cose».
Riflessioni su questa nuova apertura, poetico-filosofica, conterrà anche la lettera a Hérelle del novembre 1892, in cui si ricordavano certi esercizi da «cesellatore» come forme estenuate di artificio: «Ma queste sottigliezze di forma rendevano sterile la mia intelligenza, restringevano il cerchio del mio spirito». Il percorso che d’Annunzio stava seguendo non portava certo alla poesia di meditazione sulle «dubie sorti umane», si allontanava tuttavia dall’assoluta certezza estetica, per allargarsi sull’inesplorato e misterico mondo dei simboli. Nella formulazione assoluta dell’«emistichio sentenziale» d’Annunzio storicizzava la sua poesia e dichiarava anche la sua fine.
Bibliografia essenziale
Bibliografia primaria
Gabriele d’Annunzio, Isaotta Guttadàuro ed altre poesie, illustrazioni di Vincenzo Cabianca, Onorato Carlandi, Giuseppe Cellini, Enrico Coleman, Mario De Maria, Cesare Formilli, Alessandro Morani, Alfredo Ricci, Giulio Aristide Sartorio, Roma, Editrice La Tribuna, 1886.
Poesie di Gabriele d’Annunzio, Isottèo-La Chimera (1885-1888), Milano, Treves, 1890.
Gabriele d’Annunzio, L’Isottèo [1886] – La Chimera [1885-1888], Istituto Nazionale per la Edizione di Tutte le Opere di Gabriele D’Annunzio, Verona, Mondadori, 1930.
Gabriele d’Annunzio, L’Isottèo [1886] – La Chimera [1885-1888], Il Vittoriale degli Italiani, 1939.
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, Milano, Mondadori, 1950.
Gabriele d’Annunzio, Commento alle poesie liriche di Gabriele d’Annunzio, a cura di Ferruccio Bernini, Bologna, Zanichelli, 1928.
Gabriele d’Annunzio, Il fiore della lirica, a cura di Francesco Flora, Milano, Mondadori, 1935.
Gabriele d’Annunzio, L’Isottèo – La Chimera, a cura di Enzo Palmieri, Bologna, Zanichelli, 1955.
Gabriele d’Annunzio, Poesie, Teatro, Prose, a cura di Mario Praz e Ferdinando Gerra, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966.
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, ed. diretta da Luciano Anceschi, vol. I, a cura di Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 1982.
Gabriele d’Annunzio, Poesie, a cura di Federico Roncoroni, Milano, Garzanti, 1982.
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore, a cura di Pietro Gibellini, Torino, Einaudi, 1995.
Gabriele d’Annunzio, Tutte le poesie, vol. I, a cura di Gianni Oliva, Roma, Newton Compton, 1995.
Bibliografia secondaria
Henri Frédéric Amiel, Fragments d’un journal intime, Torino, Einaudi, 1978-1981, 4 voll.
Giorgio Bàrberi Squarotti, Invito alla lettura di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mursia, 1982.
Giorgio Bàrberi Squarotti, Il sogno dell’Isottèo, «Annali d’Italianistica», 5, 1987, pp. 111-128.
Sergio Cigada, Flaubert, Verlaine, e la formazione poetica di D’Annunzio, «Rivista di letterature moderne comparate», marzo 1959.
Concordanze dell’«Isottèo» e delle «Elegie romane» di Gabriele d’Annunzio, a cura di Alida D’Aquino e Giuseppe Savoca, Firenze, Olschki, 1990.
Angelo Conti, La beata riva, a cura di Pietro Gibellini, Venezia, Marsilio, 2000.
D’Annunzio a Georges Hérelle, correspondance présentée par Guy Tosi, Paris, Denoël, 1946.
Eurialo De Michelis, Tutto D’Annunzio, Milano, Feltrinelli, 1960 [rist. Guida a D’Annunzio, Torino, Meynier, 1988].
Alfredo Gargiulo, Gabriele d’Annunzio, Napoli, Perrella, 1912; ed. accr. Firenze, le Monnier, 1941.
Emerico Giachery, Verga e D’Annunzio, Milano, Silva, 1968.
Emerico Giachery, Verga e D’Annunzio. Ritorno a Itaca, Roma, Studium, 1991.
Maria Rosa Giacon, La degradazione del simbolo: il giglio in Dante Gabriele Rossetti e in Gabriele d’Annunzio, «Atti e memorie dell’Accademia Patavina di scienze, lettere e arti», XCII, 1980.
Maria Rosa Giacon, L’«imagination re-créatrice» e l’«au-delà nuageux de toutes les choses du nord» nel paesaggio dannunziano, in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, Editoriale Programma, 1993.
Valeria Giannantonio, L’universo dei sensi nell’«Isottèo», D’Annunzio per una grammatica dei sensi, a cura di Gianni Oliva, Chieti, Solfanelli, 1992.
Sebastiano Grasso, Per il D’Annunzio isottéo: l’«Intelligenza» alle origini del «Dolce grappolo», «Siculorum Gymnasium», gen.-dic. 1982.
Giuseppe Fatini, Il D’Annunzio e il Pascoli e altri amici, Pisa, Nistri-lischi, 1963.
Georges Hérelle, D’Annunzio à Georges Hérelle, 1891-1913, a cura di Maria Giovanna Sanjust, Bari, Palomar, 1993.
Lettere a Georges Hérelle, 1891-1913, a cura di Maria Giovanna Sanjust, Bari, Palomar, 1993.
Angelo Jacomuzzi, Una poetica strumentale. Gabriele d’Annunzio, Torino, Einaudi, 1974.
Pier Vincenzo Mengaldo, La tradizione del Novecento. Da D’Annunzio a Montale, Milano, Feltrinelli, 1975; La tradizione del Novecento. Terza serie, Torino, Einaudi, 1991.
Enrico Nencioni, Isaotta Guttadàuro, in Nuovi saggi di letterature straniere e altri scritti, Firenze, Le Monnier, 1909.
Adelia Noferi, Per una storia dello stile dannunziano, «Quaderni dannunziani», fasc. VIII-IX (1958).
Gianni Oliva, D’Annunzio e la poetica dell’invenzione, Milano, Mursia, 1992.
Gianni Oliva, La cultura dell’estetismo romano e gli scritti di Angelo Conti, in D’Annunzio a Roma, Atti del Congresso (Roma 1989), Roma, Istituto Nazionale di Studi romani, 1990, pp. 113-134.
Ettore Paratore, Studi dannunziani, Napoli, Morano, 1966.
Ezio Raimondi, Il silenzio della Gorgone, Bologna, Zanichelli, 1980.
Edoardo Sanguineti, Tra Liberty e crepuscolarismo, Milano, Mursia, 1961, 19772.
Enrico Thovez, L’arco di Ulisse, Napoli, Ricciardi, 1921.
Guy Tosi, Influences françaises sur la langue et le style de D’Annunzio de «L’Isottèo» au «Piacere», «Rivista di letterature moderne e comparate», XXXI, marzo 1978, pp. 22-53.
Guy Tosi, D’Annunzio e la cultura francese, Saggi e studi (1942-1987), a cura di Maddalena Rasera, Lanciano, Rocco Carabba, 2013, 2 voll.
Guy Tosi, D’Annunzio et le symbolisme français, in D’Annunzio e il simbolismo europeo, Atti del convegno di studio di Gardone Riviera, 14, 15, 16 settembre 1973, a cura di Emilio Mariano, Milano, Il Saggiatore, 1976, pp. 223-282.
Guy Tosi, D’Annunzio et la France (état présent de la question), in L’arte di Gabriele d’Annunzio, Atti del convegno internazionale di studio, Venezia-Gardone Riviera-Pescara, 7-13 ottobre 1963, a cura di Emilio Mariano, Milano, Mondadori, 1968, pp. 421-435.