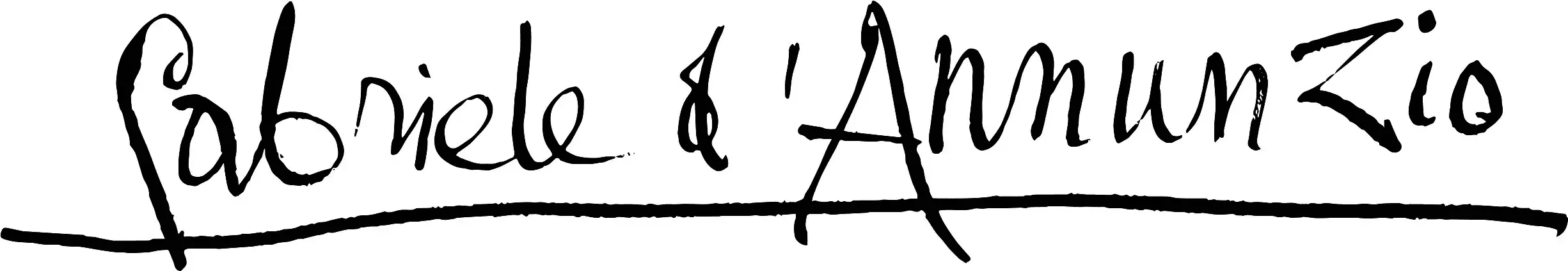di Pietro Gibellini, Enciclopedia dannunziana
I tre poeti più celebrati dell’Italia unita – Carducci, Pascoli, d’Annunzio – erano accomunati dall’apertura alle nuove suggestioni della letteratura europea. Questo accadeva in misura e in modi diversi: Carducci era attratto da autori francesi e soprattutto tedeschi, da Béranger e da Heine; Pascoli aveva prontamente recepito e spesso precorso le scelte innovative del simbolismo poetico, specialmente francese; d’Annunzio aveva assorbito e originalmente rilanciato le suggestioni tematiche e linguistiche del decadentismo, facendo della Francia il trampolino della sua fama internazionale. Questa vena cosmopolita, in tutti e tre i poeti, coesisteva con il sentimento della modernità dell’antico e la volontà di rivisitare i classici greci e latini. Tutti e tre si cimentarono con le traduzioni o «tradimenti», come li chiama d’Annunzio, il cui libro d’esordio, latinamente intitolato Primo vere per suggestione del carducciano Vere novo, presentava un’appendice di versioni dai classici (quattordici testi da Orazio, due da Catullo, una da Tibullo, quattro dagli Inni omerici). Fra i tre, Pascoli fu il più assiduo e filologicamente attrezzato e aggiunse all’attività di antologista (Lyra, Epos) quella di poeta in latino. Per Carducci, il ritorno all’antico riguardava la forma, con la sperimentazione della metrica barbara nella quale si cimentò anche il giovane d’Annunzio; ma coinvolgeva soprattutto la visione del mondo, la nostalgia risorgimentale della gloria di Roma, alla luce di un neopaganesimo virile ed eroico. D’Annunzio mirava, in questo, a cogliere l’eredità del maestro, proclamandosi vate della nuova Italia.
I classici nella biblioteca del Vittoriale
Dopo gli studi ginnasiali e liceali all’eccellente collegio Cicognini di Prato, d’Annunzio si iscrive alla Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma, frequentando poco le lezioni e rinunciando presto a conseguire la laurea; tra i pochi docenti ricordati con stima compaiono il filologo romanzo Ernesto Monaci e il latinista Onorato Occioni. La familiarità con il latino e il greco, acquisita al ginnasio-liceo, non venne mai meno; la biblioteca del Vittoriale, dove il poeta si ritirò a partire dal 1921, abbonda di opere di autori latini e greci. Parecchi di questi appartengono al nucleo librario del precedente possessore della villa di Gardone, lo storico dell’arte rinascimentale Henry Thode; solo una parte dei nuclei delle biblioteche delle principali antecedenti dimore di d’Annunzio, quelle della Capponcina e di Arcachon, confluirono nella villa sul Garda.
D’Annunzio, che nel Libro segreto (1935) si definì «bibliomante» con un neologismo coniato sul termine rabdomante, si muoveva con grande destrezza tra le migliaia di pagine della sua biblioteca, col sussidio di preziosi strumenti di consultazione: l’orientamento per la lingua e la letteratura italiana lo offriva il Vocabolario del Tommaseo, quello per il latino lo fornivano il prezioso strumento approntato da Egidio Forcellini, il Totius Latinitatis Lexicon, presente tra i libri del Vittoriale nell’edizione del 1839-41. S’intende però che la conoscenza della letteratura classica era capillare, e non riguardava solo gli autori maggiori. Questi, nella biblioteca gardonese, che naturalmente documenta più le riletture che le prime letture, disseminate tra gli anni della giovinezza e della prima maturità, figurano spesso in diverse edizioni, tra cui le più qualificate collane europee. Per i testi greci, quando disponga di traduzioni convincenti, come quella di Vincenzo Monti per l’Iliade, o Felice Bellottri e di Leconte de Lisle per i tragici greci , lo scrittore se ne giova (lo ha mostrato Ilvano Caliaro per Fedra). Per le edizioni fornite di versione a fronte, i segni di lettura mostrano che d’Annunzio, almeno il d’Annunzio dai cinquantott’anni in su, per facilitare la lettura scorre preferibilmente la traduzione, salvo spostare l’occhio e il lapis sull’originale nei punti che più gli interessano. Quando si imbatteva in una lezione controversa o in un passo espressivamente interessante, era infatti in grado di controllare agevolmente l’originale.
Per avere un’idea della quantità, qualità e stato dei testi classici nella biblioteca del Vittoriale, do qualche ragguaglio sui volumi di Ovidio, il più amato dei poeti latini. Delle trentacinque stampe rintracciate negli scaffali della sua villa, quattordici recano l’ex-libris di d’Annunzio, una solo quello di Thode e tre quelli di Leo Olschki: trattandosi di libri antichi, potrebbero essere frutto di acquisto, di dono o del recupero di parte della biblioteca della Capponcina andata all’asta con altri beni della villa fiorentina per sanare i debiti dello scrittore. Si tratta in buona parte di stampe pregiate, tra cui sei cinquecentine, compresa l’edizione figurata stampata a Lione nel 1557, con dedica al poeta della donatrice, la marchesa Luisa Casati Stampa, l’eccentrica amante di d’Annunzio descritta nella Contemplazione della morte (1912) e nel Libro segreto (1935).
Molte recano i caratteristici segni di lettura di Gabriele: postille, sottolineature interlineari, tratti a margine, cartigli annotati, angoli piegati dei fogli, fiori secchi inseriti tra le pagine. Queste tracce si addensano nei grossi tomi delle Metamorfosi volgarizzate da Arrigo Simintendi (Prato, 1846-1850) e nell’edizione teubneriana dei Tristia, dell’Ibis, delle epistole Ex ponto e dei Fasti (Lipsiae, 1889). La prima opera è posata sul tavolino della Stanza del Lebbroso, come d’Annunzio battezzò la camera della meditazione; l’altra si trova nella stanza del lavoro, l’Officina. La collocazione di questi libri suggerisce che la rilettura del poeta sulmonese sollecitava ancora il vecchio scrittore, per ragioni che potremmo collegare, per la prima, al fatto che d’Annunzio, entusiasta del cinema, aveva scritto che con quel moderno mezzo d’espressione si sarebbero potute rendere con effetti speciali le mitiche metamorfosi ovidiane (Del cinematografo, 1914, ora d’Annunzio 2003), mentre la seconda consuona con due motivi dominanti nel vecchio eremita del Vittoriale, quasi esule in riva al Garda: i fasti della patria celebrati dal Vate e la tristezza che affiora spesso nel vecchio diarista.
Tra le edizioni dei classici ellenici, segnaleremo per i lirici l’Anthologie grècque a cura di Friedrich Jacobs pubblicata a Parigi da Hachette nel 1863, i cui due volumi recano fitti segni di lettura da parte di d’Annunzio. Dei sedici volumi con tragedie di Euripide, quattro sono edizioni tedesche, tre recano l’ex-libris di Thode e uno la dedica del curatore allo studioso germanico. Al contrario, due edizioni dedicate da Ettore Romagnoli – l’«ellenista, contrappuntista, poeta» ricordato nel Libro segreto (d’Annunzio 2010, p. 163) – risultano parzialmente intonse: ma si tratta di volumi del 1911 e del 1912, successivi cioè al confronto ravvicinato con l’Ippolito coronato, la tragedia di Euripide febbrilmente compulsata da Gabriele per comporre la sua Fedra (1909). L’edizione del teatro di Euripide più costellata di segni di lettura è invece quella parigina di Lemerre, 1884, con la versione di Leconte de Lisle, mentre non ne figurano sulla versione di Felice Bellotti (possedura dallo scrittore nella stampa fiorentina del 1875). Il fatto che le edizioni dei classici greco-latini in tedesco siano quasi tutte attribuibili al nucleo librario di Thode dimostra come d’Annunzio non conoscesse il tedesco, mentre le fitte note sulle edizioni elleniche segnalano la sua profonda conoscenza del francese.
Echi intertestuali e ideologici
Ora, la piena padronanza del latino e del greco comporta conseguenze anche sulle caratteristiche del linguaggio dannunziano. Non mi riferisco alla sintassi, poiché la costruzione di periodi ampi e ricchi di subordinate, che da Cicerone attraverso Boccaccio e Bembo aveva caratterizzato secoli di prosa italiana, è estranea a d’Annunzio, la cui scrittura è essenzialmente paratattica, tanto nei periodi brevi che in quelli lunghi. È invece il lessico che ci offre spesso latinismi di tipo semantico o formale: il lettore s’imbatte dunque nel sostantivo numero riferito al ritmo della prosa, o a grafie quali imagine, ebro o transposizione: e gli esempi potrebbero moltiplicarsi a piacere. Più limitato l’uso dei grecismi, circoscritto generalmente a passi in cui si evoca l’antica civiltà ellenica e a termini tecnici a lei connessi (peltasti, lebete, porfirogenito ecc.), per non dire dei soprannomi assegnati alle amanti (Corè, la giovane dalla bellezza statuaria; Mélitta, bionda come un’ape e dolce come il miele; Lachne, dalla guancia deliziosamente lanuginosa ecc,). Sono da ricordare le correzioni che l’autore pose alla versione francese della Città morta preparata da Georges Hérelle, ad esempio la restituzione della grafia grecizzante «Akheron» al termine con cui il traduttore aveva reso «Acheronte», cioè «Achéron» (esaminando questa e altre varianti in un mio vecchio studio ho parlato di «archeologia linguistica»; Gibellini 1976). Le ricerche sul linguaggio dannunziano, che certo non mancano, mi pare abbiano trascurato di approfondire questo aspetto.
I testi di d’Annunzio, specie in prosa, abbondano di citazioni e motti latini, particolarmente fitti negli scritti di oratoria patriottica. Basti ricordare che, mentre i libri di versi dedicati alla conquista della Libia e alla Grande guerra evocano l’epica carolingia e la fratellanza antitedesca (Canzoni della gesta d’oltremare, 1912; Canti della guerra latina, 1915-18), gli scritti per la campagna d’Abissinia recano per titolo il motto latino di Cesare (Teneo te Africa, 1936), presentando di fatto come reincarnazione del condottiero romano il duo Duce-Re celebrato nella popolarissima canzone di Micheli e Ruccione Faccetta nera (cfr. Braccesi 1989). Echi e citazioni in italiano dei poeti greci non mancano nella poesia e nel teatro, ad esempio nella Città morta, aperta dalla versione di un passo dell’Antigone di Sofocle, un verso di Sofocle (Eros anìkate màchan, «Amore invitto in battaglia»), figura nel frontespizio come esergo in caratteri greci. Inoltre non mancano citazioni in caratteri greci, come ad esempio l’erotico Carmen votivum, (1927) inserito nel Libro segreto: tutto trapunto di frammenti dei lirici greci, scritti inizialmente in caratteri latini sostituiti nell’autografo dalle lettere dell’alfabeto greco. Tra questi, spiccano le ultime parole del celebre frammento di Saffo riportato dallo Pseudo-Longino come esempio di stile sublime (Phàintaì moi kênos, fr. 22), cioè allà pân tòlmaton: nella sua versione in latino dell’ode saffica Catullo aveva inteso quell’espressione come una esortazione finale – rivolta soprattutto a sé – a sopportare le pene d’amore («sed omnia, perferendum», Liber, 51), mentre d’Annunzio, nel contesto del suo poemetto, la interpreta come esortazione al massimo ardimento erotico nelle forme dell’amplesso amoroso: una sfumatura traduttologica che la dice lunga sulla visione dell’amore, etica nel poeta latino, atletica in quello moderno. Nello stesso Carmen, il sessantaquattrenne Dongiovanni-Narciso, contemplando il corpo nudo della giovane amante, è incerto se accostarla frontalmente o dorsalmente, e scrive: «Nella greca mia mente Euclide istesso / tra circolo e triangolo è perplesso». La «mente greca» (e latina) di d’Annunzio affiora soprattutto nelle note che lo scrittore maturo incluse nel Libro segreto, e che vertono spesso sulla propria esperienza biografico-letteraria e sull’arte in genere. Leggiamone un paio: «Viaggiare non giova. io conoscevo la vera Grecia prima di approdare a Patrasso e di riverire Erme in Olimpia, prima di toccare le colonne del Partenone e le maschere micenee di oro» (d’Annunzio 2010, p. 341). E poi: «Se l’umanesimo non è se non l’arte di farsi uomo di là dall’umano […], se l’umanesimo non è se non l’arte di costruire sé medesimo facendosi il fabro del suo proprio ingegno, il suo proprio fabro mentale, io sono il supremo degli umanisti, ch’ebbi la pazienza ed ebbi la costanza di vivere in comunion di spirito con l’intiera somma della umana esperienza, con la Somma intellettuale e morale a noi conservata dalle Lettere greche e latine e italiane e francesche» (ivi, p. 343).
Nel primo passo lo scrittore manifesta la sua innata natura ellenica, prima dell’agnizione legata al viaggio in Grecia del 1895 che segnò una svolta nella sua produzione, i cui frutti più vistosi sono il disegno di restaurare la tragedia, enunciato nel Fuoco (1900) per bocca del protagonista Stelio Èffrena, suo trasparente doppio, e avviato con la composizione della Città morta (1898) e con parti cospicue del primo libro delle Laudi, Maia (1903).
Nella seconda riflessione chiarisce la sua idea di umanesimo, del quale si ritiene il rappresentante più completo, e che coinvolge la vocazione alla totalità dell’essere, maturata e alimentata dal suo contatto con le quattro letterature elette: due antiche, la greca la latina, e due moderne, l’italiana e la francese. La Weltliteratur del d’Annunzio lettore contempla, con il sussidio di traduzioni, frequenti puntate nei territori delle letterature inglese e anglo-americana, tedesca, e russa, oltre a una buona conoscenza dei libri biblici, vangeli apocrifi inclusi, e sporadiche spedizioni nelle antiche regioni dell’India e della Persia, fino al lontano Giappone: ma i quattro distretti fondamentali restano quelli da lui indicati nel frammento sul suo personale umanesimo.
C’è dunque un problema di Weltanschauung, che non riguarda puramente il linguaggio e le fonti, ma una visione di civiltà. A tal proposito, almeno un cenno va fatto anche alla visione storico-politica dello scrittore in rapporto alle società antiche. Di Roma latina egli celebra soprattutto la forza conquistatrice e civilizzatrice: in questo egli si colloca nella linea risorgimentale, poi nazionalista, irredentista e (purtroppo) imperialista dell’Italia otto-novecentesca. Lo scrittore contesta dunque già nel Piacere l’Italietta borghese e la Roma «bizantina»; al mitomane protagonista delle Vergini delle rocce lo scrittore fa cullare il sogno di generare un nuovo Re di Roma che rinnovi i fasti del caput mundi; celebra in versi in Elettra gli eroi che si prodigano per ridare alla patria la gloria antica. Ne consegue che l’Urbe esaltata, che nel Piacere era soprattutto la Roma barocca, è diventa sempre più quella imperiale costruita da Cesare, mentre la Roma repubblicana resta sullo sfondo; tra le virtù dei pristini mores lo scrittore esalta solo il valor militare, collegato alla volontà di potenza della sua visione superomistica. Della Grecia, invece, d’Annunzio esalta essenzialmente il culto sovrano della bellezza; poco o nulla gli preme dell’ideale democratico della pòlis, e la figura da lui ammirata, a parte i poeti, è il conquistatore Alessandro. In un intervento del 1963 Carlo Diano compendiava la visione dannunziana della grecità identificando la terna delle figure a lui più care: come uomo, l’audace e spregiudicato Alcibiade; come eroe Ulisse, visto soprattutto in quanto esploratore e guerriero; come dio Ermes, il mercuriale campione del dinamismo, maestro nel cogliere il kairòs, l’attimo fuggente dell’opportunità (cfr. d’Annunzio 2010, p. 343).
Quanto alla civiltà letteraria, i limiteremo a segnalare gli autori che più incisero tra gli scrittori assimilati da d’Annunzio. Tra gli scrittori greci Omero e soprattutto gli Inni omerici e quelli Orfici, che giocarono un ruolo importante nella genesi delle Laudi; Esiodo, da un cui passo scaturì l’idea di intitolare ciascun libro del ciclo delle Laudi a una delle Pleiadi, la costellazione generata dalla mitica trasformazione in astri delle figlie di Pleione, che insegna la rotta ai naviganti e regola il tempo dei lavori campestri (cfr. Gibellini 2018), ma anche gli storici, i trattatisti e i biografi (Erodoto, Senofonte, Pausania, Plutarco), mentre meno rilevante appare l’influenza dei poeti ellenistici (Teocrito, Callimaco). Da notare poi, nella riscrittura parablasfema del Vangelo secondo l’Avversario (nel secondo tomo delle Faville del maglio, 1928), la consultazione della Bibbia greca dei Settanta.
Nella letteratura latina spicca, come accennato, soprattutto Ovidio, che nel capolavoro poetico dell’Alcyone risulta di gran lunga il più echeggiato. Ovidio è il prediletto non solo per la comune provenienza abruzzese – un particolare cui lo scrittore fu sempre sensibile – ma per la congenialità di materia e di forma: la polarità tra erotismo e malinconia, l’accesa fantasia mitologica, la celebrazione delle glorie patrie, la ricchezza del lessico, e lo stile musicale. A Ovidio segue Virgilio. Dalle Metamorfosi provengono i soggetti e titoli di tre poesie alcionie (Terra, vale!, Stabat nuda Aestas, Altius egit iter), mentre dall’Eneide virgiliana è preso quello di Furit aestus. Meno congeniale a d’Annunzio era il terzo dei grandi poeti, Orazio: il suo senso della misura non si confà a d’Annunzio, portato al superamento del limite, e la satira bonaria del poeta di Venosa è decisamente lontana dalla tendenza enfatica del Pescarese. Qualche rilievo hanno i poeti elegiaci (Properzio, Catullo), mentre assai meno rilevante è il ruolo giocato dai prosatori, con l’eccezione di sant’Agostino, di cui il “neopagano” scrittore è lettore attento e ricettivo, non solo delle Confessioni, care al D’Annunzio memorialista dell’ultima stagione , quella introspettiva.
Attraverso Nietzsche: Maia, La città morta, Fedra
Ora, sarebbe impossibile nello spazio di una voce enciclopedica dar conto dei temi e degli echi classici nella smisurata opera di d’Annunzio: del resto, disponiamo di una consistente serie di commenti, che danno egregiamente conto delle reminiscenze greco-latine dello scrittore, specialmente del poeta: va reso omaggio, in tal senso, alla pionieristica annotazione che Enzo Palmieri procurò per le raccolte poetiche di d’Annunzio tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, sfruttata nel commento dei «Meridiani» che non dà adeguato riconoscimento al lavoro pionieristico di Palmieri. Mi soffermerò ora sui due casi più adatti a illustrare il tema assegnato, quelli della tragedia in versi mitologica Fedra e del terzo libro delle Laudi, Alcyone. Nel passo del Libro segreto sopra citato, d’Annunzio scrive che egli portava la Grecia dentro di sé prima di visitarla. Vero è che comunque il viaggio in Grecia del 1895 segnò una svolta per la carriera intellettuale e artistica dello scrittore. Di quel viaggio abbiamo molte testimonianze: i Taccuini di d’Annunzio e i diari di due degli amici che lo accompagnarono in quella spedizione sul panfilo di Edoardo Scarfoglio, cioè l’antropologo Guido Boggiani e il traduttore francese delle opere dannunziane, Georges Hérelle. D’Annunzio caricò l’imbarcazione di libri; i classici greci – epici, tragici. lirici, storici, ma non filosofi – al punto da far abbassare pericolosamente la linea di galleggiamento (cfr. Tosi 1947 e gli atti del convegno Verso l’Ellade) .
Episodi di quel viaggio vennero riversati e trasfigurati nel poema di Maia: l’incontro con un velista solitario gli fece pensare di aver incrociato Ulisse; la prostituta del bordello dove lo scrittore si precipitò appena sbarcato al Pireo venne reinventata come la sfiorita Elena ricondotta in Grecia dopo l’incendio di Troia. Sul panfilo il poeta aveva con sé anche Les excursions archéologiques di Charles Diehl, e il contatto con le cosiddette tombe degli Atridi scoperte da Heinrich Schliemann negli scavi di Micene gli diedero spunto per la composizione della sua prima tragedia, quella Città morta già promessa a Eleonora Duse ma che Gabriele affidò alla rivale dell’attrice, Sarah Bernhadt, convinto che il debutto a Parigi avrebbe avuto maggior risonanza, causando così la prima rottura con l’attrice italiana, compagna della sua stagione creativamente più intensa. Ma la lettura più decisiva in questo torno di tempo è quella di Friedrich Nietzsche, scoperto inizialmente attraverso la mediazione di testi francesi, come dimostrò un maestro del rapporto tra d’Annunzio e la Francia, Guy Tosi.
Attraverso la visione nietzschiana della dialettica tra Apollo e Dioniso come polarità essenziale della civiltà ellenica, d’Annunzio rinnovò il suo classicismo, fino ad allora allineato a posizioni neoclassiche, carducciane e parnassiane; la scoperta delle pulsioni istintive ridava sangue, per dir così, a una grecità irrigidita sugli schemi di armonia, misura e razionalità. Anche se d’Annunzio, scrivendo all’amico Vincenzo Morello, volle dirsi nietzschiano prima di conoscere il geniale «distruttore», come lo definì nell’ode commemorativa inclusa in Elettra, quel saggio esercitò un’influenza decisiva su di lui.
Lo scrittore, già celebre come poeta e narratore, si appassionò all’idea di restaurare la tragedia, sostanzialmente emarginata nell’Ottocento e rimpiazzata dal dramma romantico e verista, e con quella la natura stessa della fruizione teatrale: un teatro con carattere di festa sacra, proposto all’aperto all’intero popolo, una rivelazione di bellezza fondata essenzialmente sulla parola poetica (di qui la scarsa fortuna scenica del teatro dannunziano, adatto invece alla lettura). Il sogno di restaurare e rilanciare il teatro romano di Albano, coltivato all’incrocio dei due secoli, l’avrebbe ripreso al Vittoriale, progettando un teatro en plein air sul modello di quelli antichi, realizzato però nella dimora gardonese solo dopo la morte del poeta. L’idea di fondo, collimante con l’antistoricismo di Nietzsche, è che sotto la parvenza del divenire storico (l’«errore del tempo», come lo definisce d’Annunzio) permangano i potenti istinti ancestrali che agitano da sempre l’animo umano e ne condizionano la condotta immutati: la competizione per il potere e per il sesso, la gelosia e l’odio inter- e intrafamiliare, la passione incestuosa… In fondo, Sigmund Freud stava muovendo in direzione analoga, cercando nel mito greco gli archetipi dei «complessi», e trovando i due forse più celebri proprio nei miti tragici. Lo scrittore immagina che un ideale sosia di Schliemann, più colto e aristocratico, scopra le tombe regali di Micene con le maschere d’oro degli Atridi: lo scavo però rimuove, con la polvere millenaria, quello che l’autore chiama l’«errore del tempo», sicché riemergono le antiche maledizioni di quella stirpe, macchiata di sangue e di incesti. Il protagonista si innamora della giovane sorella dell’amico fraterno, un poeta che l’ha accompagnato nella missione archeologica; la moglie dell’archeologo, cieca ma veggente, percepisce il crudele destino cui non può opporsi; vi si oppone il poeta che, per evitare all’amico il disonorevole adulterio, ma spinto anche dalla gelosia, uccide la sorella, verso la quale nutre una inconfessabile passione. Questo «atto puro», nelle intenzioni dell’autore, differenzierebbe l’eroe moderno, capace di contrastare in parte il fato, dai personaggi antichi. Di quelli, però, i suoi condividono, nelle dichiarazioni dell’autore, la possanza delle titaniche creature di Eschilo e di Sofocle e al tempo stesso la leggerezza di chi calca il carro di Tespi, «ombre» e «simboli» oltre che personaggi.
Dopo varie prove teatrali di diversa ambientazione storica e geografica, d’Annunzio nella tragedia in versi Fedra (1909) si cimenta nuovamente con la mitologia greca, riscrivendo e innovando la storia della moglie di Teseo. Nella tradizione, con varianti anche significative, la protagonista languisce perché innamorata del figliastro Ippolito che, quando apprende di questa passione proibita, respinge inorridito la donna, la quale decide di suicidarsi, lasciando però un messaggio in cui accusa Ippolito di averla insidiata, provocando in tal modo la maledizione di Teseo, la quale, accolta da Poseidone-Nettuno, provoca la morte del figlio innocente.
La vicenda aveva già ispirato grandi scrittori del passato remoto e prossimo: il greco Euripide (la cui tragedia però esponeva nella vetrina del titolo il protagonista maschile: Ippolito coronati), una delle Eroidi di Ovidio (lettera di Fedra a Ippolito), la tragedia di Seneca, quella di Jean Racine, il poemetto drammatico di Algernon Swinburne (quest’ultimo letto in versione francese). Sono tutti testi ben presenti a d’Annunzio, il quale nella sua visione di una Weltliteratur non pone barriera di tempo né di lingua. Nella sua pratica di contaminatio d’Annunzio non si limita a cogliere spunti tematici e verbali dalle cinque riscritture del mito di Fedra sopra citati; egli aggiunge altre tessere antiche: attinge vari episodi dai Sette contro Tebe di Eschilo, dai due Edipo di Sofocle, dalle Supplici e dalle Fenicie di Euripide, senza contare le fonti erudite per la descrizione del Mediterraneo antico (Pausania) e per la minuziosa terminologia equestre (Senofonte). Quando poi descrive l’episodio di Capaneo fulminato da Zeus mentre scala le mura di Tebe, d’Annunzio attinge a piene mani a espressioni di Dante, che aveva posto il bestemmiatore tebano nel suo Inferno.
Il carattere transculturale della prassi dannunziana coinvolge, oltre alla pluralità delle fonti ispirative, anche quella dei generi. L’autore dichiara infatti che all’origine della sua tragedia sta l’interesse per gli scavi condotti da Arthur Evans a Creta, che avevano stimolato nel 1903 la composizione del quarto Ditirambo di Alcyone, dedicato al mito di Icaro, e il motivo del Labirinto, posto in copertina e nel testo del romanzo quasi coevo a Fedra, Forse che sì forse che no, del 1910 (cfr. l’Intervista a Simoni del 1909, ora d’Annunzio 2002), ma anche l’aria Divinités du Styx dell’Alcesti di Gluck, che gli instillò l’idea di assegnare a Fedra un culto di divinità notturne venerate a Creta in opposizione alla teologia olimpica rappresentata dall’ateniese Teseo.
Pur dichiarandosi ammiratore di Racine, e citando il suo celebre verso «C’est Venus tout entière à sa proie attachée» (I, v. 396), disse che voleva restituire all’eroina raciniana, che gli appariva addobbata con panni stile Louis XIV e abitata da valori cristiani, il pelo e il sangue pagano del personaggio di Euripide. In realtà d’Annunzio altera radicalmente il personaggio rispetto ai modelli precedenti, Euripide incluso; la donna – secondo il mito – è vittima innocente di Afrodite-Venere che, adirata perché il giovane Ippolito si dedica solo alla caccia venerando la casta Artemide-Diana e disprezzando l’amore, si vendica facendo innamorare di lui la matrigna. Dunque nel tragico greco, nel latino e nel francese, essa soffre la sua disdicevole passione, e si lascerebbe morire se non intervenisse la nutrice impietosita a incoraggiarla a svelare al giovane il suo sentimento, e quando, disperata per il diniego del giovane ma anche offesa per il disprezzo da lui mostrato verso lei e l’intero genere femminile, Fedra decide di suicidarsi, ritorce su Ippolito l’accusa di una passione incestuosa. D’Annunzio fa invece di Fedra una specie di Superuomo al femminile: è lei che rivela sfrontatamente a Ippolito il suo desiderio, lo giustifica con ragioni etiche e pratiche che trovava in Ovidio (lei gli è matrigna e non madre, la coabitazione favorirà la tresca senza destare sospetti), ostenta una sensualità alla Swinburne, dice apertamente di essere stata violentata da Ippolito e, dopo la morte del giovane, rinfaccia a Teseo di aver tradito sua sorella Arianna, di averla a suo tempo rapita come una preda; rivendica con orgoglio la sua regale stirpe cretese disprezzata dai greci e il culto delle divinità ctònie, contrapposte agli dèi olimpici. La tragedia termina con la donna che, assunto il veleno, regge il corpo di Ippolito per varcare la soglia dell’Oltretomba dove potrà congiungersi con lui in un misterioso amplesso, rinnovando l’esempio della moglie di Capaneo che era salita sul rogo dove ardeva il corpo del marito come su un talamo funebre. Fedra è fiera di aver tenuto alla dea e al fato: un tratto distintivo che separa la tragedia antica dalla moderna, tema oggetto delle Deux masques di Paul de Saint-Victor, il ponderoso saggio letto e postillato da d’Annunzio sull’edizione parigina del 1889-94 in vista della stesura di Fedra.
Fedra incarna l’Uebermensch declinato al femminile, è stato detto giustamente (cfr. De Michelis, pp. 313-316); ma accanto alla forte consonanza con Nietzsche, nella mente di Gabriele c’era un pizzico di Wilamovitz, il filologo che attaccò il pensatore che aveva scritto l’Origine della tragedia. Un segno della sensibilità filologica di d’Annunzio lo trovo in un dettaglio non trascurabile. Prima dell’Ippolito coronato, tragedia che ci è giunta integra, Euripide aveva composto sullo stesso mito un Ippolito velato che suscitò scandalo, si suppone per ragioni moralistiche: forse una confessione aperta della donna, forse un bacio in scena. Per questa ragione Euripide compose il Coronato, mente il Velato andò perduto. I due titoli si riferiscono rispettivamente alla corona d’alloro che vien posta sulla statua di Ippolito nel tempietto che gli viene dedicato, e al velo che il giovane si era posto sul volto per celare il turbamento provocato dalla vergognosa proposta di amoreggiare con la matrigna. Con molta probabilità d’Annunzio volle dar corpo all’Ur-tragedia perduta, per dare nuovamente scandalo agli spettatori; lo suggerisce una spia verbale dell’ultima scena, quando Fedra ordina che il corpo esanime di Ippolito sia coperto con un velo; e aggiunge: «Sola io porterò su le mie braccia d’ombra / Ippolito velato all’Invisibile». Quindi, rivolgendosi ad Afrodite: «O dea, / tu non hai più potenza. / Spenti sono i tuoi fuochi. Un fuoco bianco / io porto all’Ade. Ippolito / io l’ho velato perché l’amo. [… ] / Velato all’Invisibile / lo porterò su le mie braccia azzurre, / perché l’amo».
Alcyone come viaggio nel mito
Passiamo ora all’altro esempio, considerato non solo il capolavoro della lirica dannunziana ma anche un libro capitale della poesia italiana del Novecento: l’Alcyone. La raccolta, che contiene alcune tra le liriche più celebri – La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, i Pastori – uscì con la data 1904 nel dicembre del 1903, unitamente ad Elettra, pochi mesi dopo la comparsa del primo libro delle Laudi, Maia, dedicato in gran parte alla rivisitazione della Grecia classica legata al viaggio del 1895. Composto per la porzione più consistente nell’estate del 1902, Alcyone fu definito da Sergio Solmi «diario lirico di un’estate marina» (Solmi 1963, pp. 6-7). In realtà, come ho potuto dimostrare nei miei studi precedenti (Gibellini 1975, pp. 398-424; 1977, pp. 31-84), raccoglie testi stesi man mano tra il 1899 e il 1903, organizzati però in una struttura che trasforma gli accadimenti diaristici in tappe di un percorso paradigmatico, che non è solo travestimento dei soggiorni del poeta in Toscana e a Roma con la Duse, ma un vero viaggio nel mito, lungo l’arco temporale di un anno ideale – quello cui si riferiscono le poesie – che va dalla fine della primavera all’incipiente autunno, attraverso l’esplosione estiva. Avvicinamento, incontro e perdita dell’Estate incarnata, e con lei del clima mitico, sono i tre momenti fondamentali del libro. Non senza ragione d’Annunzio preferiva chiamare «poema» la sua raccolta di liriche, fruibili isolatamente ma inserite in una salda struttura da canzoniere. Viaggio nel mito significa anche viaggio nella classicità, tant’è che il l’opera è stata non a torto definito da Diego Valeri (1968) quale «moderna Metamorfosi», anche perché l’autore classico più echeggiato è Ovidio.
Seguiamo, a volo d’uccello, alcuni passaggi significativi tra i tanti richiami alla classicità – lungo l’arco della raccolta. Il testo di apertura, La tregua, rappresenta un congedo dal libro precedente, Elettra, epicamente volto alla celebrazione degli eroi, e annuncia il registro idillico e georgico del nuovo libro. La seconda lirica, Il fanciullo, costituisce la vera introduzione ad Alcyone, nella quale d’Annunzio espone in forma verseggiata e immaginativa la propria ars poetica. Mentre Pascoli, in una prosa di pochi anni prima, aveva presentato il «fanciullino» come lo sguardo del poeta che conserva nel proprio intimo la infantile capacità di stupirsi delle cose più umili e semplici, d’Annunzio oggettiva il fanciullo nell’ipotiposi di un flautista adolescente, «nudo fanciul pagano» dell’Alcyone, che riunisce tratti di Ermes e di Orfeo; sa incantare le creature viventi con il suono del suo flauto, fatto da cui escono due melodie, quella della luce e quella dell’ombra, specchio della doppia inclinazione del poeta, solare e notturno, vitale e melanconico; quelle canne le ha colte nell’orto di un fauno o forse negli Orti Oricellari, cuore del Rinascimento fiorentino «quando di Grecia le Sirene eterne / venner con Plato alla Città dei Fiori». Più avanti, il poeta implora il fanciullo di tornare con lui «nell’Ellade scolpita / ove la pietra è figlia della luce / e sostanza dell’aere è il pensiere». Per trattenere il Fanciullo che si allontana gli promette di riedificare il tempio in rovina del culto pagano, riprendendo l’immagine e le parole con cui Nietzsche annunciava alla fine la morte di Pan e del mondo antico; era questo l’assunto della poesia proemiale di Maia, L’Annunzio, che finge da premessa all’intero ciclo laudistico: «il gran Pan non è morto». Il Fanciullo però scompare all’orizzonte, confondendosi con le stelle o trasformandosi iin qualche creatura vivente. Le sette ballate in cui è scandito Il fanciullo tracciano, a ben vedere, l’arco dell’intera raccolta: l’aspirazione a riedificare il tempio pagano, a rivivere la dimensione mitologica – che si realizza nell’epifania dell’Estate in forma di gigantesca dea ignuda – e la perdita di quella dimensione con l’autunno, la stagione della visita alle rovine archeologiche di Roma, l’unico retaggio di quel mondo consentito ai moderni, che possono però farlo rivivere grazie all’immaginazione poetica.
Con l’ascesa stagionale, progredisce anche l’avvicinamento al mito, che assimila il paesaggio toscano a quello greco: «L’Ellade sta tra Luni e Populonia», suona un verso del sonetto A Gorgo, incluso nella Corona di Glauco, il cui titolo echeggia quella di Meleagro. Mito significa anche e soprattutto metamorfosi: ecco dunque, sul modello ovidiano ricreato personalmente, la trasformazione del pescatore Glauco in divinità marina nel secondo Ditirambo (più avanti, nell’ecloga Bocca di Serchio, il poeta chiamerà Glauco e Ardi se stesso e il figlio, protagonisti di una cavalcata nella boscaglia litoranea); ecco la trasformazione di Dafne in alloro nell’Oleandro (ma è una Dafne che a differenza del modello supplica Apollo di impedire la trasformazione arborea per poterla godere carnalmente), ecco la conversione in creature vegetali del poeta e di Ermione, entrati nello spazio magico della pineta divenuta sotto la pioggia una magica orchestra. Dal poema di Ovidio d’Annunzio trae e rielabora la storia di Dedalo e Icaro, nel quarto Ditirambo, disseminandola di allusioni testuali; basti un esempio, quello dell’ammonimento che il padre rivolge al figlio perché non voli troppo alto né troppo basso per non danneggiare le ali da lui costruite connettendo con la cera penne d’uccelli. Il poeta latino aveva scritto: «“Medio” que “ut limite curras, / Icare,” ait “moneo, ne, si demissior ibis, / unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat / e carpe viam.”»; e d’Annunzio: «Giova nel medio limite volare; / ché, se tu voli basso, l’acqua aggreva / le penne, se alto voli, te le incende / il fuoco». Nel calco elegante, anche l’ablativo latino medio limite viene ripreso tal quale come sintagma italiano, ricercato ma ineccepibile, nel verso dannunziano: il raffinato poeta, che amava i gioielli, inserisce una gemma citazionale entro il castone parafrastico.
Spiccano alcune riuscite favole di nuovo conio; il drammatico combattimento tra il cervo e il Centauro (La morte del cervo), il sensuale incontro con la ninfa boschereccia Versilia, che erompe dalla corteccia con il suo corpo carnale per sedurre il poeta, la naiade Undulna che legge le curve dell’onda come note musicali… Poi, come detto, la fine dell’estate segna non solo l’allontanamento dalla marina versiliana, ma anche dal mondo mitico e classico che quello sfondo paesistico aveva evocato. L’asse della classicità passa dalla natura alla cultura, e in questo passaggio fa capolino, dea della modernità, la «Melancolia»: preannunciata nel finale del Fanciullo e nell’Oleandro, essa si fa nostalgia nei Sogni di terre lontane, ed è al tempo stesso nostalgia di epoche lontane. L’escursione archeologica e museale che il poeta compie in settembre assieme alla Duse pietrifica in ruderi, per dir così, il miracolo della mitica estate alcionia che il poeta si era illuso di rivivere con Eleonora trasfigurata in Ermione, in una dimensione fuori dal tempo, la «favola bella / che ieri / t’illuse, che oggi m’illude»: dove favola ricalca fabula, il termine con cui i latini tradussero il greco mythos. In altre parole, l’abbandono del litorale toscano a fine estate trascende la cronaca trasfigurata di una vacanza marina: segna il passaggio dal vitalismo immaginativo degli antichi alla malinconia e alla erudizione dei moderni: uno stacco che, in altra forma, avevano colto lo Schiller del saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale, il Leopardi della canzone Alla primavera, il Baudelaire del Voyage à Cythère.
Dedicando a Giovanni Pascoli il libro che inizialmente pensava di indirizzare a Carducci, d’Annunzio definisce l’anico-rivale «l’ultimo figlio di Virgilio» (Il commiato); nel sonetto La Vittoria navale, introduttivo a una sezione di ebbrezza dionisiaca legata alla vendemmia settembrina, il poeta definisce altrimenti se stesso: «Io son l’ultimo figlio degli Elleni: / m’abbeverai alla mammella antica; / ma d’un igneo dèmone son ebro». Sulla decisone di dedicare il libro a Pascoli anziché a Carducci dovette agire la consapevolezza della maniera più moderna con cui la classicità era reintrpretata dai due emancipati discepoli del poeta, anche se d’Annunzio marcava la diversità del loro approccio all’antico: georgico quello di Giovanni, dionisiaco quello di Gabriele; più sensibile ai latini il primo, più ai greci il secondo.
Gli ultimi anni
Dopo i poemi di Maia e Alcyone e dopo le tragedie La città morta e Fedra, d’Annunzio non scrive più opere in cui la civiltà classica abbia un ruolo così rilevante, e la poesia sostanzialmente tace, a parte le composizioni patriottiche dedicate alla conquista della Libia (Merope) e alla Grande guerra (Asterope), ovvero si insinua tra i frammenti raccolti nel Segreto, facendone un prosimetrum. Matura la svolta per cui d’Annunzio passa dalla «prosa di romanzo» – narrazioni dove l’autore si nasconde dietro la maschera del protagonista – alla «prosa di ricerca», nella quale si esprime direttamente; questa si bipartisce fondamenente tra scrittura introspettiva autobiografica e immaginativa da un lato, e l’oratoria celebrativa e patriottica dall’altro. Nella prima i riferimenti alla letteratura greco-latina sono piuttosto scarsi, mentre nella seconda il latino serve soprattutto a fornire motti (Quis contra nos?, Semper adamas, Memento audere semper ecc.). Un caso a sé è rappresentato dal Libro segreto, il suo ultimo scritto importante anche se a lungo trascurato o sottovalutato dai critici. In quell’opera, costituita dalla scelta e dal montaggio di note e frammenti vergati nel quinquennio precedente, molti dei quali sono costituiti da riflessioni di estetica, il poeta torna a confrontarsi con le proprie radici classiche. Ora, tra i fitti richiami alla cultura classica, spesso legati a ricordi autobiografici o alla sua curiositas di erudito, spiccano i continui riferimenti alla bellezza della forma, con particolare riguardo alla metrica: perfetto come un’ode greca è il corpo nudo dell’amante, la sua scrittura «notturna» supera per ritmo e prosodia i migliori esempi antichi. Al vecchio malinconico signore del Vittoriale l’eredità classica che più riconosce e ammira sembra quella di natura puramente estetica.
Abbiamo dunque percorso a volo d’uccello il vasto campo della cultura classica di d’Annunzio, considerato come la conoscenza della letteratura greca e latina, insieme a quella italiana e francese, fosse fondamentale per sua concezione di «umanesimo». Ci siamo fatti un’idea delle conoscenze linguistiche di d’Annunzio, della profonda conoscenza delle lingue classiche, e della dimestichezza con il francese, che attraverso le traduzioni diventa un mediatore del mondo classico – anche se a d’Annunzio non mancava la capacità di consultare l’originale. Di fatto, la preferenza accordata alle due letterature classiche e alle due neolatine chiarisce la visione geo-letteraria di d’Annunzio: la sua Europa ha un baricentro mediterraneo e latino. Dalla civiltà greca e latina l’Imaginifico Gabriele ha attinto l’ideologia neopagana e il culto della bellezza. Le due nazioni sorelle, la gloriosa Italia e la dolce Francia, ne hanno assunto l’eredità e devono trasmetterla ai contemporanei; questo pensa, con il d’Annunzio artista, anche il Poeta-soldato, fiducioso nella perenne modernità dell’antico.
Bibliografia essenziale
D’Annunzio e il classicismo, Atti del Convegno, «Quaderni del Vittoriale», 23, 1980.
Fedra da Euripide a D’Annunzio, Atti del Convegno, «Quaderni Dannunziani» 5-6, 1989.
Verso l’Ellade. Dalla «Città morta» a «Maia», Atti del XVIII Convegno Internazionale (Pescara, 11-12 maggio 1995), Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani e della Cultura in Abruzzo-Ediars, 1995.
Da Ovidio a d’Annunzio. Miti di metamorfosi e metamorfosi dei miti, Atti del convegno di studi, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2019.
Da Foscarina a Ermione. Alcyone: prodromi, officina, poesia, fortuna, Atti del XXVII Convegno di Studio, 25-26-27 maggio 2000, Francavilla al Mare, Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani e della Cultura in Abruzzo, 2000.
Lorenzo Braccesi, L’antichità aggredita. Memoria del passato e poesia del nazionalismo, Roma, L’Erma, 1989.
Ilvano Caliaro, D’Annunzio lettore-scrittore, Firenze, Olschki, 1991.
Sabino Caronia, Gabriele d’Annunzio. «Torna con me nell’Ellade scolpita», in Il mito nella letteratura italiana, III, a cura di Raffaella Bertazzoli, Brescia, Morcelliana, 2003, pp. 283-327.
Catullo, Le poesie, a cura di Guido Ceronetti, Torino, Einaudi, 1969.
Gabriele d’Annunzio, Poesie, a cura di Enzo Palmieri, Bologna, Zanichelli, 1941-1964.
Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini, Milano, Mondadori, 1982-1984.
Gabriele d’Annunzio, La città morta, a cura di Milva Maria Cappellini, Milano, Mondadori, 1996.
Gabriele d’Annunzio, Intervista a Renato Simoni, «Il Corriere della Sera», 9 aprile 1909, ora in Interviste a d’Annunzio, a cura di Gianni Oliva, Lanciano, Carabba, 2002, pp. 137-151.
Gabriele d’Annunzio, Del cinematografo come strumento di librazione e arte di trasfigurazione [1914], in Id., Scritti giornalistici, II, a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2003, pp. 668-674.Gabriele d’Annunzio, Il Libro segreto, a cura di Pietro Gibellini, Milano, Rizzoli 2010.
Gabriele d’Annunzio, Alcyone, ed. critica a cura di Pietro Gibellini, Venezia, Marsilio, 2018.
Gabriele d’Annunzio, Fedra, ed. critica a cura di Edoardo Ripari, Edizione nazionale delle opere di Gabriele d’Annunzio, Gardone Riviera, Il Vittoriale degli Italiani, 2024.
Eurialo De Michelis, Guida a D’Annunzio, Torino, Meynier, 1988.
Carlo Diano, D’Annunzio e l’Ellade, in L’arte di Gabriele d’Annunzio, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Venezia-Gardone Riviera-Pescara, 7-13 ottobre 1963, a cura di Emilio Mariano, Milano, Mondadori, 1968, pp. 69 ss.
Pietro Gibellini, Per la cronologia di “Alcione”, «Studi di filologia italiana», 33, 1975, pp. 398-424.
Pietro Gibellini, Logos e mythos. Studî su Gabriele d’Annunzio, Firenze, Olschki, 1985.
Pietro Gibellini, D’Annunzio and the Greek and Latin Classics, in Gabriele D’Annunzio and World Literature: Multilingualism, Translation, Reception, a cura di Elisa Segnini e Michael Subialka; Edimburgo, Edinburgh University Press, 2023, pp. 29-47.
Emilio Mariano, D’Annunzio e la Grecia, «Il Verri», 7-9, 1985, pp. 48-76.
Saffo, Frammenti, a cura di Antonio Aloni, Firenze, Giunti, 1996.
Sergio Solmi, L’«Alcyone» e noi [1939], in Id., Scrittori negli anni, Milano, Il Saggiatore, 1963.
Guy Tosi, D’Annunzio e la cultura francese, a cura di Maddalena Rasera, Lanciano, Carabba, 2013.
Guy Tosi, D’Annunzio en Grèce, Paris, Denoël, 1947.
Diego Valeri, L’«Alcyone» o le moderne metamorfosi, in L’arte di Gabriele d’Annunzio, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Venezia-Gardone Riviera-Pescara, 7-13 ottobre 1963, a cura di Emilio Mariano, Milano, Mondadori, 1968, pp. 173-179.
Enciclopedia digitale dannunziana, Vol. I, 2024 (ISBN 979-12-985369-0-6)